
Introduzione
Notte di Natale. Il sergente
Cerutti stava compiendo il consueto giro d’ispezione delle sentinelle. Era col
caporale Mancuso, che seguiva il sergente stando un passo dietro di lui;
seguendo il sentiero arrivarono alla postazione dove c’era il soldato Antonelli.
“Sentinella, all’erta!”
“All’erta sto!”
Dopo queste parole i tuoni annunciarono un bombardamento dell’artiglieria. I tre
si dispersero nelle buche del terreno, in cerca di un riparo dalle bombe
nemiche, mentre i primi colpi dell’artiglieria iniziavano a martellare la
posizione in cui erano poco prima. Il bombardamento era ancora in corso quando
dalla buca in cui si era rifugiato il sergente si alzò un grido. Il caporale
Mancuso, sfidando le bombe, uscì a vedere cosa aveva fatto urlare il suo
superiore; arrivato, vide che il sergente era stato colpito da una scheggia di
granata alla gamba destra, e perdeva copiosamente sangue. Bisognava subito
portarlo da un medico.
Il bombardamento in quella zona era finito, ora stavano martellando le
postazioni sul monte Alpe. Disgraziatamente, proprio lì c’era l’ospedale da
campo più vicino. Ma se voleva salvare la vita al suo sergente, Mancuso non
aveva scelta. Si caricò Cerutti sulle spalle, e lentamente lo portò verso il
monte Alpe.
Parte I
Monte Alpe. Il 24° reggimento, che presidiava quel tratto del fronte, aspettava
nelle caverne la fine del bombardamento. Il tenente De Marchi era tra i più
vicini all’entrata, e vide una figura che, sfidando la morte, stava portando un
carico pesante verso la caverna; era Mancuso. Il tenente si accorse che il
carico pesante era un ferito, e chiamò un medico.
“Signor tenente, il medico è morto!”
“C’è qualcuno che possa aiutare quel poveraccio?”
Si fece avanti un infermiere; appena Mancuso fu entrato nella caverna, questo
gli tolse il carico dalle spalle. Solo in quel momento il tenente De Marchi
riconobbe il caporale Mancuso e il sergente Cerutti, entrambi nel suo
battaglione. Chiese a Mancuso:
“Cos’è successo?”
“Siamo stati sorpresi dal bombardamento dell’artiglieria mentre facevamo il giro
d’ispezione delle sentinelle. Il sergente è rimasto ferito, e…”
“E’ morto!” interruppe l’infermiere, mostrando una ferita da scheggia di granata
che aveva colpito Cerutti alla testa.
Cerutti cercò il colonnello de Marchi, comandante del reggimento. Lo trovò al
telefono in un angolo della caverna, mentre comunicava col comando di divisione.
Quando il colonnello ebbe riattaccato, il tenente De Marchi si avvicinò:
“Buon Natale, signor colonnello!”
“Buon Natale, tenente! C’è qualcosa che volete dirmi?”
“Il sergente Cerutti è morto. Il caporale Mancuso ha riportato il cadavere.”
“Il caporale ha rischiato la vita per riportare un cadavere?”
“Signornò, quando il caporale se l’è preso in spalla, il sergente era ancora
vivo.”
Dopo un po’ il colonnello disse:
“Il Kamnina è sotto attacco, lo stiamo perdendo. Siccome tra due giorni il Primo
Ministro, nel suo giro d’ispezione del fronte, arriverà a visitare questo
settore, il comando di divisione non vuole fare brutte figure. Ci hanno ordinato
di attaccare non appena finisce il bombardamento, per alleggerire la pressione
sul Kamnina. Tenetevi pronti.”
Il tenente De Marchi riandò verso l’uscita della caverna, dove stava prima. Fu
raggiunto dal sottotenente Milani, della compagnia H, di cui De Marchi era
comandante, cui disse:
“Appena finisce il bombardamento andiamo a farci massacrare. Buon Natale!”
Nella caverna la situazione era surreale. Ignorando il bombardamento, i soldati
si scambiavano regali, auguri e cantavano; cantavano canzoni di Natale!
Il sottotenente Milani chiese:
“Il natale come lo passavi?” tra tenenti e sottotenenti ci si dava del tu.
“Da civile intendi?” Milani annuì. “La vigilia di Natale mi ricordo che la
passavo coi miei genitori e i miei fratelli a casa dei miei nonni; la vigilia di
Natale mia nonna preparava il capitone, e…”
Si interruppe. Era stato colto dalla nostalgia, e capì perché i soldati
cantavano, bevevano e si scambiavano regali nonostante il bombardamento;
semplicemente, cercavano di vincere la nostalgia per le loro case e le loro
famiglie.
“Lasciamo che si godano il loro ultimo Natale prima che vengano spediti al
macello” disse Milani
Il tenente De Marchi annuì.
Dopo un ora il bombardamento cessò. Il reggimento uscì dalla caverna e riprese
posizione nelle trincee. L’ordine:
“Signori ufficiali, in testa ai reparti! Pronti per l’attacco!”
Ripetuto per due volte nel gelo della notte natalizia, fece intendere ai soldati
che stavano per attaccare. Il silenzio riempiva gli istanti precedenti
l’attacco, non un solo rumore, non un fruscio. Gli unici rumori erano quelli
della battaglia che si combatteva sul Kamnina, lontani e ovattati.
Il tenente De Marchi iniziò a recitare mentalmente il Padre Nostro, il
sottotenente Milani vuotò una gavetta di cognac, frettolosamente distribuito ai
soldati quando era arrivato l’ordine di attaccare. Tutti pregavano, o bevevano.
L’attesa era snervante, quella quiete così irreale, se confrontata con l’inferno
che stava per scatenarsi.
Poi, l’ordine arrivò:
“Fuori!”
E i soldati uscirono dalle trincee; urla e spari. Molti spari. Il nemico si era
accorto dell’attacco in corso, le mitragliatrici avevano iniziato a vomitare
fuoco e proiettili, che si riversavano sui soldati allo scoperto nella terra di
nessuno.
Il reparto del tenente De Marchi ancora non era uscito, e dalla trincea questi
osservava l’attacco in corso, commentando:
“E’ una follia! Ci stiamo facendo ammazzare.”
I soldati tacevano, e silenziosamente approvavano.
Poi anche il reparto del tenente dovette uscire, assieme alla seconda ondata. I
superstiti della prima erano sdraiati sulla neve, riparandosi dietro a sassi o
altri anfratti nel terreno, e da lì sparavano sulle trincee nemiche. Ma con
pochi risultati. I soldati della seconda ondata arrivarono alle postazioni già
occupate dalla prima, anche loro decimati dal tiro delle mitragliatrici nemiche.
Non si poteva procedere oltre.
Il tenente De Marchi mandò un portaordini a cercare il colonnello Grossi, per
chiedergli il permesso di ritirarsi; ma il portaordini tornò dicendo che il
colonnello era morto. Allora il tenente mandò a cercare il maggiore Russo, il
secondo in comando, il quale rispose che era d’accordo con De Marchi: l’attacco
era fallito, bisognava ritirarsi subito.
Per coprire la ritirata, il sergente Trevisan lanciò una granata che esplose
nella trincea nemica. Il nemico per un attimo cessò di sparare, e in quell’attimo,
nell’oscurità, la compagnia del tenente De Marchi iniziò la ritirata, mentre il
sergente Trevisan rimase con due uomini a coprire la ritirata della compagnia;
poi anche loro si allontanarono. Nel frattempo, il nemico aveva smesso di
sparare, capendo che l’attacco era finito.
“Tenente De Marchi!”
Il tenente si voltò. Era il maggiore Russo.
“Comandi!”
“La sua compagnia quanti morti ha avuto?”
“Dodici morti signor maggiore, e ventun feriti.”
Dopo una pausa, il maggiore aggiunse:
“Il capitano Gatti, che comandava il suo battaglione, è morto. Buon Natale!”
“Buon Natale, signor maggiore!”
De Marchi nel suo battaglione era il tenente con la maggiore anzianità di
servizio; quello che il maggiore voleva dire, ma non aveva detto, era che De
Marchi adesso era comandante di battaglione.
L’attacco del 24° reggimento fu inutile, quella notte il Kamnina fu perso.
L’unico risultato dell’attacco fu che la terra di nessuno, sulla neve, era
fiorita di cadaveri.
.
Parte II
Nel mezzo del bosco, il
corteo, al centro del quale c’era l’auto del Primo Ministro, si fermò:
“Perché ci siamo fermati?” chiese all’autista.
“Eccellenza, la strada asfaltata finisce qui. Bisogna proseguire a piedi.”
Detto questo, l’autista scese e aprì la portiera al Primo Ministro. Intanto,
anche il Comandante d’Armata, che viaggiava su un’auto più indietro, era sceso e
stava camminando verso il Capo del Governo. I giornalisti al seguito del corteo
stavano scaricando le telecamere.
Due uomini in uniforme militare si avvicinarono al Primo Ministro, seguiti dal
capo scorta.
“Eccellenza, io sono il sottotenente Milani, lui il sergente Trevisan, del 24°
reggimento. Il nostro comandante di Divisione, il generale Scipioni, ci ha
incaricato di farvi da guide fino al campo sul monte Alpe. Su questi sentieri è
facile perdersi, specialmente se non si conosce la zona, dunque preghiamo lei e
gli altri di seguirci passo per passo.”
“Quanto dista il campo?” chiese il Primo Ministro.
“Circa mezz’ora di cammino.”
Il Primo Ministro non era preparato a camminare per mezz’ora su sentieri
montani, ripidi e fangosi. Era vestito come si sarebbe abbigliato per andare a
fare un discorso alla Camera dei Deputati, ossia con giacca e cravatta.
Arrivò al monte Alpe coi pantaloni sporchi di fango fino all’inguine.
“Eccellenza, il fango è il primo marchio distintivo del soldato in trincea!”
dichiarò il sottotenente Milani.
“E il secondo qual è?”
“I pidocchi!”
Arrivati al monte Alpe, il picchetto fece il presentat-arm al Primo Ministro e
al Comandante d’Armata, che furono ricevuti dal comandante della divisione, il
tenente generale Scipioni. Dopo queste formalità e l’ispezione delle truppe,
filmata dalla troupe televisiva al seguito del Primo Ministro, nella capanna del
generale Scipioni si tenne una riunione cui parteciparono i comandanti di
brigata, il Comandante d’Armata e il Primo Ministro.
Comandante d’Armata: De Simone, ho saputo che la sua divisione ha perso
il Kamnina!
Generale Scipioni: Sì, ma presto lo riconquisteremo! Domani tenteremo un
assalto per conquistare la vetta.
Comandante d’Armata: Possiamo riconquistarlo?
Generale Scipioni: Possiamo e dobbiamo!
Primo Ministro: Cosa intende con “dobbiamo”?
Generale Scipioni: Il Kamnina è la chiave della valle. E’ la vetta più
alta, e si trova al centro della valle. Conquistarlo vuol dire avere la strada
spianata verso la capitale nemica. Se invece ce l’hanno loro, saranno loro ad
avere la strada spianata verso la nostra capitale. E’ fondamentale
riconquistarlo.
Comandante d’Armata: Signor Primo Ministro, forse sarebbe il caso se lei
tenesse un discorso ai soldati.
Primo Ministro: Dice? Veramente il mio scrittore di discorsi è rimasto
nella capitale.
Comandante d’Armata: Non fa niente, lo sente per telefono. Però adesso la
prego di uscire perché dobbiamo occuparci di cose serie.
Generale Scipioni: Il Comandante ha ragione. Per piacere, ci lasci soli,
che qui dobbiamo lavorare.
[Il Primo Ministro esce dalla stanza e va a scrivere il discorso alle truppe]
Comandante d’Armata: La guerra è troppo importante per lasciarla in mano
ai politici!
Generale Nava, comandante XXII Brigata C.: Retori, servi del verbiloquio!
Generale Scipioni: Per fortuna, la guerra è fatta dalle persone pratiche!
Intanto, nell’osservatorio dell’artiglieria sul monte Alpe, il tenente De
Marchi, il sottotenente Milani e il capitano De Simone, ufficiale
dell’artiglieria, discorrevano sulla situazione bellica. Dei tre, De Marchi e De
Simone erano i veterani, in guerra rispettivamente da tre e quattro anni; Milani
fino a un anno prima studiava al liceo e, quando gli ufficiali avevano iniziato
a morire, e i laureati e i diplomati avevano iniziato a scarseggiare, aveva
ricevuto la cartolina ed era stato arruolato come “aspirante ufficiale” dopo un
corso di corsa; due mesi prima era stato promosso sottotenente. Aveva diciannove
anni.
De Marchi: Ci spediranno al macello per riprendere il Kamnina.
De Simone: Già, moriremo per niente, affinché loro possano ricevere
medaglie e promozioni per meriti di guerra.
Milani: Ma, il Kamnina non è la chiave della valle?
De Simone: Senza l’artiglieria la chiave resta appesa al muro.
Milani: In che senso?
De Marchi: Le pareti del Kamnina sono troppo ripide perché ci si possa portare
l’artiglieria…
De Simone: …e senza l’artiglieria la postazione è inutile; appunto, la
chiave resta appesa al muro. Ci avevamo portato due pezzi da 75, smontati e
portati a dorso di mulo, ma avevano una gittata troppo corta per coprire tutta
la valle. Inoltre, quando abbiamo abbandonato la montagna, li abbiamo resi
inservibili. Affinché la posizione sul Kamnina sia realmente di qualche utilità,
servirebbero i pezzi da 152, ma quelli è impossibile farli arrivare lassù.
Milani: E quindi, se si tentasse di aggirare la postazione…
De Marchi: …dal Kamnina potrebbero fare ben poco. Nella valle ci potrebbe
passare una intera armata senza che dalla “chiave” possano fare qualcosa. Il
Kamnina è solo una mosca sulle carte degli alti comandi.
Milani: Ma per conquistare la mosca, noi ci faremo ammazzare. Hai visto i
poliziotti della scorta al Primo Ministro?
De Marchi: Certo! Sono armati meglio delle truppe speciali. Hanno fucili
mitragliatori e giubbotti antiproiettile, roba che qui in prima linea ci
sogniamo.
De Simone: Ma non solo loro, tutti i poliziotti. Quando due mesi fa sono
andato a casa in licenza, erano tutti così! Sai cosa vuol dire?
Milani: Che il governo ha più paura del nemico interno che del nemico
esterno. Certo che lo so. Ma il nemico è messo peggio!
De Marchi: Già, i nostri i fucili mitragliatori li hanno, i loro invece
li usano.
Milani: Se questa guerra non finisce presto, saremo anche noi nella
stessa situazione.
De Marchi: Dubito che la guerra possa finire presto. Non appena i
generali sentono che i politici iniziano a parlare di trattative diplomatiche,
lanciano un'offensiva su tutto il fronte.
De Simone: Bisogna sperare che l’esercito capisca chi è il suo vero
nemico, che volti le spalle a questi morti di fame che abbiamo di fronte e marci
fino ad arrivare nella Capitale. Lì c’è il gran quartier generale nemico. Se
succederà, io con le mie artiglierie sarò in testa alla Rivoluzione.
Milani: Quindi, lasciamo il campo al nemico.
De Simone: No, perché quando la Rivoluzione scoppierà qui, scoppierà
anche da loro, e faranno lo stesso che faremo noi!
Milani: E poi? Una volta fatta la Rivoluzione cosa faremo?
De Simone: Il popolo va al governo e i mezzi di produzione vengono messi
in comune; è il Socialismo!
La giornata si concluse con il discorso del Primo Ministro ai soldati. Fu un
discorso famoso, trasmesso in tutti i telegiornali, e che viene ricordato come
“discorso del monte Alpe”, ma che tuttavia riuscì nell’impresa di scontentare
tanto la truppa quanto i generali.
I soldati non gradirono il passaggio:
“Questa è la battaglia finale! Ripreso il Kamnina, avremo la strada spianata
verso la capitale nemica, e saranno costretti ad aprire le trattative di pace.
Questa è la battaglia per la pace!”
C’era qualcuno che ancora ci credeva?
I generali invece non apprezzarono quando, a complemento delle affermazioni
citate in precedenza, il Primo Ministro affermò:
“La guerra sarà finita entro Pasqua!”
Si dicevano i generali: “Come possiamo combattere una guerra se i politici fanno
di tutto per fiaccare lo spirito combattivo dei soldati?”
Il giorno successivo ci sarebbe stato il pianificato attacco al Kamnina.
.
Parte III
Quel 28 dicembre le truppe
erano in linea in attesa dell’ordine di attaccare. Come la notte di Natale, il
silenzio regnava incontrastato. Un silenzio surreale, impossibile, destinato a
morire al primo sparo e ad essere la prima vittima della battaglia.
Si attacca alle 10 in punto. Il tenente De Marchi chiese:
“Che ore sono?”
Un sergente che aveva l’orologio rispose:
“Le 10.30 passate.”
“Ma come? Siamo in ritardo?”
Già, perché non davano l’ordine? Cosa era successo?
Poi, trafelato, un soldato arrivò, e urlò a squarciagola:
“La guerra è finita!”
Come sarebbe a dire “la guerra è finita!”? Il tenente De Marchi andò verso il
soldato e gli chiese chi gli avesse dato quella notizia.
“Al telegiornale hanno annunciato che nella Capitale gli studenti sono scesi
nelle piazze a chiedere la pace. Il Re è fuggito e il governo provvisorio ha
promesso di aprire subito trattative di pace.”
De Marchi era ancora incredulo. Andò nella più vicina capanna in cui vi fosse un
televisore; la trovò affollata di soldati affamati di notizie fresche. Questi
videro che De Marchi era un ufficiale, ma nonostante questo non fecero il saluto
né lo salutarono. Lo ignorarono. Il tenente se la prese, e pretese il rispetto
della gerarchia militare, ma fu inutile. Uno dei soldati disse volto a De
Marchi:
“E’ finita la camorra!”
La questione finì lì. Nessuno dei due aveva molta voglia di discutere visto ciò
che succedeva.
Il televisore trasmetteva il discorso del Capo del Governo Provvisorio, che
prometteva l’armistizio entro la fine dell’anno.
De Marchi uscì. Allora è vero; la guerra è finita, l’attacco al Kamnina è
diventato di colpo obsoleto, come del resto la gerarchia militare. Ma, a
proposito di gerarchia militare, dove sono i generali? Non si fanno vedere!
I soldati festeggiavano la fine insperata della guerra; erano state sfondate le
botti di alcolici, si mangiava cioccolata e marmellata, prese chissà da dove
(“avranno saccheggiato qualche magazzino della sussistenza”, pensò De Marchi). Le
urla più diffuse erano “Basta guerra!” e “Tutti a casa!”, e molti cantavano.
In piedi, dannati della terra,
In piedi, forzati della fame!
La ragione tuona nel suo cratere,
È l'eruzione finale.
Milani arrivò dove stava De Marchi, e gli porse una gavetta di cognac. Il
tenente la bevve senza pensarci due volte, poi disse:
“Adesso che ne sarà di noi?”
“Cosa intendi dire?”
“Prima della guerra ero un disoccupato con una laurea in psicologia, che si
chiedeva cosa fare della sua vita; qui ero comandante di battaglione, comandavo
centinaia di uomini, avevo una grossa responsabilità, ma sentivo di avere uno
scopo. Anche tu, che nemmeno avevi finito il liceo; qui comandavi ventidue
uomini e guidavi i soldati all’assalto. Ora che la guerra è finita, non possiamo
semplicemente tornare a quello che facevamo prima.”
“Non pensiamoci, godiamoci il momento!” e dicendo questo, gli passò un’altra
gavetta di cognac.
Quel 28 dicembre fu una giornata dai contorni onirici. Ma, come è ben noto, il
confine tra i sogni e gli incubi è molto sottile. Il mattino era stato puro
sogno, ma il pomeriggio, e la successiva notte, si sarebbero rivelati incubi.
Alle ore 15 arrivò la notizia che tutti temevano, e che ebbe l’effetto di un
bicchiere di azoto liquido versato in una tazza di tè.
Contrordine! La rivolta degli studenti è stata repressa; i carri armati sono
nelle strade della Capitale. Il Re è tornato al suo posto, ha deposto il governo
in carica e frettolosamente formato un gabinetto di militari; i membri del
Governo Provvisorio sono fuggiti all’estero. Leggi speciali, censura sulla
stampa, chiusura delle associazioni operaie, e soprattutto, la prosecuzione
della guerra.
I generali al fronte ricevettero il potere di applicare “ogni misura che sia
ritenuta necessaria per riportare la disciplina nei reparti”. E di “misura
necessaria” se ne conosceva una sola, ma sempre efficacissima per ridurre
all’obbedienza i soldati: la decimazione.
Nella divisione del generale Scipioni, il reparto che più di tutti rischiava la
decimazione era la XXII Brigata C., del generale Nava. I soldati di quel reparto
non tornarono nei rifugi come avevano fatto gli altri al “la guerra continua!”,
ma rimasero all’esterno, in atteggiamento pacifico. Avevano fatto un falò dei
fucili, per rendere evidente la loro intenzione di non voler tornare a
combattere.
Quella notte il tenente De Marchi era in una delle capanne in cui alloggiava il
suo battaglione. Entrò il generale Scipioni, i presenti si misero
immediatamente sull’attenti; il generale passò brevemente in rassegna quel
reparto, almeno in apparenza, così obbediente e ordinato, poi chiamò De Marchi:
“Tenente!”
“Comandi generale!”
“Se in questo momento le dessi l’ordine di attaccare le postazioni nemiche,
potrei contare sul suo battaglione?”
“Signorsì!”
“E se invece ordinassi di reprimere l’ammutinamento, potrei fare affidamento sui
suoi uomini?”
De Marchi guardò i suoi soldati, poi disse:
“Non credo”
“Mi dia una risposta chiara! Posso contare sul suo battaglione, sì o no?”
“Signornò!”
“Il suo è tradimento!”
“Signor generale, lei mi ha chiesto se i miei uomini sarebbero disposti a
sparare sui loro commilitoni. Io le ho solo dato una risposta.”
Il generale uscì, nel rifugio in cui era il tenente De Marchi nessuno tornò a
dormire. Tutti, compreso il comandante, rimasero in ascolto di ciò che avveniva
fuori.
Alla fine un reparto disposto a sparare sugli ammutinati fu trovato: una
compagnia cui fu promessa l’impunità per ciò che era successo quel giorno se
avesse “ristabilito l’ordine”. I soldati furono disposti di fronte alla brigata
ammutinata, con le armi pronte a sparare. Il generale Scipioni urlò:
“Avete rifiutato di riprendere le armi! Il vostro è un tradimento che deve
essere punito immediatamente.”
Quindi alcuni soldati contarono i soldati ammutinati, tirando fuori dal gruppo
un uomo ogni dieci. 437 soldati, che dovevano essere fucilati lì, sul posto.
E così l’ordine fu riportato nei reparti al fronte.
.
Parte IV
Erano passate due settimane
da quel 28 dicembre. La divisione del generale Scipioni era ancora lì, sul monte
Alpe, intorno al Kamnina; si aspettavano i rinforzi per sferrare una nuova
offensiva contro il nemico. Le perdite di quella notte erano state pesanti, non
era pensabile attaccare in quelle condizioni.
Il sottotenente Milani, insieme al suo plotone, si godeva un momento di riposo
dentro alla baracca del plotone. Stavano mangiando una gallina che uno dei
soldati aveva “trovato casualmente” nelle trincee; quando il soldato l’aveva
mostrata al sottotenente, raccontandogli come l’aveva trovata, Milani gli aveva
chiesto:
“Lo sai qual è la pena inflitta ai saccheggiatori?”
“Signorsì.”
Guardando fuori dalle finestre, uno dei soldati notò un camion carico di bare,
che si era fermato presso le baracche e aveva iniziato a scaricare il suo
macabro carico, e disse:
“L’offensiva si avvicina!”
Arrivò poco dopo un secondo camion:
“L’attacco sarà più massiccio del solito!”
Sopraggiunse nel frattempo una colonna di soldati, giovani coscritti appena
arruolati per rimpinguare le file dell’esercito.
“Guardate quanto sono premurosi i generali! Ci mandano anche la roba per
riempirle, le bare!”
Il reparto di Milani uscì per ispezionare quei novellini. Il sergente Trevisan,
veterano con alle spalle cinque anni di guerra, disse al suo superiore:
“Sono così innocenti! Dei poveri agnellini che moriranno al primo contatto col
nemico.”
Proprio Trevisan fu il primo a rivolgersi ai nuovi arrivati, chiedendo a uno di
loro:
“Quanti anni hai?”
“Sedici!”
“E tu?”
“Quindici!”
Trevisan si volto verso Milani: “Tra un po’ li prenderanno direttamente dalla
culla!”
Poi Trevisan esaminò il loro armamento. Prese la baionetta di uno di loro, e
osservò le tacche incise sulla lama:
“Dove hai imparato a fare queste tacche?”
“Me lo ha insegnato il mio istruttore, perché?”
“Queste non le usa più nessuno, abbiamo fatto un patto col nemico. E’ molto
meglio usare questa [estrae la sua pala], che oltre ad essere un’arma consentita
è anche più efficace: quella dopo ogni affondo devi estrarla dal busto del
nemico, e col tempo che perdi che rischi di rimanerci secco! Invece con questa,
se colpisci il tuo nemico qui [appoggia la pala tra la spalla e il collo del
ragazzo], lo decapiti in un colpo solo.”
“Cazzo!”
Sentito questo, il sergente disse:
“E’ la guerra! Cosa vi aspettavate, che fosse come andare in vacanza al mare?”
Nel frattempo arrivò De Marchi, anche lui per ispezionare le nuove reclute del
suo battaglione. Preso in disparte Milani, gli chiese:
“Come sono?”
“Come tutte le reclute. Non sanno nulla, sarà già tanto se su venti la metà sarà
ancora viva dopo il primo attacco alle linee nemiche.”
Due giorni dopo, il comando fissò l’attacco per la settimana successiva, il 20
gennaio. E il momento tanto temuto arrivò.
Le truppe erano in linea, nelle trincee, pronte per l’attacco. All’ora
stabilita, arrivò l’ordine di uscire.
Fuoco di mitragliatrice, urla agonizzanti e corpi che cadevano nel fango. Spari,
molti spari nemici, pochi quelli nostri. Molti soldati della prima ondata sono
morti, i superstiti cercano un riparo da cui rispondere al fuoco nemico.
Milani faceva parte della prima ondata, De Marchi era ancora nella trincea, in
attesa di uscire.
A un certo punto, dalle trincee nemiche si udirono delle voci, sempre più forti.
Le mitragliatrici cessarono di sparare, e i soldati nemici si misero in piedi
sui parapetti urlando:
“Basta! Non fatevi uccidere così, tornate indietro!”
Nessuno sparava. Il nemico non sparava, i nostri neppure.
Milani, che era sdraiato col fucile, pensò che avrebbe potuto ucciderne uno. In
fondo, fino a un attimo fa ci sparavano. Col fucile ne puntò uno, ma appena lo
ebbe nel mirino, non riuscì a premere il grilletto. Vide che era un ragazzino di
sedici anni, a cui probabilmente avevano riempito la testa con retorica
nazionalista su sacri confini, patri valori e stronzate varie; un ragazzo a cui
sui banchi di scuola era stato insegnato l’odio contro chi si sarebbe opposto a
questi ideali. Ossia, un ragazzo come lui.
Posò il fucile e cercò lo sguardo del sergente Trevisan, e guardandolo capì che
stavano pensando la stessa cosa. Dopo qualche minuto di silenzio, ordinò:
“Torniamo indietro!”
Fu subito imitato dagli altri comandanti della prima ondata. La ritirata fu
estremamente pacifica; infatti nessuna delle due parti sparò un colpo. Quando fu
rientrato nelle trincee, De Marchi disse a Milani:
“Bravo! Hai fatto la cosa giusta!”
De Marchi e Milani non lo sapevano, ma durante la ritirata il generale Scipioni
aveva ordinato all’artiglieria di tirare sulle proprie truppe per costringerli a
tornare all’attacco. Ma il capitano De Simone rifiutò di obbedire finché non gli
fosse arrivato un ordine scritto; quando l’ordine scritto arrivò, i nostri già
erano nelle trincee, De Simone lo riferì al comando di divisione, il quale
revocò l’ordine, essendo ormai diventato inutile eseguirlo.
Il generale Scipioni decise quindi di ordinare una nuova decimazione, fucilando
cinque militari estratti a sorte tra quelli che avevano partecipato all’attacco.
De Marchi, comandante del battaglione coinvolto da quei fatti, tentò di opporsi
alla decisione del generale Scipioni, ma non servì a nulla.
Tra i cinque estratti a sorte c’era il sergente Trevisan, fucilato assieme agli
altri il 1° febbraio.
.
Epilogo
Un mese dopo la fucilazione
di Trevisan, la perdita di due cime nella valle costrinse il comando nemico ad
abbandonare ai nostri il Kamnina.
De Marchi era solo. Milani era stato ferito, ed era convalescente in ospedale,
De Simone era morto quando una granata nemica aveva colpito la postazione della
sua artiglieria, facendo esplodere le munizioni che lì si trovavano.
Era assieme ad altri ufficiali in una baracca, quando arrivò l’aiutante di stato
maggiore, che chiamò fuori De Marchi per dirgli:
“Il Comando Supremo sta pianificando una offensiva a Est, contro il
Westlicherfluss. La divisione sarà trasferita lì per prendere parte ai
combattimenti.”
Gli altri ufficiali non avevano udito cosa avesse detto l’aiutante di stato
maggiore, ma comunque avevano inteso il significato del messaggio.
“Al Westlicherfluss” disse uno di loro, alzando una gavetta di cognac.
La guerra proseguiva.
.
Nota: Da un po' di tempo mi girava nella mente questa immagine di un reparto di soldati che festeggia il Natale chiuso in un bunker sotto un bombardamento. L'ho unita ad un racconto, fortemente ispirato a "Un anno sull'Altopiano" di Emilio Lussu, che avevo iniziato e non finito.

E adesso, un altro racconto dello stesso autore:
Il comandante dell'armata dimenticata
C’era una volta un bambino il
cui desiderio era servire la sua Patria in ogni modo che gli fosse possibile;
spesso giocava a sfilare in parata indossando un cappello da bersagliere
appartenuto al padre e brandendo una spada di legno. Diventato grande, lasciò
perdere i giochi da bambino e si iscrisse alla facoltà di filosofia, ma quando
era ad un passo dalla laurea, la Grande Guerra scoppiò, e in lui si risvegliò il
patriota che era da bambino.
Si arruolò volontario, e combatté. Tenente della brigata Casale, i gialli del
Calvario, il Podgora, espugnato nell’agosto del ‘16 dopo quattordici mesi di
sanguinosi combattimenti. Ma la guerra fu un’esperienza traumatica per il
tenente Russo, che vide morire molti amici e molti soldati, e il suo
patriottismo iniziò a vacillare; nell’autunno del ’16 ebbe la revoca di una
licenza perché sorpreso da un suo superiore a cantare O Gorizia tu sei maledetta
con accanto una bottiglia vuota di vermut. Ma il colpo di grazia lo ebbe nel
gennaio del ’17. Deve sapere il lettore che il tenente Russo era molto
innamorato di Charlotte Henryson, crocerossina inglese che Umberto aveva
conosciuto a Gorizia; lei ricambiava il suo sentimento, e pianificavano di
sposarsi una volta finita la guerra, ma il 13 gennaio 1917 Charlotte fu colpita
da una scheggia vagante mentre prestava servizio nel suo ospedale. All’inizio
non sembrava grave, ma poi la ferita si infettò andando in setticemia, e
Charlotte morì dopo oltre una settimana di agonia. Fu un colpo da cui Umberto
non riuscì mai a riprendersi, e da quel momento in poi cambiò completamente.
Come scrisse lui stesso nelle sue memorie, l’unica cosa in grado di farlo
sentire meglio, era uccidere gli austriaci che avevano ucciso la donna amata. E
iniziò a farlo in modo sempre più brutale, tanto da destare lo sconcerto dei
suoi superiori. Un maggiore riferì di averlo visto:
“[…] nell’atto di uccidere un mitragliere nemico, nonostante avesse manifestato l’intenzione di arrendersi, il tenente Russo lo sgozzò come un animale, per poi, mentre la vittima ancora agonizzava, aprirgli il petto per strappare il cuore. E dopo averlo studiato in ogni sua parte, lo lanciò in direzione della trincea nemica.”
I superiori lo guardavano con
sospetto, ma i suoi sottoposti lo adoravano: il tenente Russo aveva rinunciato a
tutti i privilegi che gli sarebbero spettati essendo un signor ufficiale, e
faceva la stessa vita che facevano i suoi soldati. Oltretutto, a differenza di
molti altri ufficiali, il tenente Russo la guerra sapeva farla: aveva compiuto
molte azioni in cui da solo o con pochi uomini si era infiltrato nelle linee
nemiche, tornando alle linee italiane con armi, vettovaglie e prigionieri
austriaci (nelle rare giornate “misericordiose”, o se gli servivano per avere
informazioni). Per alcune di queste azioni fu anche decorato, ricevendo due
medaglie di bronzo e una d’argento al valore militare.
Nella rotta di Caporetto nessuno dei suoi soldati abbandonò l’uniforme, e il suo
plotone ripiegò ordinatamente fino al Piave, nonostante fosse rimasto
accerchiato dalle truppe austro-tedesche.
Quando la guerra finì, un simile elemento fece fatica a riadattarsi alla vita civile, e ciò lo spinse ad aderire alle squadracce di camice nere, come fecero molti altri ex-commilitoni. Così trovò una sua dimensione negli assalti alle camere del Lavoro e ai sindacalisti, con la giustificazione di salvare la Patria dai maledetti rossi. Ma poi incorse in una nuova delusione. Infatti, una volta che Mussolini assunse il potere, progressivamente si allontanò dal fascismo, come confermato dal fatto che nel 1933 fu confinato per due anni a Lipari, perché sentito pronunciare in pubblico il bestiario fascista:
“L'aquila, che è rapace; la lupa, che è vorace; l'oca, che è Starace”
E da quel momento cominciò a
crescere in lui l’odio verso il Regime.
Negli anni tra le due guerre si era mantenuto facendo i lavoratori più
disparati; nel 1943 era venditore ambulante, e girava per gli abitati con una
gerla carica di spazzole, rasoi, pennelli, ecc. Un giorno di agosto, in uno dei
suoi giri, vide un militare tedesco che stava cercando di abusare di una
ragazza. Guardò a destra, guardò a sinistra, e non vide nessuno. Doveva agire
subito. Prese la prima cosa che gli capitò in mano. Un rasoio.
Andò verso il tedesco e prima di agire gli sussurrò nell’orecchio:
“Dì addio alle tue palle!”
Quella che aveva salvato era
Anita Pincherle, che sarebbe stata la prima aderente ai GLA e, secondo molti
storici, amante di Umberto. Ma nell’agosto del 1943 l’Italia era ancora alleata
con la Germania, nonostante Mussolini fosse già caduto e fossero i corso le
trattative per l’armistizio. Pertanto Umberto e Anita si nascosero, e intanto
iniziarono a compiere delle prime azioni contro i tedeschi “perché loro sono i
nostri veri nemici”.
Poi, l’armistizio. Si formarono le brigate partigiane, e anche i GLA crebbero di
numero. Ma non avrebbero mai superato i novanta membri.
[…]
Dopo la guerra, Umberto si
ritrovò nuovamente incapace di reinserirsi nella vita civile. Si dice che più
che combattere i tedeschi, coi GLA avesse cercato la morte in battaglia. Ma non
era il suo destino. Nel 1951 provò a pubblicare le sue memorie, senza successo.
Era troppo scomodo, e nessuno voleva pubblicare quel manoscritto. Non c’era più
nemmeno Anita: la sua fedele compagna negli anni della resistenza era morta nel
1949, stroncata da una polmonite.
Depresso, commise quello che per uno scrittore è l’equivalente di un suicidio:
bruciò in una stufa il manoscritto delle sue memorie. Poi, nel 1955, dimenticato
da tutti, morì in un sottoscala di Roma.
I manoscritti non bruciano. Vent’anni dopo la sua morte negli archivi della casa
editrice fu ritrovata una copia delle memorie di Umberto Russo, che fu
pubblicata lo stesso anno.
.
Altro breve racconto bellico inviatoci da Dario:
La fine della Guerra
Finalmente la guerra era finita. Giovanni e Filippo stavano tornando a casa; erano dello stesso paese e la guerra l’avevano fatta assieme dal primo all’ultimo giorno. Le montagne, non quelle dell’Abruzzo ma quelle della Macedonia, ostili e sconosciute. Le battaglie, la cattura e la lunga prigionia.
I loro carcerieri si erano arresi e finalmente avevano potuto tornare a casa. Era finita per fortuna; la fame era stata resa più leggera da due ragazze che, di nascosto dai carcerieri, gli portavano del cibo.
Era finita, ora stavano tornando a casa, avrebbero rivisto il loro paese, mangiato coi loro parenti e rivisto gli amici che erano tornati; la domenica dopo la messa avrebbero fatto sospirare le ragazze e nella settimana sarebbero tornati a lavorare alle loro botteghe. Giovanni, sarto, aveva intenzione di aprire la sua.
Ogni passo li avvicinava a casa, era ancora molta la strada da fare ma sia Giovanni che Filippo erano felici; il peggio era passato, erano sopravvissuti alla Grande Guerra, e avrebbero potuto raccontare la loro esperienza ai loro figli e poi ai loro nipoti, a differenza di molti loro amici che sui monti della Grecia ci erano rimasti per sempre.
“Perché ti sei fermato?” chiese Giovanni a Filippo.
“Là c’è un laghetto. Non voglio arrivare a casa puzzolente come un caprone!”
“E perché, i nostri parenti che zappano la terra profumano quando tornano la sera? Ti laverai a casa.”
Ma Filippo non diede ascolto al consiglio dell’amico. Si tolse l’uniforme, ormai lacera e sporca dopo anni di guerra, spogliandosi nudo, ed entrò nel laghetto.
Appena entrato si portò le mani al petto, l’acqua era gelata. Uscì poco dopo che tremava e batteva i denti, e Giovanni vide che le dita delle mani di Filippo erano diventate blu; subito prese da terra la giacca dell’uniforme e gliela mise addosso.
“Ho sonno Giovanni, fammi dormire.”
“No, non devi dormire, resta sveglio! Non chiudere gli occhi, pensa a tua sorella che ti aspetta a casa! Filippo! Rispondimi!”
Ma non rispondeva. Giovanni sentì il petto, e si accorse che il cuore di Filippo aveva smesso di battere. Era morto.
“Mancava così poco, eravamo quasi arrivati a casa! Adesso dovrò andare da tua sorella a dirle che non tornerai casa.”
Mia nonna mi
ha raccontato, e tuttora mi racconta, di come suo padre, Giovanni Tinari,
tornando dalla guerra vide il suo migliore amico morire sotto ai suoi occhi. Non
mi aspetto di averla resa in maniera precisa al 100%, anche perché mia nonna
parla di “acqua avvelenata” quando secondo me suo zio morì di ipotermia.
Ad ogni modo, questa storia, in un certo senso, ha un lieto fine: la sorella di
Filippo era la madre di mia nonna, e il mio bisnonno e la mia bisnonna
iniziarono a frequentarsi dopo che Giovanni le portò la notizia della morte di
suo fratello.
Il riferimento nel racconto alle ragazze che di nascosto avevano portato del
cibo al mio bisnonno, durante la prigionia, non è casuale. Mia nonna infatti si
chiama Nevenga, come una delle suddette ragazze (Nevena o più probabilmente
Nevenka, che poi il mio bisnonno rese come Nevenga)
.
Diamo ora la parola a Maggioriano:
Liegi 1914
di Maggioriano
Ho scritto un breve racconto sul Principato di Liegi, spero che renda l'idea di come una Teocrazia in Belgio sopravvissuta dal Medioevo fino al XX secolo avrebbe potuto cambiare la storia. Nel racconto si accenna anche all'agonia di questa teocrazia ed ad un futuro dominio del mondo da parte della Germania. Buona lettura.
.
28 Agosto 1914:
A Jean Sarbusse era stata affidata una missione complicata : si trattava di una missione di tipo diplomatico, in vista della guerra imminente.
Tre mesi prima era stato accusato di alto tradimento e di codardia, quando lui era sottotenente di fanteria in Marocco ; quando il suo distaccamento era stato distrutto dalle truppe di Abd el Krim era fuggito, salvandosi dalle truppe nemiche.
Da quanto seppe più tardi era stato l'unico sopravvissuto della divisione.
Trascinato davanti al tribunale militare fu prima esonerato con disonore e, quando pensava che tutto fosse finito, richiamato nello stesso tribunale, dove rischiava la fucilazione.
Stava per essere condannato quando fu ucciso l'Arciduca Ferdinando.
Quest'ultimo con la sua morte gli salvò la vita : fu richiamato dalle autorità militari e gli fu affidata la missione che si accingeva a compiere.
Si ricordava ancora del colloquio che aveva avuto col suo nuovo superiore, di cui lui non conosceva il nome.
27 Agosto 1914:
Il superiore, con un cenno, fece capire a Barbusse che doveva avvicinarsi. Con l'aria di un vecchio amico che gli si confidava iniziò a parlare : - Quella che le affidiamo è una missione della massima importanza : lei deve andare nel Principato Teocratico di Liegi e convincere il principe ad entrare in guerra nel nostro campo. Non siamo ancora pronti per la guerra e le fortezze del principato ritarderebbero il nemico di molto. -
Sarbusse incredulo chiese:
- Ma perché affidate proprio a me la missione ? -
Il Superiore gli rispose:
- Tu sei uno dei pochi a parlare correntemente Fiammingo e Tedesco , sei un cittadino liegese, oltre che francese, ed, inoltre, mi pare che tu sia parente del del Vicario di Liegi.-
Sarbusse evitò di menzionare il fatto che lui ed il Vicario (non sapeva
neanche che lo fosse) non si rivedevano da due anni, perché se l'avessero trovato inadatto alla missione, l'avrebbero fucilato oppure spedito in un battaglione speciale di rieducazione.
Il Superiore, continuando disse:
- Dovrai allora vedere il Vicario, favorevole all'Intesa, e fare in modo di convincere il Vescovo a schierarsi dalla nostra parte ; partirai oggi stesso e ricordatevi che questa missione deve riuscire.-
- Va bene -, rispose Sarbusse. Fece per alzarsi, prima di essere fermato dal Superiore :- E ricordati che hai cinque giorni per riuscire ; altrimenti per te ci sarà il battaglione di rieducazione, la feccia dell'esercito. -
Sarbusse accennò un timido saluto ed uscì, più preoccupato che mai.
Si diresse verso il Quartiere dei Marais, giusto per fare quattro passi e calmarsi : partiva tra tre ore, dalla Gare du Nord.
Tardo pomeriggio del 28 Luglio 1914:
Dalla malandata automobile che lo trasportava insieme ad un prete Sarbusse vide un gruppo di corazzieri, in tenuta da campagna; portavano fieramente sul petto lo stemma del principato: il Perron di Liegi al centro, circondato da quattro croci, simbolo del Vescovo, Gérard de la Merck.
Avevano un portamento alla volta militaresco e raffinato, da ufficiali gentiluomini, avrebbe pensato un civile.
Fu allora che Sarbusse disse sommesso:
- Che teste di cacchio ! -.
- Come ? - chiese tranquillo il prete.
- Niente, padre, niente. -
Liegi non era cambiata molto : era ancora dominata dai resti della cattedrale di San Lamberto, saccheggiata dai Liegesi durante la Rivoluzione francese, e dal cinquecentesco palazzo del Vescovo.
Dalla parte opposta c'era il palazzo del comune, il tutto era sovrastato dalla cittadella.
Niente lasciava pensare che Liegi fosse la capitale di uno stato, che avrebbe determinato l'esito della guerra.
Sapeva a malapena dove si trovasse Jean. Doveva vivere in una specie di convento vicino alla Place Sainte Véronique, vicino al quartiere della cattedrale, quello dei preti per intendersi.
Sarbusse arrivò davanti ad una stauetta di Santa Veronica. Si trovava nella strada giusta, pensò. Non gli restava che trovare il convento. Si mise a camminare lungo la via, finché non si trovò accanto ad un colonnato, davanti a cui era scritto : Couvent de Sainte Véronique.
Era arrivato.
Al prete che stava all'entrata chiese di vedere padre Bonnefoi. -
Gli annuncio la vostra visita -, disse il padre.
Sarbusse rimase ad aspettare per una quindicina di minuti, prima che il prete tornasse ad annunciargli che il Vicario l'aspettava.
Vedendo il suo influente cugino Sarbusse esclamò:
- Jean, non credevo che tu avessi fatto carriera ! -
- A dire il vero non lo credevo neanch'io – rispose Jean. - Tu invece ce l'hai fatta nell'esercito?
- Non proprio -, Rispose Barbusse ricordando il suo processo, ancora in sospeso. Riprese poi:
- Passiamo subito al nocciolo della questione. Tu sai della guerra ? -
- Certo. - Rispose Jean.
- E sai pure che Liegi determinerà il vincitore? Sono stato mandato per convincere il Vescovo a passare dalla parte dell'Intesa. -
Subito il sorriso stampato sulle labbra del Vicario scomparve:
- Mi pare molto difficile. Il Principe Ferdinando Massimiliano è un di Baviera ed è favorevole alla Germania,
cioè all'Impero tedesco. Il nostro vescovo è molto malato ed è il principe a detenere il vero potere.-
- Ma l'organo supremo non resta il consiglio dei religiosi, presieduto dal vescovo? -
chiese Sarbusse.
- Certo, ma si riunisce solo in occasioni d'urgenza -, rispose Jean.
- Ed una guerra non è urgente? Io ho solo cinque giorni per farcela. Devi usare la tua influenza presso il vescovo per scavalcare il potere temporale! -
esclamò Sarbusse.
- Personalmente la mia influenza è minima -, disse Jean – Ma, per quanto mi riguarda, posso fissarti un appuntamento dal segretario del Vescovo, che d'influenza ne ha molta e che non è dalla parte della Triplice. -
- Va bene -, sospirò rassegnato Sarbusse. - Sarà più complicato di quanto pensassi. -
29 Luglio 1914:
Il Palazzo Vescovile si ergeva vicino alla cittadella ed era residenza dei Vescovi sin dal XIII secolo Venne saccheggiato una volta dai Borgognoni, per essere ricostruito da un De la Merck, antenato dell'attuale vescovo.
Era in stile rinascimentale ed era costruito attorno ad una corte, dove un'edera si avviluppava attorno a parte dell'edificio.
Sarbusse, entrato nella Corte, vide il Segretario del Vescovo e si avvicinò a quest'ultimo.
- Buongiorno -, disse al Segretario. Quest'ultimo era un uomo sulla cinquantina, basso e tarchiato ; era anche calvo, ma aveva una faccia complessivamente bonaria, che ispirava fiducia.
- Cosa vuole da me, giovane? - chiese il Segretario.
- Si tratta di un affare molto importante. -
Sarbusse gli espose tutti i fatti. Il Segretario prese un taccuino e scrisse tutto.
- Bene –, aggiunse, – esporrò questa faccenda al vescovo, ma dovete sapere che è seriamente malato ; cosa posso fare d'altro per voi ? -
- Datemi un mezzo per fuggire in Olanda -, rispose Sarbusse.
- Sarà fatto -, ribatté il Segretario. Sarbusse se ne andò lasciando il Segretario; non credeva che la faccenda sarebbe passata sotto gli occhi del vescovo, ma aveva fatto il suo dovere e d ora aveva intenzione di fuggire in Olanda.
30 Luglio 1914
Il Segretario aveva seriamente intenzione di sottoporre la faccenda politica al vescovo : era stufo che il principe, un laico, prendesse le decisioni più importanti in quella che doveva essere una Teocrazia.
Tuttavia le cose non andarono come avrebbe voluto : si era fatto tardi e lavorava ancora fra le scartoffie che riempivano la sua scrivania ; per sbaglio, con un gesto distratto, gettò varie carte nel secchio della spazzatura, tra di esse c'era anche il foglio sul caso di Sarbusse. Subito dopo chiuse gli occhi e si addormentò.
Quando rinvenne cercò il foglio ma non lo trovò. Venne il medico personale del vescovo, che gli annunciò che Gérard de la Merck, vescovo di Liegi, era morto durante la notte. Il Principe diventava l'unica autorità del Principato.
Intanto Sarbusse fuggiva verso l'Olanda, ma, inseguito da un'altra automobile di cui non conosceva gli occupanti dovette germare la sua automobile e correre verso il castello di Huy, dove c'erano le caserme. Sempre inseguito da gente che doveva essere Francese entrò in un ufficio di reclutamento, sperando di seminare i suoi inseguitori.
Commise allora uno degli atti più vani della sua vita: chiese al sottoufficiale che faceva da reclutatore di entrare nell'esercito del Principe,
e fu subito accettato.
Finì la guerra col grado di tenente.
Oggi Sarbusse è considerato come colui grazie a cui la Germania ha vinto la guerra: sarebbe stato lui a far decidere al governo di entrare in guerra a fianco della Triplice Alleanza, sventando un tentativo di avvicinamento tra Francia ed il Principato di Liegi.
Si dice che senza di lui sarebbe stata la Francia a vincere la guerra. Oggi un suo monumento si eleva nella Place Saint Lambert.
.
Ecco ora a voi il "discorso ucronico" di Benedetto XV al termine di una Prima Guerra Mondiale vinta dagli Imperi Centrali (il come non è l'oggetto del contendere, in questo caso). Se volete farmi conoscere il vostro parere a proposito di esso, scrivetemi a questo indirizzo.
.
L'inutile strage
« La guerra che abbiamo attraversato è stata una piaga inutile, frutto dei malevoli sogni di dominio di ogni potenza. Per evitare che un massacro così futile si ripeta, in questo consesso dobbiamo gettare le basi di una futura intesa sovranazionale, che tuteli il diritto di ognuno e non si fondi su politiche su sperequazioni etniche e sociali.
La lotta che dobbiamo compiere ora non è più di natura militare, ma di natura eminentemente etica e sociale, per garantire finalmente una pace.
Una pace in cui gli eserciti saranno considerati una reliquia del passato.
Per compiere questo passo non si poteva prescindere dall’invitare qui, a Trento, anche gli stati sconfitti, parola quest’ultima che non s’abbia più a ripetere.
Oggi ognuno di noi rinunzierà a qualcosa, sacrificherà una parte delle proprie ambizioni per dare corpo, forma ed identità a ciascun popolo d’Europa e non solo.
Ora cedo la parola ad un uomo che inevitabilmente prima di tutti ha visto che quanto stavamo compiendo era un massacro di proporzioni epiche; se posso osare riferirmi alle sue parole, ha definito questo conflitto un’inutile strage. Non abbiamo ascoltato il suo monito, incuranti delle vite che stavamo sprecando: ascoltarlo ora sarà d’ammonimento per tutti noi. »
Carlo scese dai gradini del palco lentamente, come se stesse misurando i suoi passi a bella posta per poter vedere le facce di tutti i presenti.
La compagine di diplomatici americani era quella più mesta e, nel contempo, quella che dava più segni di impazienza: il presidente Wilson aveva condotto gli Stati Uniti a capofitto in una guerra che nessun americano desiderava e, come se ciò non bastasse, l’aveva, in pratica, fatta schierare dalla parte di quelli che avevano perso. Tutte le altre delegazioni si rendevano perfettamente conto che alle prossime elezioni sarebbe stato duramente bastonato.
Quando Benedetto XV salì sui gradini e sistemò il microfono per parlare all’uditorio, il silenzio cupo di Inglesi, Francesi e Italiani era talmente minaccioso che, se non si fosse trattato della conferenza di pace internazionale, probabilmente se ne sarebbero andati via dalla sala pestando rumorosamente i piedi in segno di dissenso.
Non mancava chi sfoggiava, come Sonnino, dei sorrisetti nervosi e sfrontati, come se stesse aspettando il più piccolo errore da usare quando sarebbe stato il suo turno di parlare. Clemenceau aveva manifestamente voltato la testa alle sue spalle per parlare con il suo segretario, tanto per rendere chiaro a tutti che qualsiasi cosa il Papa dicesse non era affar suo, e non poteva minimamente interessargli.
Nonostante tutto questo il Sommo Pontefice non era né, a quanto pare, si sentiva, intimidito; cominciò a parlare in tono chiaro e forte, sfoggiando una tranquillità impensabile a fronte di tutta quella palese ostilità nutrita da parte di un buon numero di delegazioni.
« Carissimi signori, nonostante io sappia che le mie parole ai più non risulteranno gradite, non può rimanere inascoltato il grido di dolore che si leva dai molti popoli che sono rimasti coinvolti in questo tragico evento, che già gli storici denominano guerra mondiale.
Tutto quello che intendevo dire è già stato riassunto nell’intervento dell’imperatore Carlo.
Vorrei però ora volgere le sguardo non al frutto dei nostri madornali errori, ma alla sfida che ci attende.
La tecnologia si è evoluta, e, io penso, si evolverà ancora, ad un ritmo travolgente; la ragione dell’uomo ha creato potentissimi mezzi per creare o, se vuole, distruggere intere città, interi paesi.
A voi dunque domando: è tuttavia cresciuta la nostra capacità di discernere il bene ed il male? Siamo forse in grado, ora come ora di garantire pace, benessere e prosperità a tutti gli esseri umani?
Sarei menzognero se affermassi, come molti, che è solo una questione di tempo prima che tutto questo accada.
Siamo stati tanto affascinati dalle nuove potenzialità che la ragione ci dispiegava innanzi che abbiamo dimenticato come si usa, questa ragione. Ragione è porsi delle domande sul senso della realtà; ragione è andare a fondo dei nostri giudizi, chiederci il perché di ogni cosa; ragione infine è avvertire la sproporzione tra l’uomo e Dio. L’uomo è creatura finita e mortale e mai potrà paragonarsi ad Esso. Pur tuttavia, anche con tutti i suoi limiti tutti gli individui anelano ad un oltre.
Tutto ciò che è stato fatto dalle filosofie e dalle frenesie di questi ultimi decenni è negare la realtà di questo oltre; è l’affermazione che tutto ciò che non dà un benessere, benessere, badate bene, non felicità, immediato, è illusorio. La Chiesa è stata accusata di mistificare la verità impedendo a tutti di godere fino all’ultimo istante di vita, è stata accusata di negare la felicità, nonostante il fatto che lo stesso Gesù Cristo parla del “centuplo quaggiù” ovvero fa riferimento ad una gioia e letizia su questo stesso mondo. Ora però si sono visti i frutti della cancellazione, teorica e pratica, delle domande di senso dal cuore dell’uomo.
Il benessere, la gioia e la letizia si possono ottenere solo tenendo ben presente questi interrogativi, che trovano applicazione in ogni aspetto della vita e possono guidare al bene comune molto più di qualsiasi filantropismo o ragion di stato.
Spero vivamente, quindi, che l’accecante utopia dalla quale ci siamo risvegliati in compagnia di milioni di cadaveri, sia servita a qualche scopo e che questo errore, questo tragicissimo errore, non si ripeta. »
Nonostante tutti i meschini propositi di sfida, l’uditorio intero si era ammutolito, e anche gli atei massoni più forsennati avevano dovuto riconoscere che quelle parole erano sagge, molto sagge, quasi ispirate…e per questo lo odiarono ancora di più.
.
Aggiungiamo questa bizzarra proposta del Marziano:
Mi frulla per la testa un'idea balzana.
Una tribù Inuit ed una di Boscimani, che si muovono dalle proprie terre, e si incontrano/scontrano e dopo si fondono, nel cuore della Penisola
Istriana. Che accade?
.
Così gli replica Enrica S.:
Le due tribù si muovono mosse dalla "Profezia dell'Incontro": una leggenda di entrambe afferma che, quando l'una tribù incontrerà un'altra proveniente "dall'altro angolo della Terra", nascerà chi porterà ordine nel caos (nella Forza, direbbero i seguaci di SW). Dopo secoli di cammino le due tribù erranti si incontrano nel terzo secolo a.C. nella penisola istriana, si riconoscono l'un l'altra e si fondono. Esse si stabiliscono su alcune colline dell'interno e rimangono lì per secoli, chiamati Istropigmei da Greci e Romani. Passano attraverso la dominazione gota, bizantina, veneziana, austriaca, fino a che uno di loro non si arruola nella polizia asburgica. Questi è di stanza a Sarajevo il 28 giugno 1914, quando vede un giovane correre verso l'auto scoperta di Francesco Ferdinando d'Asburgo. Si ricorda della profezia, si intrufola tra la folla approfittando della sua bassa statura, estrae la pistola e spara, abbattendo sul colpo Gavrilo Princip. Niente guerre mondiali, niente rivoluzione bolscevica, niente Guerra Fredda, l'Europa è in pace da due secoli. Davanti al Palazzo di Vetro dell'ONU a Ginevra è stata eretta la statua all'Istropigmeo che riportò ordine nel caos dell'era moderna...
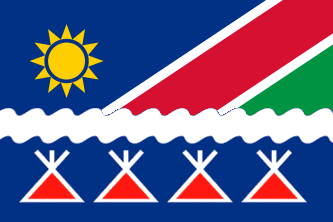
La bandiera degli Istropigmei
