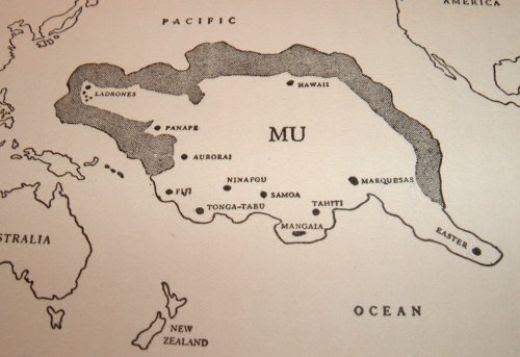
Magellania: storia di un continente
dedicata ad Enrico Pellerito
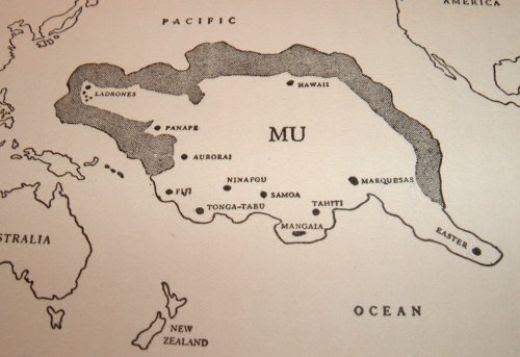
Fig. 1.1 La Magellania in una mappa del XIX secolo
1- Brevi cenni di storia geologica
La storia di questo continente inizia seicento milioni di anni fa circa, con l'emersione dei primi, cosiddetti, 'cratoni', placche di terra che, in seguito, si espanderanno progressivamente per dare vita a veri continenti. Nel primo paleo-oceano di cui deduciamo l'esistenza, detto di Mirovia, il cratone magellanico occupava all'incirca una posizione intermedia tra il cratone kalahariano e quello rioplatense. Non sarà però in loro 'compagnia' che proseguirà il suo viaggio sulla superficie terrestre: duecento milioni di anni dopo, il continente magellanico occuperà la porzione sud-orientale del supercontiente di Pangea, stretto tra il blocco australo-antartico e quello indiano. A partire da quella data inizierà il suo lento e progressivo spostamento in direzione nord-est. Prima di staccarsi dai suoi 'vicini' – a nord-ovest il continente eurasiatico, a sud-ovest il continente australo-antartico, tuttavia, dovranno passare centinaia di milioni di anni (durante i quali la parte orientale dell'oceano Tetide, che poi formerà l'oceano Indiano, sarà un enorme mare chiuso tropicale); per la precisione, intorno ai quaranta milioni di anni fa. Pur tuttavia, il progressivo avvicinamento al continente sud americano porterà all'urto con la placca di Nazca, motivo per il quale inizierà l'orogenesi dei monti della catena orientale del continente, oltre che la 'protrusione' della penisola sud-orientale. L'orogenesi dei monti della catena australe, invece è ben più antica e deriva dalla collisione della placca sudpacifica, in movimento in direzione nord, con quella magellanica. La pressione congiunta di questi due movimenti porterà ad un innalzamento particolarmente importante a sud-est, dove sorge il massiccio di Uwam, la cima più alta del continente, con i suoi 6724 metri. In generale, in tutti i 17.443.891 Kmq dell'intera Magellania, si ha un'elevazione particolarmente prominente e gli altipiani con altezze comprese tra i millecinquecento e i duemila metri non sono così rari (0).
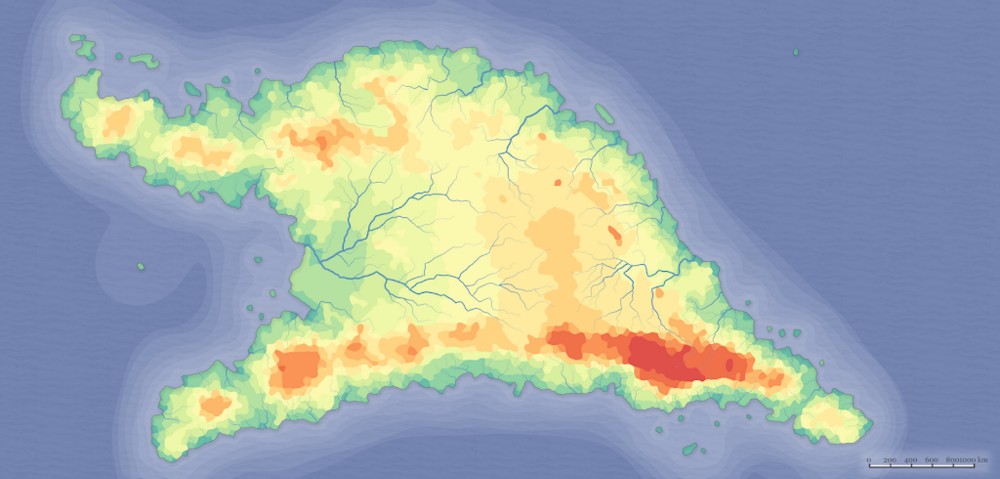
Fig. 1.2 cartina fisica del continente

Fig 1.3 cartina degli habitat del continente
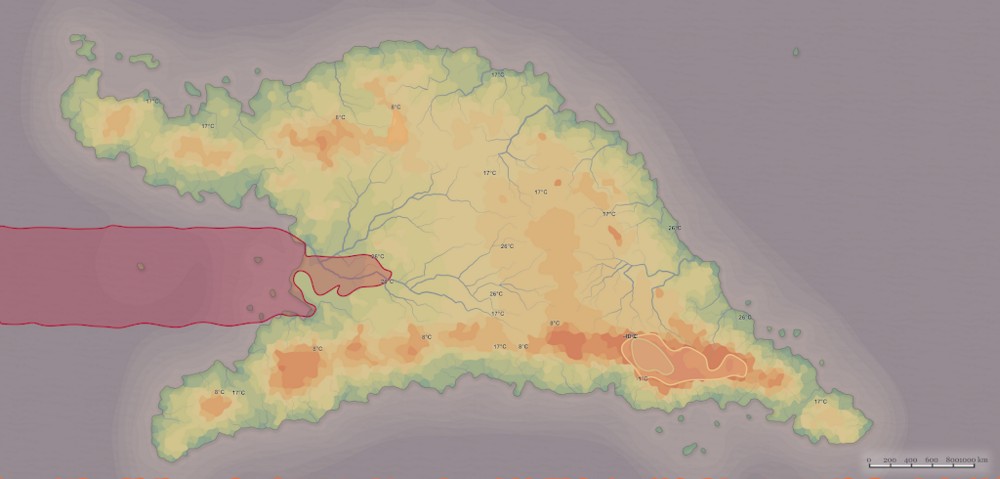
Fig. 1.4 Temperature del continente
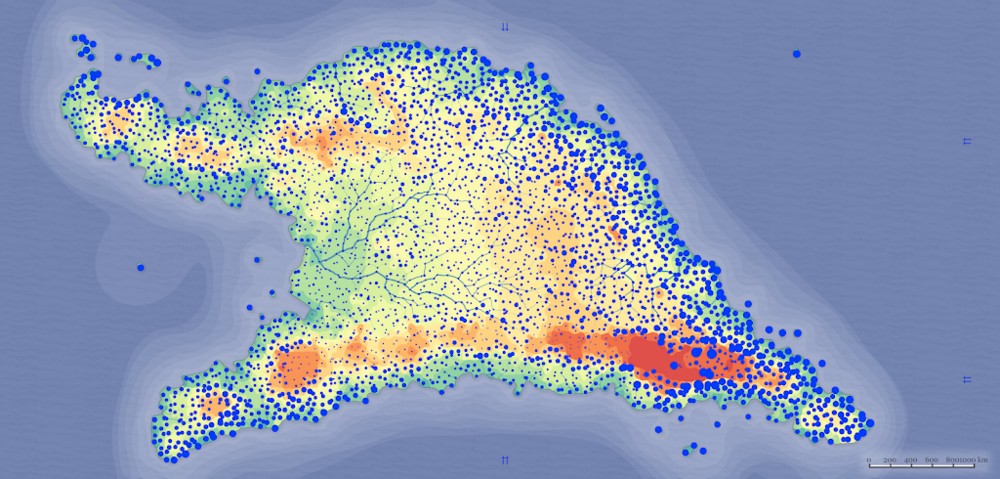
Fig. 1.5 precipitazioni medie del continente
2 - Brevi cenni di storia paleontologica e zoologica
I continui processi
orogenetici a cui è stato sottoposto il continente nel suo 'viaggio' rendono
questo continente piuttosto deludente, dal punto di vista dei ritrovamenti
fossili dei periodi anteriori al mesozoico. Le scoperte più importanti in questo
senso è stata quella di un genere di placodermi del tardo devoniano e un genere
di gorgonopsidi molto enigmatico, in quanto estremamente vicino al limite P-T e
con caratteristiche fisiche basalmente orientate verso la vita acquatica.
Scoperte ben più sostanziose provengono dall'epoca dei dinosauri, con una messe
di generi di sauropodi e teropodi di grandi dimensioni, in particolare il
Tromerosaurus, che doveva essere l'equivalente del T-Rex in Magellania.
'Figli', se così si può dire, dei dinosauri, sono gli uccelli in Magellania ci
fu una evoluzione esplosiva di un numero straordinario (e variopinto) di forme
avicole, volanti e non.
Senza alcuna esitazione, il più noto rappresentante di questo tipo di fauna
sopravvissuto fino ai giorni nostri è il Moa, un mastodontico uccello non
volante. Stando ai dati sul DNA recentemente giunti in nostro possesso, questi
animali dovettero ridursi ad un numero veramente limitato di esemplari intorno
ai 30mila anni fa. Non sappiamo cosa sia accaduto, anche se si suppone possa
essere un qualche drastico cambiamento climatico nel loro habitat o la caccia
intensiva cui furono sottoposti dalle prime comunità umane. Resta il fatto che
se a tale causa fu dovuto il rischio di estinzione, gli uomini stessi
rimediarono, poiché le prime comunità neolitiche ne iniziarono l'allevamento.
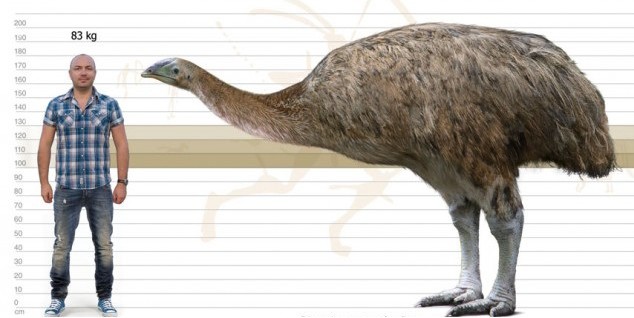
Fig. 2.1 Il Moa
Decisivi per la storia
dell'evoluzione sono i ritrovamenti risalenti al terziario e al quaternario, che
ben rappresentano il percorso divergente dei mammiferi continentali rispetto
alle altre terre emerse. In particolare, il dominio dei marsupiali sui
placentati almeno sino al pleistocene. Particolarmente sorprendente è la
constatazione del grado di convergenza evolutiva che ha portato animali
filogeneticamente molto differenti ad acquisire tratti fenotipici similari. Un
esempio su tutti è quello che è stato approssimativamente definito come il 'cane
marsupiale', ossia il Pimbo, (nome scientifico Pimbus longicrus) o, dagli
australiani, quadraroo, in quanto si tratta di un lontano discendente dei
balbaridi, antichi macropidiformi che non avevano ancora perfezionato il salto
come mezzo di locomozione. In Magellania questi strani canguri quadrupedi, dai
diversi tipi di alimentazione (esistevano infatti sia specie erbivore che
prevalentemente carnivore) hanno raggiunto dimensioni notevoli (alcune specie
gigantesche sono state documentate fino a 30mila anni fa, vale a dire all'arrivo
dell'uomo nel continente), ma una delle specie di dimensioni più modeste venne
addomesticata dall'uomo come compagno nelle sue attività di caccia e raccolta.
Una caratteristica che condividono con i cugini dall'altra parte del mare è la
pressoché totale assenza di scorie gassose derivate dalla digestione dei
vegetali; tali residui vengono convertiti in acetati che possono essere
convertiti in energia dall'animale.
Altri marsupiali particolarmente iconici della Magellania sono il Tinavo, grosso
mammifero palustre vagamente somigliante a un capibara, ma dal comportamento e
dalle dimensioni molto simili a quelle di un ippopotamo (Si tratterebbe di un
lontano parente del diprotodon, vombato gigante estinto nel tardo pleistocene in
Australia. Anche il Tinavo ha rischiato, dal XIX secolo la stessa fine, ma un
programma di salvaguardia del suo habitat e di reintroduzioni ha permesso alla
specie di riprendersi gradualmente), il leone marsupiale e il lupo marsupiale,
predatori in cima alla catena alimentare nelle savane e nelle giungle del
continente.

Fig 2.2 Un lupo marsupiale nella foresta
Last but not least, un altro vombatiforme, il Simbi, forse il più importante tra le specie marsupiali locali per lo sviluppo della civiltà. Agli occhi dei primi europei a mettere piede in questa parte di mondo parve un bizzarro incrocio tra un tapiro ed un maiale e, come quest'ultimo, videro che i locali lo allevavano per la sua carne. Per 'colpa' del Simbi, per lungo tempo venne data inoltre una interpretazione fenotipica erronea di una specie pleistocenica australiana, il Paleorchestes Azaei, che venne rappresentato con una proboscide. Solo di recente si è ipotizzato che la conformazione delle cavità nasali del teschio non coincide con questa raffigurazione. Naturalmente, anche in questo caso, si possono trovare in tutta la Magellania resti fossili di specie prossime di dimensioni ben maggiori, scomparse tra i venti ed i diecimila anni fa, probabilmente a causa del fatale mix tra i cambiamenti climatici e la caccia intensiva da parte dei primi uomini.

Fig. 2.3 Rappresentazione artistica di un Simbi (disegno di Paolo Maltagliati)
Ciò che per lungo tempo ha
rappresentato un complesso mistero per gli scienziati è come i placentati
provenienti dal sud-est-asiatico (sufficientemente vicino alla Magellania e
spesso, durante le ere glaciali pleistoceniche, persino ad esso collegato) non
siano riusciti a spodestare e rimpiazzare i marsupiali dominanti, come invece
avvenuto in Sud America dopo la nascita dell'istmo di Panama. In particolare, i
canidi, sebbene presenti nell'ovest del continente, hanno iniziato a diffondersi
verso l'interno solo in compagnia dell'uomo nelle ondate migratorie più recenti
(e che comunque, strano a dirsi, gli ha presto preferito il pimbo al pari dei
primi aborigeni).
L'ipotesi più ragionevole elaborata dagli esperti è che, sebbene all'apparenza
ecologicamente 'normale', con una serie di biomi non dissimile da quelli che si
possono trovare in altre regioni equatoriali e tropicali del mondo, la
summenzionata grande elevazione del territorio reca con sé due effetti secondari
non trascurabili: la temperatura sensibilmente minore rispetto a molte aree
poste alle medesime latitudini e, soprattutto, un minore apporto di ossigeno
dalla respirazione, che impone una maggior difficoltà di adattamento. Diversi
paleoclimatologi e paleontologi si spingono persino ad affermare che ciò ha
avuto come fortuito corollario che il tasso di estinzione della macrofauna
pleistocenica attribuibile all'overkill da parte dell'uomo è stato
percentualmente più lento che altrove, in quanto più lenta è stata la velocità
di colonizzazione umana del continente stesso (1).
Una possibile causa dell'estinzione della megafauna marsupiale magellanica è
piuttosto da identificarsi nel cosiddetto 'interscambio magellanico-patagonico',
avvenuto a partire da ventimila anni fa. Infatti, a causa delle glaciazioni e
del conseguente abbassamento del livello dei mari, le isole dell'arcipelago Juan
Fernandez, che si protendono dalla punta orientale della Magellania fin verso il
Cile (e che rappresenterebbero i monti della cosiddetta 'Dorsale di Nazca') si
ingrandirono a tal punto da consentire un passaggio via terra tra i due
continenti. Ciò permise l'attraversamento non solo a comunità umane proto –
amerindie, ma anche a diversi tipi di animali, che, abituati al clima e alle
altitudini andine, non trovarono particolari problemi ad adattarsi ai nuovi
habitat. Anzi, ironia della sorte vuole che gli animali di maggior successo si
estinguessero infine nel continente d'origine.
Il principale è senza alcun dubbio è il Mara, ossia, forse, il principale mezzo
di comunicazione della storia continentale. E' considerato, del resto non a
torto, il 'cammello magellanico' ed è stato il fedele compagno di innumerevoli
carovane umane. L'uomo ha pesantemente influito, attraverso incroci selettivi,
sulla sua specie, tanto è vero che ora ne esistono svariate razze.

Fig 2.4 Rappresentazione artistica di un Pimbo (disegno di Paolo Maltagliati)
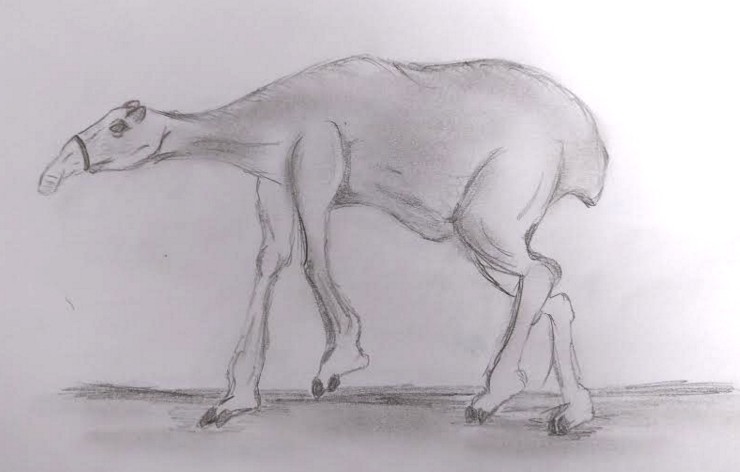
Fig 2.5 Rappresentazione artistica di un Mara (disegno di Paolo Maltagliati)

Fig. 2.6 Statuette votive raffiguranti dei Mara
A proposito di cammelli,
anche i veri camelidi sudamericani si possono annoverare tra gli ospiti. Se
sulle Ande dal Guanaco e dalla Vigogna vennero selezionati il Lama e l'Alpaca,
allo stesso modo sulla cordigliera orientale e poi in quella meridionale si
diffuse la Pecunia (da una storpiatura spagnola di un lemma indigeno), molto
apprezzata per la sua lana.
Quasi altrettanto importante del mara è il 'cavallo magellanico' (nome
scientifico: Hippidion Analasensis). Discendente dalle specie sudamericane di
cavallo, è infatti più tozzo e robusto delle sue controparti euroasiatiche (ma
forse la sua corporatura era l'ideale per una sua diffusione). Ciò nondimeno ha
svolto egregiamente il suo ruolo come trasporto di merci e persone nel corso dei
millenni.

Fig 2.7 Un cavallo magellanico allo stato brado
Molto utile per l'uomo è
stato anche lo Sciola, un possente ungulato brucatore, che, una volta
addomesticato è diventato pressoché ubiquitario come fonte di latte e carne.
Gli uomini, tuttavia, avrebbero probabilmente fatto a meno dell'arrivo in
Magellania di due grandi e pericolosi predatori, temuti e adorati come divinità
dalle prime tribù di cacciatori-raccoglitori: il puma (la cui sottospecie
magellanica è chiamata Puscia) e l'orso nero magellanico, o Atruco (nome
scientifico: arctotherium gracilis), spesso definito dalla stampa divulgativa
anglosassone 'Il cugino cattivo di Paddington', perché, al contrario dell'orso
nero dagli occhiali sudamericano, l'atruco non disdegna affatto abbattere
pecunie allo stato brado e cibarsene. Al giorno d'oggi, comunque, i casi di
attacchi agli umani sono davvero rari.

Fig 2.8 Rappresentazione artistica di uno Sciola (disegno di Paolo Maltagliati)
L'ultimo grande mammifero giunto da est sul continente è il piccolo (due metri alla spalla) elefante di Magellania, che in realtà, dal punto di vista filogenetico è molto meno imparentato agli elefanti asiatici e africani di quanto non si pensasse un secolo fa. Esso infatti è un gonfoteride, gruppo fratello a quello dei mastodonti e dei veri elefanti. Per decenni si pensò che l'elefante di Magellania fosse un'eccezione, un vero e proprio 'fossile vivente', unico modo per far rientrare la specie all'interno del semplice quadro evolutivo che i paleontologi avevano delineato, ovvero la sequenza gonfoteridi – stegodonti – mastodonti – mammuth – elefanti. Quando progressivamente iniziò ad apparire un quadro immensamente più complesso, con i cinque ordini spesso coevi in diverse zone del pianeta, l'elefante magellanico cominciò a non sembrare più così 'fuori posto', come inizialmente si era supposto.
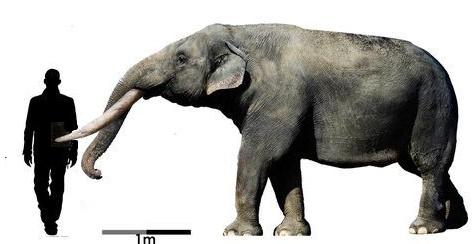
Fig 2.9 Le dimensioni di un elefante magellanico
3 – La colonizzazione umana della Magellania
3.1 Prima dei sapiens
La Magellania, sin
dall'inizio del genere Homo, è stata soggetta a numerose e diverse ondate
migratorie, le cui origini ed entità sono, spesso, molto difficili da seguire e
ricostruire. Non esistono posizioni universalmente accettate, quanto piuttosto
una serie di ipotesi più o meno accreditate che conducano dal Pleistocene sino
al neolitico e alle età del bronzo e del ferro.
Un tempo si supponeva che i primi ominidi a raggiungere il continente fossero
stati gli Erectus, in un periodo stimabile intorno al milione di anni fa. Ora
diversi fossili pongono degli interrogativi su questa ricostruzione. Nel 2005
venne scoperto un individuo dalle caratteristiche primitive e dalle dimensioni
contenute, risalente a 230mila anni fa. Subito venne associato agli scheletri di
Homo Floresiensis, scoperti nella non lontana insulindia due anni prima. Analisi
più approfondite dimostrarono che si trattava, però, di una specie autoctona,
ribattezzata sul momento Homo Latensis (dalla regione di Lat, nel sud-ovest del
continente, in cui era stato ritrovato). Due anni dopo, sull'isola di Luzon,
nelle Filippine, venne scoperto un terzo scheletro che aveva le stesse
caratteristiche di statura bassa e corporatura minuta. Subito ci fu chi si
affrettò a sostenere l'appartenenza dei tre ritrovamenti ad un'unica specie,
mentre la maggior parte degli scienziati si mostrò più scettica a riguardo. Il
dilemma più importante riguardava la filogenesi di tali individui: essi infatti
non potevano discendere da Homo Erectus, in quanto quest'ultimo detentore di
caratteristiche fenotipiche non compatibili con tale modello. Ciò lasciava
largamente supporre che - fossero essi appartenenti ad un'unica specie o fossero
piuttosto tre diverse, la sostanza del problema rimaneva tale – vi fosse stata
una colonizzazione del genere Homo in Asia antecedente all'espansione di Erectus
fuori dall'Africa, a meno di tornare alla obsoleta ipotesi che questi ultimi non
fossero di origine africana, bensì asiatica. Tesi che però era stata smentita
dagli studi genetici più recenti.
Tra il 2015 e il 2019 i risultati diagnostici confermarono che non si trattava
né di individui deformi di altre specie del genere Homo, né di un'unica specie,
quanto piuttosto una gemmazione locale (nel caso del Floresiensis e del
Luzonenis facilmente spiegabile con l'ipotesi del nanismo insulare) di un
progenitore comune migrato fuori dal continente africano molto prima di un
milione di anni fa. Ancor più sorprendente era constatare che, con ogni
probabilità, tali specie fossero convissute per molto tempo con altri ominidi,
senza subire una precoce estinzione per pressione competitiva.
Il quadro non fece che complicarsi nel 2009, quando nella Magellania
nord-occidentale venne scoperta dai paleontologi un'arcata mandibolare risalente
a 100mila anni fa, chiaramente non sapiens, per quanto con tratti decisamente
più moderni. La 'vita' di 'Homo Magellanicus' (questo il nome temporaneo) come
specie a sé stante, la cui filogenesi era ancora tutta da ricostruire, non fu di
nemmeno un anno: il paleogenetista Svante Pääbo, infatti, l'anno seguente
divulgò la scoperta di un nuovo ominide, situato molto in alto nell'albero
evolutivo, chiamato Homo Denisova, dal nome della località siberiana in cui
vennero compiuti i ritrovamenti. Fu enorme lo stupore dei paleontologi che
riportarono alla luce Homo Magellanicus nel constatare che quest'ultimo aveva
caratteristiche che lo ponevano come sottospecie di Denisova. Lo stesso Svante
Pääbo venne chiamato per un consulto e diede parere affermativo alla teoria.
Questo voleva dire che, tra i trecento e i centomila anni fa, vi fu una
radiazione extra-africana, anteriore a quella di Homo sapiens, che raggiunse
presumibilmente il sud-est asiatico e da lì la Magellania. Del resto, uno studio
comparato sul materiale genetico di Denisova e le popolazioni attuali di diverse
etnie del mondo mostrò come l'apporto genetico denisoviano nelle popolazioni
papuasiche, magellaniche meridionali e aborigene australiane ammonta al 5%,
percentuale niente affatto trascurabile e che conduce a supporre con buona dose
di certezza che vi sia stata una ibridazione tra quella e la nostra specie
(ancor più affascinante notare che la percentuale di materiale genetico
condiviso scende se il confronto si attua con il Denisova Magellanicus, prova
del fatto che esso fosse una 'versione' più antica e arcaica rispetto al suo
omologo siberiano. Resta da domandarsi se esista un – ancora da scoprire – vero
e proprio 'Homo magellanicus' discendente recente diretto dalle migrazioni
denisoviane verso il sud-est asiatico, oppure no).
.
3.2 L'approdo di Homo sapiens in Magellania
Ancor oggi identificare una
data anche solo approssimativa per il primo 'sbarco' degli uomini moderni sul
continente magellanico è molto complesso. I primi ritrovamenti fossili risalgono
ai 28mila anni fa, ma numerosi esperti sostengono che la prima colonizzazione
possa essere tranquillamente retrodatabile sino a quarantamila anni or sono, per
quanto per ora non siano ancora stati rinvenuti reperti così antichi. Studi
filogenetici hanno creduto di rintracciare una parentela di molte popolazioni
tuttora presenti sul continente, specialmente nel nord-est e nel sud, da questa
prima ondata, oltre che verificare una effettiva vicinanza con le popolazioni
papuasiche non austronesiane.
L'industria litica segue ritmi paragonabili con altre civiltà paleolitiche,
anche se la maggior parte dei reperti documentano uno stadio di lavorazione già
piuttosto avanzato (questa discrepanza è dovuta al fatto che 'la porta' della
Magellania, la costa occidentale è quella che storicamente è stata la più
soggetta a cambiamenti di natura culturale, etnica e politica, oltre che una
delle aree più urbanizzate del continente, motivo per il quale evidentemente i
siti di popolamento pre-neolitici hanno subito una continua stratificazione
preistorica e storica).
A partire dal quindicesimo millennio prima dell'era cristiana è possibile
rintracciare sull'intero continente dei tratti comuni nelle caratteristiche dei
reperti; in più, presso i siti funerari, iniziano a mostrarsi dei corredi
tipici, che ci danno una prima prova dell'addomesticamento del Pimbo. A questa
fase comune si è soliti dare il nome di cultura di Goh, dal nome del borgo
presso cui sorge il sito più grande e documentato. Essa dura all'incirca due-tre
millenni, prima di dividersi in diverse varianti locali, in particolare nel nord
pluviale del continente e nel brullo entroterra centro-orientale.
Proprio intorno al 12mila avanti Cristo si situa la seconda e, forse, più
straordinaria ondata di popolamento del continente; l'unica, per quanto ne
sappiamo, a non seguire l'usuale direttrice ovest-est. Stiamo parlando della
civiltà di Tululešana, i cui resti sono stati riportati alla luce nell'estremo
sud-est. Secondo ogni probabilità tali genti, armate di rudimentali canoe, con
le quali si dedicavano alla pesca e alla caccia del leone marino, approfittando
del minimo idrografico dell'ultima era glaciale, raggiunsero le estreme coste
sudorientali della Magellania a partire dalla terra del Fuoco, seguendo il
tragitto delle loro prede, ossia Sciola, Mara e Cavalli Magellanici.
Per decenni si è dibattuto su quella che in campo accademico venne nominata
'problema della direzione': sono stati i Tululešana a colonizzare la terra del
fuoco o il contrario? La maggior parte degli scienziati fino ai primi anni del
duemila propendeva per la prima ipotesi. Nel 2007 vennero però introdotte le
nuove tecniche di analisi degli aplogruppi dell' Y-Dna e del Dna mitocondriale
nelle diverse popolazioni e l'annosa quaestio ebbe una risposta che ai più parve
chiara: la presenza notevole dell'aplogruppo Y Q1a3a1 nelle popolazioni del
sud-est magellanico e la coeva scarsa frequenza dell'aplogruppo mitocondriale N
nei nativi dell'estremo Sud America, presente invece in percentuali sempre
piuttosto alte in tutta la Magellania.
Le più grandi innovazioni tecnologiche che emergono dai reperti attribuibili a
questa cultura sono fionde, propulsori e rudimentali archi. Con essi i
Tululešaniani cacciavano animali di media e grossa taglia, con una dieta quindi,
principalmente carnivora. Quello che ancor oggi sfugge alla comprensione è se (e
nel caso, sino a che punto) vi sia stato uno scontro per il territorio con la
cultura di Goh. Molti studi suggeriscono che l'area del sud-est continentale
fosse pressoché disabitata prima del 12mila avanti Cristo, ma la scarsità di
ritrovamenti rende tale risposta ben lungi dall'essere esaustiva.
Sia come sia, direttamente o indirettamente, le invenzioni portate e la
familiarità con molte specie animali di discreta taglia devono aver avuto un
notevole influsso su ogni angolo della Magellania, visto che da questo millennio
in avanti si trova un'esplosione di manufatti in osso sempre più elaborati e,
soprattutto, archi e frecce.
Ma i manufatti in osso potrebbero essere il portato culturale di un ulteriore
flusso migratorio verso il continente, questa volta proveniente da nord-ovest.
L'estesissimo arcipelago Nanpō, come lo chiamano i giapponesi, che collega la
penisola occidentale del continente con la baia di Tokyo, doveva doveva essere
per ampi tratti molto più esteso o, addirittura, una lunga lingua di terra, tale
da rappresentare una sorta di enorme autostrada, che dalla Siberia orientale
andava sin verso la piattaforma magellanica. In tal modo, popolazioni
paleosiberiane giunsero nell'arcipelago (allora penisola) giapponese, dando vita
alla cultura Jomon; alcune, tuttavia, proseguirono il loro tortuoso viaggio
verso climi più caldi, stanziandosi infine sul continente.
Sicuramente esse affinarono, durante il percorso, l'arte della pesca e della
navigazione con canoe, creando manufatti particolarmente eleganti e raffinati,
che tuttora affascinano anche gli artisti contemporanei.
La conseguenza più immediata di tali 'invasioni' fu che in Magellania comunque
si incontrarono, al tramonto dell'era glaciale, popolazioni diverse. Tale
incontro/scontro certamente influì su quello cui possiamo assistere dai
ritrovamenti archeologici, ossia un rapido susseguirsi di innovazioni tecniche e
artistiche che spostò in avanti le lancette della civiltà. Tra tutte, la più
evidente è la pittura parietale, fino ad allora pressoché assente, ma che, a
partire dalla costa sud, si diffuse a macchia d'olio. Di non minore importanza,
possiamo osservare, sempre sulla cordigliera meridionale, i primi, pur
rudimentali, complessi megalitici (anche se il più evocativo, in quanto si
tratta chiaramente di un orologio astronomico che sembra calcolare le fasi
lunari, risale a 10mila anni fa e si trova sulla costa nordoccidentale).
Tra i dodici e i novemila anni fa assistiamo inoltre all'addomesticamento del
Mara, tanto che sono stati trovati degli scheletri completi accanto a quelli
umani in diversi luoghi di sepoltura.
La rivoluzione più grande avvenne di lì a poco, intorno al 6mila avanti Cristo,
quando nacque l'agricoltura. Il cereale di riferimento fu essenzialmente uno, il
riso, a sua volta suddiviso nel riso magellanico di Kaemh (coltivato a secco) e
il riso magellanico di Lat (coltivato su terrazzamenti in umido). A questo,
presto si aggiunse una lunga serie di piante, coltivate per frutti, bacche e
radici/tuberi, le cui più importanti furono senza dubbio il Cocco, il Taro, il
Pandano, il Ti, il gelso indiano, lo zenzero, il pepe e la curcuma.
I primi resti noti di un villaggio agricolo del neolitico in Magellania
risalgono al 5200 a.C, circa, e si trovano nel sud-ovest. Per quanto non si
dispone di dati certi in merito, su suppone una notevole crescita demografica,
che fece da volano ad una sorta di egemonia della cultura di quella regione
(chiamata cultura di Lat) sull'intero continente.
.
3.3 Il Neolitico: nuovi arrivi
Non sappiamo se la cultura di
Lat avesse anche creato forme di aggregazione politica che andassero più in là
della dimensione di villaggio. Sicuramente esiste, in diverse popolazioni
vissute e sviluppate posteriormente, il mito di un'età dell'oro, in cui, in pari
tempo, tutte le nazioni magellaniche godessero di enorme prosperità, ma che allo
stesso tempo fossero governate con scettro di ferro da un imperatore-Dio, che
risiedeva in un'alta torre in cima alle montagne del sud, da cui tutto vedeva e
nulla sfuggiva al suo controllo. Al giorno d'oggi gli antropologi tendono a dare
una lettura in chiave metaforica e psicologica, per quanto ogni tanto spunti
qualche sedicente avventuriero che si getta alla sua ricerca ed afferma persino
di averla trovata. Altrettanto notevole è la pressoché ubiquitaria diffusione
della incinerazione in luogo dell'inumazione come sepoltura, con il ritrovamento
di urne funerarie dalle forme e dagli stilemi decorativi molto simili (pancia
molto larga, con una o più serie di decorazioni curvilinee ripetute e collo
molto allungato e stretto).
Certamente, se davvero esistettero delle città vere e proprie, ancora tutte da
scoprire, e un impero, esso fu destinato ben presto ad essere frammentato in
numerose derive locali a partire dalla metà del quinto millennio avanti Cristo.
Fattore forse rilevante di questa crisi fu la venuta, in di nuovi popoli,
presumibilmente dall'arcipelago insulindiano, che si stanziarono stabilmente
sulla sponda nord della penisola sudoccidentale tra il 4500 e il 4mila avanti
Cristo. A queste genti, chiamate cultura di Brih, risalgono i primi resti di
vere e proprie città, oltre ad una serie di gioielli in osso, giada, legno
laccato e terracotta lavorata. Sembra inoltre che siano stati loro ad introdurre
in Magellania l'allevamento del baco da seta. In realtà, la storiografia recente
tende a rivalutare in modo molto più modesto il contributo da loro fornito al
declino della civiltà di Lat. Se è pur vero che nelle tombe (praticavano
l'inumazione) appartenenti a questa cultura si possono trovare strumenti di uso
quotidiano di una complessità molto maggiore, c'è anche da evidenziare quanto il
raggio territoriale entro cui si sono reperiti manufatti chiaramente loro
attribuibili è estremamente limitato, mentre in altri scavi di villaggi
fortificati risalenti al 3mila avanti cristo circa, nel centro del continente,
sembra che non vi sia alcuno stacco netto nella produzione tecnico-artistica.
Ma chi erano? E' attribuibile una parentela tra loro e popolazioni
contemporanee? Sono state elaborate numerose ipotesi, nessuna delle quali
pienamente e indubitabilmente convincente per tutti. Particolarmente
affascinante, ma a dir poco controversa, è la tesi di G. Lǝbit che sostiene si
tratti di proto-austroasiatici. La sua affermazione si basa sul fatto che si
ritrova una stretta parentela tra il Dna degli scheletri dei defunti delle
necropoli sin qui portate alla luce e le popolazioni attualmente esistenti in
loco. Queste ultime parlano una lingua chiaramente austroasiatica, ma che è
sempre stata di difficile collocazione, in quanto contenente numerosi arcaismi
lessicali e differenziazioni notevoli nella struttura grammaticale. Il legame
tra questi due fattori sarebbe presto spiegato supponendo che la cultura di Brih
sia una migrazione precoce dallo Yunnan, seguendo la linea Delta dello
Yangtze-Taiwan-Filippine-Molucche-Papuasia-Magellania. Il punto controverso di
questa teoria è che contrasta piuttosto nettamente con le recenti tesi di Blench
e Sidwell, che ritengono la diaspora e la differenziazione delle varie famiglie
linguistiche austroasiatiche piuttosto recente, ossia non prima del 2mila avanti
Cristo, quando, seguendo il corso dei fiumi, giunsero dallo Yunnan (dove vi era
stata la transizione neolitica) all'Indocina. L'intera famiglia ha infatti
pressoché le stesse radici per tutto il lessico legato all'agricoltura (che,
appunto, sappiamo essere arrivata lungo il corso del Mekong al più tardi
quattromila anni or sono).
In un recente saggio, la Lǝbit sostiene che la sua ricostruzione non è
necessariamente in contrasto con il lavoro di Blench e Sidwell, basato sulla
dispersione fluviale soltanto in epoca neolitica. Essa infatti afferma che la
ricostruzione lessicale compiuta dai due esperti è, per quanto valida nel
complesso, a tutti gli effetti, inapplicabile per la regione magellanica
sud-occidentale e ciò non si può spiegare semplicemente con la teoria dei
prestiti linguistici dalle popolazioni circostanti (che comunque non danno
risultati pienamente congruenti, come spiegato anche in seguito). Lei propone
che alcune tribù si siano spostate non lungo l'asse nord-sud, ma, anticipando di
due millenni quello che sarebbe stata la direttrice espansionistica dei futuri
popoli Yue, lungo l'asse est-ovest, seguendo il fiume Azzurro verso la costa. A
questo punto, una parte avrebbe preso la direzione del mare, un'altra sarebbe
rimasta sulle coste della Cina meridionale, prima contribuendo alla rovina della
cultura proto – austronesiana di Hemudu, quindi facendosene assimilare. Anzi, è
probabile che tale fusione sia stata all'origine della nascita della cultura di
Liangzhu, che raggiunse il proprio acme tra il 3mila e il 2500 avanti Cristo
circa.
L'obiezione più forte a questa teoria è che mancherebbero tracce delle 'tappe
intermedie' del viaggio degli austroasiatici verso la Magellania, segnatamente a
Taiwan e nelle Filippine. In verità, sempre secondo la Lǝbit, uno studio
sull'esistenza di eventuali lingue di substrato nei linguaggi delle Filippine
non è mai stato affrontato davvero e, a suo dire, potrebbe riservare delle
sorprese rilevanti.
Meno complesso ricostruire la seconda ondata migratoria di genti chiaramente
austroasiatiche, questa volta attraverso la direttrice 'classica',
Malesia-Sumatra-Borneo-Isole della Sunda-Magellania, avvenuta intorno al 2mila
avanti Cristo. Essa sarebbe più serenamente compatibile come una prosecuzione
dell'espansione lungo il Mekong verso la penisola malese. Di essa, inoltre, vi
sono rassicuranti testimonianze linguistiche di substrato in alcune lingue di
Sumatra e del Borneo interno. La cultura di Kaemh, come viene chiamata questa
civiltà, è la prima a regalarci oggetti di gioielleria, composti da metalli a
bassa temperatura di fusione, come stagno, zinco, argento e piombo. Nonostante
l'ossidazione, rimangono oggetti che denotano un gusto e una bellezza unici. I
corredi funerari iniziano a mostrare indumenti sempre più elaborati (fa la sua
comparsa anche la seta). Al contrario della cultura di Brih, quella di Kaemh
conobbe una notevole estensione nell'entroterra semi-arido del continente,
attraversato, in modo non dissimile dal Nilo in Egitto, da vasti bacini
fluviali, che garantivano lo sviluppo di una civiltà urbana di natura ricca e
complessa. Proprio nella cultura di Kaemh possiamo intuire, dai reperti in
nostro possesso, una divisione in caste della popolazione, anche se non ci è
noto quanto rigida. Il loro tratto peculiare, che più accende gli studiosi, è il
ricco patrimonio di simboli, più o meno astratti, che si possono trovare sia
incisi su pietra, sia su vasellame e gioielli. Dalla loro prima scoperta, nel
lontano 1927, il mondo archeologico si divise tra coloro che la ritenevano una
prima e rudimentale forma di scrittura, e chi invece la considerava
semplicemente una modalità di rappresentazione puramente artistica. Al giorno
d'oggi, la stragrande maggioranza degli esperti è più propenso a ritenere si
tratti di pittogrammi dall'intento religioso, astronomico e apotropaico,
piuttosto che una forma di alfabeto vera e propria. E' altresì probabile che la
nascita della scrittura in Magellania nelle culture immediatamente successive si
sia ispirata proprio a tali raffigurazioni.
Nel frattempo, a nord, al principio del primo millennio avanti Cristo (1900 –
1800 a.C. circa), fa la sua prima comparsa la cultura di Lumpaɣ, con ogni
probabilità la progenitrice di tutti i successivi regni e culture
nord-occidentali del continente. Essa è chiaramente austronesiana, come si
evince dalla genetica (presenza dell'aplogruppo O1), ma anche quella che ci ha
lasciato misteriosi templi di forma piramidale, molto simili alle costruzioni
delle civiltà mesoamericane. Come nel caso dei Maya, è altrettanto probabile che
fungessero sia da osservatori astronomici, sia da altari per sacrifici (anche se
i resti umani trovati nei pressi sono tutti ordinati e composti, oltre che
accompagnati da un corredo, motivo per cui pare poco probabile che fossero
vittime, quanto piuttosto fedeli abbienti che volevano essere inumati vicino al
proprio dio). La cultura di Lumpaɣ viene spesso, per quanto mai direttamente
(tanto da far parere a diversi paleoantropologi che si tratti di un tabù),
nominata nel legendarium dei regni dell'età del ferro del nord-ovest, come i
Babal o i Layam. Essi, nelle loro cronache mitologiche, narrano di un tempo
antico, in cui giunse, dal profondo delle acque del mare, la gente della grande
isola. Il loro sovrano si faceva chiamare, a quanto sembra, “Colui che corre
incontro al sole”, cosa che lascia supporre uno spostamento di tale popolo da
ovest verso est. Quale sia tuttavia questa “grande isola”, è difficile da
stabilire. Per ragioni di prossimità, il candidato più probabile è l'isola di
Mindanao. Che i Lumpaɣ fossero abili navigatori è assolutamente possibile, per
quanto resti il fatto che la distanza in mare aperto tra Mindanao e la punta
occidentale della Magellania sia discreta. Tale ipotesi, tuttavia, non convince
tutti fino in fondo. Altra ipotesi, meno accreditata, ma comunque non priva di
argomentazioni a favore (come il fatto che, nelle tavole di legno laccato
lasciateci dalla mitologia Layam, sia presente anche la leggenda secondo cui la
luna all'inizio fosse un secondo sole, presente ancora oggi tra il popolo
taiwanese dei Bunun), è che il punto di origine dei Lumpaɣ sia l'isola di
Taiwan.
Essi non sarebbero stati, però, gli unici popoli austronesiani accasatisi sulle
sponde occidentali della Magellania. Un'ulteriore, per quanto di minore portata
demografica, 'invasione', questa volta dell'estremo sud, giunse tra il 1200 e il
1000 avanti Cristo, mettendo in seria difficoltà gli esponenti della cultura
austroasiatica di Brih. Si può affermare che essi appartengano già al ceppo
etnolinguistico detto Malao-Magellanico, che tanta fortuna politica avrà in
seguito. Quest'ultima cultura, detta di Qaqaqe, è assolutamente peculiare perché
è la prima in cui vediamo un notevole (poi diffuso a macchia d'olio in tutto il
continente) uso dei metalli. Inizialmente rame, molto presto le capacità di
creare forni in grado di erogare calore intorno ai 1500 c° portarono al
massiccio utilizzo del metallo più abbondante della regione, ossia il nichel, da
solo o in lega con il rame stesso (cupronichel). Sicuramente si trattò,
perlomeno inizialmente, di un caso, ma questo metallo era perfetto per il clima
caldo umido della regione, in quanto particolarmente resistente all'ossidazione,
alla corrosione e all'erosione. Questa invenzione, molto probabilmente, diede
alla cultura di Qaqaqe un vantaggio decisivo sui propri vicini e nemici, tanto
che, con ogni verosimiglianza, essa impose una sorta di egemonia regionale, di
cui abbiamo prove da pittogrammi incisi nelle pietre ritrovate nei loro siti,
indicanti offerte di tributi da parte di popoli confinanti (interessante notare
come gli stilemi di questo genere di rappresentazione siano sorprendentemente
simili in tutte le civiltà del mondo).
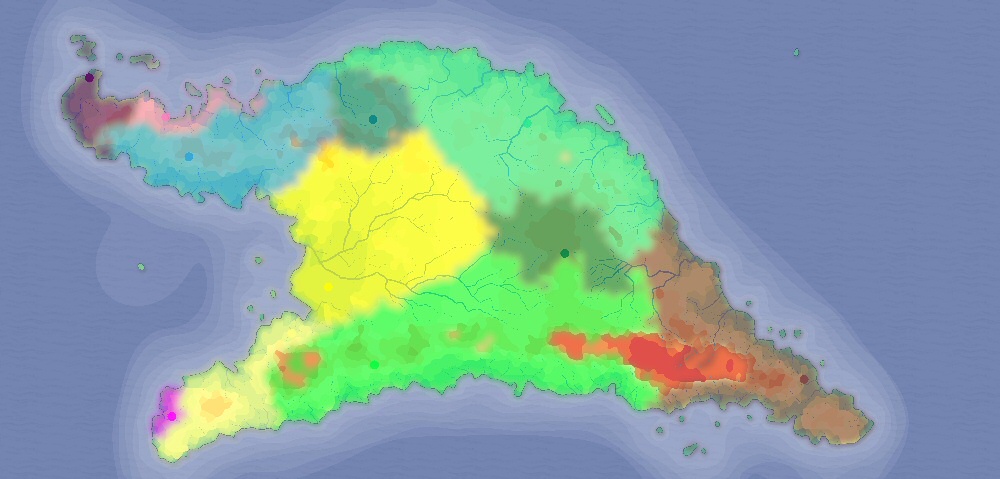
La cartina soprastante mostra l’approssimativo areale delle varie culture del continente, come ricostruito da archeologi e paleoantropologi. In particolare: in marrone le popolazioni derivate dalla cultura Tululešana, nelle diverse tonalità di verde le aree aborigene (eredi della cultura di Goh e di Lat – in verde brillante al sud); in giallo pallido la cultura di Brih, in giallo la cultura di Kaemh, in rosa la cultura di Lumpaɣ, in lilla la cultura di Qaqaqe, in viola scuro al nord, le popolazioni dell’arcipelago Nanpō. In azzurro il supposto areale di una cultura ancora non identificata, di cui abbiamo solo vaghe indicazioni a posteriori.
.
4 – La nascita della scrittura e l'età dei metalli
4.1 La penisola nord-occidentale, tra invasori, conquistatori e fuggitivi
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, la prima forma di scrittura pervenutaci del continente risale al 900 avanti cristo circa, la cosiddetta Pietra di Amuä, rinvenuta nell'estremità occidentale della penisola di nord-ovest. Si tratta di un alfabeto ideografico che ricorda vagamente i pittogrammi della cultura di Qaqaqe. Per gli storici e per gli archeologi non è stato semplice spiegarsi come due reperti tanto distanti possano essere così simili. L'ipotesi oggi universalmente riconosciuta è anche la più semplice (poiché non implica né drastici spostamenti di popolazioni, né improbabili proto-imperi continentali), vale a dire l'esistenza di logogrammi, a noi non noti, più arcaici, discendenti diretti dai pittogrammi meridionali, la cui nascita è da collocarsi presumibilmente presso il delta del fiume Kemh. Da lì, il sistema si sarebbe espanso (seguendo le vie commerciali carovaniere o marittime) nel giro di un paio di secoli, con una serie di varianti locali lungo tutta la costa occidentale del continente, fino alle isole Nanpō.
Ben minore accordo tra gli studiosi si può trovare su una interpretazione corretta del significato. Sebbene l'aspetto generico dei simboli utilizzati sia chiaramente riconducibile a scritture a noi note successive, non esistono prove certe di 'discendenza diretta'. Ad oggi, il più largo consenso si trova nel considerare i simboli situati in basso come una indicazione temporale, se non una vera e propria data. Per quanto riguarda il testo vero e proprio, molti sostengono si tratti della glorificazione delle gesta di un sovrano locale, mentre altri credono di individuare le caratteristiche di una stele funeraria (con tanto di maledizioni nei confronti di eventuali, incauti, profanatori).
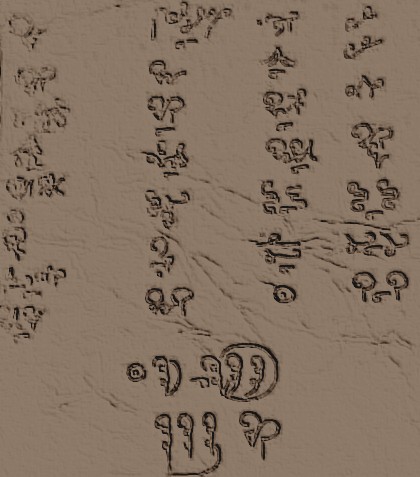
La 'Pietra di Amuä'
Chi fu l'autore? A quale cultura apparteneva? Ad oggi, queste domande ancora non trovano una risposta soddisfacente: nessuna tomba, abitazione, tempio o palazzo è mai stato rinvenuto nelle immediate vicinanze della scoperta. Ancor più misterioso e senza apparente spiegazione è il 'salto' di quasi due secoli tra la pietra e le fonti scritte immediatamente posteriori.
In compenso, dal VIII secolo a.C, nella penisola nord-occidentale c'è una vera e propria 'esplosione' di documenti. I due principali supporti scrittori utilizzati furono tavolette di argilla essiccata da una parte e lamine di varie leghe metalliche dall'altra. E' interessante notare che, proprio a partire dalla scelta del materiale, emerge sin da questo periodo una caratteristica tipica di molte culture dell'area, ovverosia l'utilizzo di lingue differenti a seconda del contesto (e, in seguito, anche della casta).
In particolare, questa caratteristica si può vedere presso il regno di Layam, primo aggregato politico di cui conosciamo la storia, pur per sommi capi.
Le piastre di rame o nichel incise avevano un ruolo 'ufficiale': servivano per raccontare le gesta dei sovrani, fissare le leggi, stipulare trattati o comunicare con le divinità. L'argilla era invece dedicata agli accordi tra privati, spesso di natura commerciale (e in qualche caso anche militare). Non è difficile pensare che fosse prassi per ogni individuo di ceto elevato imparare la 'lingua della terra' da giovane e solo una volta raggiunta la maturità, o cariche particolarmente elevate in ambito politico o sacerdotale, apprendere la 'lingua del metallo'. Se la prima è chiaramente austronesiana, così non si può dire della seconda, che tradisce un'origine diversa (probabilmente più antica), che, oltretutto, permane anche nel nome delle località. Del resto, che una lingua arcaica sia utilizzata in ambito religioso è un tratto comune anche delle civiltà mesopotamiche, in cui il sumero continuò ad essere usato dai sacerdoti per lungo tempo, anche quando la popolazione usava ormai prevalentemente lingue semitiche. Più strano è pensare che la lingua religiosa, arcaica, fosse utilizzata per la narrazione celebrativa (che comunque avrebbe dovuto avere tra i suoi scopi anche l'essere compresa da un numero molto ampio di persone) e per l'ambito più strettamente politico. Stando alle lamine di Suliŋ, che ne raccontano l'origine semi-mitica, il Layam sarebbe nato dallo stanziamento di una casta politica militare proveniente dalla costa settentrionale, sicuramente colonizzata da popolazioni proto – austronesiane, presso l'interno montuoso, in cui era già presente una civiltà urbana di grande vitalità. Se dobbiamo prestare credito alla leggenda, l'eroe fondatore non si è posto come 'conquistatore' della civiltà preesistente, ma come suo protettore da un nemico esterno, i cosiddetti 'demoni della foresta' (su cui torneremo).
Ecco il passaggio più saliente:
'Re Culukes giunse dal nord, dalle coste del grande mare, con dodici suoi seguaci, e giunse al grande massiccio, ai cui piedi dimorava il popolo delle alte colline. Re Culukes cercava aiuto, poiché le sue terre erano state devastate dalle incursioni dei demoni della foresta, che tutto distruggevano e che mai facevano prigionieri. […] Quando tuttavia, dopo molte fatiche e privazioni, giunse infine nella bianca Keñjatutu, sulla sommità del monte, egli scoprì che il popolo di Melnelak, arrogante e superbo, non teneva in nessun conto ciò che accadeva nel resto del mondo. [...] 'La nostra città è una roccaforte inespugnabile. Ha subito molti assedi e mai una volta è caduta. Perché dovremmo preoccuparci ora? Chi sono questi demoni di cui tu dici? Non li abbiamo mai visti e, se anche esistessero, noi certo non li temiamo.' A Culukes queste parvero parole avventate e che tenevano in nessun conto le bizze degli dei, nemmeno di Pa-ruteq il grande, che, con i suoi venti, soffia sul mare tanto forte da affondare le isole. Che cosa erano per lui le difese di una misera città di uomini? [...] Infine, giunse il tempo della punizione, come Culukes aveva previsto e da nessuno ascoltato. I demoni infine arrivarono e Pa-ruteq giocò il suo tiro ai Melnekak, abbattendo le difese di Keñjatutu. Il loro signore, Kititu, fuggì, ma, troppo carico di ricchezze, cadde da un dirupo e si spezzò l'osso del collo. Senza una guida, essi si affidarono a Culukes e ai suoi dodici fidi, nonostante per loro non fossero che degli stranieri portatori di sventura. Egli abbassò umilmente il capo e mostrò il dovuto rispetto e omaggio a Pa-ruteq il grande, che soddisfatto, si placò. […] I demoni, senza più il favore del dio, furono presto in balia di Culukes, che li sconfisse e li cacciò dai monti. I Melnelak gli giurarono totale obbedienza e anche molti del suo popolo, dal nord, presso le coste del grande mare, accorsero al suo cospetto. Una volta stabilita la pace egli ribattezzò la bianca città, chiamandola Qanay e ne fece la sua gloriosa dimora per sempre.'
Ad oggi non conosciamo con certezza la dimensione di questo regno, anche se le stime di un secolo fa sono state drasticamente riviste al ribasso, escludendo dal suo dominio diretto gli insediamenti costieri (per quanto alcuni di essi fossero senza dubbio nella sua sfera di influenza). Tale considerazione deriva da ciò che si evince indirettamente dalla Tavola di Bujiŋgimur, risalente al 630 a.C. Circa, in cui si dice:
'Al tempo nostro, nel sesto anno di regno del re Dukes, grande rovina si abbatté sulla città di Tapoqon, sulla costa del grande mare a nord. Il signore di Tororo reclutò un grande numero di guerrieri provenienti dalle mille isole. Egli infatti era invidioso del singore di Tapoqon, i cui forzieri erano pieni di molti preziosi beni, che gli derivavano dal commercio con le mille isole. Queste ultime erano in grande fermento, poiché grandi scontri erano in corso tra i loro signori e tra essi e alcuni selvaggi pirati del nord. Per questo motivo vi era un gran numero di uomini avvezzi alle armi tra loro, pronti a cedere i propri servigi in cambio di nuove terre in cui dimorare. Il sovrano di Tororo largheggiò in promesse con loro, per essere sicuro di averli dalla propria parte. Vistosi in pericolo, il sovrano di Tapoqon chiese aiuto al prode nostro re Dukes, in nome di un antico patto di difesa e sottomissione. Certo da Layam tale promessa non era stata dimenticata, per quanto, invece, poveri di memoria fossero lì come in altre città costiere, da cui nessun giuramento con noi era mai stato mantenuto sin dal tempo di Culukes il grande. Per tal motivo li lasciammo al loro destino, come era giusto che fosse.'
Da questo testo si deduce, al di là di altre considerazioni sulla situazione geopolitica della regione, una pretesa di controllo del regno di Layam sulle rotte commerciali della costa settentrionale della penisola che, in circa un secolo, non si era tuttavia mai veramente concretizzato. Vi erano sicuramente molte città stato, più o meno ricche, con diversi gradi di dipendenza, ma di certo non un dominio diretto. Forse fu proprio il fallimento di questo progetto a decretare il declino di una civiltà che, per quanto raffinata, finì per rinchiudersi in se stessa, sino a scomparire dalle cartine politiche entro la metà del VI secolo a.C.
Essi lasciarono tuttavia delle eredità molto importanti a tutti coloro che verranno dopo di loro.
Innanzitutto dal punto di vista religioso: il panteon layamita fece scuola, così come i numerosi templi costruiti sulle cime dei monti. Tutta la regione del nord-ovest fu accomunata dalla venerazione della diade Pa-ruteq e Pa-yanaq. Inizialmente il primo era 'semplicemente' il dio del vento, mentre la seconda era la dea della montagna. Ben presto, però, le altre divinità passarono in secondo piano, mentre il campo di azione dei due si espandeva, fino a far del primo il dio di tutto ciò che era movimento e cambiamento, mentre la seconda di tutto ciò che era quiete e stasi. In questo orizzonte, come si può vedere da certe rappresentazioni artistiche scolpite nella roccia, anche il carattere della diade subì importanti mutamenti. Se infatti inizialmente Pa-Ruteq aveva delle caratteristiche che lo qualificherebbero come un dio malvagio, Pa – Yanaq era, al contrario, una dea esclusivamente benevola. Man mano, lentamente, sia il primo, sia la seconda, acquisirono dei tratti più ambigui e sfumati, in quanto era necessaria l'azione di entrambe le forze divine per poter permettere all'essere umano la vita sulla terra. La lotta costante tra i due passò dall'essere un combattimento violento, di cui l'uomo finiva per essere vittima inconsapevole, all'essere una sorta di corteggiamento amoroso, in cui il ruolo dell'uomo era di mediatore tra le parti, allo scopo di preservare il delicato equilibrio tra la stasi e il mutamento.
Questa visione essenzialmente dualistica (che non per niente raggiungeva la sua apoteosi tra luglio e agosto: in quel periodo le stelle più luminose del cielo notturno, ossia Majaq - la nostra Altair - che rappresentava Pa-Ruteq, si incontrava con Ta-nalaŋ, ovvero Vega, che simboleggiava Pa-Yanaq. Le due formano con Tamis, cioè Deneb - che rappresentava il genere umano - un asterismo estivo di particolare visibilità) influenzerà in modo molto forte le future scuole di pensiero che sorgeranno nel continente e darà un'impronta particolare anche a tutte le religioni e filosofie 'd'importazione', come buddhismo, islam e cristianesimo.
La seconda grande eredità lasciata dai Layam è rappresentata da un'idea 'imperiale' di dominio. In un panorama politico composto essenzialmente da città-stato, essi si configurarono come il primo, riuscito, esempio di sovranità su molte città e su popoli differenti, dando un orizzonte molto più ampio all'idea di stato.
Poco a ovest, tra l'VIII e il principio del V secolo, si sviluppò invece il popolo Babal. Di essi non possediamo fonti scritte dirette, ma solo numerose citazioni da parte delle potenze confinanti (inclusi i Layam), oltre a tre diverse necropoli in cui sono stati trovati manufatti e gioielli di fattura straordinaria. Anche la loro lingua doveva essere di tipo proto-austronesiano, se interpretiamo bene le fonti. Essi, a quanto pare, non formarono mai un regno unitario, quanto piuttosto una confederazione di città o tribù piuttosto labile e, spesso, in lotta tra loro. La caratteristica peculiare che spicca presso tutti i vicini è la loro aggressività. Secondo la campana istoriata di Tianda, del 690 a.C.,
'Gli strani Babal sono su di noi in ogni momento. Cavalieri un giorno e navigatori il giorno dopo. Essi non sanno che litigare tra di loro, ma quando uniscono le forze, guardati da loro! Fai risuonare questa campana, affinché avvisi la nostra gente del loro arrivo. Poiché per terra, fiume o mare, dovrai essere celere per contrastarli.'
Ancora più esplicita è, dello stesso periodo, la lamina di Guteqwaq:
'Il grande sovrano Ma-Cenaw stipula con Semay un'eterna alleanza. Con essa i Babal di Tajay, empi adoratori di spiriti maligni e dediti unicamente all'ubriachezza e al saccheggio delle nostre dimore, verranno infine scacciati dalle nostre risaie.'
Sempre nella Tavola di Bujiŋgimur, viene data una descrizione dei Babal in un periodo più tardo:
'Essi [i Babal], sono degli ottimi guerrieri, per quanto pessimi comandanti. Mai nella loro storia, la dea ha vinto sul loro animo. Ciò per noi Layam fu un male ed un bene ad un tempo. Fu un male poiché, mai domi, mai sazi, sempre cercarono di invaderci, con quelle loro frecce che scoccano sui loro veloci cavalli indemoniati. Fu un bene perché mai riuscirono ad unirsi tra loro, ed anzi, finirono per diventare soldati di molte diverse città, finendo per combattere la loro stessa stirpe in ossequio ai padroni del momento. La benedizione di Pa-Ruteq era su di loro, ma è stata anche la loro rovina. Ora però invece di case di legno e tende costruiscono come noi mura di pietra. Dicono che vogliono darsi un re come i Layam. Facciano pure, poiché ormai il loro modo di combattere è noto a tutti i loro nemici. Se desiderano voltare le spalle a Pa-Ruteq per rivolgersi d'un tratto completamente a Pa-Yanaq, tutti i popoli che hanno maltrattato sino a questo momento piomberanno su di loro come avvoltoi famelici per vendicarsi. Oppure nuove genti benedette da Pa-Ruteq spunteranno dal nord o dall'occidente, dove il sole termina la sua corsa, per prendere il loro posto. Per sfuggire a questo destino, molti hanno smesso di dimorare presso le loro terre per venire ad abitare tra noi e, invero, vi sono alcune città abitate quasi più da Babal che da Layam.'
Stando a queste e ad altre fonti, i Babal possedevano con ogni probabilità armi di metalli particolarmente duri e resistenti, come il ferro e, soprattutto, svilupparono la tecnica della monta al cavallo, specializzandosi nel combattere tirando con l'arco in movimento. Eppure anche loro entrarono in decadenza tra il 600 ed il 500 a.C, al pari dei Layam, sia per via delle divisioni interne, sia per cause esterne, come nuovi nemici, più aggressivi e combattivi, proprio nel momento in cui essi si stavano facendo assimilare dai costumi sedentari delle città stato limitrofe.
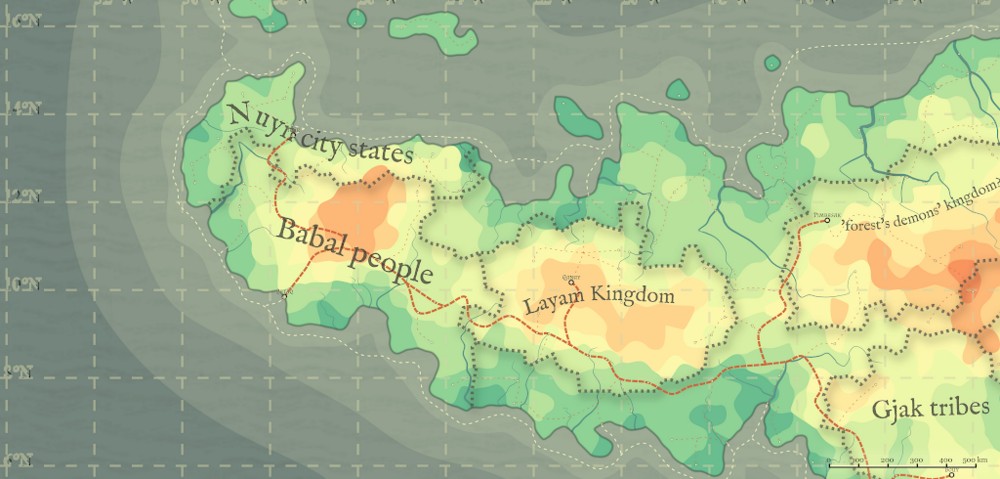
Come si sarà potuto dedurre, anche dalle diverse fonti citate precedentemente, la situazione culturale e politica della penisola non fu mai caratterizzata da particolare stabilità. Anche in tempi successivi essa sarà infatti la 'porta' attraverso la quale diverse genti, usi, costumi e religioni penetreranno nel continente. L'arcipelago delle Nanpō non smise infatti, anche dopo il paleolitico, di fungere da ponte da e verso le isole giapponesi, con tutte le conseguenze del caso. Tra il XII e il VI secolo avanti Cristo, sorse, nelle isole più meridionali e sulla punta del continente, una complessa rete di città-stato, intensamente interconnesse da una rete commerciale prevalentemente navale; molto spesso questa cultura, detta di Nuyn, viene definita, per quanto impropriamente, come i 'micenei dell'estremo oriente'. Senza dubbio, con la controparte europea condividono alcune caratteristiche, come la costruzione di città con poderose cinte murarie in luoghi sopraelevati (che lasciano intuire una intensa attività bellica) e, allo stesso tempo, porti sulla costa per gli scambi marittimi, elaborati templi e numerose leggende, alcune delle quali, ancor oggi, sono al centro di infuocate controversie alimentate dal nazionalismo degli stati contemporanei.
Le città stato di Nuyn, perlomeno nella loro fase più antica, non parlavano un idioma facilmente attribuibile ad un ceppo noto. Fino agli anni '20 del XX secolo nessuno osava mettere in discussione la loro classificazione all'interno della famiglia malao-magellanica, proposta da Von Humboldt nel primo ottocento. Nuovi studi (e nuovi reperti) portarono però in auge la teoria che si trattasse di un linguaggio isolato. Nel 1933, Mashiho Chiri, principale studioso giapponese di lingua Ainu, asserì che la lingua di Nuyn fosse in realtà stretta parente con quella, appunto, degli Ainu. Tale ipotesi ebbe scarsa fortuna, poiché molti studiosi, specialmente anglosassoni, le fecero pessima accoglienza, in quanto considerata un mero tentativo di giustificare le mire espansionistiche giapponesi sul continente magellanico. L'idea di Chiri tornò in auge negli anni '50, fino a che Isidore Dyen non sostenne che anche la parentela tra Nuyn e Ainu era, in realtà, nient'altro che una serie di prestiti linguistici. Questa tesi a sua volta, venne (e viene tuttora) rigettata decisamente dai linguisti giapponesi, poiché presuppone la necessità di riscrivere la pre e protostoria del paese del sol levante. Sebbene Dyen non specificasse in che modalità era avvenuto il contatto tra i Nuyn e i proto – Ainu, lasciava implicitamente capire che i primi avessero esercitato la propria influenza culturale e forse politica sui secondi, almeno sino alla venuta degli Yayoi dalla Corea. Inoltre, lo stesso autore insinuava anche che alcuni lemmi (segnatamente toponimi) della lingua giapponese di supposta origine Ainu (relitto della cultura Jomon), fossero invece di derivazione Nuyn, addirittura senza un passaggio intermedio. Ciò implicava che gli Yayoi avessero avuto modo di entrare in contatto diretto con il popolo magellanico. Robert Blust, negli anni novanta, produsse studi tesi a rafforzare questa teoria, oltre che a documentare l'influenza che gli antichi Nuyn potrebbero aver avuto sulla cultura nipponica delle origini. Gli studiosi giapponesi tendono invece solitamente ad affermare l'esatto opposto, ossia che la 'fuga' degli jomon di fronte all'avanzata Yayoi si sia svolta non solo verso nord (Hokkaido), ma anche verso sud (isole Nanpō) e che, a un certo imprecisato punto e momento della storia, questa fuga abbia spinto prima i residui jomon, poi gli stessi yayoi a contatto con le genti Nuyn.
Fa eccezione la recente ipotesi di Hideo Inoue, la quale sostiene che il quadro è in realtà molto più complesso di quel che appare. Secondo la sua teoria, le isole Nanpō, in realtà, per la loro posizione strategica, erano il cuore di uno sprachbund; la 'vera' lingua Nuyn delle origini, qualunque ne sia la filogenesi (che personalmente suggerisce essere addirittura pre-proto-altaica) fu irrimediabilmente trasformata in periodo protostorico e storico dal continuo contatto con le parlate austronesiane (sia peninsulari, sia insulari), la lingua delle popolazioni di ascendenza Jomon e – di tutte la più recente – la lingua della cultura Yayoi. Questo sprachbund, che avrebbe fatto del Nuyn recente una vera e propria lingua franca, sarebbe stato esteso, come minimo, dalla baia di Tokyo al capo Bgö, sulla costa nord-occidentale del continente magellanico.
Indipendentemente da tale
idea, certo da un punto di vista culturale la rete di città – stato Nuyn lasciò
la propria indelebile impronta su un'area incredibilmente vasta, oltre a
consegnarci il più celebre componimento epico di tutta la storia antica del
continente magellanico. Anche in questo caso, il paragone con l'omerica Iliade
sorge spontaneo, anche perché, al pari di quanto accade in occidente, i quesiti
sull'identità dell'autore e sulla corretta identificazione dei luoghi sono
tuttora aperti (e spesso danno origine a teorie quantomeno fantasiose). Allo
stesso tempo, però, è anche un paragone altamente improprio, poiché il contenuto
teologico e filosofico della sua parte conclusiva, nato da un ulteriore
approfondimento della diade divina dei Layam, ne farà la base per i successivi
testi sacri di molte religioni magellaniche.
Tale opera, il Canto di Ayona, narra della fuga verso una nuova dimora della
regina della città di 'Toruin', – Ayona, appunto – posta su 'un'isola lontana a
settentrione'.
"Per aver quiete ella dovrà muovere il mondo. Per aver pace, dovrà cercare il conflitto. Per aver vita, ella dovrà dare la morte. Mai le vie di Tyuka e le vie di Ratuyna si conciliano, eppure sempre le è chiesto di scegliere tra di esse. E ogni scelta è rovina e benedizione insieme."
L'autore, pur senza dirci il proprio nome, si da' una definizione, con cui sarà noto per i secoli a venire: egli infatti ama farsi chiamare 'lo strabico'.
"Per cantare le imprese della nobile regina, mi feci strabico. Un uomo dalla sana vista vede infatti tutto intero e tutto mischiato. Invece il mio occhio destro vede il mondo di Tyuka e il mio occhio sinistro vede il mondo di Ratuyna. Di ogni passo della grande Ayona potei così conoscere la direzione, con una chiarezza che non è mai bene abbiano gli uomini."
L'opera è tradizionalmente divisa in due parti principali. La prima è la fuga vera e propria di Ayona dalla sua città natale, verso sud, in cui incontra genti, sia amichevoli, sia ostili e mostri che impediscono il suo viaggio se non dopo essere stati sconfitti o che sottopongono l'eroina ad un qualche tipo di prova per poter procedere oltre. La seconda parte, che solitamente è quella che attrae maggiormente l'interesse per la maggior ricchezza di spunti politici, filosofici e socio-culturali, narra invece del 'ritorno'. Ayona, divenuta una regina ricca e potente sulla cosiddetta 'ultima isola prima della grande terra', dopo averne scacciato gli arroganti sovrani, decide, contro ogni parere della sua corte, di tornare a nord per riconquistare Toruin.
"In principio ero tutta di Tyuka. Ma per giungere sino a qui e divenire nuovamente regina, da fuggiasca che ero, ho dovuto donare il mio cuore a Ratuyna. Ed egli è un amante esigente. Non tollera che ottenuto ciò che desideravo, gli abbia voltato le spalle e sia tornata devota alla sola Tyuka. Il suo spirito mi sussurra ogni notte. Oh, miei fidi, non lo sentite come si lamenta nel soffio del vento e nello sciabordio delle onde?"
Durante il ritorno, scoprirà che coloro che aveva scacciato, appresa l'umiltà e la saggezza, si erano diretti a nord e avevano già eliminato e soppiantato gli usurpatori che avevano esiliato Ayona da Toruin. Inoltre, viene a conoscenza del fatto che la sua stirpe stessa aveva conquistato Toruin con la forza, (e persino rinominato: Gente mia, che Toruin chiamasti quella che Toy Nuy era per chi divorasti ) massacrandone i precedenti abitanti.
Sentita svuotatasi del suo compito, ella lancia un'invettiva contro la diade divina, che spinge gli uomini a inseguire allo stesso tempo due ideali inconciliabili, conducendoli solo alla propria inevitabile distruzione. Questa cornice fa da sfondo alla summenzionata parte finale dell'opera, che analizza in maniera radicale la condizione umana e il suo rapporto con la divinità:
"Ayona la
grande più nulla sentiva di avere. Colei che più aveva amato Tyuka tra tutti gli
uomini e colei che più aveva amato Ratuyna tra tutti gli uomini, né dall'una, né
dall'altro era sostenuta, come nessuno degli uomini prima di lei.
Ma ecco che una voce giunse dalla terra e un'altra, in pari tempo, dalle
profondità del mare.
'Un giudice all'uomo serve', dissero all'unisono.
'Senza il movimento, non ci può essere quiete cui valga la pena tornare.'
'Senza la quiete, non c'è movimento che valga la pena affrontare.'
'Un giudice all'uomo serve', dissero di nuovo, insieme.
'Serve un terzo', dissero ancora una volta.
'A te noi chiediamo.
Signora degli uomini , da cui prima d'ora mai siamo stati amati tanto, a te noi
chiediamo. Chiediamo un consolatore per l'uomo, giacché amare noi, Tyuka e
Ratuyna, insieme e ad un tempo, è per lui necessario, eppure egli non può.
Quando ama Tyuka non ama Ratuyna e viceversa.
Noi non comprendiamo come ciò sia possibile. A te perciò noi chiediamo', essi
domandarono ad Ayona.
La gran regina dunque rispose: 'Miei nobili signori di tutto quanto è, voi
chiedete che l'uomo accetti che ciò che ha creato sia necessario venga
distrutto, prima o poi.
Voi chiedete che l'uomo accetti che per creare sia necessario distruggere,
correndo il rischio di essere distrutto a sua volta. Ciò conduce l'uomo che
prende sul serio i vostri comandamenti alla follia.
Egli o più nulla farebbe, scontentando il nobile Ratuyna, o tutto distruggerebbe
al proprio passaggio, scontentando la nobile Tyuka.
Due vie nei miei viaggi ho veduto, per evitare la perdita del senno, e ora
finalmente le comprendo.
La via del lontano settentrione è la via del distacco: se l'uomo non ama troppo
ciò che è frutto dei suoi sforzi, tanto meno ne soffrirà quando essi vani si
mostreranno.
La via del profondo meridione è la via dell'attaccamento: se l'uomo ama
profondamente ciò che è frutto dei suoi sforzi, tanto più saprà che nessuno di
essi è mai veramente vano.
Ogni uomo scelga la via che più gli si addice.'
Dopo aver molto ponderato in silenzio, le voci di Tyuka e Ratuyna, così
solennemente decretarono:
'Un terzo serve, all'uomo, per scegliere.
Un terzo serve all'uomo per essere consolato nel suo giudizio.
Un terzo serve all'uomo, per non perdersi nel rammarico che il giudizio reca.
Grande regina tra gli uomini più non sarai, Ayona.
Tu sarai gioiello risplendente tra gli astri.
Tu sarai tra noi equidistante.
Tu sarai spirito guida per l'uomo, affinché non perda il senno. Tutti coloro che
vedranno una sorte benigna calare su di loro, te ringrazieranno, perché sapranno
che li hai guidati verso giuste scelte.
Una perla rara e preziosa sarà il tuo simbolo. Sarai con noi tra le stelle e il
tuo nome sarà Tamah.'"
.
4.2 Il vasto entroterra continentale e il delta del Kaemh: il cuore culturale e politico del continente
Se la penisola
nord-occidentale ha rappresentato un motore di sperimentazione politica,
culturale, religiosa ed economica, come del resto era normale che fosse, vista
la sua apertura al mondo esterno, le 'grandi civiltà' ancora oggi,
nell'immaginario collettivo, sono quelle del centro semi-arido del continente.
Per certi aspetti, tale deformazione prospettica si deriva dalla volontà, anche
un po' autocelebrativa, di equiparare lo splendore delle antiche città e imperi
sorti sulle rive dei grandi fiumi che attraversano la Magellania, a quelli più
familiari al pubblico occidentale, ovverosia l'Antico Egitto e le culture
mesopotamiche.
Pur tuttavia, se dal punto di
vista degli introiti turistici tale trovata può avere un qualche appeal, certo
non ne evidenzia le caratteristiche originali da un punto di vista strettamente
storico, artistico e culturale, rendendo anzi loro un pessimo servizio. Inoltre,
il paragone sarebbe inesatto anche da un punto di vista di coordinate temporali.
Delle civiltà locali coeve a quella del nuovo regno egizio o del primo impero
babilonese (le summenzionate culture di Brih e Kaemh) è infatti oggettivamente
rimasto relativamente poco in proporzione, sia da un punto di vista monumentale,
sia da un punto di vista più propriamente storico (dato che le fonti rimasteci
sotto forma di pittogrammi sono ancor oggi intraducibili, perlomeno fino a che
non verrà ritrovata una qualche 'stele di rosetta' che ci consenta di penetrarne
il significato); motivo per il quale è più gratificante per l'orgoglio nazionale
degli stati magellanici interessati confrontare una civiltà del XV secolo avanti
Cristo, con una di molti secoli più tarda.
Sotto la definizione di 'imperi del Kaemh' rientrano quattro popoli che nel
periodo tra l'VIII e il V secolo a.C. Diedero vita a civiltà urbane lungo le
rive del fiume che nella letteratura antica porta il nome, appunto, di Kaemh
(che con i suoi 3024 Km è il fiume più lungo della Magellania) e dei suoi
affluenti, alternativamente contraddistinte da una fase imperiale dalla durata
più o meno lunga.

I primi, e in ordine di tempo
i più antichi, sono le tribù austroasiatiche del delta, che nelle fonti si
definiscono semplicemente come 'genti del fiume'. Esse non costituirono mai un
regno unitario, per quanto la città di Bǝkah, situata alla confluenza tra Kaemh
e Gjeh, abbia acquisito, tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, una sorta di
egemonia regionale, prima di diventare preda delle ambizioni di conquista dei
regni circostanti.
Gli scavi dei templi di Bǝkah, iniziati al principio del XX secolo, hanno
portato alla luce numerosi reperti che hanno permesso di gettare luce su questa
affascinante civiltà.
Il loro pantheon era affollato di divinità antropomorfe, la più importante delle
quali era Pakuǝm, dea celeste e terrestre ad un tempo, in quanto sovrana sia
della fertilità, sia della pioggia. Uno dei suoi principali attributi era
infatti quello di 'domatrice delle acque'. Da alcune iscrizioni sappiamo che era
alternativamente (o forse allo stesso tempo, come non è raro vedere per esempio
nelle divinità egizie) sorella o sposa di Kaemh, la divinità del fiume. Si
trattava di una moglie bizzosa, spesso vendicativa nei confronti del marito . I
periodi di siccità erano infatti dovuti, secondo il mito, a incomprensioni della
coppia. Anzi, addirittura Laem, il fondatore e primo re di Bǝkah, secondo il
mito era egli stesso una divinità, frutto dell'unione adulterina tra Kaemh e
Gjeh. Sebbene la regione del delta fosse più umida rispetto al resto del corso
del fiume, Il regime delle precipitazioni della parte centrale del continente è
pur sempre caratterizzato da una stagione secca, più o meno lunga e una,
solitamente più breve (ma spesso intensa), stagione delle piogge, pertanto era
necessario placare saltuariamente con offerte la 'gelosia di Pakuaem'. Da fonti
del IV-III secolo a.C. Ci è noto che la popolazione era divisa in caste. La
casta dominante era quella sacerdotale e i re, poiché di stirpe semidivina,
erano anche i primi amministratori del culto. Vi erano inoltre molti schiavi,
che, naturalmente, rappresentavano una sorta di status symbol per l'aristocrazia
dominante. Ben presto i clan più potenti non solo di Bǝkah, ma anche di altre
città, come Bǝlipahah e Bǝhiŋ si affrettarono ad attribuirsi genealogie
risalenti alle varie divinità, per giustificare la loro scalata al potere. Nel
550 a.C. Circa, all'epoca di massimo splendore di Bǝkah, possiamo intuire che il
sovrano ricoprisse un ruolo puramente religioso, con le grandi famiglie intente
a lottare tra loro.
Da quanto possiamo ipotizzare dai resti pervenutici, le tecniche d'irrigazione
dovevano essere piuttosto avanzate, conferendo alla regione un aspetto
verdeggiante. Ma fu proprio questa prosperità la causa della rovina. La Cronaca
degli antichi giorni di Rièt
(2), la principale fonte storica sul periodo (che
tuttavia mescola fatti reali con il mito, oltre ad essere risalente al III
secolo a.C.) riporta di popoli provenienti da settentrione che, attirati dalle
straordinarie ricchezze di Bǝkah, invasero e sottomisero le genti del delta,
ponendo fine per sempre alla loro importanza. Tuttavia, i dati archeologici non
danno alcun indizio di una fine violenta della città, tanto da indurre gli
studiosi a suggerire una versione alternativa, quella dell'abbandono graduale
del sito in favore di altri territori, posti più all'interno, in concomitanza
con fenomeni migratori. Le cause di tale abbandono possono essere state di
natura tecnica: i canali potrebbero essere stati nel tempo non sufficienti per
irrigare il sempre maggior numero di campi, creati per far fronte al rapido
incremento demografico.
Gli invasori provenienti da nord summenzionati sono invece gli austroasiatici
Pah, che egemonizzeranno il corso del Gjeh e in seguito il delta del Kaemh dal V
al III a.C. I primi segni di una civiltà agricola fluviale sono riscontrabili in
verità già dal 500 avanti Cristo circa, ma è un secolo dopo che questo popolo
guerriero acquisirà rapidamente fama e gloria, grazie all'opera di re Gulam di
Gjoeum.
Al tempo in cui i Rièt ancora non avevano ancora camminato verso occidente, Gulam della lontana Gjoeum marciò verso settentrione con i suoi carri sottomettendo i regni di Pah. Essi veneravano dei stranieri come Tjǝk e Rǝt, portati in quelle terre dai barbari Gjak dell'arida regione di Ghèet. Egli riportò la fede nel dio Gjeh tra i Pah e li unificò sotto il suo comando. I Pah giurarono a lui e ai suoi eredi per dieci generazioni assoluta fedeltà e divennero sua spada e suo scudo. Caedar, figlio di Gulam volse invece lo sguardo verso meridione e impose tributi ai figli di Pakuaem alle foci del grande Kaemh. Fu così che i figli di Pah crearono un regno come non se n'era mai visto prima. E da tutto il mondo giungevano frotte di uomini a Gjoeum, che ingrassava con i tributi e gli schiavi provenienti dai quattro angoli del mondo.
Arma vincente dell'espansione
dei Pah furono i carri da guerra, veloci e letali, che conferirono al loro
esercito un indubbio vantaggio sul nemico. Essi crearono, attraverso una rapida
espansione lungo gli assi fluviali, il primo regno esteso della regione. Da
quanto ci rivelano le (scarse) fonti che possediamo sul periodo, anche i sovrani
di Gjoeum avocavano a sé una stirpe divina. Non solo: sembra che le campagne di
conquista avessero un movente religioso; i Pah imponevano ai popoli conquistati
i propri dei come forma di assimilazione. Inutile dire che La cronaca degli
antichi giorni, quale fonte di un popolo concorrente, li dipinge, per tale
ragione, come dei tiranni crudeli, che reprimevano con violenza le frequenti
rivolte all'imposizione del proprio pantheon. Particolare rilevanza assume
l'utilizzo della forza contro 'gli adoratori di Tjǝk e Rǝt'. Non sappiamo se
effettivamente la citazione sia una attribuzione retroattiva oppure se veramente
tale culto iniziasse a diffondersi nel corso del V secolo a.C.; quel che è certo
è che esso altro non è che la variante locale della diade layamita, penetrata
attraverso le vie carovaniere anche all'interno del continente. Tale religione
dualistica supererà gradualmente le religioni politeistiche precedenti e
diventerà la principale religione autoctona della Magellania, motivo per il
quale la Questione delle origini è particolarmente dibattuta dalla comunità
degli studiosi ancor oggi. Esisteva già un canone di testi sacri preesistente a
quello più antico a noi noto (del II sec. a.C)? Quanto il sostrato di tradizioni
locali ha alterato, nel corso del tempo, il messaggio originale?
Fortemente legata a tale discorso è la diatriba su 'tempio del sole e della
luna', un complesso monumentale del 480 a.C. portato alla luce presso l'antica
Tǝhuǝl. Gli altorilievi e le iscrizioni di cui si è riuscito a interpretare il
significato mostrano come oggetto di devozione i due principali astri del cielo,
glorificandoli senza nominare altri dei. In più, gli attributi che vengono
conferiti sono ambiguamente vicini a quelli che di solito verranno
successivamente dati a Tjǝk e Rǝt. Nel 1980 A.H. Christie sostenne che si
trattava di una 'fase intermedia tra il politeismo tradizionale e la definitiva
affermazione della religione dualistica', suscitando non poche polemiche tra i
suoi sostenitori e chi affermava che le caratteristiche generiche delle due
divinità del tempio non sono prove sufficienti e incontrovertibili di una
qualsivoglia relazione con quella diade.

Ricostruzione virtuale del Tempio del Sole e della Luna
Anche dal punto di vista
linguistico i Pah lasciano domande. Ad oggi, infatti, non sappiamo di preciso
che lingua parlassero, per quanto ci doveva essere una certa parentela con altre
dello stesso areale. Questo perché le iscrizioni che abbiamo finora trovato sono
tutte in una variante della lingua e dell'alfabeto Huaek, vera e propria lingua
franca di un territorio estremamente vasto. Con ogni evidenza i Pah, nel loro
cammino di conquista verso sud, presto adottarono l'idioma più prestigioso per
la propria corte e i propri monumenti, relegando il vernacolo tradizionale ad un
ruolo di secondo piano. In altre parole, la conquista del delta del Kaemh diede
il via ad un lento ma inesorabile processo di assimilazione linguistica. Anzi,
si può dire che furono gli stessi Pah a contribuire alla diffusione di un
sostrato culturale comune per l'intero bacino idrografico del fiume Gjeh.
Il loro regno durò circa centocinquanta anni, prima di soccombere, per
differenti cause: la prima deve essere stata la summenzionata crisi religiosa,
che mise in difficoltà il ruolo sacro dei sovrani. In secondo luogo
l'onnipresente minaccia delle popolazioni seminomadi del nord che saltuariamente
venivano unificate da un capo carismatico in grado di infliggere seri danni con
le proprie scorrerie alle città e alle vie di comunicazione. Le città più
settentrionali si staccarono così dal regno per provvedere autonomamente alla
propria difesa; in particolare, l'indipendenza della città di Wenèet, presso
l'alto corso del Sǝlah privava del controllo sull'unica via carovaniera lungo
l'asse sud-nord (verso le città Rièt). In terzo luogo, la progressiva avanzata
verso ovest della potenza Rièt, popolo originario della confluenza tra i fiumi
Kaemh e Lǝm, tolse il dominio sul delta, divenuta la risaia del regno.
In ultimo, vi furono delle fratture interne: sappiamo che intorno al 280 a.C.
Circa, vi fu una lotta fratricida tra gli eredi al trono, che si risolse in una
spartizione tra Grèes e Gjoeum. La prima, tuttavia, era alla mercé delle tribù
nord-occidentali, con una diarchia in cui un capo 'barbaro' deteneva il vero
potere militare, mentre il sovrano legittimo assumeva un ruolo puramente
cerimoniale.
Nel frattempo, sorgeva, presso il medio corso del Kaemh, la civiltà Huaek, che
per secoli rimase culturalmente egemone nel cuore del continente. Prima della
fase imperiale Rièt, ovverosia tra il VI e il III secolo a.C. essa si
configurava come un conglomerato di città-stato in lotta tra loro: Kmbadaw,
Gǝhah, e Hayok, assieme alle meno potenti Tagjatam, Gjòot, e Cǝk.
La loro felice posizione lungo l'asse di transito carovaniero fluviale ovest-est
le rese una tappa imprescindibile dal punto di vista economico e commerciale. In
esse si concentravano le merci provenienti dal delta e dal regno Pah e quelle
provenienti dall'alto corso del Kaemh, dove sorgevano le città Rièt.
Nell'immaginario collettivo, gli Huaek sono un popolo di artisti, mercanti e
scienziati. E' Huaek, infatti, la prima attestazione di misure standard in
stagno, recanti un'incisione che ne determinava il preciso peso. Molto
probabilmente si tratta del primo passaggio da un'economia basata sul baratto ad
un'economia proto-monetaria. Sono inoltre loro, per testimonianza anche delle
culture successive, ad aver inventato il calendario usato in gran parte
dell'epoca antica nel centro della Magellania. Si tratta di un calendario
lunisolare, il che lo accomuna con molte civiltà dell'antichità, con dodici mesi
o, saltuariamente, tredici mesi (anni embolismici). Naturalmente, l'osservazione
degli astri diede vita ad un oroscopo e a delle costellazioni, di cui però ora
si hanno notizie frammentarie. Certo è che l'osservazione delle stelle aveva
anche e soprattutto un valore religioso. Di particolare rilievo la sacralità non
solamente del sole e della luna, ipotizzabili, ma anche della via lattea, che è
il 'Kaemh celeste', speculare al grande fiume terrestre e sua, per certi
aspetti, continuazione.
Ma la caratteristica fondamentale che ci è rimasta degli Huaek è la lingua e
l'alfabeto, che vennero utilizzati, come già detto, anche da altri popoli, come
strumento veicolare e, spesso, come lingua alta per secoli. L'alfabeto, di
natura logosillabica, venne usato, nonostante le continue evoluzioni, per più di
un millennio, prima di essere messo progressivamente da parte a partire dal VII-
VIII secolo d.C., quando i rapporti con il mondo esterno (l'impero Srivijaya)
portarono alla creazione di alfabeti abugida di derivazione brahmica. Per quanto
riguarda più strettamente la lingua, anch'essa ebbe notevole fortuna, tanto che
tuttora esistono le 'lingue huaek', da essa derivate (sebbene, con la futura
espansione delle lingue malao-magellaniche, il loro areale si sia gradualmente
ridotto). Ironia della sorte, le fonti propriamente storiche sui conflitti tra
queste cinque città-stato, sono scarse. Il più grande documento storico sono le
iscrizioni presso le tombe reali di Gǝhah, che trattano sommariamente delle
imprese dei sovrani, sempre e comunque in ottica celebrativa. Esse coprono un
centinaio di anni, dal V al IV secolo avanti Cristo. Ci documentano una civiltà
molto lontana dall'essere pacifica, ma allo stesso tempo ricca di vita. Eccone
uno stralcio, risalente al 420 a.C. circa:
Con una forza di molti uomini traversammo il fiume, assieme ai nostri sudditi, i signori di Gjòot, messi in retroguardia. Mostrammo alle tribù del sud la nostra potenza, ed essi ci temettero e ci offrirono molti tributi in segno di pace. Ma Suyak, malvagio capo dei Taw dell'est, tradì la parola data e sulla via del ritorno ci attaccò a tradimento. La retroguardia di Gjòot, cui avevamo affidato la nostra difesa, subì l'urto del nemico e codardamente si diede alla fuga. Ma i nostri mara, ben addestrati, rimasero fermi e saldi e i loro cavalieri passarono al contrattacco, falcidiando molti nemici. Ne catturammo molti e dello stesso Suyak avemmo la testa. Traversato il fiume e tornati nella terra di Huaek, presto corremmo a punire Gjòot e la ponemmo sotto il nostro diretto dominio, poiché non ci si poteva fidare dei signori di quella città.
Dal punto di vista religioso,
gli Huaek furono piuttosto sincretici; da nord e da ovest, si infiltrò
gradualmente la religione dualistica, che evidentemente si arricchì di elementi
locali.
Senza dubbio, però, se i Pah contribuirono loro malgrado alla diffusione di un
culto potenzialmente universalistico, fu attraverso l'incontro con la cultura
Huaek, che poté divenire veramente tale. Gli ingredienti religioso e linguistico
erano pronti. Mancava solo il popolo in grado di raccogliere questa eredità e
creare una compiuta idea di unificazione imperiale del territorio. A questo
provvedettero i Rièt.
Molti storici vedono questi ultimi come nient'altro che una continuazione verso
oriente (seguendo il corso del Kaemh e dei suoi tributari) della cultura Huaek.
La cronaca degli antichi giorni dopotutto parla retrospettivamente, quando
un'identità regionale propria si è già sviluppata, motivo per cui non è detto
che tale affermazione sia falsa. Gli archeologi, tuttavia, hanno più volte
ribadito che da Hayok, ultima città Huaek a est, andando verso l'interno, si può
verificare uno stacco più o meno netto della produzione artistica (nonostante un
certo grado di influenza). Quel che è certo è che durante la fase pre-imperiale,
emerge una lunga lista di centri urbani in conflitto reciproco, in maniera non
dissimile dai loro vicini occidentali.
Quello che cambia, e di molto, le ruote della storia, è la vorace e documentata
espansione del dominio della città di Kǝteŋ, che da semplice città-stato
diventerà un impero in grado di abbracciare una considerevole parte del
continente.
Gli inizi di questa avventura non sono semplici. Ancora nel V secolo a.C. Essa
non è altro che un nucleo abitato sotto l'influsso della ben più potente Hayok,
che aveva esteso il suo tentacolare controllo. L'onomastica dei sovrani tradisce
questa sottomissione, che, però, ha fine nel 390 a.C:
Durante il suo dodicesimo anno di regno, re Ksomwen di Kǝteŋ accolse nella sua città molti stranieri provenienti da Gueut, Poeus e ancor più lontano. Sotto di lui tutto era prosperità. Pur tuttavia egli doveva pagare tributi ad Hayok degli Huaek, in nome di un'antica e assurda usanza. Ksomwen sapeva che che gli Huaek erano potenti e il loro esercito era pieno di abili cavalieri [ndc: di mara], perciò non osava fargli guerra. Mentre continuava in silenzio a sottomettersi, tuttavia, tessé numerose alleanze. Ottenne le spade di Hcèen, nel sud. Essi, per quanto poco numerosi, erano avvezzi alla guerra contro i barbari Taw, forgiati da molte battaglie. Riuscì a fare pace con Gueut; con Poeus e Səŋec stipulò trattati di amicizia, per ottenere il libero passaggio dei suoi mercanti lungo la via del piccolo Kaem, che essi trascuravano. Da ciò ne guadagnò in ricchezze. Quando si sentì pronto, con un esercito forte e numeroso giunse a mezza via da Hayok e là occupò il villaggio di Bəhah, che ingrandì e fortificò, per farne un imprendibile castello a guardia del passaggio sul fiume. Come egli aveva previsto, re Pawdan di Hayok, una volta saputo ciò, volle un tributo ulteriore. Nonostante non si aspettasse un esercito ben munito, la sua potenza ebbe comunque quasi la meglio su Ksomwen. Il quale aveva però tenuto in riserva i suoi elefanti da guerra, che aveva acquistato a caro prezzo dalla lontana Səguh. Grazie alla loro carica, Pawdan fu costretto a ritirarsi e da quel giorno Kǝteŋ non dovette più pagare tributi ad Hayok, che perse ogni potere sugli Rièt occidentali.
Con il tempo, Kǝteŋ si
affermò come principale snodo commerciale della zona, superando di gran lunga
per popolazione le città-stato vicine.
Intorno alla metà del IV secolo a.C., dopo aver ottenuto l'affrancamento
dall'egemonia Huaek, essa dovette affrontare la 'triplice alleanza' di Gueut,
Poeus e Səŋec, che, temendo di essere surclassate economicamente e
demograficamente, fecero fronte comune:
Nel decimo anno di regno di re Mriècom, Kǝteŋ stava per dichiarare guerra a re Sòokpak di Gueut per l'ennesimo affronto da parte dei predoni Knaboh, si trovò di fronte ad una amara sorpresa: Gueut aveva stretto alleanza con Poeus e Səŋec per distruggerlo. La situazione era disperata: non aveva alleati e poteva contare solo sulle sue forze. Chiese mercenari agli Huaek, ma essi glieli negarono, gelosi dei propri mara da guerra. Decise dunque di mettere al lavoro tutte le forge della città per dotare i suoi guerrieri di corazze leggere ma resistenti. Il fabbro Pukmièn inventò una lega che soddisfaceva i requisiti del re, guadagnandosi così onori e ricompense. Con quella stessa arte produsse armi e scudi per i soldati. Così muniti, gli uomini di Kǝteŋ inflissero gravi perdite all'esercito nemico. Ma Mriècom volle farla finita con quelle minacce. Marciò su Gueut e l'assediò. La guerra fu lunga e furono numerose le sortite di quelli, cui mancavano i viveri e si facevano sempre più disperati. A nulla valsero i tentativi di mediazione e i buoni uffici dei suoi alleati. Quando infine la città aprì le porte, Mriècom decretò che non venisse data tregua e che tutti gli abitanti venissero uccisi o resi schiavi. Le mura di Gueut vennero distrutte e la città non riprese mai più l'antica forza. Poeus e Səŋec intimorite da quella dimostrazione di forza, per essere risparmiate preferirono assoggettarsi volontariamente a Kǝteŋ. I loro re furono però deposti e Mriècom assegnò dei governatori per controllare quelle terre. Gli abitanti di quelle due città ottennero il passaggio sul fiume a prezzo di tributo; in cambio poterono essere dichiarati uomini liberi.
Nel giro dei successivi
cinquant'anni altri territori caddero sotto il dominio di Kǝteŋ (Hayok
compresa), che si espandeva sempre più. Al termine del IV secolo rimaneva una
sola città che si opponeva al dominio sulla totalità dei Rièt: Səguh.
Essa rappresentava l'ultima città verso oriente sulle sponde del fiume Kaemh. Da
lì si snodavano le vie carovaniere che attraversavano l'entroterra per giungere
sino alle catene montuose continentali.
Nel quinto anno di regno del re Poeuktaw, Səguh si alleò con i barbari delle terre di Gəliɲ, tradendo l'alleanza perpetua con Kǝteŋ e dunque tutti i Rièt. Essi erano una moltitudine e per combattere non utilizzavano mara, ma cavalli. Essi utilizzavano carri da guerra, che facevano strage di nemici, poiché erano molto veloci e robusti. Il regno di Səguh aveva inoltre un buon numero di elefanti da guerra, che vivevano nelle savane circostanti. Per fronteggiarli Poeuktaw mandò un'ambasceria ai barbari delle terre di Nsuyeh, a nord di Lweey, che controllavano la grande via che portava alle terre del gran re dei Pah. Per tramite loro, il gran re stipulò amicizia con Kǝteŋ e gli inviò alcuni dei suoi carri. Poeuktaw li esaminò e cercò di carpirne i segreti. I suoi artigiani migliori si misero dunque al lavoro, ma erano scettici sulla possibilità che essi battessero la prodezza dei barbari. Le loro previsioni furono esatte in quanto alla velocità, ma non in quanto ad abilità. L'organizzazione e l'addestramento rendevano le armate Rièt forti e tenaci in guerra. Səguh venne infine battuta, anche se dopo molti lutti. Era una città grande e possente e Poeuktaw decise di prenderla per sé e non darla ad alcun governatore per molti mesi, tanto che, passato un anno, non sembrava nemmeno che avesse subito un assedio. In tutto quel tempo, Poeuktaw riorganizzò le provincie e amministrò la giustizia. Tornò infine nella capitale e lì si fece ungere dal gran sacerdote di Rǝt come imperatore di tutti i Rièt. “Se male era stato fatto per giungere a quel risultato, esso era necessario per ottenere il bene che certo ne sarebbe derivato. Le guerre e i tumulti avevano rafforzato lo spirito e avevano messo alla prova i Rièt. Ora le prove erano state superate ed era giunto il momento per godere della giustizia.” Questo proclamò il sovrano, che fece incidere queste parole su una stele del tempio.
Al periodo a partire dalla
conquista di Səguh e dalla proclamazione dell'impero Rièt, gli storici sono
soliti dare il nome di 'prima fase imperiale'. Le fonti vanno arricchendosi con
testi di varia natura, la società diviene raffinata e colta e l'impero si
protende con decisione verso occidente. La forza dell'impero Rièt non fu solo
militare, ma anche politica: attraverso l'integrazione delle elites delle città
conquistate e la creazione di un complesso apparato burocratico per la gestione
del territorio, si assicurò una invidiabile stabilità politica: la macchina
statale non si inceppava durante i conflitti dinastici, che pure erano presenti,
ed era capace di fungere da volano per ulteriori conquiste.
Con la confederazione delle cinque città Huaek (che per giunta si allearono con
le tribù seminomadi a sud, cui in questo periodo viene dato genericamente il
nome di Taw) vi saranno tre guerre nel giro di vent'anni, che si conclusero con
la definitiva annessione entro il 270 a.C; con essa si aprirono ai Rièt le porte
del delta e lo scontro con i Pah. In realtà, alla metà del III secolo prima di
Cristo questi ultimi non avevano più un regno unitario, ma si erano divisi in
diversi potentati, tra cui i principali erano: il regno di Bǝkah, che
approssimativamente occupava tutta la zona del delta; il regno di Grèes, che
occupava il nord-ovest; il regno di Gjoeum lungo il basso e medio corso del
fiume Gjeh; il regno di Wenèet a est, lungo il fiume Səlah e infine, lungo
l'alto corso del Gjeh, il regno dei Kaap, un popolo faticosamente sottomesso dai
Pah, ma che con l'andar del tempo aveva riacquistato la propria autonomia. Il
processo di conquista fu, in questo caso lungo e piuttosto incruento: in un
primo tempo l'impero si limitò a creare una rete di alleanze per la difesa
contro i popoli barbari all'ovest e al nord; il passo successivo fu portarli
progressivamente a diventare degli stati tributari, anche se l'impero non si
inserì oltre nell'amministrazione territoriale.
In seguito, dal 200 a.C., con il peso della difesa militare di questi regni
sempre più sotto la responsabilità imperiale, i re vennero uno dopo l'altro
spodestati e sostituiti con governatori fedeli allo stato centrale. Con
l'assedio e la conquista di Kəmuar nel 170 a.C. L'impero aveva unificato
pressoché tutta la civiltà urbana sviluppatasi lungo gli assi fluviali del
centro del continente. Rimanevano escluse dalla 'pax imperiale' solo le
confederazioni tribali e seminomadiche del nord, del sud e del lontano est, ai
piedi delle catene montuose.

Con la crescita dell'impero
si diffonde, come collante religioso, anche il culto dualistico di Tjǝk e Rǝt.
Esso però non è da intendersi come una religione in senso stretto, in quanto non
sostituisce la struttura sostanzialmente politeistica delle credenze
preesistenti. Piuttosto, queste sono inserite in una cornice filosofico-mistica
più ampia, in modo non dissimile da quello che farà il buddhismo in Cina e in
Giappone.
La codifica nelle norme etiche non avverrà in una sola fase. Il primo grande
canone (o almeno, il primo di cui abbiamo testimonianza scritta) verrà però
scritto da Dkay Han di Lwèey intorno al 160 a.C.
La prima parte tramandataci di questo testo è di natura teogonica: Tjǝk e Rǝt
non sono presentati come creatori del mondo dal nulla, ma come artefici. La
materia è eterna e entrambe le divinità vogliono plasmarla a proprio piacere; il
primo vuole creare la quiete, la pace e l'ordine, mentre il secondo vuole creare
il movimento e il disordine. Da questa lotta si crea il mondo come lo
conosciamo. Anche gli esseri umani sono soggetti a questa duplice natura o
meglio, il loro animo lo è. E, a seconda di quale dio ha avuto maggior peso nel
forgiare il loro spirito, prevarrà un aspetto o l'altro(fermo restando che sono
sempre presenti entrambi). La natura dell'anima non è però stabile: In una fase
della vita può prevalere una forza e nella fase successiva un'altra.
Addirittura, sono le situazioni che impongono a volte di agire, altre di stare
fermi.
A questo punto l'autore passa alla parte più propriamente morale: come stabilire
quale spirito seguire per ottenere la felicità? Emerge qui la natura vagamente
deterministica di questa filosofia. Nel mondo c'è tanto moto quanta quiete, per
mantenere l'equilibrio tra i due dei. Questo significa che per ogni situazione
in cui un uomo decide per la quiete, ci saranno altri uomini che decideranno per
il movimento. Ciò significa che egli non è completamente libero dal volere degli
dei, per quanto sia apparentemente capace di scelta.
L'uomo deve sforzarsi dunque di 'essere a somma zero', alternando quiete e
movimento. Del resto anche i fenomeni naturali seguono questa regola: i
cataclismi avvengono in un luogo e non in un altro perché da qualche parte è
necessario che vi sia movimento dopo troppo tempo di quiete. In questo senso si
innesta il discorso sulla natura del male. Il male fisico subito è dunque
necessario nell'economia generale del mondo e nell'economia generale della
propria vita. Anzi, in un certo senso è persino catartico, in quanto
ristabilisce l'equilibrio delle forze. Non solo: l'anima è 'condannata' a essere
immortale. La quiete assoluta della morte è solo apparente. Semplicemente, è
stata esaurita la quantità di moto prestabilita per un determinato corpo; vi
sarà dunque un nuovo ciclo vitale da qualche parte nel mondo. E il male
compiuto? Anticipando di millenovecento anni Leibniz, l'uomo vive in un mondo
che, per certi aspetti, è il migliore di quelli possibili. Viviamo in un
universo in cui gli atti di violenza sono inevitabilmente presenti come 'eccesso
di disordine'. Ciò significa che, se in un luogo vi è guerra, in un altro luogo
vi sarà pace. Se la sofferenza si subisce, occorre trarre conforto dal fatto che
essa non sarà eterna (o perché fattivamente o perché conduce alla morte), per
quanto la preghiera possa influire sulla propria capacità di sopportazione della
stessa. Se la sofferenza la si compie, occorre (un po' come il karma indiano)
stare attenti alle conseguenze del gesto. Il primo luogo in cui la violenza
porta disordine e disequilibrio di forze è lo spirito. Ciò significa che fare
violenza affretta la propria morte. E' comunque possibile che da un male derivi
un bene. (infatti di solito gli imperatori Rièt giustificheranno le guerre come
'disordine necessario per ottenere un successivo ordine')
In sintesi, il testo di Dkay Han sosterrà una condotta che potremmo definire 'moderata'.
Giustifica l'azione e persino la violenza nei confronti del prossimo, ma non
tanto da esaltarla. Giustifica l'intraprendenza e l'arricchimento personale, ma
non gli eccessi e l'opulenza. Giustifica l'ordine costituito dello stato, ma non
tanto da smorzare qualsiasi tendenza individualistica. Molti storici sostengono
che tale impalcatura etica avrà un influsso duraturo sullo sviluppo delle
istituzioni politiche ed anche economiche del continente; che sia vero o meno,
sicuramente lascerà la propria traccia dal punto di vista culturale per molti
secoli a venire, anche dopo la decadenza dell'impero (fornendo anzi una base
ideologica per i successivi stati che cercheranno di 'restaurare l'ordine').
.
4.3 Il sud-ovest e i primi navigatori verso occidente
Nelle terre meridionali della Magellania, parzialmente isolate dall'influenza delle altre culture continentali, si sviluppano, tra VII e II secolo a.C., diverse civiltà, tutte accomunate da un rapporto privilegiato con il mare, in maniera non molto dissimile a quanto accadeva nella penisola settentrionale.
Cinghia di trasmissione con le culture del Kaemh furono innanzitutto i Pəluaŋ. Situati a sud della zona semidesertica di Taw, svilupparono due nuclei statuali distinti: uno, avente come centro la città di Reumpièk, situato in una felice posizione sulle rive del pescoso golfo di Samkat, proiettato verso il mare. Un altro di natura seminomade e prevalentemente pastorale – fatto salvo per alcuni centri sulle vie carovaniere verso nord – nell'entroterra. Si trattava di un popolo la cui discendenza linguistica è di difficile attribuzione. Sembra ormai abbastanza certo che parlassero una lingua di ceppo austroasiatico, ma il legame di parentela con i vernacoli del centro del continente è labile, se mai ve n'è uno. Conosciamo il loro idioma da una stele trilingue risalente al III secolo a.C, rinvenuta presso le rovine di Reumpièk nel 1896. Essa è scritta in caratteri Huaek di età proto-imperiale da un lato e di altri logogrammi da essi derivati dall'altra. La prima lingua è Huaek classico, la seconda è la lingua detta 'di Reumpièk'. Un piccolo frammento della stele ci fa intuire l'esistenza, in caratteri diversi dalle due precedenti, di una terza lingua, la cui attribuzione è tuttora incerta. Alcuni esperti si sono lanciati nel sostenere si tratti di un idioma austronesiano, ma le prove non sono incontrovertibili.
La 'lingua di Reumpièk' è da taluni studiosi considerata un supporto a sostegno della summenzionata tesi di Lǝbit di una prima migrazione proto-austroasiatica tra il tardo paleolitico e il primo neolitico, antecedente a quella che avrebbe colonizzato il centro del continente a partire dalla foce del Kaemh. In questo caso, l'attuale gruppo etnolinguistico Bkat sarebbe erede dei Pəluaŋ, i quali, a loro volta, sarebbero gli eredi della cultura di Brih, nominata in precedenza.
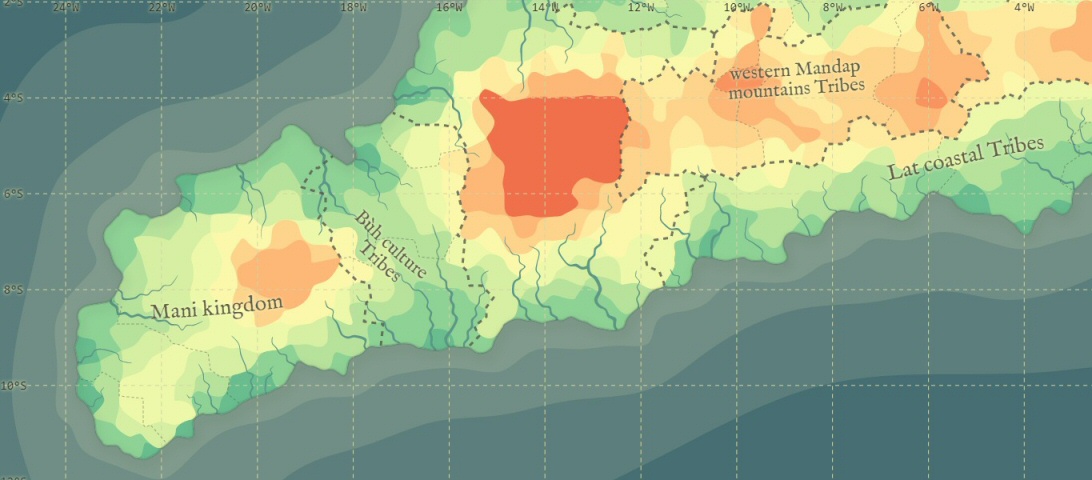
Il testo si configura come una lista di regole e di leggi, volute da un non meglio definito 'consiglio dei saggi', che precisa anche le pene per i trasgressori. In particolare, la parte finale è un monito verso tutti i pirati e truffatori. La decifrazione della stele fu un fatto entusiasmante non solo per i glottologi, ma anche per gli storici del periodo, che derivarono l'esistenza di una società che aveva un avanzato livello di scambi commerciali, tanto da sentire il bisogno di scolpire su pietra, anche a beneficio degli stranieri, delle misure che li regolamentassero. Ci sfugge se le transazioni si effettuassero tramite baratto o se una civiltà del genere avesse introdotto l'utilizzo di una qualsivoglia forma di moneta. Molti esperti sono propensi a credere di sì, per quanto per ora gli archeologi non abbiano trovato alcun tipo di conio nei livelli IV e III degli scavi, ossia quelli relativi al periodo VI-II secolo a.C.
Un secondo aspetto che ha interrogato gli studiosi è il termine 'pirati'. Quando il testo venne tradotto venne infatti trovata una parola nuova, mai apparsa prima, che univa i logogrammi delle parole 'ladro' e 'mare'. La spiegazione ufficiale fu, all'epoca, che lo Huaek evidentemente non disponeva di un vocabolario molto ricco, per i termini legati alla navigazione, perciò si faceva pressante il bisogno di inventare una nuova modalità grafica per esprimere qualcosa che precedentemente non era necessario.
Negli ultimi decenni, tuttavia, un'analisi più accurata delle fonti huaek più tarde, successive alla frammentazione dell'impero Rièt, indicano che la lingua non aveva un lessico così scarno relativamente alla sfera semantica del mare. I 'pirati', nel V secolo dopo Cristo, vengono designati con una diversa composizione logografica.
Questo ha fatto desumere due grandi teorie, in contrasto tra loro. La prima è che effettivamente il lessico Huaek, fino a quel momento basato su una civiltà che di marinaresco non aveva nulla, a partire dal II secolo dopo Cristo sia stato influenzato da lingue di popoli avvezzi alla navigazione con cui era entrato in contatto per via di scambi culturali e commerciali.
La seconda, più avvincente, ma più controversa, ritiene che i termini dell'ambito semantico in questione fossero già presenti, addirittura sin da un'epoca pre-neolitica (e quindi retaggio della grande migrazione dall'Asia verso la Magellania). Ciò sta a significare che la locuzione 'ladri del mare' non sia da intendere come un generico 'pirati', di cui sarebbe già esistita una diversa rappresentazione grafica, ma indicasse un popolo ben preciso, ossia le genti austronesiane stanziatesi intorno al capo Nine. Dal VIII al II secolo a.C., come poi vedremo meglio, l'espansione delle popolazioni stanziatesi presso la punta sud-occidentale del continente fu vertiginosa. Essa si concentrò soprattutto lungo la costa meridionale della Magellania, ma nulla impedisce di credere che mercanti (e, appunto, pirati) si siano invece spinti verso nord, attratti dalle ricchezze che gli scambi con le civiltà del Kaemh potevano portare. Ciò retrodaterebbe l'influenza austronesiana dal sud sull'impero Rièt e i suoi epigoni di mezzo millennio. Per quanto concerne nello specifico i Pəluaŋ, resta il fatto che, in un modo o nell'altro, la città di Reumpièk rappresentò un centro economico fondamentale nell'antica Magellania, in cui le merci del nord e del sud convergevano, dandole probabilmente un aspetto cosmopolita.
Un'altra questione che interroga gli storici è la ragione per la quale l'impero non abbia preferito invadere la regione e annetterla, né durante la sua prima fase espansiva, né in seguito. Dopotutto, la maggior parte delle informazioni su Reumpièk e i Pəluaŋ ci derivano da Nòomsiec di Gueut e dal suo dei popoli barbari, testo del II sec. a.C, che testimonia il fatto che i Rièt ben li conoscevano:
A Reumpièk dei Pəluaŋ non vi è un re, ma molti, tanto che ci chiediamo come facciano a non battibeccare l'un con l'altro. Essi si riuniscono a consiglio diverse volte l'anno, per discutere delle faccende più importanti e si dice non lascino il luogo di adunanza finché non giungono ad un accordo sul da farsi. Sono comunque dei mercanti senza onore, né nobiltà e tutto può essere venduto o acquistato in quella città. Pagano a volte tributi al nostro signore imperatore, ma per il resto sono in tutto indipendenti. Vi si parlano diverse lingue, compresa la nostra, che capiscono benissimo, pur a volte fingendo di non intenderla. Del resto, molti dei nostri si sono trasferiti lì e mi si dice che abbiano fatto fortuna commerciando in schiavi dal lontano sud.
Da queste poche righe si evince peraltro che la città fosse retta da un sistema non autocratico, bensì oligarchico, una rarissima eccezione della storia extra-europea. Non si sa se i Rièt non abbiano mai provato a conquistarla o se, più semplicemente non abbiano mai ritenuto necessario il farlo. Resta il fatto che la savana semi-arida a sud del Kaemh rimarrà a lungo una regione di frontiera scarsamente colonizzata. Molto più tardi verranno erette opere di fortificazione per prevenire eventuali invasioni, militarizzando la cultura. Tra V e VII secolo d.C. L'età dell'oro dei commerci di Rmpièk poteva però dirsi ormai conclusa, a vantaggio dei nuovi e più aggressivi stati meridionali.
Nelle narrazioni storiche e semi-mitiche di questi ultimi si nomina più o meno uniformemente come progenitore comune il regno di Mani. Eppure, di fonti dirette in merito non ve ne sono, tanto da dubitare sulla sua stessa esistenza. La soluzione più semplice al mistero, che spesso viene menzionata dai libri di testo scolastici è quella che – così come i Pəluaŋ sono i discendenti diretti di coloro che abbatterono la cultura di Brih (o, per la Lǝbit e altri, eredi DELLA cultura di Brih), allo stesso modo l'ipotetico Mani sia l'erede della cultura Qaqaqe. Logica conseguenza è dipingere i due territori come eterni rivali per il dominio dei mari, con la decadenza di Reumpièk come diretta conseguenza di epici scontri navali che la videro perdente.
A partire dagli anni '70 e '80 gli storici iniziarono ad essere più cauti a riguardo. Innanzitutto, come detto, non si da' del tutto per scontato che il regno di Mani possa effettivamente essere un mito auto-celebrativo per nobilitare e glorificare i propri antenati e dar loro un'aura di progresso e civiltà al pari delle coeve e ben più raffinate culture che esistevano a settentrione.
In secondo luogo, si ragiona sul fatto che se la diffusione di Mani fosse stata la primaria ragione del declino dei Pəluaŋ e che Mani stessa fosse erede diretta dei Qaqaqe (o addirittura, come alcuni hanno supposto, che i due fossero la stessa cosa), l'impero Rièt difficilmente avrebbe conosciuto o anche solo avuto sentore della gloria della città di Reumpièk. Insomma, i tempi non coinciderebbero.
Ciò lascia concludere che per diversi secoli l'interazione tra i due popoli sia stata stabile e vantaggiosa per entrambi, relegando fantomatiche epiche battaglie protostoriche nel pensiero degli scrittori di romanzi.
Se tale regno effettivamente ci fu, non la sua presenza, bensì la sua successiva frammentazione sarebbe stata deleteria per i Pəluaŋ.
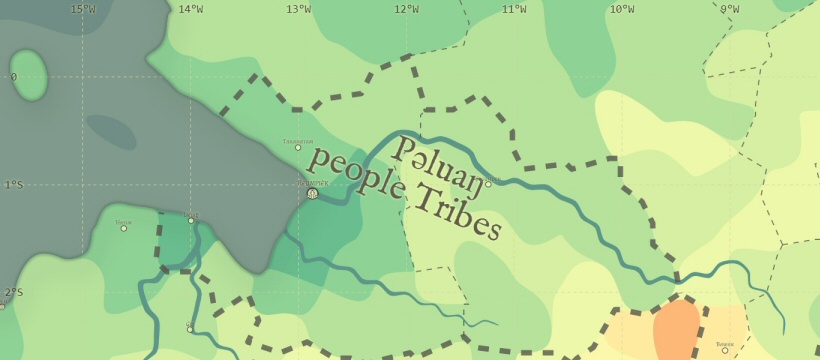
La questione si complicò ulteriormente a partire dal 1997, quando, presso il villaggio di Bùh vennero scoperte delle tombe inizialmente attribuite al Qaqaqe 5, o finale (VII - V secolo a.C.). La notizia, nel mondo archeologico, fece una certa sensazione, poiché esse si trovavano diversi chilometri a settentrione rispetto alla estensione massima dell'areale supposto per quella cultura. In più, si trovavano in una regione abitata da genti di lingua Gòn, quindi di ceppo austroasiatico. La vulgata classica che voleva una espansione continua delle culture austronesiane a danno di quelle austroasiatiche per tutto il corso della storia antica e medievale era così messa piuttosto in crisi. A 'sistemare' la questione venne l'analisi, dieci anni più tardi, del materiale genetico residuo estratto dai resti portati alla luce. Essa mise in evidenza l'appartenenza dei defunti a etnie non austronesiane, con, piuttosto, una forte corrispondenza con il materiale genetico delle genti della cultura di Brih e Pəluaŋ.
Risolto un mistero, ne sorgeva un altro, però: i manufatti trovati erano indistinguibili da quelli già presenti in altre necropoli più meridionali della cultura Qaqaqe, di cui tuttavia era inequivocabile l'ascendenza austronesiana.
Le ipotesi messe in campo dagli archeologi furono varie: la più diffusa è che si tratti semplicemente di una riproduzione di stilemi altrui considerati come maggiormente prestigiosi. Questa teoria ha il vantaggio della praticità: non si implicano conquiste militari e si mantiene inalterata la mappa etnografica già consolidata, variando unicamente la 'sfera di influenza' che la cultura austronesiana del sud-ovest aveva sui propri vicini.
Un nutrito gruppo di studiosi, tuttavia, pensa che liquidare semplicemente come imitazione la necropoli di Bùh apra più quesiti di quanti ne risolva. Bùh è più vicina a Reumpièk di quanto possa essere qualsiasi insediamento del supposto regno Mani, quindi è quantomeno anomalo che il 'modello di prestigio' scelto dagli abitanti sia stato quello meridionale e non quello settentrionale. Non sarebbe dunque, per quanto più dirompente, più logico supporre che la presenza austronesiana si espandesse da sud, già in evo antico e prima dell'arrivo delle popolazioni Malay, fin quasi al delta del Kaemh?
Una tesi ancor più radicale, è quella del professor Q. Lintam, il quale sostiene la necessità di 'ribaltare i preconcetti' sul regno Mani. In altre parole la necropoli di Bùh non sarebbe stata affatto situata in una regione 'periferica' sotto l'influenza di un regno austronesiano posto più a meridione, bensì si sarebbe trovata al centro di un regno in cui l'aristocrazia era e restava di ceppo etnolinguistico austroasiatico; era il meridione austronesiano a essere sottomesso a questo dominio, non viceversa. Lintam, del resto, ritiene che nella stele trilingue di Reumpièk, la famosa e misteriosa terza lingua sia perfettamente interpretabile come una lingua austroasiatica e non austronesiana. Eppure, se questa tesi corrispondesse a verità, come si spiegherebbe la grande ondata colonizzatrice dei secondi lungo tutta la costa meridionale del continente? Una possibile soluzione è stata proposta dallo storico T. Melekeok, il quale, pur ritenendo plausibile la teoria di Lintam, in un suo saggio sull'era mitica delle esplorazioni sostenne:
È piuttosto superfluo, se non per attizzare a tempo perso velleitarie folate di orgoglio nazionalistico, chiedersi 'chi comandava chi'. Più le prove archeologiche si accumulano, più diviene evidente che nessuna società antica era contraddistinta da una divisione etnica rigida come gli stati-nazione moderni, men che meno quelle della penisola meridionale del nostro continente. Al massimo, possiamo concedere che etnie diverse abbiano assunto ruoli sociali differenti, fondendo la divisione etnolinguistica a quella di casta. Le popolazioni austronesiane hanno potuto così coltivare la loro posizione nell'ambito navale e mercantile in massimo grado, mentre – ipotizzo – il ruolo burocratico e sacerdotale sia stato occupato dalle popolazioni austroasiatiche. Non credo del resto nemmeno in una linea divisoria netta tra i due areali, quanto piuttosto una situazione, in tutto il sud-ovest della Magellania, a macchia di leopardo. Non mi stupirei si scoprisse, in un prossimo futuro, uno stesso sepolcreto con individui provenienti da diversi gruppi o, ancor meglio, in cui siano presenti caratteristiche genetiche di entrambi gli aplogruppi nel medesimo individuo.
Una cosa però è certa: qualunque sia stata la ragione, Mani o chi per esso è stato il motore di una straordinaria spinta propulsiva e colonizzatrice verso le coste meridionali del continente. Navi di audaci esploratori compirono viaggi sempre più lunghi, verso mete sempre più lontane, in cerca di luoghi in cui costruire prima empori e scali commerciali, poi vere e proprie città. Bolaw- come venivano chiamate le antiche imbarcazioni a bilanciere della regione di capo Nine – cariche di prodotti andavano e venivano, creando reti commerciali sempre più fitte e che all'alba del II-III secolo d.C dovettero raggiungere le estreme propaggini sud-orientali del continente.
Un interessante resoconto di questo oscuro quanto avventuroso periodo ci viene dal 'mito di Kewn', la leggenda di un mercante avventuriero che, naufragato presso un regno sconosciuto di barbari, riesce ad entrare nelle grazie del sovrano locale, tanto da diventarne consigliere, per poi rapirne la figlia e fuggire con notevoli ricchezze, sino a fondare una propria città, ovviamente non senza aver sconfitto nel mentre una discreta dose di mostri e guerrieri nemici. Al di là dei particolari specificatamente fantastici, la narrazione ci presenta diversi particolari altamente verosimili. La leggenda ci fa capire come spesso i rapporti con gli indigeni locali fossero un misto di convivenza e conflitto e che sovente i colonizzatori reperissero sul posto le donne per garantirsi una discendenza. Inoltre è piuttosto evidente come tali imprese non avessero un coordinamento univoco, quanto, piuttosto, fossero un mix di interessi privati di natura economica e demografica. Resta tuttora difficile razionalizzare o anche solo comprendere pienamente lo 'spirito' che animava tali imprese, ma un fatto è certo: l'epopea dei navigatori-avventurieri austronesiani forgerà in maniera irreversibile e indelebile la cultura magellanica.
Diversi antropologi teorizzano anche un movente di natura mistico-religiosa, ovverosia una primitiva fusione tra elementi distintivi delle credenze dei popoli austronesiani a vaghi echi dualistici riconducibili alle filosofie del nord. In particolare tutto graviterebbe intorno al concetto di 'mana', l'energia vitale che permea ogni elemento della realtà. Ogni uomo avrebbe insito in sé il potere di assorbire il mana dal mondo circostante, ma nel concreto, solo pochi ci riescono davvero. Alla nostra morte, il mana del nostro spirito perlopiù si disperde nell'ambiente. Questo è normale e finanche necessario, affinché si generi altra vita. Ma, in taluni, rari casi, il nostro mana non si disgrega. Solo gli spiriti molto potenti possono rimanere in questo stato e continuare a influire sui mortali (e proteggere i propri discendenti, entro i vincoli stabiliti dall'equilibrio delle forze cosmiche). Ma per diventare pienamente e compiutamente immortali, occorre assorbire molto mana o aiutare gli spiriti ad assorbirne attraverso le preghiere di nuovi fedeli. In altre parole, la conquista e la colonizzazione di nuovi territori (per quanto molte storie e leggende farebbero comprendere molto bene che il fine non poteva giustificare ogni mezzo, in questa sete di grandezza). Probabilmente molti filosofi dell'impero Riet avrebbero bollato questa sete di conquista come impura, ma quegli stessi filosofi non potevano sapere che di lì a qualche secolo il concetto di mana sarebbe diventato una componente fondamentale delle future credenze dualistiche del centro del continente.
.
4.4 La Cordigliera orientale e i popoli seminomadi delle foreste e delle savane
4.4.1 Gli eredi dei Tululešana
Per concludere la nostra panoramica sulla Magellania antica occorre gettare lo sguardo su quello che il paleoantropologo J. Reinhard ha definito come il vero e proprio 'mondo perduto' della Magellania. Mondo su cui egli stesso ha enormemente contribuito a gettare una luce, mettendo a frutto la propria esperienza in Mesoamerica. Stiamo parlando infatti delle popolazioni che hanno abitato in passato lungo la cordigliera orientale e che oggi, salvo rare eccezioni, sono state relegate a una presenza marginale a motivo delle successive migrazioni. Come già menzionato, il fatto che la civiltà di Tululešana derivi da una migrazione dalla Terra del Fuoco attraverso ponti di terra durante l'ultima era glaciale è una teoria relativamente moderna, peraltro validata solo al principio del XXI secolo con l'utilizzo della genetica.

Ma andiamo con ordine: che tra le lingue vitiche (ovverosia quelle dell'estremo sud-est del continente) ve ne fossero alcune (in seguito raggruppate in una famiglia a sé stante) con un sostrato chiaramente non austronesiano, era cosa nota ai linguisti, per quanto poco approfondita. Il primo a compiere un estensivo studio in merito fu il professor P. Ganilau, al termine degli anni '50, il quale sottolineò l'impossibilità che tale sostrato potesse essere di qualsiasi ceppo austroasiatico antico o moderno.
Rimaneva la possibilità che esso fosse afferente a una qualche gruppo aborigeno presente o passato. Purtuttavia, gli studi etnolinguistici in Magellania erano ancora ai primordi e molti vernacoli di popoli isolati delle valli montane o delle foreste pluviali non erano ancora stati analizzati. Fu lo stesso Ganilau a suggerire una documentazione più approfondita sui Liqai, nome con cui - con qualche leggera variante – i popoli costieri della Magellania sudorientale definiscono gli abitanti del meno ospitale entroterra montuoso. Il problema evidenziato da Ganilau fu che a livello prettamente storico, le fonti cronachistiche della regione risalgono al massimo al VIII – IX secolo dopo Cristo e, per quell'epoca, già l'entroterra era già politicamente subordinato alla costa e i toponimi riportati erano già in idiomi austronesiani. Non restava che appellarsi a eventuali fonti letterarie narranti di un passato mitico. Il lavoro di Ganilau riaccese l'interesse, politicamente poco gradito, relativamente alla questione delle origini delle lingue vitiche, tanto che, dopo la sua morte diversi paleoantropologi e linguisti ripresero il suo lavoro.
Fu così, che in una delle molteplici riedizioni tarde del mito di Kehuna (Kewn), si scoprì il ricorrente riferimento a un popolo astuto e ostile di pastori delle montagne, che più volte riusciva a mettere inizialmente in scacco l'eroe. Chiaramente ciò non voleva dire nulla di per sé, visto che poteva essere semplicemente la ripresa di un topos (sfida in astuzia dei navigatori contro i pastori dei monti) molto antico; ma quello di cui erano a caccia gli studiosi erano termini (toponimi, idronimi, etnonimi) caratteristici, quelli sì con un fondamento verificabile. Dopo una lunga ricerca, si arrivò a poter identificare con una certa chiarezza, almeno tre popoli non austronesiani, ossia gli Analas, i Patara e gli Atruk. Il capo dei primi, Tarakash, è citato in non meno di tre versioni come antagonista principale dell'eroe. In una versione è anche citato il suo aiutante Juaylca, che in un'altra ancora diventa Iwaica. Chiaramente nessuno scienziato aveva la pretesa di poter ricostruire un intero linguaggio (ammesso che fosse uno e non, invece, molti) da poche parole riportate a secoli di distanza, per giunta da una persona straniera. Però i termini sembravano finalmente compatibili. Era quella (o quelle) la lingua di sostrato che aveva influenzato le parlate austronesiane della regione. Tuttavia, tanti divieti da parte di governi ostili a tale lavoro, negarono per diverso tempo l'autorizzazione per poter portare a termine l'operazione che avrebbe permesso di completare il quadro: una spedizione etnologica alle pendici del monte Puscia, per raccogliere dal vivo testimonianze delle lingue native. Il clima politico, tuttavia, dal termine degli anni '60, iniziò a mutare e i governi smisero di considerare pericolose ricerche volte a dimostrare l'origine 'non indigena' della propria nazione.
In particolare, K. Mara riuscì a registrare e – in seguito – comporre un dizionario e una grammatica minime dell'antica lingua del popolo Wania (parlata in gran parte dalle generazioni di ultrasessantenni) che fornì una miniera di informazioni sulle 'popolazioni originali perdute' dei massicci montani del sud-est. Fu lo stesso Mara a interrogarsi sulla famiglia linguistica entro cui inserire il Wania e, successivamente, il Kiyalukupi e altri linguaggi locali. Nel 1979, la del tutto casuale amicizia con un allora giovane filologo cileno, Oscar Aguilera, portò Mara ad una conclusione sensazionale, all'epoca accolta con una certa freddezza: per quanto apparentemente improbabile, la lingua conosciuta più vicina era il Kawesqar della terra del Fuoco. Le implicazioni di tale conclusione erano enormi: significava infatti, che dalla Magellania alla Terra del Fuoco gli uomini avrebbero utilizzato la 'autostrada meridionale', per giungere nel continente americano. L'inizio di scavi estensivi volti a supportare questa tesi, portarono, come già menzionato in precedenza, alla scoperta e alla chiara identificazione della cosiddetta civiltà di Tululešana (anche se, lo ripetiamo, rimase poco chiaro il rapporto che questi popoli ebbero con altre – più note – civiltà magellaniche preistoriche). Dalla fine degli anni '80, la teoria di Mara divenne canonica e tutti i libri di storia raccontavano delle 'due strade' che avrebbe affrontato l'uomo per colonizzare il continente americano, all'estremo nord e all'estremo sud. Già però dal 1986, alcuni paleontologi avevano manifestato aperto dissenso: se la fauna tipica della cordigliera orientale magellanica mostrava di essersi originariamente evoluta in sud America, per poi essersi spostata verso ovest, perché pareva a tutti ovvio che, unico tra tutti, homo sapiens si fosse mosso, per così dire 'contro corrente'? La teoria che voleva i cacciatori essersi mossi sempre più verso oriente in cerca di prede pareva loro debole, in virtù dell'ovvia constatazione che la megafauna mesoamericana era sopravvissuta meglio e più a lungo in Magellania, che non in Sud America. Non era più semplice e logico pensare che il diradamento delle prede disponibili avesse spinto i fueghini verso occidente, piuttosto che il contrario?
Il fatto che la teoria 'da ovest a est' andasse per la maggiore era forse in virtù di un inconscio preconcetto razzista, ma negli anni '90 la teoria 'da est a ovest' guadagnò sempre più sostenitori, anche tra i linguisti (che cercarono di capire se e quanto quelle da una parte all'altra dell'oceano fossero innovazioni fonetiche o no) per quanto le prove rimanessero fondamentalmente indiziarie. Fu però la genetica a tagliare definitivamente il nodo di Gordio, dimostrando inequivocabilmente come rotta migratoria fosse in accordo con quanto sostenuto inizialmente dalla paleontologia.
Ma quanto, di questa stupefacente migrazione, influì sulla storia più recente della Magellania?La vulgata ormai entrata nell'immaginario comune è che, un tempo dominatori di una grande fetta del continente, gli epigoni dei Tululešana, siano stati progressivamente scacciati dalle loro dimore da nuovi e aggressivi venuti, in particolare nel periodo II – VII secolo d.C.
Eppure, fino ad ora, non sono stati ritrovati reperti che lascino indicare una sostituzione demica violenta. E' vero, i navigatori austronesiani non disdegnavano la guerra e la razzia nei confronti delle popolazioni native, è testimoniato da tutti i racconti mitologici di cui siamo entrati in possesso. Pur tuttavia, lo stesso corpus di leggende ci narra più spesso di interazioni di altra natura, specialmente economica, se non addirittura di convivenza e alleanza (storie di austronesiani che si alleano con popolazioni dei monti contro altri austronesiani non sono nemmeno poi così rare). Ad oggi, non siamo nemmeno sicuri che i Liqai siano stati incapaci di creare stati veri e propri e siano rimasti allo stadio di tribù o di villaggi fortificati, come la vulgata tende a far credere. Quello che è certo è che per il VII secolo al massimo, tutti i regni storicamente documentati sono di Viti, Ikami e Taumati, ossia sempre e comunque di popoli austronesiani. Alcuni storici tendono ultimamente a favorire l'ipotesi di una presa progressiva di potere da parte di elites mercantili (o anche guerriere, in taluni casi) austronesiane in centri preesistenti, dello spostamento dell'epicentro di tali domini dall'interno alle coste e, consequenzialmente, dell'assimilazione linguistica, lenta ma inesorabile. Del resto, se in alcuni valli isolate dell'interno popolazioni native di locutori non austronesiani esistettero ed esistono tuttora, significa che, verosimilmente per secoli, si ebbe una situazione di sostanziale diglossia in moltissime comunità: acroletto austronesiano e basiletto nativo.
.
4.4.2 I 'veri' magellanici
l'aggettivo 'magellanico', in senso etnico è stato, a ben vedere, accostato alle popolazioni più disparate, a volte dando origine a contese, invero piuttosto buffe, su quale sia il gruppo etnico che possa portare con maggiore diritto tale appellativo rispetto ad un altro. Ma, per quanto originata da motivazioni piuttosto superficiali e finanche razziste, la ricerca dei 'magellanici originari' ha portato ad una messe di scoperte paleontologiche ed archeologiche nel XX secolo, alcune delle quali sono già state ampiamente menzionate. Resta però ancora da capire dove e quanto sopravvissero i popoli aborigeni di fronte alle successive ondate migratorie provenienti dall'Asia (e, nel caso particolare osservato nel paragrafo precedente, dall'America).

Gli eponimi della cultura paleolitica di Goh e di quella neolitica di Lat sicuramente non vennero spazzati via. Nella stragrande maggioranza dei casi si fusero con i nuovi venuti. Occorre pertanto sfatare il mito un po' stantio della caccia e dello sterminio che ogni nuovo popolo avrebbe adoperato a danno di quelli preesistenti; in aggiunta, bisogna ricusare anche l'idea di un divario culturale tale da rendere inevitabile la sottomissione e l'assimilazione dei 'veri magellanici' nei confronti dei più recenti austroasiatici e austronesiani. D'altro canto, è però vero che chi finì per non essere assimilato e mantenne le proprie strutture etnolinguistiche pressoché inalterate fu tutta quella serie di tribù che dimorava nelle località più impervie e di difficile accesso, vale a dire le foreste pluviali, tropicali, subtropicali o temperate, alle pendici delle principali catene montuose del continente. E' probabile che durante tutta l'età antica i popoli aborigeni permanessero, per quanto a macchia di leopardo, lungo tutta la linea delle due cordigliere (meridionale e orientale), con particolare concentrazione dove le foreste si facevano più fitte. Le fonti a nostra disposizione tendono a confermarcelo: l'esempio più lampante è forse rappresentato dai summenzionati 'demoni della foresta', che rappresentano l'antagonista primario che fa da sfondo all'origine mitologica dell'impero Layam (peraltro, negli ultimissimi anni sono emerse diverse teorie che vogliono i Layam de facto un impero aborigeno con solamente un leggero superstrato austronesiano).
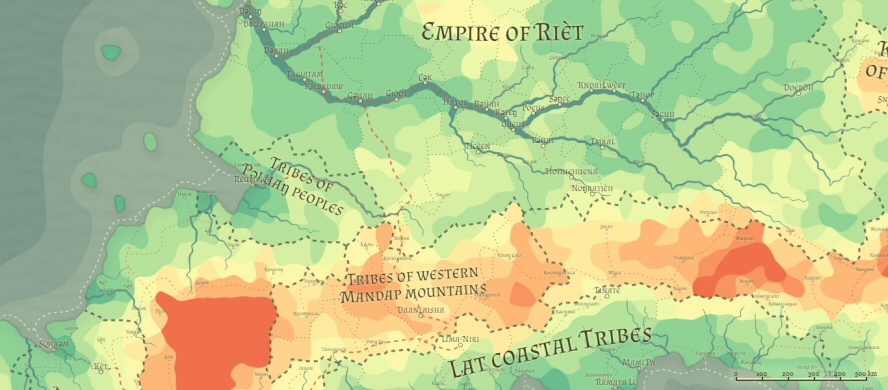
In merito ai 'popoli delle selve', le fonti esterne ci consentono di identificarne tre grandi macrogruppi:
1) i popoli del Mandap, il vasto complesso montuoso a sud-ovest;
2) gli 'Indac': probabilmente un termine contenitore che racchiude al suo interno tribù tra di loro eterogenee, accomunate dal fatto di essere il principale antagonista alla penetrazione verso l'interno della colonizzazione austronesiana sulla costa orientale del continente. Peraltro, troviamo un termine molto simile, 'Ndaek', usato nel II secolo d.C. Da Koekah di Seguh, autore del trattato storico/religioso 'Sull'equilibrio tra quiete e moto'.
Nessun impero
o regno è fatto per espandersi all'infinito. Prima o poi troverà situazioni
interne o esterne, che lo costringeranno a quietarsi e trovare un nuovo
equilibrio. Oppure essere completamente distrutto, per dare possibilità a
qualcosa di nuovo di nascere dalle sue ceneri, ormai troppo consumate. Che il
nostro glorioso dominio e gli anni sul trono del nostro caro sovrano possano
durare ancora a lungo, ma augurare loro una vita infinita è come augurarsi la
rovina del mondo.
Non è semplice comprendere la differenza tra coraggio e avventatezza e, allo
stesso tempo, non è semplice comprendere la differenza tra ignavia e saggezza.
Ma quando non riusciamo a compiere tali ardue distinzioni, molto spesso le forze
cosmiche intervengono direttamente, costringendoci a delle scelte radicali:
fermarsi o perire. Così è anche per noi Rièt, che ci vediamo porre, verso
oriente, un limite invalicabile, i grandi monti verdi, popolati dai feroci Ndaek.
Nessun forte dura più di una stagione, nessuna vittoria dei nostri rimane da
loro invendicata il giorno dopo, nessun villaggio di pionieri resta immune da
una qualche pestilenza. E' un segnale che non siamo voluti e volerci espandere
oltre è follia.
Ammesso e non concesso che 'Indac' e 'Ndaek' siano un riferimento agli stessi popoli, è incontrovertibile che la zona geografica è più o meno la medesima;
3) infine, il gruppo degli Amulann, presso i passi del nord, al limitare delle pianure steppose, dove si trova l'immensa foresta decidua presso il letto dei fiumi Neiti e Kutak. Una menzione di loro la abbiamo da un autore del tardo II secolo d.C. Rulam di Grèes, nella sua opera etnografica Dei popoli barbari di Nòomsiec di Gueut continuato.
La riva sinistra dell'alto Gjeh è abitata dai popoli delle alte pianure. I Kaemoc e i Sèn non vi daranno passo: orgogliosi, instancabili, litigiosi. I loro più grandi difetti sono le loro più grandi virtù. Non vi è nemico più pericoloso, non vi è amico più fedele. Non amano i Mara, e dicono di essere stati loro ad istruire all'utilizzo dei cavalli tutti i popoli del sud, ossia per noi coloro che dimorano a a oriente di Gəliɲ. Non temono troppo la potenza del nostro impero. Se fossero rissosi tra loro anche solo la metà, potrebbero marciare su Wenèet e distruggerla, sconfiggendo le nostre armate di confine senza troppa fatica. Coloro che invece temono, e molto, sono i popoli delle foreste montane, gli Amulann, che loro sostengono essere dotati di strani poteri magici. Ritengono indispensabile non entrare in dissidi con loro, anche perché conoscono ogni passo montano attraverso i boschi che conduce dalle loro vaste pianure fino alle città marinare della costa del nord.
Ma cosa ne è rimasto di loro attualmente? Per quanto possa essere triste, molto poco. Dei tre gruppi, l'unico sopravvissuto alla storia medievale e moderna della Magellania è quello Indac. Ancor esistono, sul versante interno dei monti Lifi, alcune tribù aborigene, che vivono in maniera tradizionale. Alcuni locutori viventi delle lingue native vi sono ancora, ma, a parte il fatto che sono tutti ormai anziani, il vernacolo che essi parlano è ormai una una lingua fondamentalmente austronesiana, con influenze austroasiatiche e persino di spagnolo. Solo alcune parole e alcune locuzioni tradiscono una origine ben diversa e più antica. Parole di vitale importanza, su cui alcuni paleoetnologi e linguisti australiani intendono approntare al più presto possibile un lavoro di ricerca, prima che sia davvero troppo tardi.
.
4.4.3 Gli altopiani e le steppe
In maniera non molto dissimile rispetto a quanto avvenuto nel continente asiatico, la regione interna lontana dalle grandi civiltà fluviali, un mondo di savane dove grandi mandrie di mara vivevano in stato brado, alternate a vaste pianure erbose e aridi e aspri altopiani, era abitata da popoli seminomadi, caratterizzati da un rapporto quasi simbiotico con le proprie cavalcature. Esse rappresentarono per secoli il terrore dei Rièt, con la loro forza d'urto, la loro prodezza militare e la loro grande mobilità. Prevenire scorrerie sul confine settentrionale e nord-orientale fu un cruccio costante dell'impero, mai veramente risolto. Naturalmente, i Rièt non disdegnarono l'impiego di alcuni clan all'interno del loro stesso esercito, con le conseguenze che possiamo immaginare, ovverosia, da un lato la loro progressiva 'kaemhizzazione', dall'altro, tuttavia, la penetrazione nell'impero e il popolamento da parte di stirpi barbare di numerosi territori di confine. In diversi casi, non diversamente dall'impero romano o cinese, generali ambiziosi scalarono i gradini delle gerarchie militari, fino ad arrivare a conquistare il potere centrale e, in taluni casi, divenire essi stessi imperatori (anche se non furono mai in grado di creare dinastie durature). I cronisti imperiali citano fondamentalmente quattro stirpi barbare del nord, ma non sappiamo con esattezza i loro 'gradi di parentela reciproca' e abbiamo persino difficoltà a collocarli geograficamente e cronologicamente (anche perché sussisteva la pervicace tendenza nella letteratura a 'chiamare tribù nuove con nomi vecchi').
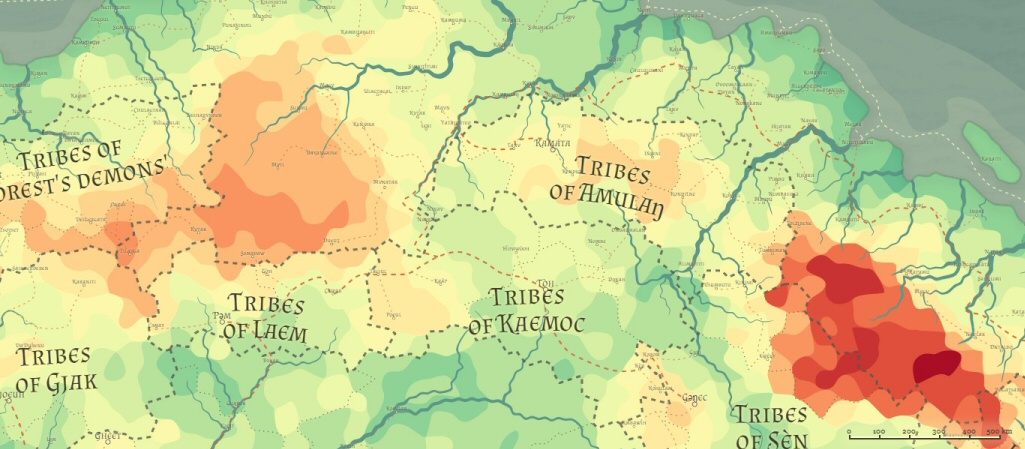
I più importanti, perlomeno dal punto di vista delle nostre fonti, furono senza dubbio i Laem. Essi controllarono per un lunghissimo periodo la principale via di comunicazione dell'impero con il mondo esterno, lungo l'alto corso del fiume Pah. Sulle loro origini, attualmente vi sono numerosi dilemmi, ma i già citati Nòomsiec e Rulam(che continua la sua opera) non sembrano avere dubbi:
I Laem, stirpe bellicosissima, sono in realtà frutto della mescolanza di due popoli. Una parte del loro sangue è degli antenati dei grandi Pah che rifiutarono di migrare verso il delta del Kaemh con il loro gran re e preferirono rimanere nelle loro terre ancestrali. Riottosi e testardi nei confronti degli ordini del loro sovrano, rimasero dove si trovavano. Tuttavia furono influenzati e, infine, si unirono a una parte dei discendenti dei Kaap, che fuggirono verso nord quando le loro case furono conquistate e invase – quale strano gioco di quiete e movimento – dai Pah stessi. Il nome di Laem deriva dal loro mitico re, che decise di dare nuove leggi e ordinamenti e voltare le spalle alle passate origini e parentele. Quando noi Rièt arrivammo ad ereditare le terre dei Kaap e dei Pah, essi non vollero avere niente a che spartire con i loro antenati e scioccamente preferirono rimanere a noi estranei e nemici.
Al giorno d'oggi i più sono scettici nei confronti della ricostruzione antica. I Pah nacquero come civiltà fluviale e, sebbene abbiano compiuto una progressiva migrazione verso sud, il territorio di confine tra savana, steppa e colline non era abitato da loro. Al limite è possibile che, come gran parte dei Pah si mossero verso sud, una porzione migrò invece verso settentrione, ma decisamente tardi, al più presto nel secondo secolo avanti Cristo, in concomitanza con il loro declino a spese degli stessi Rièt. E' molto probabile, pertanto, che la storia dell'origine Pah dei Laem sia un tentativo posteriore di nobilitazione. Rulam scrive in un'epoca (inizio del terzo secolo dopo Cristo) in cui era piuttosto normale vedere cavalieri del nord dimorare nella sua città (e regione) natale, Grèes. Oltretutto, va detto che vi furono degli imperatori di ascendenza laemita tra secondo e terzo secolo, motivo per il quale non è peregrino supporre che si volesse creare il mito di una discendenza 'nobile' per giustificare le proprie pretese di governo.
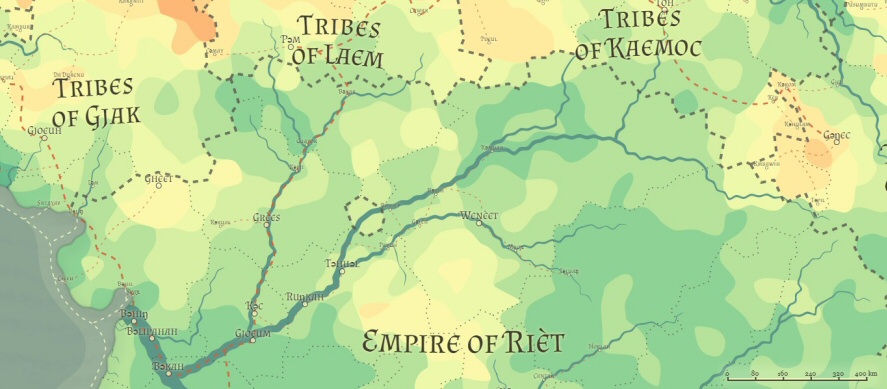
Il popolo 'cugino' dei Laem, con i quali confinavano a oriente, sono i Kaemoc. Sappiamo decisamente meno su di loro, in quanto entrarono nella 'grande storia' dell'impero Rièt molto più tardi. Il primo a nominarli fu proprio Rulam, nel passo già citato in cui vengono portate testimonianze sugli Amulann. Se i Laem venivano considerati in qualche modo barbari 'semicivilizzati' i Kaemoc hanno una reputazione certamente peggiore. Reputazione che non farà che scendere nel periodo immediatamente successivo , dato che nel 260 d.C. Circa, i Kaemoc (o un popolo proveniente dalle stesse zone a cui venne dato il medesimo nome, occorre sempre fare questa precisazione) misero in atto ciò che Rulam temeva: approfittando delle divisioni in seno all'impero, il governatore secessionista di Kəmuar li userà come mercenari per conquistare il principale centro del nord-est dell'impero, ossia la la grande città di Wenèet, e metterla a sacco. Non che il 're' Boeuloeuk, poté godere a lungo del suo successo. I Kaemoc si ribellarono al suo controllo, fondarono un loro regno proprio incentrato su Wenèet, facendo pace con l'imperatore Rièt Boetam II (che dovette fare buon viso a cattiva sorte), per poi sconfiggere e uccidere Boeuloeuk (e saccheggiare anche Kəmuar, che però, al contrario di Wenèet, non si riprenderà mai più). A partire dal IV secolo, il termine 'Kaemoc' iniziò a essere usato in senso territoriale, invece che etnico per la regione tra la riva sinistra del fiume Soelah e quella destra del Gjeh; ironia della sorte, i territori oltre la riva sinistra del fiume Gjeh, da cui originariamente provenivano i 'Kaemoc etnici' vennero invasi da altri popoli, prima i Sèn da est e i Tagjul da ovest (questi ultimi imparentati con i Laem), infine, da nord, i Koele e i Lanuma.
Affascinanti e misteriose furono le tribù Gjek. Situate a nord-ovest dell'impero Rièt, vengono citate spesso con il termine di 'popolo dei cantori' e 'flagello dei Pah'. Secondo le leggende tramandate nella cronaca degli antichi giorni, Un neonato regno Pah (quindi la storia si dovrebbe collocare nel V o addirittura VI secolo avanti Cristo) organizzò una campagna verso occidente, al fine di sterminare i cosiddetti 'cantori'. Perirono molti Gjek, ma una donna – una sorta di capotribù sciamana – di nome Koenit chiese udienza al gran re dei Pah. Quest'ultimo pensava che venisse a discutere nella sua tenda i termini della resa, ma con grande sorpresa, ella disse:
Noi non possiamo perire, gran re. Il nostro compito è di testimoniare. Periremo, quando sarà tempo, come tutti. Ma la voce è ancora debole, per cui è troppo presto. I tuoi, piuttosto, periranno, qui, ora. Non hanno causato male se non quello che tu hai ordinato loro di fare, pertanto moriranno esenti da colpe... Ciò nondimeno per la tua brama di estinguere la verità, essi dovranno tutti morire perché essa si diffonda.
Il giorno dopo, una grave epidemia si sparse presso l'accampamento dei soldati del gran re dei Pah, stando alla storia. Egli fuggì prima a Grèes, poi a Tǝhuǝl, dove decise di dimorare per il resto dei suoi giorni.
Chiaramente la storia deve essere presa per quello che è, essendo stata scritta più di tre secoli dopo il presunto evento. Quel che si desume è che per i Rièt la terra dei Gjèk e i suoi abitanti (altamente dubitabile che fossero le stesse popolazioni a dimorare lì per settecento e più anni, ma il nome era ormai associato agli abitanti di quella regione) avevano un che di 'sacro e magico'. Questa sorta di superstizione indusse l'impero a non tentare mai una vera conquista di quel territorio. In quanto considerati come portatori del culto di Tjǝk e Rǝt nella regione del Kaemh, i Gjak, per proprietà transitiva erano forse considerati messaggeri degli dei stessi e, pertanto, intoccabili. Ghèet, la città carovaniera più occidentale dell'impero, al confine con la 'terra dei Gjak' divenne essa stessa un importante centro di culto, con una prolifica scuola teologico-filosofica. Diversi imperatori garantirono facilitazioni commerciali e donazioni ai templi di Ghèet, che ne garantiranno una consistente ricchezza e finanche una certa autonomia amministrativa.
Questo però dice poco di chi effettivamente abitasse le terre tra il confine occidentale dell'impero e la penisola nord-occidentale della Magellania. Per certo sappiamo che a Ghèet si parlasse, assieme allo Huaek come lingua dell'amministrazione imperiale, un dialetto proprio con forti influenze non austroasiatiche, certo proveniente dalla regione del Layam. Al contrario di molti basiletti dell'impero di questo abbiamo notizia proprio grazie al fatto che diversi testi sacri vennero composti in questa lingua, che quindi, per quanto inferiore a quella ufficiale, aveva pur una sua dignità letteraria. Con le successive invasioni Malay, l'etnografia della regione fu completamente stravolta, ma analisi genetiche sui resti nei tumuli ritrovati ci confermano come quella zona fosse abitata da un popolo prevalentemente austroasiatico, di fatto strettamente imparentato a tutti gli abitanti del corso dei fiumi Pah, Gjeh e Soelah, così come ai seminomadi del nord (mentre i popoli del Kaemh hanno una parentela più lontana). Non mancano tuttavia, con l'andare del tempo presenze percentualmente sempre più rilevanti di aplogruppi tipicamente esistenti nella penisola nord-occidentale, che mostrano come, nel corso dei secoli, gli equilibri etnici di quella regione tendano a mutare, anche se non sappiamo di preciso per quale ragione (anche se sicuramente è indipendente rispetto all'espansione marinaresca degli austronesiani del sud).
Da ultimo, non possiamo terminare la nostra sintetica panoramica senza citare le popolazioni dell'arido e roccioso entroterra orientale, i Sèn e i Siembar. Sui primi abbiamo – e non è una novità, purtroppo – poche quanto frammentarie informazioni, ancora inferiori rispetto ai loro vicini occidentali, i già citati Kaemoc. Questa scarsità ci deriva dal fatto che le loro interazioni con i Rièt furono molto scarse. Da Rulam sono appena citati come popolo selvaggio e crudele, che vive ai piedi delle montagne nel lontano nord. Poche altre notizie ci derivano dai resoconti di viaggio di Utoluki il Lanuma, di Wenèet, del tardo IV secolo dopo Cristo. La sua è un'era molto lontana dalla massima gloria dell'impero dell'epoca di Noomsièc e dal pur grande e potente Rièt 'imbarbarito' di Rulam. Del resto, egli stesso è un 'barbaro', anche se ormai ampiamente sedentarizzato: i Lanuma, di cui parleremo più estesamente nei capitoli successivi, sono uno dei primi popoli chiaramente austronesiani che faranno capolino nelle città settentrionali del (ormai diviso) impero dopo aver attraversato i monti degli Amulann e, appunto, dei Sèn. Il discorso sulla durezza e crudeltà di questi ultimi ci viene da Utoluki ribadito, ma arricchito di particolari macabri:
I Kaemoc tengono i Sèn in sdegno, considerandoli barbari crudeli che sanno solo andare a cavallo e mangiare carne cruda, ma, a dire il vero, Goennec, la capitale della loro signoria, non ha nulla a che invidiare, in ricchezza, a questa nostra Wenèet. Si trovano merci provenienti dal sud, dal nord, dall'ovest e dall'est. Sicuramente derivata da saccheggi e violenze, non lo metto in dubbio, e non procurate onestamente. Quando i miei antichi padri giunsero per primi nel loro territorio, dopo aver attraversato le impervie e boscose montagne, piene di mostri e demoni, essi risero della loro miseria e chiesero un tributo di sangue se volevano proseguire il loro viaggio. Essi si nutrivano infatti di carne umana e quella dei nostri infanti piacque a loro particolarmente. Raccontano i nostri vecchi che piegammo a questa loro richiesta e venimmo 'ospitati' da loro per diversi anni, trattati come schiavi e costretti a dar loro nutrimento con la carne della nostra carne. Finalmente vi fu una grande ribellione e ci vendicammo del sangue versato. Potemmo giungere alle fertili terre a settentrione del grande Gjeh e ivi costruirci una nuova casa.
E' pressoché certo che quella di Utoluki fosse un'esagerazione prospettica, che dipingeva il suo popolo come i 'buoni' mentre i Sèn erano perfidi e crudeli, ma ben ci mostra l'inizio di un grande ciclo di invasioni e arrivo di nuovi popoli che durerà secoli e che ribalterà l'assetto etnografico del continente, rispetto al mondo 'statico' dell'impero Rièt.
Sui Siembar, invece, abbiamo una conoscenza maggiore. Innanzitutto essi vengono considerati dai Rièt – caso pressoché unico – come un 'regno' vero e proprio, e non semplicemente come dei barbari senza leggi. Siamo a conoscenza di trattati commerciali tra l'imperatore Doekah e il principe di Siembar nel 110 d.C. Circa. Poiché solitamente gli imperatori non 'trattavano', ma 'concedevano', il tutto risulta particolarmente sorprendente. I Siembar erano probabilmente imparentanti dal punto di vista etnolinguistico con i Sèn e insieme a loro rappresentano – non contando i Brih e i loro epigoni - il terzo ceppo propriamente austroasiatico del continente, detto Coeruico (dall'altopiano di Coeruh) assieme al gruppo Kaemhitico e al gruppo Gjehtico (ovverosia quello dei Pah, dei Laem, dei Kaap e dei Kaemoc, per citare i popoli già menzionati).
Numerosi mercanti di Rièt attraversavano la scoscesa via che portava sino a mille metri di altezza, fino a Sntaŋ, la capitale del regno. Ciò che evidentemente preservò a lungo la vita di questo stato fu il fatto di essere situato in cima ad un altopiano roccioso di difficile accesso, alla cui sommità, tuttavia, si aprivano una serie di oasi verdeggianti. Si trattava per forza di cose di uno stato pacifico, senza troppe velleità guerresche, che si faceva forte della sua imprendibilità per mantenere relazioni pacifiche con le tribù confinanti e con il poderoso impero Rièt a occidente. Una cosa veramente sorprendente che ci è stata tramandata di Siembar è che si trattava di una società fondamentalmente matriarcale, fatto che i mercanti di Seguh trovavano piuttosto sconvolgente (sebbene la società imperiale non si potesse definire esageratamente maschilista).
Stando alle descrizioni, 'Siembar' era sia il nome del popolo, sia il nome che veniva dato alla 'regina-sacerdotessa', come per tramandare l'idea una figura monarchica eterna che si identificava in tutto e per tutto come lo spirito della propria gente, e che semplicemente si reincarnava in un'altra forma. I Siembar, sempre secondo i racconti tramandatici, erano pervicacemente impervi all'insegnamento della religione diadica, mantenendo una propria religione, di cui non sappiamo nulla, se non che era officiata da sacerdotesse. Purtroppo, per lungo tempo mancarono – e certo dovevano essercene – fonti interne sulla storia del regno, tanto da non sapere nemmeno il periodo esatto in cui nacque e, tanto meno, quello in cui crollò. I mercanti smisero di passare da Sntaŋ, che pare dunque sparita tra le nebbie della storia. Solo monumentali rovine a una ventina di chilometri dalla città di Coeru-Nili.
Perlomeno fino alla scoperta, nel 1921, delle 'tavole di Doeròh'. Esse, scritte in gran parte in una variante orientale della lingua Huaek, risalgono al principio del III secolo dopo Cristo. Esse vogliono essere la storia dell'ultimo periodo del regno di Siembar e, probabilmente, erano parte di un progetto più comprensivo.
La storia che narrano è decisamente poetica e struggente: la città di Sntaŋ venne colpita da una grave epidemia che ne decimò la popolazione. La situazione si fece politicamente caotica e la casta dei guerrieri (prevalentemente maschile) attuò un colpo di stato, per destituire coloro che, evidentemente, non servivano più, ossia le sacerdotesse (visto che gli dei li avevano abbandonati).
Per evitare inutili spargimenti di sangue, l'ultima Siembar decise di cedere volontariamente il potere, anche se ciò non sortì l'effetto sperato: il governo della casta militare, da tutto il popolo inizialmente acclamato come salvifico, mostrò presto i suoi rovinosi effetti. In particolare, i generali organizzarono l'attacco ai confini orientali dell'impero Rièt, allo scopo di razziare risorse vitali per risollevarsi rapidamente dalla crisi. Il conflitto si risolse in una disfatta, ma l'impero Rièt si 'accontentò' di un controllo economico più stringente e la riduzione in schiavitù di ostaggi eccellenti dell'establishment politico dei Siembar... Vale a dire le sacerdotesse. I generali infatti fecero cadere sulla Siembar, ormai de facto priva di ogni potere, la responsabilità del conflitto.
Molti, che ormai avevano in odio i militari, organizzarono una violenta ribellione, che tuttavia venne repressa nel sangue. Frattanto, la Siembar e la sua corte vennero trasferite nell'impero e finirono nel gineceo dell'imperatore, in cui, però, il loro trattamento non fu particolarmente benevolo (tanto che a quanto pare la sovrana meditò di togliersi la vita). E' proprio la parte sulla 'vita nell'harem' che, a differenza delle altre, forse per non essere letta da occhi indiscreti, fu scritta in quella che a tutti gli effetti è un'altra lingua, evidentemente quella nativa dei Siembar, anche se in caratteri Huaek (tradotta in maniera soddisfacente e con molteplici sforzi della comunità scientifica solo nel 1943). L'ultima parte, nuovamente in lingua imperiale, narra di come la regina e le sue ancelle vennero infine 'liberate' e poste in una sorta di arresti domiciliari a Doeròh, cittadina sul confine orientale, dove vissero una vita sostanzialmente molto modesta. Tuttavia, un numero sempre crescente di Siembar decise di migrare dall'altopiano e trasferirsi proprio a Doeròh, dove si formò una folta comunità di esiliati.
Il testo termina qui e non sappiamo quanto fu importante tale comunità per la storia successiva della regione (anche se alcuni storici, a seguito della scoperta, sembrano propendere per una risposta affermativa). Quel che è certo è che questo toccante diario intimo sulla vita della sfortunata sovrana, di cui mai sapremo il nome proprio, oltre ad essere divenuto una delle più studiate e amate opere letterarie dell'antica Magellania (si sprecano i film e le serie TV su questa storia), ha contribuito a gettare una importantissima luce su questo popolo e sulla sua influenza anche dal punto di vista etnolinguistico.
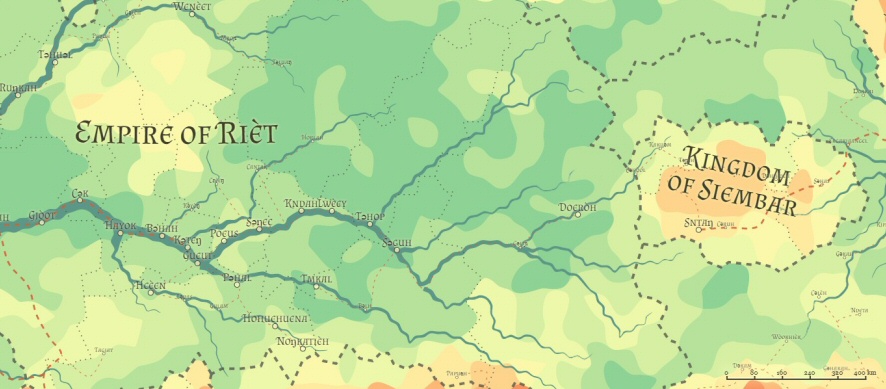
.
5 - Il lungo 'medioevo' magellanico
5.1 Il nord – ovest: porta o confine?
E' opinione piuttosto comune che la penisola Layamica sia stata la principale via di collegamento tra l'Asia e la Magellania. Molti sono tuttora convinti che tutte le influenze culturali esterne che il continente ha ricevuto (o subito, secondo alcune interpretazioni) siano passati attraverso l'asse Cina – Giappone - Nanpō. Per quanto ciò sia indubbiamente falso, in quanto molteplici e diverse furono le vie di ingresso di Buddhismo, Induismo, Islam e Cristianesimo, è però vero che 'la lunga strada', come viene soprannominato l'arcipelago, ebbe un ruolo determinante nell'evoluzione della società magellanica.
Ciò detto, gli storici che vogliono quantificare più nel dettaglio tale apporto si trovano subito di fronte un grande mistero, che sarà il principale tema dei prossimi capitoli: abbiamo un lunghissimo periodo di silenzio delle fonti dirette dal IV secolo a.C. Al principio del III secolo d.C. Scampoli di testi, legende su unità di misura per il commercio, iscrizioni votive, incisioni rupestri; questo è tutto quello che si ha a disposizione per ricostruire un periodo decisivo. Molti archeologi trovano questa sconcertante povertà di informazioni paragonabile, se non peggiore, a quella che sussiste tra il XV e il XII secolo avanti Cristo in Europa e Vicino Oriente. Si passa da un impero Layam che mostra segni di crisi e fratture a un mondo, mezzo millennio dopo, completamente mutato, in cui il grande impero è solo un ricordo, per di più mitizzato e abbellito dai propri epigoni, mentre popoli completamente nuovi si contendono il predominio della regione. Cosa è accaduto in questo lasso di tempo?
Il modo più semplice, ma spesso inaffidabile, per farsi un'idea è affidarsi a resoconti più tardi. Tuttavia, buona parte di essi vengono redatti a distanza di diversi secoli, il che significa imprecisioni più o meno vistose, sintesi spesso poco chiare e sovrapposizione di personaggi mitici a soggetti realmente esistiti. Il testo fondamentale che funge da base ideologica rimane però sempre lo stesso, ossia il sopracitato canto di Ayona. Precedentemente ci siamo soffermati sul suo valore dal punto di vista letterario, oltre che punto di partenza di una serie di riflessioni teologiche che porteranno il diadismo a divenire il credo principale di buona parte delle civiltà antiche del continente. In realtà, esso non fu semplicemente uno 'spunto'. Divenne infatti la pietra d'angolo per forgiare una sorta di identità collettiva (inizialmente solo mistico-filosofica, poi quasi etnica, come tra poco vedremo) di molte delle popolazioni della regione. Abbastanza paradossalmente, però, forse non dai diretti epigoni del popolo di provenienza dell'autore.
La lingua in cui venne scritta la sua prima versione è la misteriosa lingua dei Nuyn, linguaggio tuttora considerato isolato, ma i cui legami e contatti con altri idiomi sono stati talmente vasti e di lunga durata da essere stato, di volta in volta, associato a numerose famiglie linguistiche. La summenzionata tesi che possa essere imparentato con l'attuale famiglia linguistica Ainu è, come già evidenziato, molto controversa.
Tuttavia, perlomeno dal III secolo dopo Cristo, se non addirittura prima, il canto di Ayona non viene più letto in originale, ma in una versione 'recente', scritta in una lingua differente (abbiamo una copia del IV secolo dopo Cristo che ce lo testimonia). Quale? Si tratta di uno dei tanti dialetti degli... Ayona.
Proprio così, il nome della protagonista di un'opera letteraria è anche il nome che si attribuisce un intero gruppo di popoli, i quali affermano di discenderle.
L'idioma delle versioni recenti in che rapporto si pone con quello del testo originale?
Presto detto, i due linguaggi non sono strettamente imparentati, sebbene vi sia un ampio contributo lessicale di quello più antico nei confronti di quello più moderno. In parole povere, dal Nuyn non deriverebbe direttamente la famiglia linguistica Ayona. Oltretutto, la parentela di quest'ultima con le lingue Ainu è piuttosto incontrovertibile, per quanto sia più complesso stabilire a quale livello specifico (studi più recenti tendono a rigettare l'affermazione 'stessa famiglia linguistica' presente nei vecchi manuali e aderire più alla definizione 'differenti famiglie linguistiche con un – ignoto – progenitore comune').
Secondo il cosiddetto 'modello giapponese' (definito così perché sostenuto in larga maggioranza dagli storici nipponici), quale che fosse il rapporto antecedente tra Nuyn e la cultura Jomon, esso di colpo mutò: i secondi fuggirono sotto la pressione militare e demografica dei nuovi venuti e, a loro volta, invasero le terre dei primi, distruggendone la società, ma, allo stesso tempo, assimilando ampie parti della cultura della società di arrivo.
Come abbiamo già visto quando si parlava dei Nuyn, dietro questo modello c'è sempre lo spettro e lo spauracchio del nazionalismo e dell'imperialismo giapponese, motivo per il quale la sua accettazione, confutazione o correzione è sempre stata al centro di numerose polemiche.
La principale obiezione a tale teoria è che ciò che ci viene narrato del periodo da fonti posteriori non menziona invasioni di portata epocale o ondate migratorie particolari. Gli stessi popoli Ayona sono piuttosto ambigui ed indecisi, nel momento in cui devono descrivere la propria etnogenesi. Da un lato essi riconoscono di non essere affini ai Nuyn, né da loro derivare in alcun modo; dall'altro, però, rivendicano la loro discendenza da Ayona, di fatto negando in tal modo che essa fosse di etnia Nuyn. In più, non vi sono riferimenti netti al loro provenire da terre diverse da quelle in cui dimorano. Per quanto tutto ciò sia in buona sostanza spiegabile come un tentativo di nobilitazione a posteriori delle proprie origini, la base su cui poggia il modello giapponese non è estremamente solida.
Secondo il modello 'magellanico', invece, non vi sarebbe stato alcun sommovimento demografico. Innanzitutto perché le popolazioni Jomon non sarebbero state affatto etnolinguisticamente omogenee al loro interno; secondariamente perché non vi sarebbe stato nessun confine preciso tra i Nuyn e gli altri popoli e nemmeno all'interno delle loro stesse città-stato. Qualsiasi sia stata la loro origine, il significato stesso della parola 'Nuyn' con il tempo era diventato di natura economico-sociale, più che etnico. Il che significa che mentre la casta dominante così si (auto)definiva, negli strati medi e bassi della società urbana che si era venuta a creare nell'antichità, c'era e permaneva una certa varietà, anche linguistica, a noi sconosciuta ma non per questo inesistente. Quando poi la casta dominante crollò (con un processo lento e costante, che a noi sembra improvviso solo per la discontinuità delle fonti), ecco che la luce della 'grande storia' fece emergere dall'anonimato tutto quel sottobosco multietnico di cui anche gli Ayona dovevano (già da secoli) fare parte. Sebbene questa ipotesi sia affascinante, anch'essa non è esente da critiche. La presunta disomogeneità qui ipotizzata, infatti, avrebbe dovuto lasciare, per quanto poche, delle tracce, che al momento semplicemente non ci sono. Banalmente, per quale motivo non abbiamo trovato delle strutture tipiche delle città-stato Nuyn in Giappone? O perché non è mai stato scoperto un dogu a sud del Tropico del Cancro?
Anche in questo caso, lo storico nipponico Hideo Inoue ha elaborato una sua propria teoria 'di mezzo', che per quanto manchi ancora di rilevanti prove a suo sostegno, ha una sua certa plausibilità. Egli infatti sostiene che un aumento del flusso migratorio dal Giappone alla Magellania ci sia effettivamente stato, in conseguenza all'aumento della pressione demografica degli Yayoi. Allo stesso tempo, negare l'esistenza di meccanismi di inculturazione e meticciato tra i vari popoli e ridurre tutto alla diade 'invasione-fuga' sarebbe errato (e implicitamente razzista). Al tempo probabilmente non si percepì una rottura radicale perché flussi migratori in direzione nord-sud c'erano sempre stati, non si trattava di una particolare novità. Del resto, chi migrò? Per il ricercatore nemmeno in questo caso di percepì una totale alterità dei nuovi venuti. Gli Jomon-Ayona non erano alieni: erano già presenti da tempo loro comunità nelle principali città Nuyn e con queste stesse città sussisteva un proficuo rapporto commerciale di lunghissima data. Proprio per questo, non esisteva uno stacco così radicale e netto a livello culturale e materiale tra i vecchi e i nuovi venuti. Tra il 200 avanti Cristo e l'inizio dell'era volgare vi furono conflitti e violenze razziali? Probabile, sarebbe ipocrita negarlo, ma la loro intensità e radicalità andrebbero riportate nelle loro giuste dimensioni. Fece un certo scalpore, soprattutto in patria ma anche all'estero, una tagliente dichiarazione di Inoue nel 2019:
'Se applicassimo il modello giapponese al mondo di oggi tra mille anni, allora sui libri di storia europei troverebbe spazio come ricostruzione veridica la delirante teoria di Gerd Honsik sul presunto piano Kalergi'.
Lo storico, tuttavia, evita di esprimersi in maniera altrettanto precisa a riguardo del contributo che ebbero in questo i proto-giapponesi. Sostiene infatti che quanto di tutto questo fosse causa diretta o indiretta dei cosiddetti Yayoi sia troppo difficile da stabilire, anche se, a livello del tutto personale, tende a credere nell'idea che gli Ayona potrebbero essere stati degli
Jomon “nuynizzati” che nel frattempo stavano già iniziando a “yayoizzarsi”, se mi passate l'infelice espressione.
La teoria di Inoue, tuttavia, non è esente da difetti. Il problema principale è l'apparente inspiegabilità relativa al mantenimento della lingua originaria da parte dei nuovi venuti. In pressoché tutti i fenomeni di inculturazione, gli immigrati, presto o tardi, tendono inevitabilmente ad assimilare anche la lingua della cultura di arrivo, specialmente nel caso – ed è questo – essa sia di maggiore prestigio. Quindi perché gli Ayona avrebbero dovuto mantenere il proprio idioma e, anzi, soppiantare quello precedente come lingua veicolare maggioritaria nella regione?
Un tentativo di replica a tale obiezione potrebbe provenire da una attenta analisi dei fattori religiosi in gioco. Per arrivarci, però, occorre prima fare un passo indietro e soffermarci ancora una volta sulla genesi della religione diadica.
La realtà è che le sue origini sono ancor oggi difficili da dipanare. Sembra paradossale che quella che ancor oggi è considerata una delle grandi religioni (o piuttosto, filosofia di vita: occorre sempre ricordarsi che la stragrande maggioranza delle correnti diadistiche è più da vedere e concepire come il Confucianesimo, il Daoismo e, in parte il Buddhismo, che non come Islam e Cristianesimo) dell'umanità ed è tuttora praticata da milioni di persone nelle sue diverse correnti abbia dei punti così oscuri, eppure è così. Tradizionalmente, come peraltro già accennato, si attribuisce la sua prima nascita nell'impero Layam, in cui due divinità emersero su numerose altre come principali all'interno di un ricco e variegato panteon. Il Canto di Ayona in questo senso rappresenterebbe la svolta verso il diadismo vero e proprio, in cui i due dei iniziano ad incarnare attributi morali e filosofici sempre più ampi e metafisici. Eppure da questo punto in avanti, il percorso diventa assai complesso da ricostruire. Dal IV secolo avanti Cristo infatti conosciamo l'evoluzione del Diadismo nella valle dei Kaemh e dei suoi affluenti, ma non lì dove dovrebbe essere nato. Sicuramente deve aver avuto uno sviluppo autoctono, tanto che nel V secolo dopo Cristo, già si ha la netta coscienza dell'esistenza di una 'via meridionale' o, come più tardi sarà chiamata 'via della conoscenza', corrispondente al diadismo diffusosi nell'impero Rièt e una 'via settentrionale o 'via dell'ignoranza', corrispondente alle scuole diadiche della penisola layamica e in generale del nord-ovest.
Se nella prima l'esatta proporzione tra quiete e moto è vista come un valore intrinseco da perseguire per stabilire l'armonia cosmica, nella seconda non vi è nessuna pretesa né speranza che l'uomo possa sapere in anticipo o tantomeno calcolare tale proporzione. L'acquisizione della pace e della felicità starebbe dunque nel 'muoversi come le onde del mare', sapendo adattarsi all'intrinseca e imprevedibile mutevolezza della realtà. La via dell'ignoranza, tuttavia, non è riconducibile completamente ad una sorta di fatalismo stoico, perché la diade è saggia, in quanto ignora e ignorando ama, come recita una famosa preghiera; in altre parole, i due dei volutamente non desiderano conoscere o calcolare le conseguenze del loro 'eterno gioco amoroso'. Ciò implica che – al contrario della via meridionale – non sussiste alcun sospetto di determinismo fatalista, anzi sta al coraggio dell'uomo buttarsi piuttosto a capofitto tra le mutevoli onde per cogliere la felicità (intesa però comunque come pace ed equilibrio, in questo senso le due vie sono analoghe).
Tornando al discorso più prettamente storico-letterario, desta particolare interesse il fatto che la versione posteriore del canto di Ayona non sia una mera traduzione del testo originale, ma giochi su terminologia e sintassi per accordare più strettamente il messaggio del testo alla corrente teologico filosofica dominante. Tirando le somme di questa operazione piuttosto evidente, ecco che emerge una possibile ragione per cui a medio-lungo termine la lingua dominante sia diventata quella degli 'immigrati' e non l'acroletto preesistente: una precisa corrente religiosa, che in un determinato lasso temporale tra il IV e il I secolo a.C. Dovette essere nuova, trovò diffusione e popolarità presso le popolazioni di recente immigrazione. Chiaramente ciò non significa necessariamente che i Nuyn rimasero ancorati alle vecchie tradizioni, tanto da scatenare conflitti di natura religiosa che li videro perdenti; semplicemente, significa che il clero e i testi sacri di questo nuovo culto iniziarono presto a essere scritti ed esprimersi in una lingua piuttosto che in un'altra. Chiunque volesse approcciarsi al nuovo credo sentì sempre più il bisogno, a prescindere dal popolo di appartenenza originario, di comprendere il messaggio nella lingua in cui era comunicato. Anche questo, però, forse non sarebbe comunque bastato per ottenere il mutamento di acroletto: è dunque possibile che, nel giro di un secolo o più da questa prima fase, qualche rappresentante del potere politico abbia fatto pubblica professione di fede o, comunque, una sorta di endorsement ad essa, tale da rendere desiderabile anche alle classi più elevate non solo la religione in sé, quanto tutti i prodotti culturali ad essa correlati. Per quanto convincente come ricostruzione (sostenuta peraltro dallo stesso Inoue), non sono però state ancora ritrovate prove che la possano dimostrare. Ulteriore ipotesi, anch'essa al momento inverificabile (e forse influenzata dal senno del poi, come poi si capirà), vuole un conflitto di natura religiosa dovuto alla prima diffusione in Magellania del buddhismo, che verrebbe in questo caso retrodatato di più di mezzo millennio (tradizione vuole che l'arrivo del buddhismo si collochi infatti tra il VI e VII secolo dopo Cristo). La reazione tradizionalista sarebbe in questo caso paradossalmente venuta non dai Nuyn, aderenti al nuovo credo, ma dagli Ayona, che alla fine avrebbero avuto la meglio e cancellato la prima ondata di monaci Mahayana sul continente.
Sia come sia, non dobbiamo dimenticarci comunque alcune linee di sviluppo successive. Innanzitutto, sebbene scalzati, i Nuyn non scomparirono del tutto, dando vita ai due gruppi etnolinguistici dei Noe (a loro volta divisi nei Bora dell'isola di Toyana e i Megü di capo Bgö), noti per la loro abilità di infaticabili e astuti mercanti e degli Örga (anch'essi a loro volta suddivisi nei Daalban dell'omonima regione e nei Gorana, sparsi in molte comunità costiere del nord-ovest). In particolare, ancora nel X secolo questi ultimi daranno vita a un temibile principato talassocratico.
In secondo luogo, non bisogna nemmeno dimenticare che la coscienza identitaria comune degli Ayona come unici depositari dell'eredità della mitologica regina di cui portavano il nome, andò progressivamente scemando nei secoli, con l'aumentare delle diversità e delle rivalità al loro interno. Giusto per fare un esempio, già intorno all'VIII secolo dopo Cristo, tra i Kemoy delle isole e gli Ehdan della terra ferma si percepiva irriducibile diversità; a propria volta, tra questi ultimi, i vari clan del Capo, i Nin dell'interno e i gruppi più a oriente ebbero tra di loro secolari conflitti che in seguito analizzeremo maggiormente nel dettaglio.
La situazione, già di per sé complessa da dipanare, si complicherà ulteriormente con l'arrivo del popolo che gli Ayona chiamerà 'Maqu'. In altre parole, gli Yayoi dal Giappone. Chi erano veramente? Che parentela vi è tra i Maqu/Mako e gli antichi Giapponesi? Come si correla la nascita dell'impero giapponese a questi migranti verso sud?
5.1.2 Himiko svelata
Per quanto sia geograficamente, sia temporalmente, si tratti di un testo molto lontano da ciò che qui si intende illustrare, l'obbligato punto di partenza per rispondere alle domande con cui abbiamo concluso il precedente capitolo e per una migliore comprensione del periodo è il Nihongi, la principale cronaca dell'antico Giappone, risalente al VIII secolo d. C. Molti studiosi infatti, ritengono esista un collegamento tra la storia del Giappone dei primi secoli dell'era volgare e quanto accadde nel nord-ovest del continente magellanico.
Come già detto in precedenza, l'interpretazione degli storici nipponici si basa in gran parte sul paradigma 'conquista e fuga': l'espansione della cultura Yayoi dall'isola di Kyushu verso Honshu avrebbe sospinto i popoli autoctoni (Jomon) verso nord e verso la Magellania attraverso le Nanpō. Secondo tale principio, i secoli bui del nord-ovest magellanico sarebbero spiegabili semplicemente con il crollo a catena della città Nuyn prima e dell'impero Layam dopo per la pressione demografica dei fuggitivi dall'arcipelago giapponese. Infine, sarebbero arrivati anche gli Yayoi stessi, insediandosi e conquistando. Al contrario, però, rispetto alla madrepatria, essi non sarebbero riusciti ad imporsi in misura tale da annientare gli elementi etnolinguistici preesistenti, ma solo quel tanto che bastava da sviluppare una piuttosto limitata presenza e influenza culturale.
Tale ricostruzione, naturalmente, è accolta con una certa freddezza dalla gran parte degli studiosi magellanici, che peraltro si fanno forti delle recenti ricostruzioni – anch'esse già citate – di Blust sull'apporto delle lingue austronesiane nella toponomastica dell'arcipelago giapponese con o senza intermediazione di lingue proto-Ainu. In tale contesto, dirimente sembra capire chi fosse la famosa principessa-sciamana Himiko, citata in diverse occasioni dalle fonti cinesi come sovrana di un grande e potente regno, tra i tanti che affollavano l'arcipelago nipponico agli inizi dell'era volgare.
Poiché le date delle fonti non collimano tra loro, al giorno d'oggi si tende a pensare che Himiko, più che un nome di persona, rappresentasse una carica (sacerdotessa del sole). Giunti al VIII secolo, i sovrani di Yamato avevano ormai una discreta conoscenza delle fonti cinesi e, forse, inserirono tale fantomatico personaggio nelle loro genealogie reali sotto altro nome. Nessuno mise in dubbio, praticamente fino ai giorni nostri, che Himiko fosse Yayoi, quindi 'giapponese'. Del resto, l'altra grande opera del Giappone antico, il Kojiki, parla diffusamente di Amaterasu, divinità solare femminile; quindi che presso la cultura Yayoi le donne rivestissero un importante ruolo sacerdotale legato al sole pareva un'ovvietà.
Solo recentemente, l'ondata revisionista sulla storia delle identità di genere ha portato a sollevare la questione delle origini del sostanziale maschilismo nella società nipponica. Esso sarebbe stato quindi una conseguenza successiva del suo sviluppo in senso militare, mentre in origine le donne detenevano gerarchicamente un ruolo prestigioso come tramiti con le divinità? La diatriba, in sé di importanza piuttosto relativa, ha però risvegliato un'altra, ben più spinosa questione, ovverosia se lo sciamanesimo femminile non fosse un attributo autoctono, ma originario di altre culture con cui gli Yayoi entrarono in contatto.
Tale questione portò a una ulteriore quanto semplice constatazione: il più bel componimento della storia antica dell'intera Magellania, il succitato canto di Ayona, ha come protagonista una donna che, di fatto, oltre ad essere una principessa, ha un rapporto molto stretto con le divinità. Anzi, a ben vedere, ne diventa l'interprete privilegiata. Quando lo studioso magellanico K. Tikir, nel 2003, pubblicò uno studio volto a sostenere l'ipotesi che il mito di Amaterasu potesse essere in realtà basato su un racconto preesistente, presumibilmente di origine proto-austronesiana, poi passato ai Nuyn e quindi agli Ayona/Jomon e solo da ultimo agli Yayoi, ottenne una indignata levata si scudi da parte degli storici nipponici. La grande maggioranza di essi propose che, semmai, fosse il contrario, vale a dire che il mito della dea solare sia stato successivamente trasposto e modificato da altri popoli.
Chiaramente, la diatriba trascendeva i confini storici, andando a toccare nervi ideologici molto delicati. Ammettere la derivazione del mito di Amaterasu da tradizioni non autoctone avrebbe implicato infatti una sostanziale delegittimazione della stessa famiglia imperiale nipponica (che per secoli affermò di discendere dalla dea per tramite dei primi imperatori) e, a latere, di una discreta parte delle tradizioni storiche e religiose del paese. D'altra parte, affermare il contrario (cioè che sia il canto di Ayona a derivare dal mito di Amaterasu) avrebbe potuto essere inteso da taluni come un gettare discredito sul diadismo magellanico, per quanto sia essa una religione meno ancorata a miti fondativi e più a riflessioni filosofiche.
Per quanto esigua minoranza, vi furono tuttavia esperti giapponesi che accolsero con interesse le ipotesi di Tikir e, anzi, decisero di approfondire il tema.
Tra tutte, divenne particolarmente nota la ricercatrice T. Aisaka, poi autrice del celebre saggio-romanzo In viaggio alla ricerca di Himiko.
Il suo 'viaggio' partì dalla tesi di due cronisti nipponici, ossia Kitabatake Chikafusa nel XIV secolo e Arai Hakuseki nel XVII secolo, i quali affermano che 'la vera Himiko' stia nel mito di Jingū, imperatrice consorte del 14esimo imperatore, Chūai, e reggente per il successore, il figlio Ōjin. Per loro, il Nihongi avrebbe cercato di sincronizzarsi con le fonti cinesi (che appunto, come unico sovrano degno di nota del popolo Wa, citavano Himiko, non il primo imperatore Jmmu o alcuno dei suoi eredi) che, essendo modello di perfezione, non potevano mentire. Secondo il mito, Jingu dopo la morte del marito avrebbe conquistato in una campagna militare lunga tre anni, in nome di Yamato, una terra lontana di là dal mare, anche se le fonti non ci parlano affatto dell'ubicazione di tale territorio e come avrebbe fatto fisicamente a raggiungerlo. L'ipotesi più accreditata fu per secoli che l'oggetto delle conquiste di Jingu fosse la Corea sud-occidentale. La prova di ciò si sarebbe trovata sulla cosiddetta stele di Gwanggaeto, che secondo gli storici nipponici avrebbe descritto le campagne militari di un re del regno coreano settentrionale di Goguryeo (Gwanggaeto, appunto) contro degli invasori meridionali provenienti da oltremare – per logica conseguenza, giapponesi. Tale interpretazione fu smentita in diverse occasioni e ancor oggi è ampiamente controversa, visto che, a seconda di dove si inserisce la punteggiatura, lo scritto può avere significati differenti. Del resto, la stele stessa è incompleta (e gli storici coreani sono stati a lungo convinti di un interessato danneggiamento doloso da parte dei giapponesi per distruggere la parte di testo che avrebbe fatto chiarezza ).
Aisaka e il suo team di ricerca non furono i primi a ragionare sulla possibilità che il mito di Jingu parlasse di una terra posta a sud e non a nord e che, quindi, si trattasse della penisola Layamica. Furono però i primi che, sulla scorta del saggio provocatorio di Tikir su Amaterasu, studiarono la possibilità che il racconto sull'imperatrice reggente presente nel Nihongi (o, forse, nelle due fonti su cui l'autore del Nihongi afferma di basarsi, ossia il Kokki e il Tennōki) si basasse su redazioni successive del canto di Ayona. In particolare, la sua ricerca si soffermò sui tanti commentari scritti sul canto dai diversi filosofi diadici tra il VI e il XII secolo. Fu infatti in questo periodo che il poema venne considerato come un vero e proprio libro sapienziale e oggetto di studio e meditazione, probabilmente per reazione/imitazione del nascente buddhismo magellanico.
Il team di studiosi giapponesi trovò la prova decisiva quasi per caso. L'opera Sulla necessità delle emozioni di Gara di Ukunin, risalente al V secolo dopo Cristo, non era (e non è tuttora), per quanto molto nota nel panorama teologico del diadismo, considerato un commentario del canto di Ayona, trattandosi di un'opera filosofica a sé stante che, piuttosto, analizza e rielabora i concetti trasmessi dalla 'via della conoscenza' (come già esposto, così solitamente vengono definite le correnti sorte nell'impero Rièt)1, per questo motivo venne inizialmente ignorato. E' tuttavia effettivamente presente un breve passaggio in cui Gara affronta il tema del canto, o meglio, del suo autore:
lo strabico cantore tace sul figlio di Ayona. Dal seme di chi essa concepì? Quali gesta compì la sua progenie? Noi non sappiamo. Eppure, tutti, qui nel nord diamo credito al mito che suo padre non fosse un dio, ma un re mortale, il quale, tuttavia, presto perì, lasciando sola la principessa della stella. Sorse però dibattito tra Tyuka e Ratuyna su quale dei due dei dovesse concedere la sua benedizione alla creatura. E nell'indecisione passarono tre estati.
Furon gli anni che il cantore ci descrive, per Ayona, di guerra e conflitto in lontani paesi oltremare. Ella sentiva crescere il figlio nel grembo, ciò nonostante seguitava a combattere per trovar pace, senza riuscirvi.
Infine il giovane principe nacque benedetto da entrambi gli dei, ma, a cagion di ciò con gli occhi storti. Ebbene sì, ogni uomo e donna, finanche i fanciulli, qui da noi tramanda e crede alla storia che lo strabico cantore altri non sia che il figlio di Ayona, per tre lunghi anni cresciuto nel suo ventre.
Oltre al tema della invasione di terre oltremare da parte della principessa guerriera, troppo generico per essere veramente determinante, nel testo appena citato è contenuta una precisa narrazione dell'insolito periodo di gestazione del figlio – postumo – di Ayona che corrisponde esattamente ai tre anni tra il concepimento e la nascita di Ōjin, figlio postumo di Chūai e Jingu.
La dottoressa Aisaka giunse dunque alla inevitabile conclusione che il mito di Jingu era mutuato con ogni verosimiglianza dalle leggende costruitesi intorno alla figura di Ayona. Restavano però da chiarire meglio le ragioni e le modalità con cui era avvenuto tale prestito culturale; inoltre, restava da capire chi era (o erano) davvero Himiko: possibile che delle reali vicende storiche siano state descritte prendendo a prestito dei topoi letterari all'epoca noti?
La ricercatrice nipponica prese in considerazione sostanzialmente due alternative. La prima, se vi fossero fonti, in Magellania nord-occidentale, che riportano notizie di una invasione vera e propria proveniente dal Giappone (le isole di Amaq, come sono solitamente definite a partire dal X secolo); la seconda, se esistono documentazioni di invasioni dalla penisola Layamica verso le Nanpō e verso Amaq.
Il problema principale della prima opzione era che tra il XII e XVI secolo l'arcipelago nanpeano fu effettivamente oggetto di campagne militari da parte di signori feudali nipponici (in particolare gli Hōjō), quindi trovare prove di invasioni nipponiche non è particolarmente complesso. Pur tuttavia, allora da dove vengono i popoli japonici di Magellania? Inoltre, questo significa anche che indizi di invasioni precedenti, durante il periodo Asuka o addirittura Kofun, potrebbero essere stati cancellati dalla sovrapposizione di dati relativi ad eventi successivi. La Aisaka venne anche accusata, durante questa fase dei suoi studi, di voler creare un 'secondo caso Gwanggaeto', ossia pretendere di trovare prove che giustificassero l'imperialismo giapponese del XIX e XX secolo, anziché in Corea, in Magellania.
La svolta nelle ricerche avvenne sempre in relazione ad Ukunin, a volte soprannominata – ancor più di Tokagu, in cui effettivamente ancora si parla una lingua Japonica - la Kyoto di Magellania. Nella sua prestigiosa biblioteca storica (una delle più importanti del continente), è conservata l'unica copia del fondamentale testo Leggi antiche e nuove dello stato, redatto da più autori tra il VII e il XI secolo, in cui si descrivono atti, codici e consuetudini di una potente oligarchia a forte vocazione marinara, la cui capitale era appunto Ukunin, ma il cui porto principale era 'Asinauma', l'odierna Asi(r)noma. La composizione del testo lascia presupporre che sia mancante della sua parte iniziale e che, inoltre, alcuni passaggi siano tratti da fonti più antiche andate perdute. Lo stralcio che catturò l'attenzione della ricercatrice nipponica fu questo:
Molti anni fa, nell'anno VIII del capo del grande consiglio Goporo, gli antichi libri mastri testimoniavano questa legge, ch'io ora riporto: 'sia stabilito che i Noe e i Chemoe, dell'est come dell'ovest, finiti sotto il nostro dominio, siano liberi di seguire le loro leggi e consuetudini e che anzi sia loro diritto esprimersi nella loro propria lingua nei nostri tribunali. In particolare, le principesse e i principi di Asinauma mantengano tutti i diritti e possessi che detenevano prima di essere accolte sotto la protezione del nostro munifico consiglio e che anzi abbiano diritto a parteciparvi. Quanto ai territori di oltremare su cui cui le principesse e i principi di Asinauma detengono pretese, appronteremo con celerità un sussidio per supportare tale rivendicazione, cosicché tornino in loro possesso e vengano strappate alle genti barbare del nord che vi hanno fatto di recente ingresso.' Questa legge venne redatta quando il grande Goporo accettò unione e alleanza con Asinauma. Essa venne rispettata e viene tuttora onorata, ma è tempo che la legge dello stato sia una soltanto, per non ingenerare confusione o, peggio, inganni. Integreremo dunque nelle nostre leggi e consuetudini, quelle usanze di Asinauma che riteniamo sensate, sagge e ancora attuali, mentre bandiremo tutte quelle leggi antiche che ormai ai nostri occhi paiono folli o desuete.
Ben strana agli occhi del consiglio degli anziani di Okone è l'usanza di Asinauma che anche le donne vadano in guerra; essi dicono che le donne siano più adatte alla guida delle imbarcazioni degli uomini, ma anche Ayona la grande, del resto, era una donna, e di tempra forte sono tutte le donne dei popoli che da lei discendono. Inoltre, ancora si racconta che la principessa di Asinauma Pi -Mequy in quelle campagne uscì sempre vittoriosa e riportò un gran numero di barbari di Hamaqtu come schiavi e mercenari presso Okone e ciò dimostra tale affermazione. Per questo tale loro consuetudine approveremo e non vieteremo.
Per quanto non ci siano riferimenti temporali precisi, questo testo trasmette due notizie molto importanti: la prima è che, sebbene non fosse comune, in taluni casi, nella società Ayona, le donne rivestivano posizioni di rilievo in ambito politico e militare; in secondo luogo, che gli stati magellanici attuarono diverse campagne militari, prevalentemente a scopo di rapina e saccheggio, ma in alcune circostanze anche di vera e propria conquista, presso le isole giapponesi. L'unione di questi due dati porta a valutare, se non probabile quantomeno possibile, la possibilità che Himiko fosse una principessa Ayona.
Anche se la prima esplicita citazione della Magellania nelle fonti cinesi risale al IX secolo (tarda dinastia Tang), come si evince dal vecchio libro dei Tang, è opinione piuttosto comune ritenere che l'esistenza di vaste terre oltre il mare fosse loro nota almeno dal VI-VII secolo d.C. (a patto che non si voglia dare credito alla teoria secondo cui Xu Fu, alla ricerca della mitica isola-montagna di Penglai per conto del primo imperatore cinese Qin Shi Huang Di, sia giunto proprio in Magellania e non in Giappone). L'indizio più citato è proprio il riferimento al Giappone presente nel libro di Sui, che, in una prosa del libro degli Han posteriori, aggiunge una significativa parte, qui di seguito evidenziata:
'Durante i regni degli imperatori Huan e Ling, quel paese [il Giappone] e le terre al di là di esso erano in uno stato di profondo disordine e non vi fu un re per molti anni'
Qualsiasi tentativo di retrodatare la conoscenza del continente magellanico da parte dei cinesi è considerato troppo ardito o controverso; se però il libro di Sui dicesse il vero, ciò implicherebbe che i cinesi intuivano l'esistenza di un legame politico tra il Giappone e le 'terre al di là', quando parlavano della regina Himiko. Leggere retrospettivamente tale passaggio alla luce delle teorie di T. Aisaka, per quanto azzardato è certamente affascinante.
Sia come sia, per la archeologia nipponica gli Yayoi non arrivarono in Magellania come invasori, bensì come schiavi o come guardie del corpo delle regine-guerriere Ayona, che evidentemente consideravano il circondarsi di schiavi stranieri come uno status symbol o comunque una manifestazione del proprio potere. Del resto, diversi estimatori occidentali del lavoro della Aisaka non mancano di evidenziare omologhi di una situazione del genere anche nella storia europea o del Levante islamico, basti pensare alla guardia variaga bizantina, ai mamelucchi circassi o ai normanni nell'Italia meridionale. Le pratiche della regina-sacerdotessa per dominare il popolo sono descritte dai cinesi come magiche, ma di preciso cosa significa, appunto, 'magia'?
Quest'ultima in antropologia è spesso legata alla sussistenza di un divario culturale e tecnologico non facilmente spiegabile secondo criteri razionali da parte di chi lo osserva e descrive. Inoltre, è un ottimo modo per scaricare la responsabilità delle proprie sconfitte su un ambito soprannaturale (fondamentalmente maligno) e incontrollabile. Le fonti giapponesi però non parlano mai di popoli sufficientemente potenti da sconfiggere e schiavizzare la progenie di Yamato; gli Emishi, i 'barbari-gambero' vengono sempre descritti, appunto, come barbari, culturalmente rozzi e inferiori. Che sia un silenzio voluto? A questo punto, tutto è possibile.
Chiaramente, l'idea che non solo Himiko non fosse proto-giapponese, ma che i proto-giapponesi venissero usati come schiavi-soldati da sovrani stranieri trovò fredda accoglienza nel mondo accademico nipponico, tranne in Inoue, che tuttavia sottolineò che le prove indiziarie sin qui raccolte sono ancora lontane dall'essere sufficienti.
Quel che è certo sono però le conseguenze a lungo termine: nella penisola Layamica si affermarono comunità di lingua japonica, che furono anche storicamente rilevanti in determinati periodi della storia nella Magellania, mentre in Giappone, ogni elemento non Yamato/giapponese (perché va ricordato che non è detto che gli Emishi fossero necessariamente imparentati con gli Ainu, semplicemente potrebbero essere japonici non Yamato) fu in gran parte cancellato. Questo in realtà è l'argomento più schiacciante in favore della teoria giapponese, nei confronti del quale nessuno dei suoi detrattori è riuscito a fornire una replica del tutto soddisfacente. Ma ora, dopo tutte queste teorie, passiamo all'evoluzione storica vera e propria dei regni della regione dal IV al X secolo d.C.
5.1.3 Tra forza e debolezza: la punta occidentale
Come si è detto, il paesaggio politico e culturale regionale all'ingresso del IV secolo è quanto mai variegato e complesso. L'idea di una comune identità Ayona appariva sempre più distante e labile. Gli Ayona 'insulari' collettivamente erano denominati Kemoy, mentre gli abitanti del continente erano detti Eh Dan. Questi ultimi, a loro volta, erano suddivisi tra gli Eh Kam, gli Eh Nin e gli Eh Num, rispettivamente a ovest, al centro e a oriente della porzione settentrionale della penisola Layamica. I racconti odeporico-religiosi di questo periodo, per quanto ufficialmente con un fine educativo e teologico, sono spaccati anche piuttosto divertenti dei pregiudizi etnici del periodo. Possiamo dunque assistere all'asprezza di modi dei Kam, all'ossequiosità insincera degli avidi Nin e alla chiassosa espansività dei Num. Questo chiaramente non deve trarre in inganno: nessuno dei gruppi citati era assolutamente omogeneo al proprio interno, per non parlare del fatto che non vi era nemmeno una unità politica.
Nonostante ci siamo soffermati nei paragrafi precedenti sugli Ayona e sul loro rapporto con i Nuyn e gli japonici, essi non erano gli unici abitanti della penisola, anzi. Il gruppo dominante nella sua parte centrale e meridionale erano e rimanevano i cosddetti 'Layam'. Quest'ultimo è un termine ombrello piuttosto fuorviante, ma allo stesso tempo ineludibile, in quanto autodefinitorio. Non sappiamo di preciso quando il nome dell'antico regno iniziò ad essere usato su base etnica, probabilmente in un momento imprecisato intorno al II secolo a.C. Quello che però sappiamo è che un vasto coacervo di popoli iniziò collettivamente a affermare di discendere dagli abitanti dell'antico impero, anche in regioni che l'antico impero non toccò mai. Sicuramente nelle famiglie regnanti dei regni Layam vi era una sorta di rivendicazione a un destino imperialistico e di dominio, un tentativo di legarsi ad antenati illustri per aumentare il proprio prestigio e giustificare le proprie mire espansionistiche. Certo è che, tuttavia, le tappe precise del cammino da una rivendicazione di qualche casta nobiliare a un aggettivo di identificazione collettiva ci sono oscure. Probabilmente giocò l'iniziale peso culturale della diade Nuyn-Ayona, che dal punto di vista religioso ed economico dominava senz'altro la scena. Forse che tutti i popoli eredi della antica cultura di Lumpaɣ sentirono il bisogno, per differenziarsi dai vicini senza sentirsi inferiori, di prendere a riferimento la presunta discendenza da un grande impero? Non lo sapremo mai. Al loro interno, però, per quanto in maniera relativamente vaga, ciò avvantaggiò la percezione di una identità comune. Chi erano i ‘secondi’ Layam, dunque? Per quanto ciò possa sembrare controintuitivo, a dispetto di quello che la popolazione del tempo (e in gran parte anche ai giorni nostri) credeva, come in parte già affermato, è molto probabile che non fossero affatto discendenti degli abitanti del primo impero, quanto, piuttosto, eredi delle diverse ondate migratorie dalla costa e da ovest in direzione delle alture di Qanay. Ciò ebbe l’effetto di alterare la composizione demografica del Layam propriamente detto, dandogli un’impronta decisamente più austronesiana e, de facto, di cancellare la ‘lingua del metallo’, così come ogni residuo pre-austronesiano. Ironia della sorte, sono le popolazioni Sampaɣ (che parlano un idioma non imparentato al gruppo delle lingue layamiche e su cui poi torneremo), dimoranti a nord-est delle alture, ad essere geneticamente più prossime alle genti dell’antico impero.
In sintesi, per quanto sia vero che per esigenze di semplificazione la storia altomedievale della regione venga resa solitamente come il rapporto tra quattro popoli (i declinanti Nuyn, i regni layamici, le città mercantili Ayona e i guerrieri erranti Amaq, ossia gli japonici), ciò è piuttosto lontano dall’essere un panorama accurato, da una parte con regni che non erano, né avevano intenzione di essere omogenei etnicamente, dall’altra perché il senso di appartenenza a macrogruppi etnolinguistici che noi moderni tendiamo ad attribuire era all’epoca men che vago. Tale semplificazione però ci è necessaria per destreggiarci nel caotico periodo che va dal quarto secolo fino alle grandi invasioni Malay del nono-decimo secolo.
Premettendo che disponiamo di fonti per forza di cose parziali (Come noi, infatti, conosciamo l'antica Grecia perlopiù dalle fonti ateniesi, così ci è nota la storia della penisola layamica altomedievale prevalentemente da testi provenienti da Ukunin, Asirnoma e, in misura minore, Tokagu e Onerum), molti stati ebbero vita breve e spesso sappiamo a malapena della loro esistenza. In particolare, a ovest delle alture di Qanay, per secoli non sorsero regni con ambizioni egemoniche, quanto piuttosto, signorie di dimensioni più o meno ridotte in costante lotta per il predominio. Tra essi spiccano i cosiddetti ‘tre regni Nin’, ossia U-Nin, Uku-Nin e Tu-Nin. Come si può intuire dal nome, i clan dominanti di questi stati provenivano dal popolo (Eh-)Nin, (a sua volta parte dei già citati ‘tre Dan’: Kam, Nin - appunto - e Num, ossia gli Ayona ‘continentali’, diversi dai Kemoy, ossia gli Ayona ‘insulari’).
Questi tre regni cercarono senza molto successo non solo di conquistarsi l’un l’altro, ma di estendere il proprio potere su tutta la costa sud-occidentale, dove però trovarono la pervicace resistenza di diversi regni (Eh-) Kam, il più potente dei quali (e che per un periodo minacciò la sopravvivenza stessa dei tre Nin) fu la talassocrazia di Asmak, forte del supporto dei regni layamici posti più a sud-est, come il Danay.
Altrettanto scarso successo ebbero le velleità, soprattutto di Uku-Nin, di espandersi lungo la costa verso oriente; nonostante i commerci a medio-lungo raggio e le fortune acquisite dai mercanti di Asirnoma (il principale porto di Uku-Nin), ci fu sempre qualche centro di potere adagiato sul promontorio di Tobikuri in grado di fermarne l’avanzata: in particolare, intorno alla fine del VIII secolo, il regno di Örgan, che aveva reso la propria capitale Daalban un grande hub commerciale, oltre che una imprendibile fortezza.
A loro volta però, i tre Nin poterono tutto sommato considerarsi fortunati: il massiccio del Prasik (poi detto di Tokagu), dissuase per secoli i regni layamici posti più a est dal tentare conquiste verso occidente, permettendo così la loro sopravvivenza politica.
La storia di questi litigiosi stati ebbe due grandi momenti di svolta: il primo alla fine del V secolo, quando re Mitay di Ukunin subì un colpo di stato. Le fonti in nostro possesso, chiaramente di parte, lo descrivono come un crudele e folle tiranno, che stava portando il paese alla rovina. il grande libro della legge di Asirnoma così ci racconta:
La causa della sua deposizione fu l’essersi invaghito della principessa Munkan di Asirnoma, donna di particolare avvenenza. Dopo aver tentato invano di sedurla, cercò di usarle violenza, salvo da lei essere malamente sconfitto (e deriso). Furente, il re marciò con il suo esercito contro Asirnoma, minacciando di raderla al suolo se gli abitanti non avessero consegnato la principessa. la città però, decise di resistere all’esercito regio e, poco dopo, ad Asirnoma si unirono nella rivolta anche altre città del regno. Grazie anche all’utilizzo di molti mercenari Amaq e all’alleanza con la città Nuyn di Seekta, l’esercito di Mitay venne sconfitto.
Il sovrano, tuttavia, riuscì a fuggire verso Tu-Nin, chiedendo l’ausilio del re di quel paese, Sisar. Quest’ultimo accettò di mettere a disposizione di Mitay le proprie armate o, almeno, così fece credere. spaventate dalla potenza di Tu-Nin, molte città furono tentate di abbandonare Asirnoma al suo destino e chiedere grazia al re, ma Munkan tanto disse e tanto fece da riuscire a tenere unita l’alleanza.
Dal canto proprio, re Sisar di Tu-Nin si alleò con re Mimok di U-Nin per spartirsi Uku (non era affatto sua intenzione rimettere sul trono Mitay). Munkan fu però più rapida e sconfisse singolarmente i suoi nemici, prima che i loro eserciti si riunissero e facessero fronte comune contro di lei. Fu così che Mimok si ritirò prudentemente dal conflitto e Sisar fece uccidere Mitay in preda all’ira, reo di aver ‘sprecato per incompetenza’ il suo esercito. Mentre i mercenari Amaq decidevano di riversarsi nei territori sguarniti del Tu-Nin settentrionale, Munkan rifiutò la corona di regina, stabilendo che Uku-Nin, da quel momento, dovesse avere un governo collegiale, così come era stato durante la guerra.
E’ interessante, per quanto chiaramente romanzato, notare l’insolito passaggio da regno a repubblica oligarchica, su cui si sono cercate numerose spiegazioni. Altrettanto particolare è il fatto che la direzione della guerra sia stata presa da una donna: per quanto le passate (e presenti) società magellaniche siano note per non essere mai state particolarmente maschiliste, perlomeno a confronto con altre coeve, è un evento decisamente degno di nota.
Sia come sia, il cambio di governo portò presto ad una alterazione degli equilibri di potere in seno ai tre Nin, con Uku che da stato più debole assunse una posizione dominante. La seconda grande svolta politica fu la ‘caduta’ di Tu-Nin, a metà del VII secolo. Come già lasciato intendere dalla fonte precedente, i mercenari Amaq erano già nel V secolo una presenza ricercata e temuta. il testo sopra citato si concludeva con la notizia che i soldati di stirpe japonica, approfittando dei disordini, entrarono nel regno di Tu-Nin, sottoponendolo, probabilmente a razzie e devastazioni.
Due secoli dopo tale presenza doveva essersi ulteriormente consolidata. L’inospitale e poco popolato (ma di grande valore strategico) massiccio del Prasik era divenuto (non sappiamo se per concessione o occupato man mano illegalmente e con la forza) la loro dimora, tanto da creare una sorta di ‘stato nello stato’. Le fonti non sono chiarissime su cosa sia esattamente successo, ma a quanto pare i mercenari Amaq già da diverso tempo detenevano il vero potere nel Tu-Nin, relegando i sovrani ad un ruolo sempre più marginale e cerimoniale. Probabilmente, la corte tentò di ridimensionare il loro potere con un atto di forza improvviso, senza successo. La reazione fu spietata: gli Amaq conquistarono la capitale, diedero alle fiamme il palazzo del re e posero il proprio comandante come sovrano di Tu-Nin, il quale prontamente spostò la capitale presso l’impervia fortezza degli Amaq in cima al Prasik, Tokagu.
Di fatto, con questo evento, l’era dei tre Nin si può dire giunta al termine. Il regno ‘Amaq’ lancerà una serie di rapide e mortifere campagne in tutte le direzioni (in particolare ne farà le spese il regno Kam-Layamico di Danay, a sud), tanto da irritare i grandi regni layamici di Limur e Pamis a est; Uku-nin accetterà la protezione del re di U-Nin in cambio del mantenimento degli organi di governo collegiali (creando una sorta di monarchia parlamentare unita, chiamata poi semplicemente ‘regno Nin’). Infine, sempre spinti da necessità difensive contro gli aggressivi vicini, i Nuyn del promontorio scacceranno i Nin e gli Amaq per fondare il summenzionato regno mercantile di Örgan, che diventerà oltretutto il centro propulsore della diffusione di una nuova religione: il buddhismo.

Territorio dei 'Tre Nin' nel VII secolo
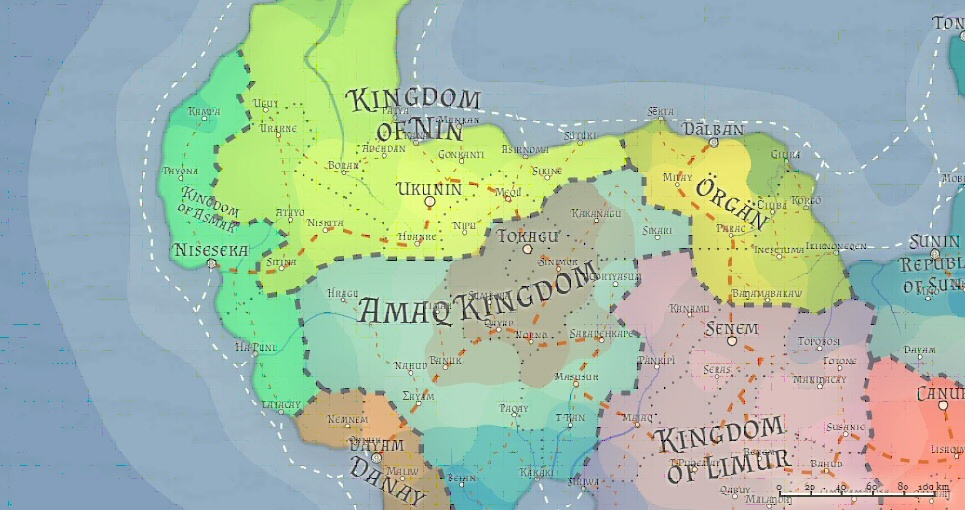
Il regno di Amaq e il Nin unificato tra VIII e IX secolo
5.1.4 il secondo Layam
Nello stesso lasso di tempo, sulle alture di Qanay si svolse una vicenda forse meno caotica, ma probabilmente molto più foriera di conseguenze per la ‘grande storia’ del continente. Già dal III secolo, infatti, andò in scena la lotta a morte per l’eredità dell’impero Layam. Fu chiaro sin da subito che i contendenti sarebbero stati essenzialmente quattro: Marat a ovest, Canuk a nord-ovest, Lannuy al centro e Ruteq a est. I sovrani di ognuna di queste città si auto-definivano ‘imperatori’, ovviamente definendo fasulli gli altri tre, poiché poteva esistere un solo e unico imperatore di Layam.
Alla fine del quarto secolo, Lannuy pareva lanciata per assumere un ruolo egemone, forte della propria posizione strategica, riparata da un arco di colline; in particolare, essa era riuscita a imporre il proprio dominio su tutta la fertile pianura meridionale, assicurandosi anche il controllo della costa e garantendosi una proficua rotta commerciale dai porti della penisola (principalmente Pipen e Pabun) sino alla foce del grande Kaemh.
Canuk e Ruteq avevano cercato di attuare un progetto speculare, cercando un’espansione verso la costa nord, ma senza ottenere lo stesso successo: i popoli delle pianure settentrionali, di stirpe Num (gli Ayona dell’est), gelosi della propria indipendenza, avevano rintuzzato con un certo successo qualsiasi tentativo espansionistico dei layamici, creando più o meno durature leghe di città contro il nemico comune. Ruteq, inoltre, dovette presto difendersi da un nemico altrettanto aggressivo, ossia i Sampaɣ. Il ‘popolo dei tre fiumi’ (Seman, Sirkata e Mouai), come essi amavano farsi chiamare, inflisse ripetutamente pesanti rovesci militari alle forze di Ruteq, che si salvò dalla disfatta totale solo grazie ad alleanze con le leghe Num. Per quanto venissero considerati ‘barbari’ dai propri vicini occidentali, i Sampaɣ non erano affatto arretrati.
Più tardi, intorno al XI secolo, dopo il diluvio Malay, rivendicarono con un certo ironico orgoglio il loro ‘barbarismo’, inventandosi un’ipotetica discendenza dai misteriosi ‘demoni della foresta’ della mitologia Layam.
Anche la loro religione era particolare. Era un diadismo eterodosso di stampo mistico, in cui la ‘forza vitale’ aveva un peso determinante. Non era infatti tanto la quiete o il caos a essere fonte di venerazione come due aspetti della medaglia del cosmo, quanto piuttosto l’energia che fluiva in ogni cosa. Saper accumulare questa forza nel proprio corpo, vederla o incanalarla (attraverso pratiche ginnico-meditative di diverso tipo a seconda della scuola) era l’obiettivo fondamentale.
Sul fine di queste pratiche, ogni setta aveva un suo credo, anche se largamente prevalente, per via del contatto con i popoli vicini, era quella che vedeva come fine il medesimo del diadismo, ossia contribuire a mantenere l’equilibrio cosmico attraverso l’equilibrio interiore. C’erano però anche sette minoritarie che vedevano come obiettivo principale quello di evitare la morte (e acquisire la saggezza), o anche gli ‘antidiadisti’: per essi, l’equilibrio che i diadisti perseguivano non era altro che un inganno, in quanto impossibile da raggiungere. Per tal ragione, la forza doveva servire a mantenere un rigido ordine immutabile o, viceversa, si doveva usare il potere in proprio possesso per portare più mutamento possibile nel proprio mondo, altrimenti esso sarebbe morto nella stagnazione. Il nome di questa fantomatica forza era una parola che aveva fatto letteralmente il giro del continente nel corso dei secoli (più avanti vedremo più nel dettaglio come): Mana.
Torniamo però al tema principale del paragrafo. Come Ruteq e Canuk, anche Marat cercò di trovare una via di espansione alternativa per controbilanciare la potenza di Lannuy, con alterne fortune. Da un lato, la pianura tra le alture di Qanay e il massiccio Prasik era una terra ricca e fertile, che i litigiosi Nin, in preda ai loro continui intrighi e conflitti, non avevano saputo portare per tempo sotto il proprio controllo; dall’altra però, ogni tentativo di espansione ulteriore verso il mare venne frustrato dal regno costiero di Danay, che per quanto si autoproclamasse un ‘regno di Layam come gli altri’, era piuttosto frutto di una strana commistione tra gli eredi degli antichi Babal, il gruppo Ayona dei Kam e i Megün, ossia gli eredi di una precedente diaspora dei Nuyn verso sud-ovest. Al Danay si aggiungerà, per un certo periodo, anche lo stato cuscinetto di Tian, fautore di una politica di assunzione massiccia di mercenari Amaq, che poi porterà alla japonizzazione di alcune province.
Alla fine del V secolo sembrava fosse ormai una questione di tempo, prima che Lannuy unificasse le quattro città e ricreasse un secondo impero Layam molto più potente del primo. Una serie di concomitanti circostanze, diede però una svolta inaspettata.
Nelle terre dei Sampaɣ scoppiò un violento conflitto tra clan per il controllo del territorio. Questo portò alla nascita di veri e propri regni e non vaghi agglomerati tribali inframmezzati da città stato. Secondo la leggenda, tramandaci dal Canto del fiume Mita, conservato tra i testi di Onerum, questa età ‘eroica’ si concluse con grande duello tra due grandi e famosi guerrieri, Kursera e Oqon. Il primo, vittorioso, fondò il regno di Cusok, con l’obiettivo di unire tutti i Sampaɣ sotto un unico dominio. Commise però l’errore di avere pietà del nemico sconfitto e, invece di ucciderlo, lo scacciò, dopo averlo sfregiato all’occhio destro. Oqon, umiliato, decise di fuggire lontano, verso ovest, attraversando il fiume Seman, che all’epoca fungeva da confine occidentale delle terre Sampaɣ, senza voltarsi, assieme al suo seguito.
Trovò ricetto presso Miqu,
città dei Num. Per diverso tempo combatté per il pavido e inetto signore della
città, fino a farsi un nome e sposarne la figlia.
il signore di Ruteq, però, che da tempo aveva mire sulla città di Miqu, cercò di
contestare il matrimonio. Impaurito dal potere di Ruteq, il re di Miqu cercò
dunque di annullare l’unione e contestualmente esiliare Oqon, il quale, però,
dopo aver invano cercato di far ragionare il re, in un impeto di rabbia gli
troncò di netto la testa e si nominò nuovo signore della città.
Mal gliene incolse: i figli del defunto sovrano si allearono contro di lui e lo sfidarono. Nonostante la sua grande forza, i quattro riuscirono ad avere la meglio su di lui, attraverso un sotterfugio. Nuovamente battuto, Oqon riuscì comunque a salvarsi la vita e fuggire, ancora una volta.
La meta fu proprio Ruteq. Desideroso di vendicarsi contro Miqu, offrì infatti i propri servigi di guerriero al sovrano Layamico, il quale accettò di buon grado. Mentre preparava la sua rivincita, però, la guerra giunse inaspettata da un altro nemico: Lannuy attaccò di sorpresa Ruteq, decisa a conquistare la rivale orientale una volta per tutte. La soverchiante forza nemica sembrava inarrestabile, ma Oqon, con una mossa ardita e disperata, sfuggì agli esploratori dell’avversario e passò alle spalle del loro esercito, puntando direttamente contro Lannuy. Colta di sorpresa e sguarnita, la città oppose ben poca resistenza.
L’esercito di Oqon ne fece scempio per tre giorni e tre notti. Dopo il massacro, i mercenari Sampaɣ tornarono a Ruteq e informarono l’esercito assediante che la loro capitale era ormai un cumulo di rovine. I lannuyti, dopo aver ricevuto inconfutabili prove della veridicità della notizia, si arresero a Oqon, il quale decise di risparmiare loro la vita. Ruteq aveva ‘vinto’, ma la vittoria era stata pagata a caro prezzo.
Le mura erano distrutte, il re morto di pestilenza, ampi quartieri della città danneggiati e la popolazione piagata dalla fame. Il condottiero Oqon decise dunque di portare la sua gente e tutti coloro di Ruteq che fossero stati disposti a seguirlo più a nord e fondare lì una nuova città. Nacque così Onerum e il nuovo regno di Oqon. Presto Onerum divenne ricca e potente e molti Sampaɣ decisero di attraversare il Seman e stabilirsi lì, divenendo la maggioranza della popolazione a discapito di Num e Layamici.
Sicuramente da questo mito si può trarre l’informazione che la distruzione di Lannuy e Ruteq siano state su fenomeni correlati ed egualmente inaspettati, a loro volta dipesi da una migrazione verso ovest di popolazioni Sampaɣ, evidentemente con conseguenze tragiche e violente per tutta la regione.
C’è però un problema in questa ricostruzione. Ossia che le tombe reali di Canuk raccontano tutt’altra storia.
re Beras di Lannuy conquistò dunque Marat, poi Ruteq e le distrusse, con l’aiuto di truppe di guerrieri mercenari dell’est, i barbari Sampaɣ, cui concesse in dono alcuni territori che erano stati di Ruteq, in cambio di tributi e servigi. Conquistò anche Canuk, ma poiché essa si arrese alle sue armate senza combattere, egli la risparmiò. E ben fece, poiché un atroce morbo colpì la grande città di Lannuy, così che il sovrano e tutta la sua famiglia dovettero abbandonarla.
Come far collimare la versione mitico-eroica di Oqon e quella delle tombe reali di Canuk? A prima vista il compito non è semplice: da una parte si parla di una città distrutta da un esercito nemico, dall’altra da una pestilenza. Nel racconto mitico di Onerum i Sampaɣ sono nemici di Lannuy, nelle epigrafi sono alleati. Eppure forse un modo per far quadrare i conti esiste: i Sampaɣ sono effettivamente stati i distruttori di Lannuy, ma non nel modo che suppone il mito di Oqon. re Beras, o chi per lui, probabilmente approfittò dei disordini all’interno dei territori Sampaɣ per reclutare un gran numero di guerrieri mercenari e attuare grazie ad essi una serie di campagne di conquista. Essi però, portarono un regalo molto meno gradito della vittoria, ossia un’epidemia (di peste? di tifo? mai lo sapremo), che falcidiò la popolazione della città, tanto da convincere il sovrano a trasferirsi nella più settentrionale Canuk.
Sempre stando alle tombe reali, quello che accadde dopo fu una lunga e distruttiva guerra civile tra i figli di Beras. Il maggiore, Pamis, entrò in conflitto con i due fratelli minori, Sumaq e Ñikud. questi ultimi avevano tentato, con un certo successo, di ripopolare e ricostruire Lannuy. Pamis, tuttavia, timoroso che i due stessero cospirando contro di lui, tolse loro il controllo della vecchia capitale. Con il trasferimento a Canuk della capitale, i feudi del sud, sentendosi ignorati, appoggiarono i due fratelli ribelli, che si spartirono le terre basse meridionali, senza che Pamis riuscisse a sottometterli. Ma non era ancora finita, poiché Limur, signore di Senem, ex-vassallo di Marat, si ribellò a Pamis e gli sottrasse parte dei territori occidentali conquistati da Beras il grande. Fu così che, a un passo dalla riunificazione, i territori Layamici si divisero negli storici quattro regni che sarebbero rimasti gli stessi per i successivi cinque secoli: Pamis, Limur, Ñikud e Sumaq (così chiamati dal nome dei principi fondatori). Mentre quest’ultimo progressivamente si ridusse in dimensioni sin quasi a scomparire, gli altri tre si rafforzarono e stabilirono un precario equilibrio di forze, mentre a nord e nord-est, le leghe Num (quelle che nel VII secolo vennero chiamate impropriamente dagli storici moderni ‘repubblica’ di Sunin e unione di Timak, con quest’ultima che all’alba del IX secolo confluirà nella prima) e il regno di Oqon cercavano di trarre profitto da queste rivalità, destreggiandosi diplomaticamente tra Pamis e Limur. E’ probabile che l’incapacità dei Layam di riunirsi in un unico stato abbia pesantemente pregiudicato le capacità di resistenza di fronte alle successive ondate migratorie e di invasione che avrebbero cambiato per sempre il volto della Magellania.
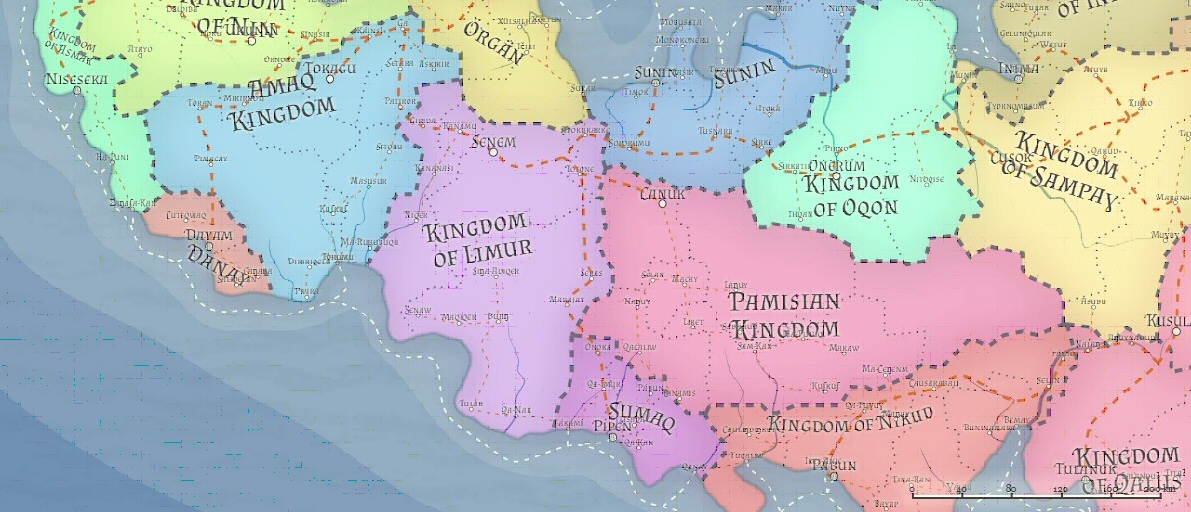
I regni Layam e Oqon nel VIII secolo
5.1.5 il margine esterno: i Sampaɣ
In questo paragrafo analizzeremo due regioni che non fanno esattamente parte, dal punto di vista geografico, della penisola nord-occidentale, ma sono culturalmente ad essa molto legate, oltre a rappresentare la principale cinghia di trasmissione tra essa e il resto del continente.
Innanzitutto, torniamo a porre il nostro interesse sui Sampaɣ, cercando di comprendere meglio chi sono. E’ bene dire che sulla loro identità, filologi, storici e genetisti non hanno ancora raggiunto un universale consenso. Essi infatti sono frutto di un processo etnogenetico relativamente recente, per alcuni iniziato al più presto intorno al primo secolo dopo Cristo. Le propaggini orientali della penisola di Layam, abbandonate a loro stesse, divennero un punto d’incontro di diverse lingue e culture, che finì per dare origine a un popolo del tutto originale e non una semplice ‘somma delle parti’.
In primo luogo, ciò su cui per diverso tempo si è dibattuto è a che livello inserire il loro gruppo linguistico nella grande famiglia austronesiana.
Da una parte, infatti, vi è chi protende a definirli come un gruppo fratello alle lingue Layam (che per alcuni non sono nemmeno propriamente austronesiane, quanto piuttosto ‘proto-austronesiane’); i sostenitori di tale posizione ritengono che gran parte delle innovazioni fonetiche sono frutto di una evoluzione indipendente e isolata. Dall’altra, chi invece ribalta la prospettiva e sostiene che l’influenza delle popolazioni austronesiane della costa nordorientale della Magellania sia stata talmente decisiva da rendere impossibile una classificazione di chiara parentela linguistica con i Layam. A rendere ulteriormente divergente le lingue Sampagiche dalle altre austronesiane vi è, inoltre, il lessico, mutuato in misura considerevole dal ramo Num delle lingue Ayona, tanto che spesso esse vengono paragonate all’inglese, ossia una lingua germanica che per ragioni storiche ha ricavato una parte rilevante del proprio lessico da quelle romanze. Non meno interessante è notare che tra tutti gli idiomi della Magellania le lingue sampagiche sono, assieme al Tielh e al Nale dell’alto Kaemh, quelle che più hanno mantenuto un substrato aborigeno.
Come se non bastasse, già abbiamo menzionato il fatto che, dal punto di vista genetico, i Sampaɣ siano più prossimi ai popoli dell’antico Layam rispetto ai successivi abitatori delle alture di Qanay, complicando ulteriormente il quadro sulle loro effettive origini.
Al momento, la ricostruzione più accreditata è quella che vuole la zona di origine dei Sampaɣ essere stata, almeno fino al IV secolo a.C., prevalentemente popolata da nativi, tra cui, forse, i famigerati ‘demoni della foresta’, di cui tanto timore avevano i Layam. Con il crollo dell’impero layamico, vi furono notevoli fenomeni migratori dei layamici dalle alture del Qanay verso le valli circostanti, sia a sud e sud-ovest, come abbiamo già potuto vedere, sia verso le valli fluviali di nord-est, tra il mare e i monti Rea. la commistione tra l’elemento Layam e quello nativo diede una prima fisionomia ai popoli di quel territorio, che rimase stabile almeno fino al primo secolo avanti Cristo.
Progressivamente, però, dalla costa, le talassocrazie Num iniziarono a costruire porti e approdi, da cui poi presero a penetrare verso l’interno per commerciare con i locali. Questo portò a un lento ma costante processo di trasformazione culturale e politica, punteggiando il territorio di empori e città stato, a volte dominati da aristocrazie locali, altre volte da principi-mercanti di ascendenza Ayona. L’ultima e decisiva spinta per la cristallizzazione di un’identità specifica venne da est: tra la fine del III e il IV secolo dopo Cristo, schiere di guerrieri e pirati raggiunsero e oltrepassarono il fiume Mouai, diventando ben presto una presenza costante del panorama delle valli ‘dei tre fiumi’. Questi gruppi di mercanti, soldati e navigatori si integrarono rapidamente con la popolazione locale, portando tuttavia con sé tutta una serie di usi, costumi, tradizioni (come il già citato concetto di Mana) e lessico. Fu probabilmente a causa di ciò che iniziò l’era ‘eroica’, in cui i Sampaɣ si coagularono in specifiche tribù intorno a capi particolarmente carismatici.
Da questi agglomerati tribali nacquero poi veri e propri regni, in grado - come abbiamo visto - di interferire con la politica degli stati confinanti in maniera decisiva. Intorno al IV-V secolo, centrato sulla città di Cusok, nacque un vero e proprio regno, con l’ambizione di riunire sotto il proprio scettro tutti i Sampaɣ.
Le sue ambizioni egemoniche non vennero pienamente coronate dal successo, riuscendo a riunire intorno a sé soltanto le tribù della valle del Seman e saltuariamente ad imporre una sorta di legame tributario al regno di Oqon, creatosi come abbiamo evidenziato da una colonizzazione tardiva dei territori occidentali. Il principale problema del regno di Cusok fu quello di non essere mai stata in grado di sottomettere pienamente le valli costiere, con i suoi floridi centri portuali, per via della pervicace resistenza della città Num di Inima e delle sue colonie. Intorno al VII secolo essa passò anzi decisamente al contrattacco e sottrasse al regno Sampaɣ tutto il bassopiano tra le foci del Seman e del Sirkata. Né Cusok riuscì mai a sottomettere i clan a oriente del Sirkata, tra cui i più potenti erano gli Ugema delle colline, gli Onata della costa e i Deman della valle del Mouai.
L’incapacità di sottomettere questi territori derivò forse in parte anche dall’insediamento sui monti Rea, a partire dalla metà del V secolo, di nuove e aggressive tribù austronesiane, i Tahi (furono proprio loro a dare il nome di ‘Rea’ alle montagne che portano questo nome). Mentre i Tahi orientali si organizzarono più avanti in veri e propri regni, i Tahi occidentali rimasero a livello di labili confederazioni tribali (tra cui la più forte, nonché l’unica che fondò un vero e proprio centro urbano, erano i Tatau), le cui incursioni e razzie divennero una costante spina nel fianco ai confini meridionali del regno Sampaɣ per tutta la sua esistenza.
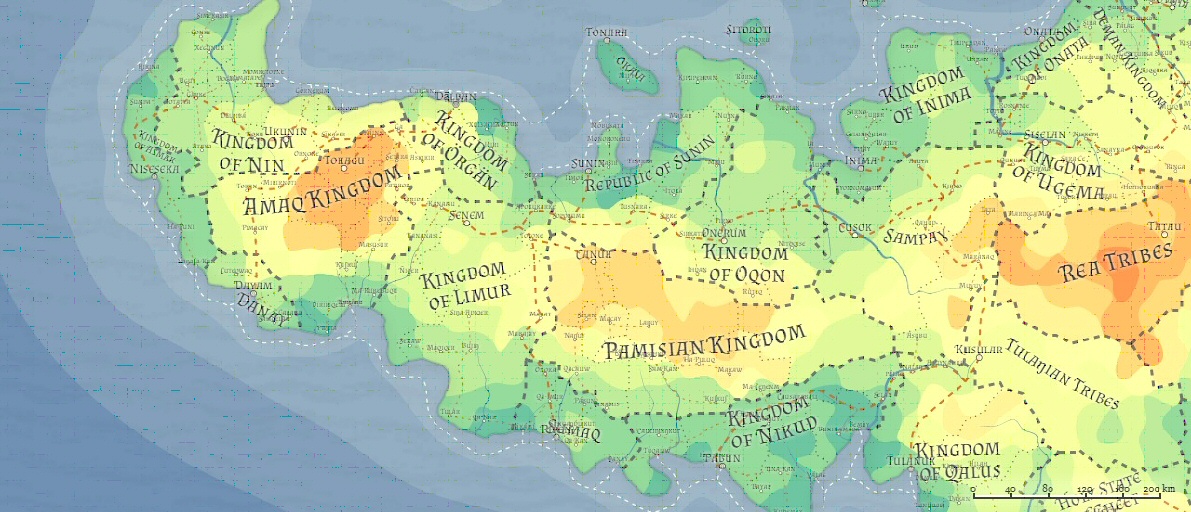
La situazione complessiva della penisola di Layam tra VIII e IX secolo
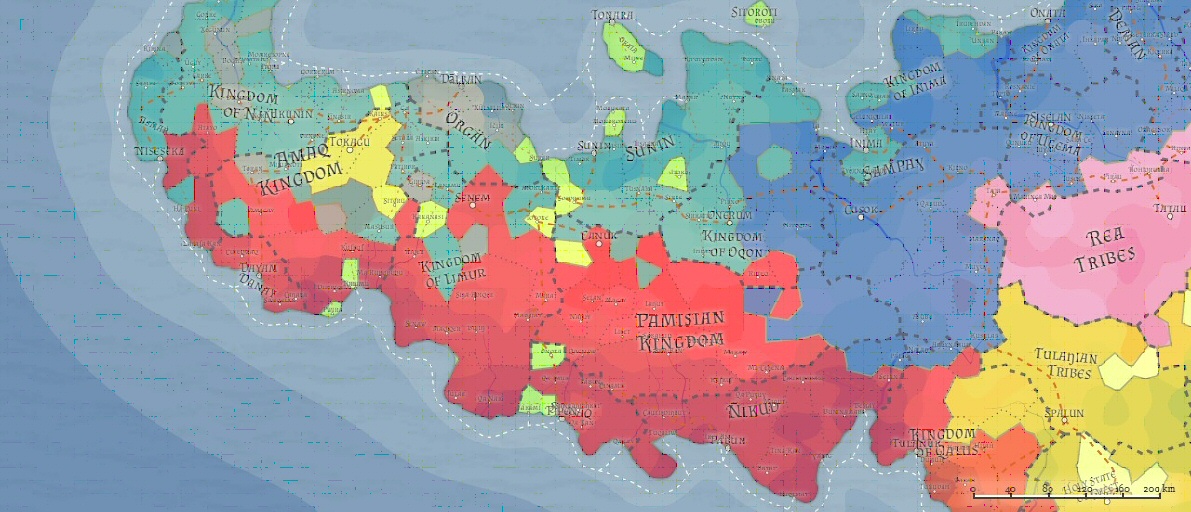
Un quadro di quella che doveva essere la composizione etnica approssimativa della regione al principio del IX secolo d.C.: in rosso le popolazioni layamiche, in giallo gli insediamenti japonici, in azzurro i popoli Ayona, in viola le residue zone a maggioranza Nuyn, in blu i territori Sampaɣe in rosa i barbari Tahi.
5.1.6. Qalus e l’arrivo dei primi Malay
Cambiando completamente paesaggio, per concludere questo capitolo è fondamentale analizzare Qalus, spesso definito nei libri di storia il ‘cavallo di Troia’ dei Malay. Situata presso il golfo omonimo, era la regione spartiacque tra il mondo peninsulare e il cuore del continente. Qui le culture layamiche e quelle del Kaemh si incontravano e ai suoi confini orientali si trovava l’impero Rièt al momento della sua massima estensione. Nel IV-V secolo dopo Cristo i confini di Rièt si erano ritirati verso sud, ma nonostante ciò i kaemhiti del delta rimanevano frequentatori abituali dei mercati di Tulanuk, il porto principale della regione, mentre i predoni Tulann abitavano le steppe semiaride che punteggiavano l’interno, tipico segno del cambio di clima rispetto alla penisola nord-occidentale. La primaria fonte di introiti dell’assolata Tulanuk erano gli schiavi: fossero mercanti Sampaɣ e Layam in cerca di esotiche bellezze Kaemhite o nobili di Laem, Wenèet o Rièt che cercavano servi per i loro possedimenti terrieri lungo il fiume o soldati Tahi come guardie del corpo personali, gli schiavisti erano in grado di procurarlo.
Furono questo tipo di affari che attirarono navigatori e commercianti da molto, molto lontano, persino fuori dal continente. Almeno dal tardo VII secolo iniziarono a serpeggiare nelle fonti due nomi che indicavano una stirpe di misteriosi e coraggiosi mercanti giunti dalle profondità del mare: Malaw e Ma-Taray. Non sappiamo di preciso chi sia stato il ‘primo’ avventuriero, che dopo aver sentito di magiche e ricche terre poste oltre le isole più orientali dell’arcipelago indonesiano, abbia sfidato il mare e sia giunto fortuitamente fino a Tulanuk. Quel che è assolutamente certo è che aprì la strada ad altri come lui. La rotta della prima ondata di mercanti Malay passava dal nord dell’isola del Borneo, per poi piegare verso l’isola di Mindanao. Da lì il tratto più pericoloso. in mare aperto. La scoperta di un comodo approdo a metà strada tra le Filippine e la penisola di Layam, l’isola di Palau, rese però il viaggio molto più abbordabile. Seguendo la costa meridionale della penisola, i mercanti della talassocrazia di Srivijaya, arrivavano infine nel Qalus. Un percorso alternativo fu, probabilmente più tardi (nel IX-X secolo), messo a punto dai mercanti giavanesi, probabilmente appartenenti al regno di Mataram, come suggerirebbe il termine ‘Ma-Taray’. Del resto, anche le iscrizioni di Kaladi, trovate in alcuni villaggi a Giava, ci confermano che si stabilì un collegamento con la Magellania. In particolare, le epigrafi di Tri Tepusan e Shivaghra (metà del nono secolo) citano ‘le grandi terre a oriente, dette di Laim e Koim’, da cui provengono ricchezze ‘seconde solo a quelle del paese di Arya’. Tale tragitto passava dalle Molucche, costeggiava la costa settentrionale di Papua sino all’isola di Rabaul, per poi giungere alle isole del golfo di Magellania e da lì sino alla foce del Kaemh.
Questi ardimentosi navigatori portarono sul continente merci provenienti dall’Asia, prima del tutto assenti, come la seta e alcune spezie indiane (anche se le spezie magellaniche furono poi altrettanto gradite all’estero), ma, soprattutto, portarono un nuovo modo di commerciare, ossia l’utilizzo di una vera e propria moneta. Invece di usare sfere o lingotti di metallo prezioso, l’utilizzo di questi piccoli dischi incisi era immensamente comodo e pratico, motivo per il quale, nel giro di breve tempo, anche i potentati locali li preferirono per gli scambi a medio-lungo raggio, innescando così una sorta di rivoluzione nelle strutture economiche.
Il secondo ‘dono’ fu l’alfabeto Kawi, discendente dalla scrittura Pallava dell’India meridionale, a sua volta originata dall’alfabeto Brahmi. Spesso ci si chiede perché il modello del Kawi, da cui derivarono successivamente una messe di varianti locali, ebbe tanto successo, a fronte di una cultura già ricca di letteratura scritta e con un alfabeto consolidato.
Molti lo attribuiscono alla sua praticità: l’alfabeto Huaek, i logogrammi Layam, la scrittura Reumpièk e le loro varianti regionali avevano una struttura logosillabica vagamente paragonabile a quella cinese, mentre gli alfabeti derivati dal Brahmi erano Abugida, ossia degli alfasillabari. Eppure, nonostante ciò possa essere vero, è piuttosto dubbio che possa essere stata solo una questione di comodità.
Diversi storici, prevalentemente francesi, tendono piuttosto a indicare la ragione dell’espansione dell’alfabeto Kawi modificato, poi detto Tasah, con la parallela espansione dell’indo-buddhismo del sud-est asiatico e delle traduzioni dei libri canonici dal sanscrito. Come poi vedremo, però, anche questa ragione può essere solo parzialmente vera, visto che il buddhismo magellanico nel X secolo ormai già esisteva da più di cento anni, proveniente dall’arcipelago giapponese. Gli studiosi magellanici tendono invece ad attribuire la diffusione alla conquista militare e all’espansione territoriale dei principati malay; anche in questo caso, tuttavia, non può essere l’unica spiegazione, a maggior ragione per il fatto che la diffusione di alcune forme di scrittura post-Kawi predata alla formazione di tali stati.
Un’altra domanda senza risposta che spesso ricorre nei testi sul tema è ‘perché non furono i magellanici a ‘scoprire’ il sud-est asiatico?’ A livello di competenze nautiche e tecnologie, nessun popolo austronesiano della Magellania difettava; men che meno gli Ayona, i Nuyn o gli japonici. Non si può nemmeno dire che fu una questione di scarsa intraprendenza, visto che gli eredi del regno Mani (ammesso che sia effettivamente esistito), partendo da capo Nine, nel giro di pochi secoli fecero letteralmente il periplo del continente, arrivando alle coste nord-occidentali, entrando in contatto con i Sampaɣ e fondando al loro passaggio una fitta rete di colonie e stati. Forse si trattò di una questione di ‘spinta’: al contrario di una galassia di isole più o meno grandi, la Magellania era un grande blocco continentale. Se ‘casa propria’ già era un enorme terra emersa ancora tutta da esplorare, non aveva senso spingersi lontano. Ma tutto ciò non può che rimanere relegato all’ambito della fantastoria.
Continua...
.
Note:
(0) Chiaramente tutte le ucronie che implicano continenti fantastici (come
quelle su Atlantide o quelle sul Doggerland quella sul Kumari Kandam del
Comandante) non possono avere basi scientifiche, perché cambiare la tettonica
implica una diversa storia della vita sulla terra.
Banalmente queste terre vengono fatte 'esistere a parità di tutto il resto',
senza cercare la base scientifica, se non in modo puramente letterario ben
sapendo intimamente che non si può.
Diverso è il discorso sul 'rendere geomorfologicamente plausibile' qualcosa. Non
è chiaramente impossibile, a patto che si voglia comunque ammettere una certa
aleatorietà, ma solo a patto di cambiamenti minimi o comunque entro un range di
calcolabilità. Ma in questo caso si devono seguire dei criteri estremamente
rigorosi, che non si possono banalmente ignorare, se non ammettendo che allora
si vorrà ricadere nel primo - più letterario che scientifico - caso.
Ad esempio: le isole Orcadi potrebbero essere fuse in una sola grande isola, i
cui abitanti potrebbero alterare la storia delle isole britaniche, o addirittura
del mondo? Quest'ipotesi, avanzata da uno di noi, è (molto) più difficile dello
stesso Doggerland in tal senso, perché si trovano proprio al limitare
settentrionale del Doggerland stesso e poco oltre una scarpata sottomarina;
diventa assai complesso pensare di elevare le Orcadi senza elevare TUTTO il
resto.
Quindi o l'isola 'semplicemente esiste' e non parliamone nemmeno di fattori
geomorfologici (ma poi il patto è che allora l'autore accetti l'implausibilità
sostanziale e la relativa accettazione passiva di ciò da parte degli altri), o
alziamo tutto l'alzabile in coerenza con le isoipse.
(1) Sulla base di queste considerazioni, il filologo e glottologo Guillermo Akur ha sostenuto una tesi ancor oggi oggetto di vivaci discussioni in ambito accademico, ossia della necessità da una parte di retrodatare pressoché sistematicamente l'arrivo di ogni 'ondata colonizzatrice' e, dall'altra, che il tasso di diversificazione linguistica e culturale è significativamente minore (per via del fatto che le diverse ondate di 'invasori' nuove tendono a esplorare meno e stare più a lungo insieme nel medesimo luogo).
(2) Secondo l'aneddoto che la stessa T. Aisaka ha descritto nella prefazione del suo saggio, la folgorazione sarebbe venuta a seguito di una visita "turistica" presso un tempio, in cui sentì un ragazzo recitare una preghiera allo "strabico figlio di Ayona che per tre anni stette nel suo grembo" basata sul testo di Gara di Ukunin.
.
Per scrivermi cosa ne pensate, scrivetemi a questo indirizzo.
