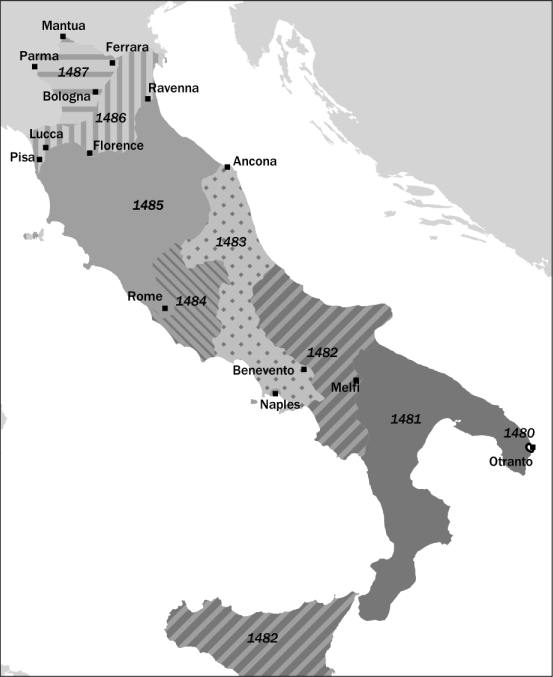
Gli Ottomani in Italia
di Alessio Mammarella e Generalissimus
.
Tutto parte dall'ucronia tratta da questo sito e tradotta per noi da Generalissimus:
Lo Stato Pontificio
Tedesco
una breve storia attraverso le mappe
I. Il pericolo
Gli eserciti Ottomani sbarcarono
per la prima volta ad Otranto nel Luglio 1480, comandati da Gedik Ahmet Pascià.
Questo fu l’inizio di una campagna di 7 anni che avrebbe visto i Turchi
schiacciare gli eserciti europei e conquistare la penisola italiana.
Sotto il comando personale di Maometto II gli invasori conquistarono la Puglia e
la Calabria l’anno successivo, seguite dalla Sicilia poco dopo.
Sconfissero sonoramente gli eserciti unificati degli Italiani e il Sacro Romano
Impero nel 1482 in quella che è nota come Prima Crociata Italiana.
Due anni dopo conquistarono tutta l’Italia meridionale e centrale, tranne Roma e
Napoli, che soccombettero entrambe dopo lunghi assedi nel 1485.
Anche la Seconda Crociata Italiana, comandata dall’Imperatore Massimiliano I,
fallì, e la Toscana e la Romagna caddero.
L’avanzata Ottomana venne finalmente fermata quando una coalizione di eserciti
francesi, tedeschi, italiani e spagnoli sotto la bandiera della Terza Crociata
Italiana, comandata da Gonzalo Fernández de Córdoba, difese con successo Ferrara
e inflisse un colpo decisivo nella Battaglia di Parma del Marzo 1487.
L’Impero Ottomano mantenne il possesso di queste terre per dieci anni, poi le
perse gradualmente nel corso di quattro decadi, venendo finalmente cacciato
dall’Italia nel 1536.
Le guerre lasciarono la penisola in uno stato penoso.
Questo, assieme alla scarsa reazione delle potenze europee nei primi anni della
guerra, lasciarono un forte e duraturo risentimento fra gli Italiani.
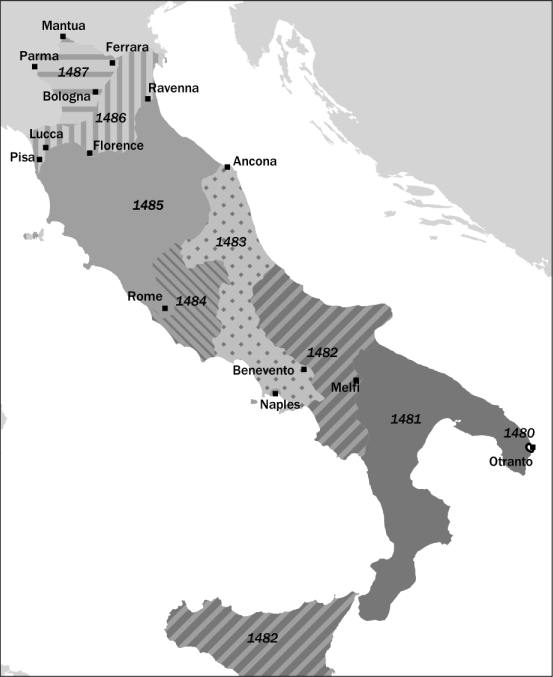
La conquista ottomana dell'Italia
II. La fuga
Il Papato aveva risieduto a Roma
per gran parte della sua storia, ma aveva passato gran parte del quattordicesimo
secolo ad Avignone, sotto la pressione francese.
Quando la caduta di Roma divenne inevitabile, Papa Sisto IV e la Curia si
trasferirono a Bologna, nel nord dello Stato Pontificio, portando con sé
convogli pieni di documenti e artefatti.
Quando a sua volta Bologna sembrò spacciata, l’apparato venne evacuato di nuovo
ad Avignone, all’epoca ancora sotto il controllo papale.
Re Carlo VIII di Francia vide questo come un’opportunità per prendere il
controllo del Papato e, con la scusa della protezione, il Papa divenne presto
essenzialmente un prigioniero del re francese.
La vigilia del primo Maggio 1496 il Papa e otto cardinali vennero portati via
nella notte e portati in Germania.
Il Sacro Romano Imperatore diede rifugio al Papa e lo invitò a stabilire lì la
nuova sede del Papato.
Il punto scelto fu Coblenza, in un’area già di proprietà della Chiesa.
L’esperienza di Avignone diede il via al peggioramento delle relazioni tra la
Chiesa e la corona francese.
La situazione si sarebbe solo aggravata quando le due sarebbero diventate rivali
geopolitiche.
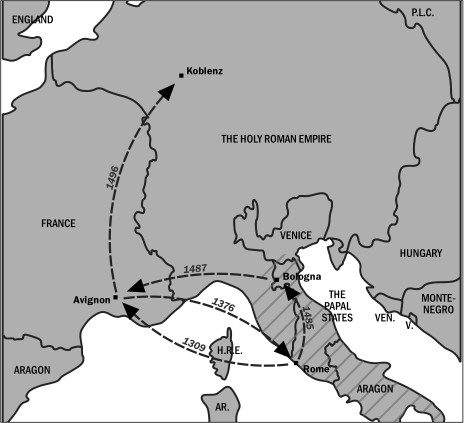
Le sedi papali
III. Il rifugio
Coblenza sorge alla confluenza del
Reno e della Mosella, a distanza di un rapido e confortevole viaggio in barca
verso Colonia, Treviri e Magonza.
In ognuna di queste città si tenevano a rotazione importanti cerimonie, mentre
venivano costruite la Cattedrale di Coblenza, la Basilica della Resurrezione e
nuovi ponti.
Queste città ospitavano i tre Principi Elettori ecclesiastici.
Lo stabilimento di una presenza fisica nell’area permise a Papa Lucio IV di
prendere il controllo diretto degli affari della Chiesa locale, usando
l’autorità spirituale per asserire l’autorità temporale.
Il controllo di tre dei sette Principi Elettori rese immediatamente il Papa il
secondo uomo più potente dell’Impero.
A cominciare da Papa Lucio V (1505-1520) la Chiesa avrebbe iniziato a
consolidare territori, ricchezza e potenza militare, diventando un importante
attore geopolitico in Europa occidentale.
Nel secolo successivo i papi avrebbero costruito un impero nell’impero ora noto
come Stato Pontificio Tedesco.
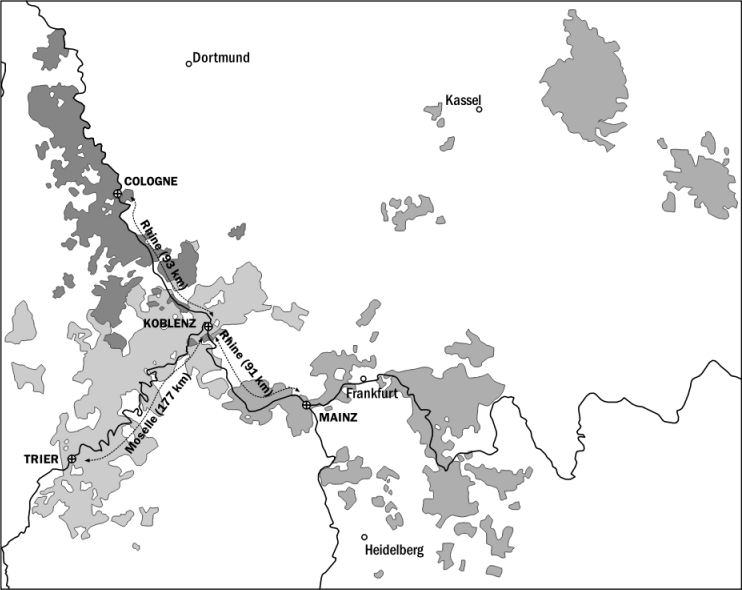
Terre degli Arcivescovadi Elettorali nel 1496
IV. L’ascesa
Entro il 17° secolo i papi
finirono col controllare un’entità che sembrava più uno stato che uno qualsiasi
dei regni indipendenti dell’epoca.
La disposizione era così conveniente e l’Italia centrale così devastata che
perfino quando la Sesta Crociata Italiana liberò Roma nel 1520 Papa Cornelio II
si rifiutò di trasferirsi.
Tutte le terre erano, comunque, ancora parte dell’Impero.
La relazione tra i papi e gli imperatori era complicata.
Da una parte c’era la lotta per il potere all’interno dell’impero, con lo Stato
Pontificio che stava diventando sempre più indipendente col passare del tempo e
più centralizzato intorno alle istituzioni Papali.
Dall’altra parte lo Stato Pontificio era un baluardo contro la potenza francese,
e faceva rispettare l’ordine all’interno dell’Impero.
L’equilibrio del potere fluì e rifluì, ma in generale i due leader riuscivano a
collaborare.
I papi venivano ricompensati con un processo noto come L’Imbuto: gli imperatori
prendevano possesso di territori quando una dinastia si esauriva, o come
punizioni per dei misfatti, o in cambio dell’estinzione di un debito, e donavano
quei territori alla Chiesa.
Così si espansero i possedimenti della Chiesa, che già includevano i grandi
territori dei tre Principi Elettori e dei principati vescovili come Liegi,
Münster o Brema.
Ci fu, comunque, qualche perdita, soprattutto le laicizzazioni di Magdeburgo,
Erfurt e Würzburg.
Inoltre , la chiesa poteva esercitare il controllo sui principi laici usando
pressioni economiche, politiche e militari.
I principi entravano così in un accordo legale con la Chiesa, sia come vassalli
del Papa che legati alla Chiesa da trattati.
Avevano obblighi militari e finanziari nei confronti della Chiesa (ufficialmente
donazioni) che in alcuni casi avevano una priorità più alta, o addirittura
rimpiazzavano, quelli dell’Impero.
Questo sistema venne codificato nel 1633, quando la Dieta di Ingolstadt
riorganizzò i Circoli Imperiali e riunì in un’istituzione unificata tutti i
territori nella parte occidentale dell’Impero controllati inequivocabilmente dal
Papa, il Circolo Papale.
Questo offrì autonomia al Papa, che ora aveva il potere di esigere tasse
piuttosto che chiedere “donazioni”, e autorità giudiziaria sull’intero Circolo.
Comunque, mise fine all’espansione dello Stato pontificio.
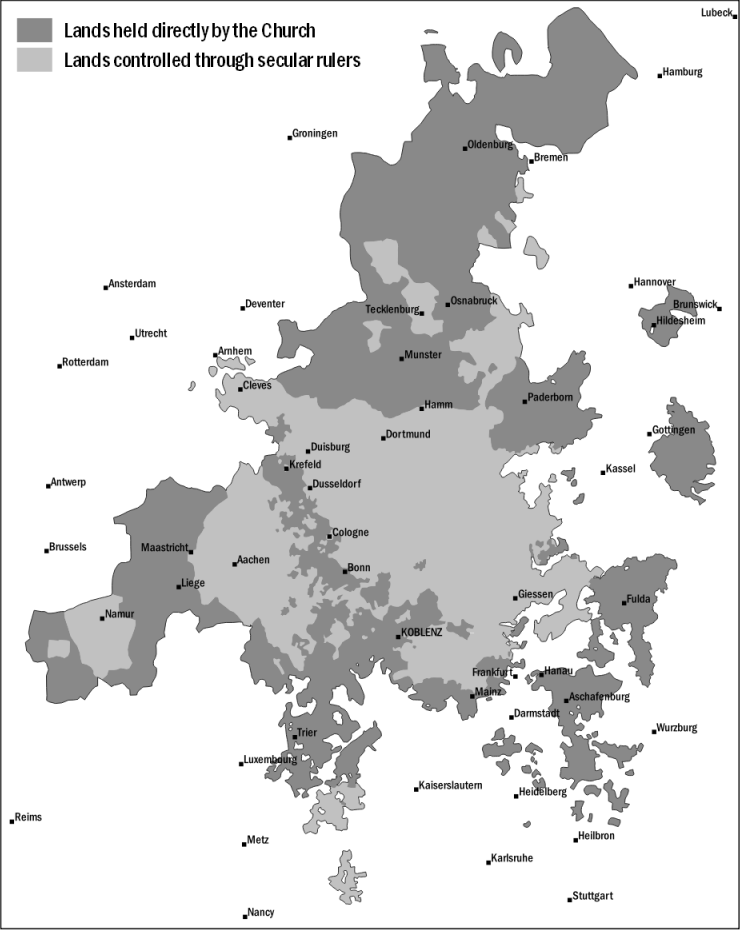
Il Circondario Papale dopo il 1633
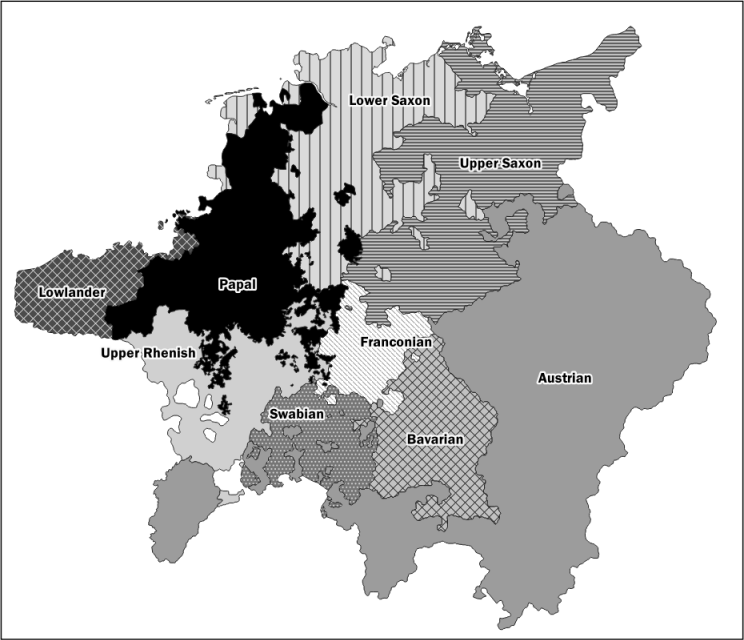
I Circondari Imperiali dopo il 1633
V. La sfida
La Riforma Protestante sarà anche
iniziata in Germania, ma mise radici permanenti altrove.
Gli storici attribuiscono ciò in gran parte alla presenza di un potente Papato
nelle vicinanze che non si faceva scrupoli ad intervenire.
Per tutto il 15° e il 16° secolo “Papi da Guerra” come Niccolò VI (1590-1596)
avrebbero organizzato crociate per sbarazzarsi dei movimenti Protestanti
nell’Impero.
Per contrasto, le lunghe frizioni tra Francia e il Papato implicarono che quando
ai Francesi venne fornita un’alternativa, questi rinunciarono con gioia ai
legami con la Chiesa Cattolica.
Re Francesco I proclamò la Francia ufficialmente Luterana nel 1545.
Nel frattempo, in Italia fu il sentimento di abbandono, sia durante l’invasione
Ottomana, quando si percepiva che il Papa fosse più preoccupato della sua
sicurezza e a mettere al sicuro la sua ricchezza che quella dell’Italia, che
dopo la Riconquista, quando il Papa ignorò l’Italia, che spinse gli Italiani
nelle braccia di varie sette Protestanti.
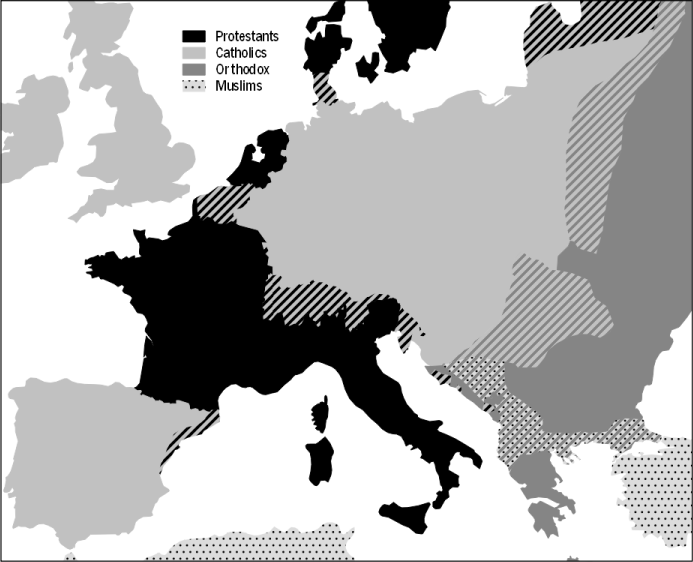
Le religioni europee alla fine del XVI secolo
VI. Il lascito
Lo Stato Pontificio venne abolito
nel 1796, quando la Germania occidentale venne conquistata dagli eserciti della
Francia rivoluzionaria.
Sotto la pressione degli alleati Cattolici e degli elementi Cattolici
all’interno della Francia, il governo di Parigi fornì al Papa un rifugio, che
copriva più o meno il complesso dei palazzi papali di Coblenza e un ex quartiere
di magazzini distrutto dalla guerra, dove la Chiesa avrebbe mantenuto un po’ di
autonomia.
Dopo il Congresso di Londra del 1800, il Regno di Prussia prese il controllo di
Coblenza, ormai la città tedesca più grande, e della Renania.
Re Federico Guglielmo II accettò di emancipare lo Stato Pontificio, nella forma
stabilita dalla Francia rivoluzionaria, come stato indipendente sotto la
protezione prussiana.
Quando col tempo lo stato tedesco cambiò forma, da regno a impero a repubblica e
perfino durante il picco del nazionalismo, non incorporò mai lo Stato
Pontificio.
Oggi lo Stato Pontificio è un’entità sovrana secondo il diritto internazionale.
Il suo territorio copre un’area di 38 ettari, e ha una popolazione di circa 2500
persone.
È ancora uno stato ecclesiastico, guidato dal Papa.
Con importanti musei come la Biblioteca della Santa Sede e le Gallerie Graumer,
accoglie circa cinque milioni di turisti ogni anno.
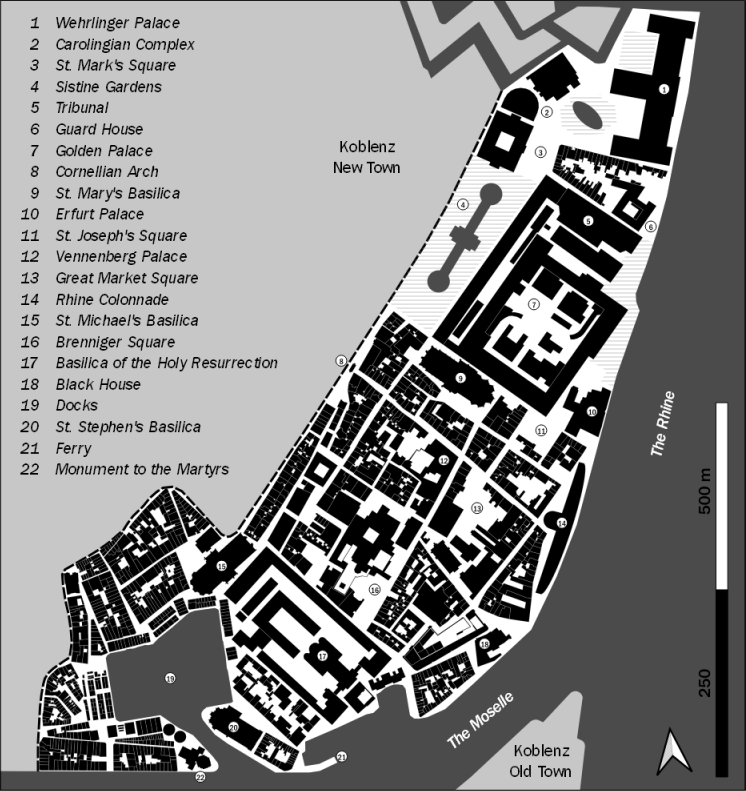
Lo Stato del Papa dopo il Congresso di Londra
.
*Bhrg'howidhHô(n-) commenta lesto:
L'idea non è sviluppata a sufficienza. Anzitutto si alterano alcune genealogie, perché è inverosimile il matrimonio di Luigi XIII. nonché quello di Luigi XIV. (e di Luigi XVI.), che comunque già non sarebbe la stessa persona. Questa alterazione mi pare importantissima (tanto per cominciare, rende impensabile una Guerra di Successione Spagnola, ma anche Polacca).
Poi non c'è Guerra dei Trent'Anni in Germania; anche questo è fondamentale.
Inoltre, come nei territori europei dell'Impero Ottomano sono rimaste musulmane la Bosnia (in piccola parte e solo dove erano già Bogomiliti) e l'attuale Turchia Europea, così sarebbe anche in Italia, se non che le zone conquistate dagli Ottomani in questa ucronia non arrivano a quelle anteriormente catare, dolciniane o ancora all'epoca valdesi - per cui viene meno il parallelo della Bosnia - e né Roma né altre parti d'Italia rimarrebbero ottomane oltre il XIX. secolo, quindi dopo la Riconquista non rimarrebbero Musulmani.
Quanto agli Evangelici, nei territori asburgici sarebbero soggetti alla Riforma Cattolica, come in Ungheria e Slesia (pressoché completamente ricattolicizzate) e quindi potrebbero rimanere solo in Piemonte, nelle Repubbliche di Genova, Lucca e Venezia, a Modena e Firenze (che non sarebbe Granducato, né Parma Ducato). La Riconquista vedrebbe lo Stato Pontificio (in questo caso simile al Regno Apostolico d'Ungheria) spartito fra Venezia, Modena e la Spagna (come è stato progettato anche storicamente; al massimo, sarebbe diventato un Principato Ecclesiastico mediatizzato), la Toscana fra Spagna e (forse) Medici, le Due Sicilie e la Sardegna alla Spagna o, se riconquistate tardi (poniamo, dal Principe Eugenio), direttamente all'Austria. Dopo Carlo II. diventerebbe comunque tutto austriaco, senza alcunché per i Savoia.
L'Imbuto è improponibile dopo il Concordato di Worms. Se un Feudo torna all'Imperatore, gli rimane.
Faccio notare che nella versione inglese l'invasione francese è del 1769, non del 1796; questo rende inverosimile la cessione della Corsica alla Francia da parte di Genova, che quindi si dovrà per forza rivolgere all'Impero, con tutto ciò che ne consegue. Penso comunque che si tratti di un refuso.
.
Ecco allora la proposta di Alessio, scritta per noi in occasione del Natale 2021:
La dominazione ottomana in Italia,
talvolta indicata con il termine di "Secoli ottomani" è stato il periodo in cui
gran parte del territorio italiano si è trovato compreso entro i confini
dell'Impero Ottomano. Un periodo che ha influito in modo notevole sulla storia
successiva del paese.
L'interesse dell'Impero Ottomano per l'Italia risaliva al sultano Maometto II,
il conquistatore di Costantinopoli, deciso almeno in teoria a conquistare anche
Roma, l'altra grande capitale dell'antico mondo romano e della cristianità. La
prima incursione ottomana in Italia era stata la sanguinosa presa di Otranto,
nel 1479. La morte di Maometto II, tuttavia, aveva interrotto i preparativi per
una spedizione di rinforzo, e il caposaldo stabilito a Otranto era stato
prontamente riconquistato dalle forze cristiane del Regno di Napoli. Negli anni
successivi, la guerra tra ottomani e cristiani, raggruppati in coalizioni che
tipicamente prendevano il nome di "Lega Santa", continuò soprattutto sul mare,
mentre il territorio italiano veniva interessato dalla rivalità tra francesi e
spagnoli per l'egemonia sulla penisola, articolata politicamente in stati
piccoli e militarmente deboli. Sembrava che la finestra di opportunità per
l'espansione in Italia si fosse irrimediabilmente chiusa, ma la conquista solo
qualche decennio più in là, verso la metà del XVI secolo, e condusse a un
dominio duraturo sulla Penisola.
La Guerra Franco-Ispano-Ottomana
Nel 1536, il Re di Francia Francesco I, che aveva già condotto
numerosi attacchi in Italia contro la supremazia di Carlo V, Imperatore e Re di
Spagna, decise di ritentare ma era alle prese con la mancanza di una flotta, a
causa della decisione della città di Genova di parteggiare per Carlo. Ciò pose
le premesse per una alleanza con il sultano ottomano Solimano I, che in effetti
non attendeva altro che una occasione propizia per inserirsi nelle vicende
italiane.
I due sovrani concordarono un attacco combinato alla città di Genova, da terra e
dal mare. Un attacco che fu sul punto di non avvenire, in quanto la guarnigione
a difesa della città era stata prontamente rinforzata da Andrea Doria, signore
della città e ammiraglio di Carlo V, e sfumò un tentativo di rivolta della
fazione filofrancese in città. Solimano riteneva tuttavia troppo importante che
i francesi continuassero a impegnare gli spagnoli nel nord Italia e così diede
ordine alla sua flotta di attaccare comunque. Al costo di alte perdite, gli
ottomani debilitarono notevolmente le difese della città, incoraggiando pertanto
i francesi a fare la loro parte. Genova fu infine presa, e a quel punto
Francesco I scese di persona in Italia per andare a combattere una battaglia
decisiva a Marignano, dove anni prima era stato sconfitto e catturato. Mentre
Francesco I prendeva la sua rivincita con la storia, un'altra flotta ottomana
aveva attaccato Brindisi e sbarcato un contingente. A causa dei notevoli impegni
sugli altri fronti, il Regno di Napoli era allora quasi sguarnito di truppe
spagnole e nel 1538, anno in cui fu concluso il trattato di pace, gli ottomani
si erano impadroniti quasi completamente del regno, lasciando libero solo un
sottile arco di territorio da Napoli all'Abruzzo Ulteriore. A nord, intanto, il
trattato di pace tra Francesco I e Carlo V stabilì il confine più generoso che
la Francia avesse mai sperato: domini sabaudi, Ducato di Milano e Liguria
venivano annessi direttamente al Regno di Francia. Francesco I attribuì al
figlio Enrico il titolo di Duca di Milano, e da quel momento il titolo divenne
associato alla figura del Delfino.
La conquista di Napoli
La rapidità e l'ampiezza delle conquiste di Solimano in Italia
preoccuparono il Papa e le corti europee, che ritenevano ormai possibile un
attacco a Roma da parte di Solimano. Fu indetta una crociata di tutte le nazioni
cristiane contro i turchi, ma Francesco I propose di risolvere la questione
diplomaticamente. Il sovrano francese si diceva convinto, nelle sue lettere al
Pontefice, che se la corona di Napoli fosse stata passata al suo figlio minore,
Carlo, ciò avrebbe dissuaso Solimano, per onore dell'amicizia con il sovrano
francese. Carlo V, sospettando una manovra coordinata dei due nemici, si risolse
a pensare che Solimano non avrebbe mai attaccato il resto della penisola, ma che
si trattasse solo di un'astuta mossa per fare ottenere la corona napoletana a
una dinastia francese a sue spese. Il sovrano ritenne piuttosto in pericolo la
Sicilia, che i turchi avrebbero potuto attaccare per consolidare la loro
supremazia nel Mediterraneo. L'Imperatore dunque rifiutò le richieste francesi
su Napoli, rifiutò qualsiasi aiuto da parte del monarca rivale e si preparò a
difendere la Sicilia. Fu un grave errore strategico perché in realtà Solimano,
indipendentemente dai tentativi diplomatici del re francese, era davvero
risoluto a proseguire verso Napoli e Roma.
Nel 1542 iniziò la seconda fase della conquista: le truppe ottomane penetrarono
nel territorio residuo del Regno di Napoli, intraprendendo l'assedio della
capitale, poco dopo che un forte contingente spagnolo era sbarcato inutilmente
in Sicilia per rinforzare le difese dell'isola. Era comunque disponibile un
forte contingente italo-spagnolo, intenzionato a rompere l'assedio, ma fu
intercettato e battuto sul fiume Volturno dal figlio maggiore di Solimano, il
talentuoso Mustafà. Questo successo, ottenuto in condizioni di inferiorità
numerica e tattica (in quella occasione l'esercito di Mustafà era quasi privo di
cannoni, l'arma decisiva in quegli anni soprattutto per la tattica ottomana)
ebbe anche una notevole importanza per la storia dell'Impero Ottomano: il
principe era infatti oggetto a quel tempo di pettegolezzi ostili, e forse
sarebbe finito assassinato in qualche cospirazione se questa vittoria non avesse
fatto decidere al padre che Mustafà fosse proprio il successore scelto dal
destino.
Dopo l'inevitabile resa di Napoli, le truppe ottomane invasero le Marche,
territorio pontificio, puntando a raggiungere Ancona in parallelo con la flotta
che risaliva l'Adriatico. Questa mossa, che lasciava intendere chiaramente
l'intenzione di conquistare l'intera penisola, gettò nel panico le corti
italiane: il Papa iniziò a valutare il trasferimento ad Avignone, nonostante
fosse profondamente irritato per le manovre diplomatiche di Francesco I che
volontariamente o involontariamente avevano permesso agli infedeli di occupare
gran parte dell'Italia; Siena, Firenze e Ferrara spesero cifre ingenti per
assoldare mercenari in svizzeri e tedeschi in quantità. Nel 1544, la corte
papale tornava ad insediarsi ad Avignone, e la riconciliazione con Francesco I
si concretizzò nella sua sua adesione alla Lega Santa contro i turchi. Anche
Venezia, visto che francesi e spagnoli erano ormai dalla stessa parte, decise di
rompere la politica di neutralità che aveva iniziato da qualche decennio e
unirsi alla Lega.
La battaglia di Sentino
Nell'estate del 1544, una parte delle truppe ottomane cominciò ad
assediare Roma. Solimano, preoccupato dall'ampliamento dell'alleanza avversaria,
ingiunse al figlio Mustafà di combattere una battaglia decisiva prima che
francesi e veneziani arrivassero a unirsi alla coalizione. L'armata cristiana a
quel punto avrebbe avuto una forza tale non solo da spazzare via gli assedianti
di Roma, ma anche di intraprendere una risoluta riconquista del Regno di Napoli.
Mustafà tuttavia, che aveva già dato prova di saper combattere in condizioni di
inferiorità, puntò sul fatto che l'enorme contingente cristiano sarebbe stato
lento nei movimenti e che l'esistenza di molti comandanti, diffidenti se non
rivali tra loro, avrebbe giovato a suo vantaggio soprattutto quando il
contingente era ancora in marcia. Per questo motivo penetrò in Umbria, pensando
di poter sorprendere il grande esercito che si stava concentrando nei dintorni
di Bologna e che era pronto a calare verso Roma attraverso la via Flaminia. I
due eserciti si incrociarono nei pressi di Sentino, località dove quasi duemila
anni prima i romani e i loro nemici avevano combattuto una battaglia decisiva
per le sorti della penisola.
Il giovane principe turco era finito in una posizione difficile, dove i suoi
avversari avrebbero potuto circondarlo. La notte prima della battaglia,
tuttavia, un gruppo di mercenari lanzichenecchi, protestanti appiccarono
volontariamente un grosso incendio presso uno dei campi dove erano acquartierati
i terceros spagnoli. L'incendio gettò il campo cristiano nella confusione: una
parte dei soldati fuggì, un'altra reagì a quello che riteneva un attacco nemico
dirigendosi in modo furioso e disordinato verso il campo turco e facendosi
massacrare. Questo episodio fece comunque capire a Mustafà che una parte del
contingente cristiano era in condizioni di debolezza e già al primo mattino
riuscì a sgominarla con un attacco della sua cavalleria leggera e a occuparne le
posizioni, che sarebbero state perfette per l'artiglieria.
I comandanti cristiani, dopo aver discusso lungamente sull'episodio, decisero
che il contingente non poteva ritirarsi, perché ciò sarebbe apparso come una
sconfitta. Decisero quindi di serrare i ranghi e combattere una battaglia
completa malgrado l'incendio avesse mandato in fumo, oltre a parte degli
accampamenti cristiani, anche i piani approntati per la battaglia. Verso
mezzogiorno le truppe cristiane attaccarono con tutte le loro forze ma
l'artiglieria turca, appostata in modo ottimo, fece gran strage di soldati
nemici. In gran parte si trattava di lanzichenecchi, di cui i comandanti, dopo
l'episodio dell'incendio notturno, non si fidavano più. In ogni caso, le elevate
perdite demoralizzarono e indussero alla fuga molti soldati cristiani,
soprattutto quelli poco disciplinati ed aggregati in modo frettoloso. Alla fine
del pomeriggio le truppe cristiane avevano perso la superiorità numerica su cui
tanto si puntava. Alla fine una irruzione della cavalleria ungherese consentì
all'esercito cristiano di ritirarsi, dopo aver perso comunque la battaglia.
Le conquiste successive
Svanite le speranze di soccorso, Roma si arrese. Pochi giorni dopo
Solimano, che si era già portato in Italia, fece ingresso in città.
Successivamente, l'esercito ottomano arrivò sotto le mura di Firenze e cominciò
ad assediarla, mentre un altro contingente, appena sbarcato ad Ancona
dall'oriente, iniziò ad avanzare verso Rimini e Ravenna. Nel 1545 si verificò
una ulteriore battaglia nei pressi dell'Arno tra l'esercito ottomano e rinforzi
spagnoli, portoghesi e polacchi. La battaglia, molto sanguinosa, si concluse in
un nulla di fatto, che non riuscì comunque a impedire la caduta di Firenze.
Ormai la coalizione cristiana aveva ben poche carte da giocare e furono avviati
colloqui di pace.
Prima della pace definitiva, gli ottomani conquistarono Bologna, Ferrara e
Mantova, fortezza storicamente in mano all'esercito imperiale, che in questo
modo perse l'ultima base d'appoggio nella Pianura Padana. Ormai i turchi erano
giunti presso il confine veneziano e la Serenissima comandò a tutti i suoi
cittadini di prendere le armi per difendere il territorio. Solimano, tuttavia,
non aveva alcuna intenzione di avanzare ancora verso il territorio veneziano. Il
sovrano, infatti, era interessato a conservare una rete di piccoli stati che
evitassero un confine diretto con i territori degli Asburgo e con quelli del
Regno di Francia. Volle quindi che Venezia restasse a garantire la pace con la
sua neutralità e dispose allo stesso modo per altri stati italiani. Agli
Estensi, tolta Ferrara, fece riconoscere Mantova, in modo da offrire un altro
spazio neutrale con il Regno di Francia, padrone di Milano e Genova. Fece
stabilire, infine, il nuovo ducato di Lucca, da attribuire alla potente famiglia
Medici di Firenze.
Quest'ordine conobbe un assestamento quando Mustafà, diventato Sultano al posto
del padre, propose a Venezia di acquistare uno degli eyalet ottomani in Italia
scambiandolo con Cipro. Venezia ottenne quindi il controllo di Bologna, Ferrara
e della Romagna. Per l'ultima conquista ottomana in Italia, la Sicilia, si
dovette invece attendere il 1587 quando, in seguito all'alleanza stipulata con
Elisabetta I d'Inghilterra, l'Impero intraprese la conquista dell'isola. Si
trattò di un conflitto di intensità modesta, che procedette piuttosto fiacco
mentre inglesi e spagnoli duellavano nell'Atlantico. Alla fine del conflitto,
dovuto principalmente alla morte della tenace regina inglese, la Sicilia divenne
un altro eyalet ottomano, aggiungendosi agli altri già istituiti nell'Italia
continentale.
Roma e il Califfato
Quando Solimano conquistò Roma, constatò che nella città,
largamente spopolata, erano rimasti pochissimi preti cristiani. Ciò significava
che non avrebbe dovuto convivere, come a Costantinopoli, con un clero cristiano
forte e radicato: la città era pronta per essere islamizzata secondo i suoi
voleri. Dopo aver spinto alla conversione gran parte degli abitanti rimasti,
fece ripopolare la città con genti prese da ogni parte dell'Impero. Voleva farne
una capitale, ma non una capitale politica, vista la minore centralità rispetto
a Costantinopoli, bensì una capitale religiosa. Nel 1554, in occasione dei suoi
sessant'anni e dopo alcuni anni di lavori e restauri della città, Solimano
proclamò il Califfato di Roma. Gli ottomani associano all'investitura come
capitale califfale la teoria della cosiddetta "Terza Roma". La prima sarebbe la
Roma antica dei miscredenti, la seconda la Roma dei cristiani, ugualmente
peccatrice seppure ispirata da un grande profeta, e infine la terza Roma
dell'islam.
Il mondo cristiano, tra l'altro, era in subbuglio perché cattolici e protestanti
avevano visioni nettamente diverse sulla caduta di Roma e sulla necessità di
riconquistarla. I cattolici consideravano la caduta di Roma come dovuta alla
divisione tra i cristiani, e consideravano prioritario che le eresie protestanti
fossero superate in favore di una ritrovata unità e di una crociata per la
riconquista della città santa. I protestanti da parte loro consideravano la
caduta di Roma come dovuta alla corruzione della chiesa cattolica ed a una
conseguente punizione divina. Consideravano prioritario piuttosto purgare la
comunità cristiana dalla corruzione e riguadagnare così il favore divino. Non
erano quindi disposti semplicemente a combattere per riconquistare la città.
Gli anni della pace
Il XVII secolo, iniziato con la fine della guerra in Sicilia, fu
quasi interamente pacifico. Anche se l'Italia non era più quella splendida del
Rinascimento, almeno nella prima parte del secolo i governi ottomani si
impegnarono molto per aumentare la sua popolazione, la sua produzione e il suo
commercio. La marina ottomana stabilì le sue principali basi a Livorno e
Taranto, città ancora oggi principali per la navigazione civile e militare.
Furono costruite importanti moschee in tutte le maggiori città e fu favorito
l'afflusso di popolazione musulmana da altre province. Ciò determinò un certo
squilibrio tra la popolazione delle città, cosmopolita e in buon numero
musulmana, e quella delle campagne, rimasta pressoché identica al passato.
A Venezia, la pubblicazione della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso favorì
la nascita di un sentimento patriottico italiano. I veneziani, che erano sempre
stati attenti più che altro agli affari e al loro interesse particolare,
cominciarono a maturare l'idea che un giorno la piccola ma progredita e ancora
opulenta Venezia avrebbe potuto liberare il resto dell'Italia. Molti letterati
italiani ivi residenti abbandonarono l'uso dell'idioma toscano, fino ad allora
prediletto in ragione dei tre grandi maestri Dante, Petrarca e Boccaccio, e
cominciarono a usare esclusivamente l'italiano di Venezia, ritenuto ancora
"puro" mentre le lingue parlate a Firenze, Roma o Napoli avevano cominciato a
sporcarsi con termini di origine orientale.
Gli anni del declino
I nipoti ed i pronipoti del grande Sultano Mustafa non si
rivelarono di altrettanto spessore e talento: l'Impero cominciò a declinare a
causa del disinteresse e della corruzione dei funzionari. Si interruppe inoltre
la consuetudine, instaurata subito dopo l'istituzione dell'erezione di Roma come
sede califfale, dei sovrani ottomani a trascorrere anche dei periodi a Roma, in
qualità di Califfo. Andò a scadere anche l'accorta politica diplomatica
inaugurata da Solimano I, anche a causa dell'impegno delle monarchie cristiane
in un conflitto fratricida, la Guerra dei Trent'anni e in particolare andò a
deteriorarsi il rapporto con Venezia, dove prendevano sempre di più piede idee
ostili all'Impero. Fu in questo contesto che il Sultano Ibrahim I, praticamente
folle, decise di iniziare una guerra con Venezia per appropriarsi del suo
principale dominio nell'Egeo, l'isola di Creta. Malgrado la morte di Ibrahim
avvenuta poco dopo, i suoi successori per una questione di orgoglio regale
decisero di proseguire fino alla completa conquista dell'isola. L'enorme
dispendio di risorse si sarebbe fatto poi sentire durante la più impegnativa
guerra contro l'Impero e la casa d'Asburgo, che riuscirono a salvaguardare
ancora una volta Vienna dalla conquista ed a infliggere agli ottomani pesanti
sconfitte. Nel frattempo i veneziani, sconfitti a Creta, avevano deciso di osare
a portare la guerra sul territorio italiano. L'esercito veneziano era stato
riorganizzato da pochi anni da Carlo Emanuele di Savoia. Il nobile, erede della
dinastia che per secoli aveva governato un piccolo stato a cavallo delle Alpi
poi assorbito dalla Francia nel corso del secolo precedente, conservava ancora i
titoli, meramente onorifici, di Re di Cipro e di Gerusalemme. In sé dunque
assommava un certo "spirito crociato" dovuto al suo lignaggio e ai suoi titoli,
e una forte convinzione sugli ideali patriottici presenti negli ambienti
politici e culturali veneziani. Morì, purtroppo per lui, qualche anno prima di
vedere all'opera il suo piccolo ma agguerrito esercito. Al suo posto a
comandarlo fu un comandante francese di lontane origini italiane, il Duca del
Monferrato. Le truppe veneziane ottennero numerosi successi sulle più numerose
ma demotivate e mal condotte truppe ottomane. Alla fine del conflitto, l'Impero
fu costretto a cedere a Venezia l'intero eyalet di Toscana.
La Riconquista cristiana
All'inizio del XVIII secolo la situazione nelle province italiane
dell'Impero Ottomano cominciarono a conoscere rivolte contro l'eccessivo carico
fiscale, la corruzione dei funzionari e lo svilimento della moneta. Fu per
questo che l'Impero non riuscì a reagire quando il nuovo Re di Spagna, Filippo V
tentò di riconquistare la Sicilia per compensare la perdita dei Paesi Bassi
spagnoli dovuta alla guerra di successione conclusasi pochi anni prima. La
flotta ottomana fu sconfitta piuttosto facilmente e non riuscì a contrastare lo
sbarco delle truppe spagnole sull'isola. Filippo V assegnò la Sicilia, con il
titolo di Re, a suo figlio minore Carlo. Il giovane sovrano avrebbe voluto
proseguire verso il continente, ma le pressioni diplomatiche delle altre potenze
europee salvarono momentaneamente gli ottomani.
Se nel secolo precedente la Riconquista cristiana era stata impedita dalle
guerre tra cattolici e protestanti che coinvolgevano le maggiori potenze,
all'inizio del XVIII secolo il problema era soprattutto la rivalità tra la casa
di Borbone, regnante in Francia e Spagna, e quella d'Asburgo, che gli ottomani
avevano estromesso dagli affari d'Italia ma che a causa di questi avvenimenti
aveva sviluppato un forte rapporto con la Repubblica di Venezia. La Guerra di
Successione Polacca fu tuttavia fatale rispetto alla dominazione ottomana in
Italia: la Repubblica di Venezia, sempre più influenzata dagli Asburgo, scese in
guerra contro la Francia e attaccò il milanese. L'obiettivo era consentire il
ritorno degli Asburgo a Milano, cosa che da lungo tempo la corte di Vienna
considerava importante e necessaria. In cambio, la Serenissima avrebbe ottenuto
Lucca, piccolo possedimento che gli Asburgo avevano ottenuto come eredità
dell'estinta dinastia medicea.
Mentre i veneziani erano impegnati nel conflitto europeo, il Re di Sicilia Carlo
fu finalmente libero di intraprendere la sua guerra definitiva contro gli
ottomani. Le truppe borboniche sbarcarono in Calabria e salirono rapidamente la
penisola. Gli ottomani offrirono comunque una certa resistenza, ma
l'organizzazione, la disciplina e l'armamento degli ottomani non erano più
competitivi rispetto a quelli dei più moderni eserciti europei, specialmente di
quello approntato da Carlo con grande cura. Le forze borboniche ottennero una
importante vittoria nei pressi di Melfi, e poi una seconda nei pressi di Canosa,
debilitando fortemente il contingente dei difensori ottomani e spingendolo a
rintanarsi nella Penisola Salentina. Solo dopo queste operazioni di
annientamento dell'esercito nemico Carlo iniziò la marcia finale verso Roma,
perché non intendeva assediare la città ma entrarvi accolto pacificamente, da
incontestabile vincitore.
Già durante la marcia lungo l'antichissima via Appia, l'esercito di Carlo subì
imboscate e assalti disordinati da parte di gruppi di musulmani che non
intendevano assolutamente ritrovarsi sotto un sovrano cristiano. In alcune città
dove una parte consistente della popolazione era musulmana, si formarono
spontaneamente delle giunte di governo formate da musulmani che cercarono di
rispondere al collasso del potere imperiale con forme di autogoverno locale
ostili al re cristiano invasore. Questi fatti prefigurarono i problemi che il
giovane sovrano avrebbe dovuto affrontare dopo la vittoria ufficiale contro gli
ottomani: avrebbe dovuto vedersela con l'ostilità della popolazione musulmana,
scontri ed episodi di crudeltà tra sudditi cristiani e musulmani, la necessità
di imporre l'ordine sul territorio.
Fu per queste ragioni, probabilmente, che Papa Clemente XII declinò l'invito di
Carlo di rientrare a Roma, dichiarando nella sua enciclica Educatio Sponsae che
la città di Roma, con una popolazione pressoché interamente musulmana, andava
prima rieducata al cristianesimo con una paziente attività missionaria, e che
solo in seguito si sarebbe potuto pensare di ricondurre a Roma la sede della
cristianità. Nonostante queste condizioni sconfortanti, Carlo confermò
l'intenzione di desiderare proprio Roma come sua capitale.
Alcuni storici, riprendendo la tesi della "Terza Roma" musulmana, hanno parlato
di "Quarta Roma" per riferirsi alla Roma capitale del nuovo Regno d'Italia
proclamato nel 1738 da Carlo I.
.
Dario Carcano si mostra soddisfatto:
Molto interessante!
Poi come prosegue? Carlo I unifica l'Italia ma resta Venezia, che assieme agli
alleati Asburgo è padrona del Nord Italia.
Si arriverà allo scontro tra le due potenze, Borbone e Venezia-Asburgo?
I musulmani d'Italia? Vengono convertiti (magari a forza) o sopravvivono fino ai
giorni nostri?
.
Non può mancare il parere in proposito del nostro grande *Bhrg'howidhHô(n-):
Alcuni punti critici:
1) La Battaglia di Marignano ha avuto, nella Storia reale, molte meno conseguenze di quello che sembrava, mentre in questa ucronia decide addirittura tutta la Storia per i due secoli successivi, nonostante vi siano state altre guerre franco-asburgiche (con vittoria imperiale nel 1551-1559), la Guerra dei Tre Enrichi, oltre ovviamente a Lepanto e alla seconda conquista di Tunisi. In questa ucronia la Spagna sparisce come Potenza (anche se neppure questo mi aiuta a capire il gesto dei Lanzichenecchi), salvo avere l’ottima idea di attaccare l’Inghilterra appena in tempo per farsi conquistare anche la Sicilia; tutto tranquillo invece fra Sublime Porta e Francia, storicamente rivali per la Corsica (nessuna parola della Sardegna).
2) La politica dei Stati neutrali verso Austria e Francia è l’opposto di quella storica degli Ottomani e in particolare di Solimano il Magnifico; gli effetti se ne vedono in questa stessa ucronia, che quindi alla scomparsa della Spagna come Potenza aggiunge un clamoroso errore storico a carico dei Sultani (ben peggiore di qualsiasi evento realmente accaduto).
3) Invece di diventare tributaria dell’Impero Ottomano (che aspetta a lungo prima di sferrare l’attacco), Venezia si allea alla fine con l’Austria per farsene circondare, allontanando i Francesi da Milano, il tutto allo scopo di acquisire Lucca (che avrebbe ottenuto altrettanto facilmente con la politica opposta).
4) Nonostante l’assenza di ogni residuo possedimento spagnolo extrapeninsulare in Europa a parte i Paesi Bassi Meridionali (e la Sardegna? In questa ucronia è più difficile che Carlo VI, impedisca che resti a Massimiliano II. Emanuele), alla fine la spartizione della Spagna avviene lo stesso come nella Storia reale (e le Potenze Europee salvano l’Impero Ottomano).
5) Nella Guerra di Successione Polacca e la in buona parte contemporanea Guerra Austro-Russo-Turca del 1735-1739, l’Impero Ottomano, anziché vincere (come nella Storia reale), perde tutto.
Il primo punto tratta Spagna e Austria come Potenze molto più fragili che nella Storia reale, il secondo l’Impero Ottomano come se praticasse un Imperialismo indiretto, il terzo Venezia come uno Stato asburgico, il quarto le Potenze europee come se avessero la mentalità del secolo successivo e il quinto l’Impero Ottomano come se fosse in condizioni opposte a quelle in cui si trovava all’epoca: ce n’è quasi per tutti.
Per questi cinque motivi oso suggerire una parziale revisione. Se l’obiettivo fondamentale dell’ucronia è di assicurare due (o magari anche tre) secoli di Turcocrazia in Italia, modificherei in questo modo i punti citati:
1) la Sublime Porta deve scacciare la Spagna il più possibile sul mare, quindi oltre a Napoli anche quanto prima la Sicilia (senza aspettare inverosimili errori di Filippo II.) e pressoché di certo anche la Sardegna, dopodiché arriva l’ora della Corsica; gli Asburgo, persi tutti questi Regni e se non sono in grado di passare alla controffensiva contro gli Ottomani, saranno obbligati a posporre qualsiasi altro obiettivo (a parte eventualmente l’Unione Iberica col Portogallo) all’incorporazione di Milano, Genova e dei territorî ex-sabaudi (al massimo i Savoia potranno conservare Nizza; escluse perfino Aosta e Vercelli), per cui Enrico IV. non arriverà mai al confine svizzero e di conseguenza nella Guerra dei Trent’Anni la Valtellina e la Bassa Engadina rimarranno austrispaniche.
2) Solimano arriva fino a Piacenza e conserva sia Mantova sia Lucca; il confine fra i due Imperi è paragonabile a quello austro-turco in Ungheria.
3) Venezia diventa tributaria come la Transilvania; nella Grande Guerra Austro-Turca del 1683-1699 passerà sotto il controllo asburgico (il ruolo di Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers sarà, come e più che nella Storia vera, del Principe Eugenio di Savoia-Carignano).
4) È escluso che alcun Feudo Imperiale spagnolo non torni all’Imperatore; in luogo delle qui non disponibili Sardegna e Due Sicilie, è chiaro che Filippo V. avrebbe dovuto rinunciare alla non ancora riconquistata Catalogna, verso cui dunque avrebbe indirizzato i proprî sforzi negli anni (o decenni) successivi e che infine Carlo VI. avrebbe costretto Vittorio Amedeo II. di Savoia a scambiare con Nizza (questo è lo scenario minimo).
5) Il punto critico arriva nella Guerra di Successione Polacca, che in questa ucronia presenta una costellazione di alleanze difficile da giustificare. In base alle modifiche ai punti 1. e 4., a puntare alla (residua) Italia Imperiale sarà solo Luigi XV., di cui ovviamente Carlo Emanuele III. sarà più che mai alleato e perciò al sicuro da Filippo V., che non avrà obiettivi realistici, non potendo attaccare l’Alleato ottomano, per parte sua casomai impegnato a recuperare (oltre alla Serbia e all’Oltenia) la Toscana, le Romagne e il protettorato su Venezia, probabilmente con successo.
Il punto di arrivo, come si vede, è che la Turcocrazia si mantiene in Italia oltre il 1739; in altri termini, l’ucronia ha più potenzialità di quante se ne manifestino nella versione originale.
Nella Guerra di Successione Austriaca, Carlo Emanuele sarà di nuovo alleato di necessità dei Gallispani. La situazione rischia di essere fatale per gli Asburgo, a livelli da XVI. secolo, ma la Sublime Porta è impegnata contro la Persia e quindi tutto si mantiene inalterato fino al Rovesciamento delle Alleanze nel 1756. In quel momento si delinea una nuova prospettiva, che potrebbe portare la Spagna (dal 1759 di Carlo III.) alla riconquista della Sardegna e delle Due Sicilie (nonché della Corsica da parte di Genova austriaca), ma il tutto deve essere rimandato a causa della Guerra dei Sette Anni.
Dal 1764 in poi il contesto europeo diventa favorevole all’operazione: una Grande Alleanza austro-russo-gallispanica contro l’Impero Ottomano può portare la Corsica alla Francia, la Sardegna ai Savoia (di Catalogna), le Due Sicilie alla Spagna e il resto d’Italia all’Austria (che recupererebbe anche la Serbia e l’Oltenia). Mi sembra molto verosimile che tutto ciò avvenga, al più tardi dal regno di Luigi XVI. e Maria Antonietta.
Non porrei la fine della Turcocrazia in Italia prima di allora. Avremo quindi quattro diverse politiche: quella austriaca ha il parallelo storico reale, la spagnola solo quello – più vago – della Reconquista, mentre per Sardegna e Corsica ci possiamo basare sulle ‘colonizzazioni’ storiche sabauda e francese rispettivamente.
.
C'è anche il contributo di Federico Sangalli:
Ci sono delle differenze sostanziali (la conquista avviene nella prima metà del Cinquecento invece che alla fine del Quattrocento; il Papa ritorna ad Avignone) però mi chiedevo se questo scenario non si potesse combinare con quello dello Stato della Chiesa in Germania che partiva da premesse simili (conquista ottomana della penisola italiana).
Mi è venuta anche un’altra idea: se il Papa si trasferisse in Germania e la tempistica fosse quella giusta si potrebbe pensare a uno Stato della Chiesa alternativo ai principati vescovili (che bell’immediato ricoprirebbero comunque questo ruolo), cioè la Prussia Orientale. Possiamo infatti immaginare che, in un periodo di caos, con la Cristianità colpita al cuore e pensieri apocalittici dilaganti che alimentano anche un certo fanatismo neo-crociato, un Collegio Cardinalizio dominato dai tedeschi elegga Papa un Cardinale-Gran Maestro dell’Ordine Teutonico e che l’Imperatore, immaginando di togliere la regione ai protestanti e ai polacchi in un colpo solo, appoggi la trasformazione della Prussia in una sorta di stato monastico-militaresco affacciato sul Baltico e sede della Chiesa (capitale Kirchesberg). Polacchi e tedeschi cercherebbero di giostrarsi il Papato fra loro, la Svezia avrà qualche paranoia mentre da lì a poco in Russia scoppieranno i Torbidi e il Patriarca di Mosca si vedrà domandare in latino come mai è così serio.
.
E feder propone:
Mi è piaciuta molto l'idea (era da un po' che ci pensavo) e ti ringrazio per averla sviluppata, ma ci sono alcuni interessanti colpi di frusta che nel tuo sviluppo non hai voluto toccare, e io desidero ugualmente menzionare.
In primis, se Mustafa resta sul trono di Bisanzio, allora l'impero si sviluppa in una direzione del tutto diversa e particolarmente imprevedibile. Forse Mustafa, sovrano colto e capace, potrebbe voler decidere di competere con l'Occidente anche sul mare, nelle Americhe oppure nelle Indie; oppure deciderebbe per una nuova spedizione militare, se non contro Vienna, contro Vilna o Mosca, i cui drammi dell'espansione ai danni tatari era molto sentita storicamente a Istanbul. Se poi il portato religioso connesso alla carica di califfo logicamente aumenta per la conquista di Roma, dubito che Mustafa o chi per lui avrebbero potuto continuare a tollerare la libera pratica dell'eresia sciita in Persia. Presto o tardi gli ottomani se ne sarebbero occupati, spartendone il territorio con i Moghul, forse, già amici per via commerciale.
In secundis, l'intera epopea della riconquista mi pare un po' affrettata. C'è tanto da dire, miti da inventare, eroi da fare nascere, epicità da mischiare al racconto. Invece si riduce tutto all'opera di un uomo solo che nel corso di niente pone fine alla dominazione islamica. Davvero? Mi sembra improbabile. Per spostare i turchi dai Balcani ci sono voluti due secoli di guerre espansive; se non vogliamo applicare una simmetria, comunque teniamo conto dell'esempio storico. Sono molto curioso di vedere come continuerà. Sei stato bravissimo a distinguere i particolari della cultura islamica nella penisola, mi hai appassionato sul serio!
.
Riprende la parola Alessio:
Chiaramente, come qualcuno ha intuito, è stata l'ucronia del Papato in Germania a ispirarmi, solo che in questo caso l'invasione ottomana dell'Italia non è un mezzo per far spostare la sede papale, ma è proprio il fine dell'ucronia, ecco perché ho cercato di trovare la collocazione temporale che mi sembra migliore per consentire la conquista e il mantenimento. Genova e Milano in mano francese e la neutralità di Venezia erano forzature per assicurare la maggior tranquillità possibile all'esperimento di una Italia musulmana. Mi rendo però conto che specialmente l'impostazione di Venezia è priorio errata e indifendibile, quindi la cambierò.
Come Dario ha ben capito, comunque, a me sembra intrigante soprattutto l'aspetto culturale. Purtroppo con una semplice ucronia non possiamo vedere come sarebbe cambiata l'italianità con il tocco dato dagli ottomani, come sarebbero cambiate il linguaggio, i costumi... questa ucronia mi interessa, più che per la concatenazione degli eventi storici, per la creazione di un mondo. Avevo una idea di come la storia sarebbe potuta proseguire, ma penso che prima di tutto dovrei concepire un nuovo finale per la dominazione ottomana, visto che a detta di tutti è stato troppo sbrigativo.
Per quanto riguarda il tema della sede papale, Avignone mi sembrava la scelta naturale. Ho anche pensato alla possibilità di una seconda cattività avignonese e un secondo scisma d'occidente, ad esempio tra un Papa francese e uno tedesco. L'idea di un papa tedesco in Prussia forse potrebbe essere ancora più compatibile con uno scenario del genere...
Più di questo però mi interessava sottolineare in che modo secondo me la caduta di Roma in mano ai musulmani avrebbe ampliato la spaccatura tra cattolici e protestanti. Che indizio dà l'episodio dei lanzichenecchi? Che secondo me i protestanti avrebbero individuato la caduta di Roma come una punizione divina per la chiesa cattolica. Quindi mentre i cattolici avrebbero cercato di unire le forze per riconquistare Roma militarmente, ma i protestanti avrebbero guardato con sfiducia e disprezzo a tali tentativi, ritenendo invece che Roma sarebbe tornata cristiana solo quando ci si sarebbe finalmente liberati della corrotta chiesa cattolica (in pratica, cattolici "crociati" e protestanti "apocalittici"). L'atteggiamento mostrato dai protestanti in quell'episodio vorrebbe quindi essere indicativo di come ai protestanti non sarebbe importato nulla di difendere Roma e di riconquistarla.
feder ha capito subito l'importanza di Mustafà in questa ucronia. Ho individuato infatti che proprio dopo la sua morte inizia di una serie di sovrani molto propensi a vivere una vita di lusso e vizio, interessandosi poco e male degli affari politici e militari concreti. Rendendo Mustafà protagonista della conquista dell'Italia, io gli salvo la vita e stabilisco le premesse perché, con lui e attraverso lui, l'Impero venga gestito un po' meglio. Il fine è chiaro: attenuare il declino, ridurre la possibilità di sconfitte militari che rimettano in discussione lo status quo in Italia.
Una precisazione: non penso che la perdita da parte della Spagna dei possedimenti italiani avrebbe segnato il declino del paese. La Spagna sarebbe rimasta una grande potenza, ecco perché non ho pensato di fare grandi cambiamenti sulle sue vicende. La guerra contro l'Inghilterra elisabettiana ci sarebbe stata comunque, e penso che sarebbe finita più o meno allo stesso modo. Solo che l'Impero Ottomano all'epoca era realmente alleato di Elisabetta, ovviamente avrebbe partecipato alle varie battaglie navali (ce ne fu una anche a Pantelleria tra inglesi e spagnoli) quindi avrebbe avuto una sua parte. Quindi nessun declino della Spagna e nessuna scelta suicida nel guerreggiare contro Elisabetta I.
.
Federico aggiunge:
Se restiamo sulla falsariga dello Scisma d’Occidente, mi immagino Enrico VIII convocare un concilio per apparire come il riconciliatore della Cristianità e ottenere qualche buon ufficio per le questioni che sappiamo, con l’esito di eleggere un terzo papa che non riconosce nessuno tranne gli inglesi e che diventa il cappellano di Enrico.
Così abbiamo tre papati, uno avignonese (il più Cattolico dei tre direi), uno prussiano (cripto-luterano, in fondo Luterò inizialmente non era contrario alle gerarchie ecclesiastiche tanto che poi il Luteranesimo ne fondò delle altre, qua si tratterebbe solo di fondarle dentro la Chiesa piuttosto che fuori) e uno canterburiano (cripto-anglicano).
Quindi, ricapitolando, ci sono un Papa francese, uno tedesco e uno inglese, l’Italia è musulmana, gli anabattisti in pieno delirio millenarista creano qualcosa di molto simile al Sacro Regno di Münster e i calvinisti gridano in piazza di bruciare sul rogo tutti e tre i pretendenti al Pontificato per mondare l’anima del Vecchio Continente. Ho dimenticato qualcosa? ;)
.
A questo punto, incredibilmemte, Alessio ha voluto proporci una seconda versione della stessa ucronia!
Ecco quella che ho anticipato come versione "Bis". Il PoD è lo stesso, ma i cambiamenti sono decisamente profondi. Diciamo che, se il primo testo che vi ho presentato era solo una rielaborazione dell'ucronia "Il Papato in Germania" con un PoD diverso e una maggiore durata della dominazione ottomana in Italia, questa versione si distacca del tutto dall'ispirazione originaria. Ho cercato di essere dettagliato e originale, spero che vi piaccia, c'è una chicca proprio all'ultimo che spero troviate simpatica!
La dominazione ottomana in Italia,
talvolta indicata con il termine di "Secoli ottomani" è stato il periodo in cui
gran parte del territorio italiano si è trovato compreso entro i confini
dell'Impero Ottomano. Un periodo che ha influito in modo notevole sulla storia
successiva del paese.
L'interesse dell'Impero Ottomano per l'Italia risaliva al sultano Maometto II,
il conquistatore di Costantinopoli, deciso almeno in teoria a conquistare anche
Roma, l'altra grande capitale dell'antico mondo romano e della cristianità. La
prima incursione ottomana in Italia era stata la sanguinosa presa di Otranto,
nel 1479. La morte di Maometto II, tuttavia, aveva interrotto i preparativi per
una spedizione di rinforzo, e il caposaldo stabilito a Otranto era stato
prontamente riconquistato dalle forze cristiane del Regno di Napoli. Negli anni
successivi, la guerra tra ottomani e cristiani, raggruppati in coalizioni che
tipicamente prendevano il nome di "Lega Santa", continuò soprattutto sul mare,
mentre il territorio italiano veniva interessato dalla rivalità tra francesi e
spagnoli per l'egemonia sulla penisola, articolata politicamente in stati
piccoli e militarmente deboli. Sembrava che la finestra di opportunità per
l'espansione in Italia si fosse irrimediabilmente chiusa, ma la conquista solo
qualche decennio più in là, verso la metà del XVI secolo, e condusse a un
dominio duraturo sulla Penisola.
La Prima e la Seconda Guerra
Franco-Ispano-Ottomana
Nel 1536, il Re di Francia Francesco I, continuando nella lotta
per la supremazia con Carlo V, Imperatore e Re di Spagna, si alleò con il
sultano ottomano Solimano I, che in effetti non attendeva altro che una
occasione propizia per inserirsi nelle vicende italiane. I due sovrani
concordarono un attacco combinato alla città di Genova, da terra e dal mare. Un
attacco che fu sul punto di non avvenire, in quanto la guarnigione a difesa
della città era stata prontamente rinforzata da Andrea Doria, signore della
città e ammiraglio di Carlo V, e sfumò un tentativo di rivolta della fazione
filofrancese in città. Solimano riteneva tuttavia troppo importante che i
francesi continuassero a impegnare gli spagnoli nel nord Italia e così diede
ordine alla sua flotta di attaccare comunque. Al costo di alte perdite, gli
ottomani debilitarono notevolmente le difese della città, incoraggiando pertanto
i francesi a fare la loro parte. In seguito alla caduta di Genova, Carlo V
concentrò tutte le sue truppe migliori verso Milano, nonostante alcune battaglie
nella valle del Ticino, la guerra tra francesi e ispano-imperiali si trascinò
pressoché inconcludente fino alla firma della pace nel 1538. Nel frattempo
tuttavia, già dopo la caduta di Genova una potente flotta ottomana aveva
sbarcato in Puglia un contingente di invasione. Il Regno di Napoli in quel
momento era poco fornito di truppe, avendo contribuito alla difesa di Milano.
Non fu quindi possibile contrastare adeguatamente le incursioni degli ottomani
che, razzia dopo razzia, cominciarono a occupare stabilmente i territori
meridionali del regno. Nel giro di qualche mese gli ottomani si impadronirono di
tutta la Calabria e sbarcarono anche in Sicilia. La pace del 1538 fu quindi
molto pesante per la Spagna, che doveva riconoscere l'occupazione francese di
Genova e del Piemonte, e quella ottomana della Sicilia e di gran parte del Regno
di Napoli.
Dopo il conflitto, Papa Paolo III preoccupato per l'arrivo degli ottomani in
Italia, promosse la formazione di una nuova Lega Santa, insistendo affinché
Francesco I abbandonasse l'alleanza con il sultano. I suoi sforzi fallirono
tuttavia a causa delle storiche rivalità tra francesi e spagnoli circa il Regno
di Napoli, e soprattutto per il sostegno della Spagna ai corsi. Dopo il
passaggio di Genova alla Francia, infatti, lo status della Corsica non era
chiaro. I francesi, ritenendo che la Corsica restasse legata a Genova,
intendevano occupare l'isola; il Banco di San Giorgio riteneva al contrario che
la Corsica fosse un dominio privato e rifiutava i nuovi dominatori,
appoggiandosi alla popolazione locale, che ovviamente avrebbe gradito
l'indipendenza, e alla Spagna.
Nel 1542 l'irrisolta questione condusse a una nuova guerra
Franco-Ispano-Ottomana. I francesi colsero l'occasione per tornare ad attaccare
la Lombardia, mentre la flotta ottomana portò la guerra in Sardegna, condotti
dal figlio maggiore del sultano, Mustafa, e conquistando l'isola in tre anni di
aspri combattimenti. Nell'ultimo anno di guerra, gli ottomani avanzarono anche
nel Regno di Napoli, conquistando altro territorio e riducendo il regno a un
arco compreso tra Napoli e l'Abruzzo Ulteriore. Per la Francia la guerra si
risolse in una grave sconfitta militare e anche politica: la questione della
Corsica fu risolta alla radice con il ritorno di Genova all'indipendenza.
Francesco I ricevette anche la scomunica e le spese della guerra portarono il
paese alla bancarotta finanziaria. L'unico a guadagnare dal conflitto fu
Solimano, che aveva aggiunto ai suoi domini la Sardegna e che sembrava ormai
aver quasi cancellato il Regno di Napoli. Proprio grazie alla conquista della
Sardegna, Solimano scelse il figlio Mustafa come successore, nonostante gli
intrighi della sua seconda moglie contro quest'ultimo.
Dalla Guerra di
Siena al Califfato di Roma
Nel 1554, nella città di Siena ebbe luogo una insurrezione contro
gli spagnoli, che occupavano la città con una guarnigione. I rivoltosi, di
fronte al debole sostegno degli alleati francesi, lanciarono un appello anche a
Solimano. L'aiuto degli ottomani non si fece attendere: dopo alcune incursioni
nel Tirreno contro i porti controllati da Firenze e dalla Spagna, gli ottomani
sbarcarono anche un contingente nella zona di Piombino. I turchi arrivarono in
ritardo per prevenire la rotta di Scannagallo, in cui l'esercito approntato da
Siena fu quasi annientato, ma riuscirono a battere l'esercito di Gian Giacomo
Medici a Montaperti, rovesciando le sorti della guerra e marciando su Firenze
fino a cingerla d'assedio.
A Roma, nel frattempo, l'atmosfera era di preoccupazione: Papa Giulio III
proclamò una crociata contro Siena, invitando il ancora una volta il Re di
Francia ad abbandonare l'alleanza con gli ottomani, ma morì poco dopo; il suo
successore, Marcello II, morì dopo appena tre settimane. Il conclave del 1555 si
aprì quindi in condizioni di grande preoccupazione per il futuro di Roma, quasi
circondata dagli infedeli presenti in Toscana, Sardegna e Campania. Fu eletto il
cardinale Giovanni Gerolamo Morone, che assunse il nome di Paolo IV. Il nuovo
Papa, uomo di Carlo V sembrava il più adatto a condurre il Papato durante la
guerra senza quartiere contro gli infedeli.
Nel 1555 nei pressi di Scandicci si scontrarono l'esercito ispano-imperiale,
condotto da Emanuele Filiberto di Savoia, e quello ottomano guidato da Mustafa.
La battaglia fu rovinosa per primi, che persero anche il loro talentuoso
comandante. Firenze non potè fare altro che capitolare. Dopo la sconfitta degli
imperiali, scacciati oltre gli Appennini, gli ottomani ripresero la loro
offensiva sul Regno di Napoli e su Roma. Enrico II, temendo di essere
considerato complice della caduta della città santa ruppe l'alleanza con
Solimano, che comunque non aveva più bisogno di alcun alleato. Nel 1558, prima
che il cerchio degli ottomani si chiudesse inesorabilmente su Roma, la corte
pontificia si imbarcò a Civitavecchia su navi neutrali fornite da Venezia. Da lì
il Papa, i membri della curia e un certo numero di romani di alta condizione
ripararono prima a Genova e poi a Milano, dove Paolo IV da cardinale era stato
Cancelliere del Ducato alle dipendenze di Carlo V.
A Milano, Enrico II sottoscrisse con Filippo II di Spagna e l'Imperatore
Ferdinando un accordo di pace definitivo, riconoscendo un generico impegno a
lottare per riportare l'intero paese in mani cristiane. Il Ducato di Milano
veniva confermato possesso legittimo del Re di Spagna, i domini sabaudi,
scomparso Emanuele Filiberto, passavano al cugino filofrancese Giacomo di
Nemours, mentre il territorio pontificio emiliano, rimasto salvo dall'invasione
ottomana, veniva destinato alla dinastia medicea fuggita da Firenze che
acconsentì a governarlo per conto del Pontefice. Il Papato disponeva il proprio
trasferimento ad Avignone, ma stabilendo che, in caso di indebite ingerenze
della corona francese sugli affari ecclesiastici avrebbe provveduto ad
individuare una nuova sede, con la collaborazione dell'Impero.
Quando Solimano conquistò Roma, constatò che nella città, largamente spopolata,
erano rimasti pochissimi preti cristiani. Ciò significava che non avrebbe dovuto
convivere, come a Costantinopoli, con un clero cristiano forte e radicato: la
città era pronta per essere islamizzata secondo i suoi voleri. Dopo aver spinto
alla conversione gran parte degli abitanti rimasti, fece ripopolare la città con
genti prese da ogni parte dell'Impero. Voleva farne una capitale, ma non una
capitale politica, vista la minore centralità rispetto a Costantinopoli, bensì
una capitale religiosa. Dopo alcuni anni di lavori e restauri della città,
Solimano proclamò il Califfato di Roma. Gli ottomani associano all'investitura
come capitale califfale la teoria della cosiddetta "Terza Roma". La prima
sarebbe la Roma antica dei miscredenti, la seconda la Roma dei cristiani,
ugualmente peccatrice seppure ispirata da un grande profeta, e infine la terza
Roma dell'islam.
Il mondo cristiano, tra l'altro, era in subbuglio perché cattolici e protestanti
avevano visioni nettamente diverse sulla caduta di Roma e sulla necessità di
riconquistarla. I cattolici consideravano la caduta di Roma come dovuta alla
divisione tra i cristiani, e consideravano prioritario che le eresie protestanti
fossero superate in favore di una ritrovata unità e di una crociata per la
riconquista della città santa. I protestanti da parte loro consideravano la
caduta di Roma come dovuta alla corruzione della chiesa cattolica ed a una
conseguente punizione divina. Consideravano prioritario piuttosto purgare la
comunità cristiana dalla corruzione e riguadagnare così il favore divino. Non
erano quindi disposti semplicemente a combattere per riconquistare la città.
L'ampliamento dell'Italia ottomana
Mustafa I, figlio di Solimano I, subentrò al padre nel 1566.
Deciso a rafforzare i domini ottomani più consolidandosi che facendo grandi
conquiste, condusse la Guerra di Cipro contro Venezia, che si concluse con la
conquista dell'isola. Successivamente iniziò a immaginare una nuova spedizione
contro Malta, che suo padre aveva fallito, ma la morte lo colse, e gli subentrò
il nipote Murad.
Il nuovo sultano Murad III aveva progetti più ambiziosi, in particolare
immaginava di estendere ulteriormente il suo dominio in Italia, cosa che i
cristiani consideravano scandalosa. Approfittando dell'alleanza con Elisabetta I
d'Inghilterra, impegnata in una lunga guerra navale contro la Spagna, Murad
mosse la sua flotta nel Mediterraneo occupando la Corsica. La scarsa capacità di
reazione mostrata dalla Spagna fece immaginare al Sultano una nuova campagna per
arrivare a conquistare Milano e Venezia, ma lo scoppio della Lunga Guerra in
Ungheria lo costrinse a rinviare i piani.
Durante la successiva guerra contro la Persia, emerse la figura di Ozgur Pascià
(nome alla nascita: Carlo Andrea Caracciolo). Nato in una delle poche famiglie
romane che non avevano lasciato la città al tempo della conquista ottomana, fu
arruolato nel corpo dei giannizzeri e con il tempo ne scalò le gerarchie. Fu lui
a risollevare le sorti di un conflitto che fino ad allora aveva avuto una
evoluzione sfortunata per i turchi.
Incoraggiato dalla vittoria nel conflitto orientale e dallo scoppio della guerra
tra cattolici e protestanti nel Sacro Romano Impero, il sultano Murad IV
incaricò Ozgur Pascià di avanzare verso il Po e possibilmente oltre. Gli
spagnoli, infatti, avrebbero impegnato la maggior parte delle loro forze oltre
le Alpi, per sostenere l'Impero e i ribelli cattolici francesi amici del Papato.
Ottomani e spagnoli si scontrarono in una prima battaglia di esito incerto
presso Imola, ma nelle settimane successive i turchi riuscirono ad assediare ed
espugnare varie città, mettendo fine al governo mediceo di Bologna. Nel 1630 gli
ottomani riuscirono a espugnare e saccheggiare anche la città fortificata di
Mantova ma lo scoppio di una epidemia di peste consigliò a tutti i combattenti
di interrompere le operazioni. Nel 1636 la battaglia di Tornavento, combattuta
nella valle del Ticino, sancì la definitiva sconfitta degli spagnoli, che non
poterono far nulla per salvare la città di Milano dalla conquista.
Ottenuto il controllo del milanese, gli ottomani furono fermati nella loro
avanzata verso il Piemonte e Genova dalla diplomazia. Francia e Impero Ottomano
non erano più alleate come un tempo, ma la Sublime Porta non considerava la
Francia un nemico e accettò di non minacciare i domini dei Savoia e dei Gonzaga,
due dinastie amiche della Francia e che erano anche vassalle di Luigi XIII
(Carlo Amedeo, Duca di Savoia, era anche Duca di Nemours, mentre Carlo II
Gonzaga, Duca del Monferrato, era anche Duca di Nevers). A causa di questa
rinuncia, gli ottomani attaccarono Genova esclusivamente dal mare, non riuscendo
tuttavia a conquistarla.
Meno fortunata la Repubblica di Venezia, che fu investita da più parti
dall'avanzata ottomana. Di fronte al timore di scomparire, Venezia si rassegnò a
comprare la sua libertà: in cambio della pace, e dello sgombero delle terre
venete, la Serenissima accettò di cedere all'Impero Ottomano la preziosa isola
di Candia.
Negli anni successivi, spagnoli e imperiali tentarono più volte di riconquistare
il milanese o di effettuare attacchi in vari punti dell'Italia ottomana,
giungendo anche a riconquistare parzialmente, per un periodo limitato, parti
della Sardegna e della Sicilia. L'ultimo di questi attacchi, l'assedio di
Orbetello, ebbe luogo nel 1646, contestualmente alla morte di Ozgur Pascià, ma
non ebbe effetti decisivi. Anche l'insurrezione di Napoli, promossa dal
pescatore cristiano Masaniello, si concluse con un nulla di fatto.
L'Italia non ottomana
Sconfitti gli spagnoli, gli unici territori fuori dal controllo
ottomano a sud delle Alpi erano il Ducati di Savoia e del Monferrato e la
Repubblica di Genova. I primi due stati erano retti da dinastie nobili legate
alla Francia, mentre Genova restava sotto il controllo spagnolo. La flotta
ottomana non era riuscita a conquistarla un attacco terrestre non avvenne in
quando il sultano comandò ai suoi generali di non attraversare le terre dei
Savoia e dei Gonzaga.
Il Duca Carlo Amedeo di Savoia ebbe solo figlie femmine e avrebbe dovuto, a
causa della legge salica, considerare come erede suo fratello Enrico, cardinale
e senza figli. Per salvare la dinastia, Carlo Amedeo decise di abolire la legge
salica per consentire alla figlia primogenita Maria Giovanna Battista di
succedere alla guida degli stati sabaudi. La diplomazia francese aveva spinto
per far fidanzare la giovane con il Duca del Monferrato, Carlo Gonzaga, così da
determinare l'unione dei territori delle due dinastie. L'Impero espresse la
propria contrarietà ma non aveva in quel momento, la forza politica di imporre
una soluzione diversa.
Malumori c'erano anche a corte, dovuti all'idea che il Gonzaga avrebbe preso in
pratica possesso dell'eredità sabauda, ma furono subito spenti a causa della
precocissima morte del nuovo Duca consorte: Carlo e Maria Giovanna Battista si
sposarono il 20 maggio 1665 e Carlo morì già il 14 agosto. Nove mesi esatti dopo
la sua morte, il 14 maggio del 1666, nasceva postumo il suo erede, il futuro
Carlo Amedeo II.
Venezia conservava la sua indipendenza ma era costretta a versare un tributo
alla Sublime Porta. Molti veneziani consideravano tale tributo umiliante,
considerando che in mille anni di storia Venezia non si era mai piegata a
nessuna grande potenza. Sempre più veneziani erano convinti che la Serenissima
dovesse ribellarsi alla supremazia turca e partecipare a una guerra di riscossa.
L'Italia nelle guerre tra imperi
La parte finale del XVII secolo fu caratterizzata dalla Grande
Guerra Austro-Turca, nella quale la Sublime Porta attuò lo sforzo finale per
sconfiggere il proprio principale nemico europeo. I due imperi consideravano
imprescindibile controllare l'Ungheria e fu l'Impero Ottomano ad attaccare per
primo. L'Imperatore Leopoldo I riuscì a concludere un'alleanza con il Regno di
Polonia e con Venezia, che si ribellò alla supremazia ottomana sperando di poter
riottenere Candia.
In realtà proprio la ribellione di Venezia giocò a favore degli ottomani, che
invadendo il territorio della Serenissima e passando dal Friuli, riuscirono a
portare un secondo esercito nei pressi di Vienna, in grado di entrare in gioco
quando la cavalleria polacca del re Giovanni Sobieski tentò di sorprendere gli
assedianti. L'assedio si prolungò così ancora per mesi, fino alla resa della
città. Per l'impero asburgico non era certo la fine, Leopoldo I spostò la sua
capitale a Praga dove era stata già in tempi precedenti. Dal punto di vista
psicologico, tuttavia, la caduta della città fu un duro colpo, che indirizzò
l'esito della guerra.
Il trattato di pace, che nei Balcani sancì l'appartenenza dell'intera Ungheria
all'Impero Ottomano, mentre Vienna tornava agli imperiali anche se ormai era
inservibile come capitale. L'Imperatore ne decretò la completa ricostruzione,
continuando comunque a risiedere a Praga. in Italia stabilì l'incorporazione di
quasi tutta la terraferma veneziana all'Impero Ottomano. Venezia, ottenne di
continuare ad esistere, ma ridotta in pratica ai confini che aveva all'inizio
del XIV secolo.
La prima metà del XVIII secolo fu un periodo di pace. Le potenze cristiane erano
impegnate nelle cosiddette guerre di successione, riguardo alla corona spagnola,
a quella polacca e a quella austriaca. L'Impero Ottomano, sempre neutrale
rispetto a tali questioni, si concentrò sulla propria politica interna, attuando
alcune importanti riforme come l'abolizione dei giannizzeri, strumento militare
valido ma politicamente potente e ingestibile. La fanteria ottomana fu riformata
da ufficiali svedesi ospitati nel paese dopo la disfatta di Poltava contro la
Russia.
In Italia, anche se il paese non era più quello splendido del Rinascimento,
almeno nella prima parte del secolo i governi ottomani si impegnarono molto per
aumentare la popolazione, la produzione e il commercio. La marina ottomana
ingrandì le sue principali basi a Livorno e Taranto, città ancora oggi
principali per la navigazione civile e militare. Furono costruite importanti
moschee in tutte le maggiori città e fu favorito l'afflusso di popolazione
musulmana da altre province. Ciò determinò un certo squilibrio tra la
popolazione delle città, cosmopolita e in buon numero musulmana, e quella delle
campagne, rimasta pressoché identica al passato.
Nel 1756 Austria, Francia e Russia stipularono un'alleanza. Anche se il loro
obiettivo principale era quello di attaccare la piccola ma agguerrita monarchia
prussiana, le tre potenze trovarono anche un accordo per attacchi coordinati
contro l'Impero Ottomano. La Sublime Porta, che non aveva partecipato ai giochi
diplomatici precedenti il conflitto, fu colta di sorpresa ma ovviamente dopo
poco tempo ottenne una offerta di alleanza da parte della Gran Bretagna e della
Prussia. L'esercito ottomano si comportò bene durante il conflitto, pur
dimostrando problemi, soprattutto a causa dell'obsolescenza della sua
artiglieria e da problemi logistici. In ogni caso la vittoria della propria
coalizione fruttò all'Impero Ottomano la città di Trieste ed altri territori
circostanti, che lasciarono l'Austria priva di ogni sbocco al mare.
Polacchi in Italia, italiani in Polonia
L'esito della Guerra dei Sette Anni non risolse il contrasto di
interessi tra Russia e Impero Ottomano, che sfociò in un nuovo conflitto tra il
1768 e il 1774 per la Crimea ma soprattutto per la Polonia, dove la Sublime
Porta appoggiava i ribelli della Confederazione di Bar contro il sovrano, devoto
alla Russia. L'intervento della Prussia si rivelò decisivo per sopraffare i
ribelli polacchi e alla fine del conflitto la Polonia fu costretta a cedere
territori a Prussia e Russia. L'Impero Ottomano a sua volta dovette cedere dei
territori alla Russia, che avanzò verso il Mar Nero, ma non nel modo decisivo in
cui l'ambiziosa zarina Caterina si aspettava. Per l'Italia ottomana, l'unica
ripercussione della guerra fu il trasferimento nel Bel Paese di alcune
importanti famiglie polacche, esiliate per aver lottato contro la Russia.
Casimiro Pulaski, in particolare, entrò nella cavalleria ottomana e ne divenne
un abile comandante.
Nel 1788, l'Austria lanciò un nuovo tentativo di penetrazione in Italia, in
alleanza con il Duca di Savoia Carlo Amedeo III. La cavalleria di Pulaski
inflisse notevoli rovesci agli invasori, ma sul fronte principale del conflitto,
quello danubiano, gli austriaci riportarono una importante vittoria presso il
Lago Balaton. Il trattato di pace stabilì una revisione dei confini, consentendo
agli Asburgo di riacquistare una parte dell'Ungheria. Quanto all'Italia, Carlo
Amedeo ottenne la Corsica, cosa che gli consentì di proclamarsi re (Re di
Corsica). Il sultano Selim III volle comunque conoscere Pulaski di persona, e
decise di affidargli il comando dell'intero esercito ottomano con il compito di
attuare una profonda riorganizzazione. Tra i giovani ufficiali che Pulaski
scelse di assisterlo nel compito, anche un giovane corso, Buonaparte.
Nel 1793, la Polonia insorse contro Prussia e Russia, provocando l'intervento
armato delle due potenze. L'Impero Ottomano intervenne a sostegno dei ribelli,
perché il sultano riformista Selim III aveva capito che la Polonia, nel secolo
precedente grande avversario, poteva essere un utile alleato da quando la sua
indipendenza era minacciata. L'Austria e il Regno di Corsica, i nemici
dell'ultima guerra, erano in quel momento distratti da ciò che stava accadendo
in Francia. La crisi economica aveva spinto i sudditi a ribellarsi, la coppia
reale era stata detronizzata e assassinata, nel paese era scattata la caccia ai
nobili ed agli ecclesiastici. Il Papa, non più sicuro ad Avignone, aveva avuto
bisogno della protezione di un esercito di svizzeri e tedeschi per rifugiarsi a
Ginevra.
Sul finire del 1795, un colpo di stato monarchico abbatté il Direttorio,
istituzione creata dai rivoluzionari, e preparò la strada per il ritorno di un
monarca. A salire sul trono Luigi XVIII, fratello dell'assassinato Luigi XVI e
zio dello sfortunato Luigi XVII, morto in prigionia pochi mesi prima della
svolta politica.
La normalizzazione dei rapporti tra la Francia e il resto dei paesi europei e il
pacifico ritorno del Papa ad Avignone consentirono all'Austria di tornare a
occuparsi della questione polacca, intervenendo militarmente. Carlo Amedeo III
invece non ebbe tempo di intraprendere nuove offensive in Italia: morì infatti
nel 1796 lasciando il trono al figlio Carlo Emanuele, uomo straordinariamente
religioso ma privo di senso pratico. Egli pronunciò un discorso in cui dichiarò
che con una campagna di 42 giorni avrebbe riconquistato Roma alla cristianità,
destando una certa ilarità da parte dei diplomatici stranieri nonché imbarazzo
da parte dei suoi stessi ministri e generali.
Nel 1798, alla morte Stanislao II, il Sejm scelse come nuovo sovrano Casimiro
Pulaski, che per accettare la corona lasciò il suo incarico al vertice
dell'esercito ottomano. Tra gli ufficiali che scelsero di seguirlo, anche
Buonaparte, che si era ormai guadagnato sul campo promozioni fino al livello di
generale. Nel 1802 Casimiro V ottenne un notevole risultato riuscendo a
concludere la pace con uno dei nemici, la Prussia, ma subito dopo fu
assassinato. Buonaparte riuscì a convincere il Sejim a sceglierlo come nuovo
sovrano, malgrado fosse uno straniero. In ogni caso provvide a sposare una
giovane principessa polacca, imparentata con il precedente sovrano Stanislao I:
Maria Leszczynska, che gli avrebbe dato due figli maschi e che è tuttora
considerata una delle più belle regine europee della storia. Nello stesso anno
anche a Torino si verificava un cambio di sovrano. Carlo Emanuele si abdicò, non
si sa quanto spontaneamente, lasciando il trono al più risoluto fratello
Vittorio Emanuele.
Napoleone I continuò il conflitto contro Austria e Russia e riuscì a mettervi
fine annichilendo gli eserciti avversari nella battaglia di Austerlitz del 1805.
Il trattato di pace dell'anno successivo prescrisse alla Russia uno spostamento
dei confini che avvantaggiò sia la Polonia sia l'Impero Ottomano, mentre
l'Austria fu costretta a cedere i principati di Trento e Bolzano. Dopo
l'incorporazione di quei territori, l'Italia ottomana raggiunse la sua massima
estensione geografica. Seguì qualche anno di pace, finché Napoleone intraprese
una nuova guerra contro la Russia. Per l'occasione approntò il più grande
esercito che la Polonia ebbe mai avuto, e puntò a raggiungere Mosca, per
umiliare lo zar e costringerlo alla resa.
Nelle battaglie combattute durante la campagna, Napoleone confermò la sua grande
capacità tattica, ma non riuscì a ottenere una vittoria definitiva, perché i
russi adottarono un comportamento sfuggente. Attratto sempre più in profondità
nel territorio russo, Napoleone commise in pratica lo stesso errore di Carlo XII
durante la Guerra del Nord del secolo precedente. Il suo esercito, falcidiato
dalla fame, dalle epidemie e dal freddo dell'incombente inverno, fu costretto a
ritirarsi senza aver colto alcun risultato definitivo. Austria e Prussia si
accorsero delle difficoltà polacche e decisero di allearsi alla Russia per
sfruttarle.
Nel 1813, Napoleone fu sconfitto a Lublino dalle preponderanti forze nemiche.
L'anno successivo gli alleati erano a Varsavia, pronti a convenire la
spartizione della Polonia, mentre Napoleone fuggì a sud rifugiandosi nei
territori della sua vecchia patria. La moglie e i figli, inizialmente rimasti a
Varsavia, si trasferirono nella neutrale Svezia che accettò concedere loro
asilo.
La questione del Regno di Corsica
Napoleone Buonaparte, giunto alla corte del sultano Mahmud II,
chiese insistentemente un sostegno per riconquistare la Polonia, ma non lo
ottenne. il sultano riteneva infatti che l'alleanza di potenze europee ostile a
Napoleone fosse così consolidata che appoggiarlo nella riconquista della Polonia
avrebbe messo seriamente a repentaglio la sicurezza dell'Impero. A Buonaparte
però il sultano promise che si sarebbe adoperato per la sua terra natia, la
Corsica.
Vittorio Emanuele I, che regnava sulla Corsica, non aveva eredi maschi. Nel
1812, mentre tutta l'attenzione delle corti europee era puntata sull'impresa di
Napoleone in Russia, aveva fatto sposare la sua primogenita Maria Beatrice con
il cugino, il Duca di Berry Carlo Ferdinando. Ciò non solo rinsaldò la storica
alleanza con la Francia, ma gettò le premesse affinché anche il Regno di Corsica
avesse un giorno un sovrano borbonico. Il sultano sospettava che fosse in
preparazione una spedizione militare contro l'Italia ottomana e anche per questa
ragione volle che Napoleone fosse presente nelle province italiane dell'impero,
in modo da poter mettere le sue capacità militari a disposizione qualora fosse
stato necessario.
Nel 1815, in effetti, la grande campagna di Luigi XVIII e Vittorio Emanuele I in
Italia ebbe inizio, ma durò soltanto 100 giorni: l'esercito invasore fu fermato
nei pressi di Novara dall'esercito ottomano guidato per l'occasione proprio da
Napoleone Buonaparte. La sconfitta non solo incrinò decisamente il prestigio dei
due sovrani, ma soprattutto fece sorgere tra i due divergenze insanabili
sull'interpretazione della battaglia, sulle responsabilità della sconfitta e
sulle strategie per proseguire la campagna. Negli anni successivi, tra l'altro,
la questione della successione a Torino rimase poco rassicurante: Carlo
Ferdinando e Maria Beatrice ebbero solo nel 1817 la primogenita Maria Carlotta e
solo nel 1819 il maschio Vittorio Emanuele. Poco dopo la nascita di quest'ultimo,
Carlo Ferdinando, le cui posizioni politiche erano nettamente conservatrici, fu
assassinato da un fanatico giacobino. Nel 1821 morì comunque anche Napoleone
Buonaparte, trasmettendo le sue rivendicazioni sulla Polonia ai figli Carlo
Napoleone e Alessandro Napoleone.
Nel 1824, Vittorio Emanuele I morì lasciando sul trono Maria Beatrice, che
iniziò a governare allineandosi profondamente alla politica del suocero, il Re
di Francia Carlo X. Il forte conservatorismo dei due sovrani stimolò la nascita
di una forte opposizione, che era in parte palese ed intellettuale e in parte
segreta e cospirativa. Centro di tali attività era la città di Genova, città
mercantile, bancaria e ancora fieramente indipendente, che divenne uno dei
maggiori punti di riferimento europei per i liberali e democratici. A Genova,
tra l'altro, giungevano anche le proteste della Corsica, parte di uno stato che
avrebbe dovuto essere incentrato su di essa e che invece la considerava una
provincia da governare in modo crudele da Carlo Felice, fratello minore di
Vittorio Emanuele I e pertanto zio della regina.
Nel 1830, nuovi moti rivoluzionari, simili a quelli del 1789, misero in crisi la
monarchia. Carlo X preferì abdicare che concedere una costituzione come
suggerito dai suoi ministri per placare l'insurrezione nella capitale. Il nuovo
sovrano, suo figlio Luigi XIX, la concesse e riuscì a placare gli animi,
evitando la degenerazione delle violenze e la proclamazione della repubblica
come avvenuto in passato. Una volta assicuratosi sulla stabilità della
situazione, Luigi attuò una vigorosa repressione, spingendo molti oppositori
della corona a fuggire all'estero. Un buon numero di essi riparò a Genova, dove
il rivoluzionario Giuseppe Mazzini stava sviluppando una rete cospirativa per
sovvertire le istituzioni del Regno di Corsica.
Nel frattempo anche in Polonia scoppiò una violenta insurrezione, nella
convinzione che i moti in Francia sarebbero stati duraturi e che le altre
potenze ne sarebbero state distratte. Carlo Napoleone Buonaparte raggiunse
Varsavia e si mise alla testa dei sostenitori, che lo acclamarono re con il nome
di Napoleone II. Nonostante l'acclamazione popolare fosse poi stata ratificata
da una investitura regolare da parte del Sejim, nessun paese europeo riconobbe
il nuovo sovrano, che l'anno successivo. fu detronizzato da preponderanti truppe
russe. La fine di Napoleone II è ignota. Si presume che sia stato assassinato
durante la fuga, ma il suo corpo non fu mai ritrovato.
A Genova intanto, Mazzini organizzò una spedizione diretta in Corsica per
sollevarla. Il progetto fu un fallimento, ma provocò una violenta reazione da
parte della regina Maria Beatrice. Incoraggiata dal suocero, che si era
trasferito presso la corte di Torino, decise che l'unica soluzione per mettere
fine alle cospirazioni fosse annettere la città. L'Impero Ottomano non potè
reagire in alcun modo, poiché in quegli anni era impegnato in una ennesima
guerra contro Austria e Russia, che questa volta comportò una severa sconfitta.
Ormai l'Impero Ottomano non era più forte e prospero come un tempo e, come
previsto dallo stesso Mahmud II, l'avanzata delle potenze cristiane fu
inesorabile. Mentre l'antica Repubblica di Genova confluiva nel Regno di
Corsica, l'Austria completava l'annessione dell'Ungheria e la Russia quella
della Tauride e della Crimea.
Vittorio Emanuele II
Figlio di due cugini, Vittorio Emanuele II pagò le conseguenze
fisiche di una stretta parentela tra i genitori con una bassa statura e vari,
seppur per fortuna non gravi, problemi di salute. Amareggiato per la sua scarsa
prestanza fisica, crebbe con l'idea di doversi mettere sistematicamente alla
prova per dimostrare grandi capacità a prescindere dal fisico. Divenuto Re di
Corsica nel 1840, alla morte della madre, e anche Re di Francia nel 1844, alla
morte dello zio Luigi XIX, era consapevole di non essere amato in nessuno dei
due paesi. I francesi lo consideravano straniero in ragione del suo nome,
completamente estraneo alla tradizione dei nomi dei re francesi. In Corsica lo
odiavano come erede di una dinastia dispotica nei confronti dell'isola, a Genova
come figlio della regina che aveva fatto occupare cruentemente la città.
Nel 1848, una nuova serie di moti liberali toccò la maggior parte delle capitali
europee. Vittorio Emanuele II decise di contrastare i liberali inaugurando una
politica espansionista, per aumentare il suo prestigio personale e il sentimento
patriottico dei sudditi. Fu così che la liberazione di Roma tornò a essere un
argomento politico fondamentale dopo essere stato archiviato per tutto il secolo
seguito alla sconfitta nella Guerra dei Sette Anni. Per prepararsi a uno scontro
decisivo con l'Impero Ottomano, Vittorio Emanuele intraprese una politica di
avvicinamento all'Austria e alla Russia, le altre due potenze principalmente
interessate ai territori della Sublime Porta.
La Gran Bretagna, tuttavia, iniziò in quegli anni a considerare la Russia il
proprio nemico principale, e dunque non era affatto disposta a tollerare una
simile alleanza. Le forti pressioni britanniche spinsero l'Austria a restare
neutrale, ma Vittorio Emanuele fu irremovibile: ci sarebbe stata una grande
guerra contro l'Impero Ottomano, e non avrebbe esitato a combattere anche contro
i britannici se fosse stato necessario. Nel 1853 scoppiò quella che viene
chiamata Guerra di Crimea, per quanto fu combattuta non solo sull'omonima
penisola fortificata dai russi, ma anche in varie altre parti d'Europa e del
Mediterraneo. Nell'Atlantico, la flotta britannica e quella francese si
scontrarono in varie occasioni. I britannici, numericamente superiori, vinsero
alcuni scontri ma non riuscirono mai a ottenere un successo veramente decisivo.
In Italia, le truppe di Vittorio Emanuele II riportarono numerosi successi nella
Pianura Padana, così come i russi nella Penisola Balcanica. Sul Mar Nero, i
britannici cercarono di distruggere la flotta russa e di espugnare la fortezza
di Sebastopoli.
Gli accordi di pace consacrarono la vittoria di Vittorio Emanuele II e dello zar
Alessandro II, che ottennero vari ingrandimenti territoriali. Il primo ottenne
tutto il territorio settentrionale italiano, al di sopra di una linea che andava
pressappoco da Pisa a Rimini e la Sardegna. Con queste acquisizioni ritenne
opportuno assumere il titolo di Re d'Italia. La Russia spostò il confine con
l'Impero Ottomano sul Danubio, ottenne il diritto di navigare liberamente con le
proprie navi militari attraverso gli stretti. Nonostante la vittoria e le
conquiste ottenute, i due sovrani non avevano raggiunto i loro obiettivi
principali, quelli di liberare Roma e Costantinopoli dopo secoli di dominazione
ottomana e anzi, nuove conquiste sarebbe stato più difficile perché avrebbe
significato riaprire le ostilità anche con i britannici. Per questo tutti e due
i sovrani pensarono di affidarsi alle ribellioni delle popolazioni locali
cristiane, sottomesse ormai da secoli ai musulmani.
Nei Balcani si verificarono insurrezioni a opera di serbi, bulgari e greci, che
portarono alla nascita e all'ampliamento di entità statali indipendenti dalla
Sublime Porta.
Nel 1863 in Polonia si verificò una nuova insurrezione e fu la volta del
secondogenito di Napoleone, Alessandro Napoleone Buonaparte, a cavalcare le ali
della rivolta. Proclamato re come suo fratello, assunse il nome di Napoleone III.
Tra i molti volontari che accorsero per combattere i russi c'era anche Giuseppe
Garibaldi, amico di Mazzini già famoso come rivoluzionario in Sudamerica. Nel
1867, su incarico segreto di Vittorio Emanuele II, Garibaldi condusse una
spedizione di volontari che partirono da Quarto, nei pressi di Genova, su due
navi mercantili apparentemente dirette in Sardegna. Sbarcati a sorpresa sulle
coste toscane, i garibaldini iniziarono la loro marcia verso Roma. L'inaspettata
mise in difficoltà le truppe ottomane presenti nella penisola, relativamente
abbondanti ma male armate, poco motivate e comandate da ufficiali che già nella
guerra contro i francesi avevano offerto una prova negativa di sé. Garibaldi e i
suoi furono infine sconfitti in una battaglia nei pressi di Mentana, ma
riuscirono a suscitare una serie di insurrezioni.
Per quasi un decennio l'Italia ottomana fu scossa da rivolte e percorsa da bande
di ribelli e soldati ottomani. Infine, nel 1876, approfittando di un doppio
colpo di Stato contro i sultani Abdullaziz e Murad V, Vittorio Emanuele lanciò
il suo esercito alla conquista definitiva dell'Italia ottomana. Le truppe
turche, incapaci di resistere, arretrarono via via verso sud imbarcandosi nei
principali porti per raggiungere la Sicilia, dove si concentrarono, protetti
dalla presenza amichevole della flotta britannica. Questa è considerata da molti
storici il capolinea dell'Italia ottomana, malgrado il fatto che la Sicilia non
fosse ancora stata riconquistata. L'ingresso trionfale di Vittorio Emanuele II a
Roma, con invito al Pontefice a tornare abbandonando Avignone, è considerato il
momento che conclude la storia dell'Italia ottomana, anche se in quel momento
non era ancora stata riconquistata la Sicilia. I preparativi di Papa Pio IX
furono tuttavia interrotti dalla sua morte. Fu comunque celebrato a Roma il
conclave che elesse il nuovo Pontefice, Leone XIII. Il primo Papa residente a
Roma dopo ben 30 che avevano guidato la cristianità cattolica da Avignone.
La riconquista della Sicilia
Nel 1883 Vittorio Emanuele II morì, soddisfatto per aver adempiuto
a quella che considerava la sua missione storica. Dopo la sua morte, Luigi, il
primo dei due figli maschi avuto dalla consorte Augusta Ferdinanda d'Asburgo-Lorena,
erede delle due corone di Francia e d'Italia, decise decise di assecondare le
richieste di riforme che il padre aveva tendenzialmente ignorato. Sciolta
l'unione personale tra i due regni, tenne per sé la corona di Francia, dove
avrebbe regnato come Luigi XX e lasciò invece il titolo di Re d'Italia al
fratello minore Umberto. Tutti due i sovrani emanarono una costituzione anche se
in Italia, paese ancora incompleto e composto da parti che avevano una storia
ben diversa, il compito di marciare verso il progresso appariva ben più arduo.
Nel 1890 il confine del nuovo stato italiano fu arrotondato con l'annessione di
Venezia, la cui indipendenza era stata sempre rispettata. L'ultimo Doge, Lorenzo
Tiepolo, consegnò le chiavi della città a Re Umberto. Nel 1897, approfittando
della guerra tra Grecia e Impero Ottomano, l'Italia colse l'occasione per
riconquistare anche la Sicilia, sbarcando con grande prontezza un corpo di
spedizione sull'isola.
L'Italia secondo Iskender Biftek
Iskender Biftek, vissuto tra il 1785 e il 1873, è stato a detta di
molti il più grande letterato dell'Italia ottomana. La sua opera più famosa "I
promessi sposi" racconta la storia di due giovani cristiani di modesta
condizione vissuti nel Ducato di Milano, negli anni immediatamente precedenti la
conquista ottomana. Il romanzo mostra i due giovani vessati dai potenti del
tempo, di origine spagnola, e ingannati dai religiosi della loro fede. Solo dopo
prove durissime, come la separazione e l'epidemia di peste, i due giovani
riusciranno a ritrovarsi e vivere il loro amore. Decisivo, in tutto il romanzo
il ruolo della "vera fede" musulmana, che i protagonisti scoprono grazie a un
saggio e generoso imam e che infonde loro il coraggio di lottare per la
giustizia. L'opera, considerata pedagogica negli anni in cui fu pubblicata, dopo
la riconquista cristiana fu accantonata e utilizzata solo come riferimento
descrittivo riguardo alla vita comune del XVII secolo. Solo in anni recenti è
stata rivalutata come opera letteraria a tutto tondo.
Sul versante politico Iskender Biftek fu un grande ammiratore di Napoleone
Bonaparte. Gli dedicò varie opere, in particolare la poesia intitolata "5
maggio" in cui celebra la morte del Buonaparte dolendosi del fatto che il grande
condottiero aveva sempre rifiutato di convertirsi all'islam.
Nota conclusiva
Insomma, la conquista ottomana dell'Italia resta un punto
delicato. La questione per me era piuttosto semplice, gli spagnoli concentrano
maggiormente le loro forze in Lombardia, per contrastare il tentativo francese
di occuparla, mentre l'invasione ottomana è sempre un po' una sorpresa. Ecco
perché il differente esito del conflitto. In ogni caso che Genova e il Piemonte
passino alla Francia non lo vedo problematico per l'ucronia. (Nella prima
stesura, avevo considerato francese anche Milano, se ricordate). Ok, il mio
approfondimento dinastico sui Savoia-Nemours potrebbe essere in questo caso
inutile, ma è stato comunque divertente.
Questione Corsica: chiaro che se Genova passa subito alla Francia, la Corsica
non diventa ottomana. Ripeto, ho considerato la Corsica solo in relazione a una
partecipazione ottomana alla guerra anglospagnola tra Elisabetta I e Filippo II.
La Francia in quella guerra non fu coinvolta, quindi se vogliamo immaginare una
partecipazione ottomana, potrebbe esserci qualche altro tipo di conquista, tipo
Malta o Tunisi. Oppure si potrebbe proprio glissare su questo punto. Io penso
che se la Corsica diventa il collante per una alleanza franco-asburgica non è
occasionale (come lo fu nella Guerra dei Sette Anni) ma praticamente perpetua
(dal 1600 fino a Napoleone) diventa poco logico. Nessun sultano sarebbe stato
così autolesionista da provocare una coalizione fortissima di potenze europee
ostili, e tenersele ostili per ben due secoli solo per la Corsica (o anche per
la Sardegna o ambedue le isole). In questa ucronia quella che conta per gli
ottomani è Roma (per il suo significato storico e simbolico, che va oltre
l'interesse mercantile e militare a controllare il Mediterraneo più che la
Penisola italiana).
Teoricamente, dovrebbe essere importante anche per gli stati cristiani, quindi
diciamo che il sottinteso dell'ucronia è che non ci sia una "crociata"
anti-ottomana prima a causa dei contrasti tra cattolici e protestanti (con
questi ultimi che non sentono la necessità di riconquistare la città) e poi
perché, con l'avvento del secolo dei lumi, l'importanza simbolica della città
viene a essere percepita molto meno. L'idea della conquista di Roma torna in
voga nel XIX secolo promossa da sovrani conservatori e tradizionalisti come
Carlo X di Francia e suo nipote (non so se ci avete fatto caso, ma il "Vittorio
Emanuele II"
dell'ucronia non è quello storico - qui non esistono neppure i Savoia-Carignano
- ma è in pratica Enrico V).
A proposito di francesi, secondo me anche per loro penso che sarebbe stato
illogica una alleanza franco-asburgica come si capisce da questo passo di Guido:
Lo scenario più logico è che diventi Generale dell’Esercito Francese e, se mai
ci fosse comunque una Rivoluzione (ma con Massimiliano I. Giuseppe in parte dei
Paesi Bassi anziché in Baviera, di conseguenza con l’Austria partecipe alla
Seconda Spartizione della Polonia anziché impegnata contro la Rivoluzione
Belga), questa verrebbe stritolata nei suoi eventuali tentativi espansionistici
dall’accerchiamento austrispanico
Questo passo ci fa capire che vari Francesco I, Enrico IV, Richelieu, Luigi IV...
non hanno fatto una certa politica perché avevano antipatia personale verso gli
Asburgo o perché intendevano conquistare determinati territori invece che altri,
ma proprio per il problema dell'accerchiamento. Questione non psicologica, ma
reale: gli spagnoli interferirono nella politica interna francese al tempo delle
guerre di religione, e se ne avessero avuto la possibilità avrebbero stabilito
volentieri un loro sovrano fantoccio al posto di Enrico IV; il secolo successivo
appoggiarono la fronda dei nobili, provando di nuovo a sovvertire la monarchia
francese. Viene da sé che siamo di fronte a "minacce esistenziali" che l'Impero
Ottomano non poneva. L'Impero Ottomano poteva, al peggio, trovarsi a occupare un
territorio che teoricamente la corona francese rivendicava richiamandosi al
Medioevo. Poteva, al peggio, essere in conflitto su interessi commerciali/navali
in qualche modo negoziabili...
In tutta sincerità, io penso che una alleanza franco-asburgica sia impossibile
in qualsiasi scenario in cui gli Asburgo controllano simultaneamente Austria e
Spagna. Quindi sicuramente impossibile in ogni caso fino a Carlo II di Spagna,
da valutare in seguito caso per caso, se la Spagna smette di essere asburgica.
Ecco perché io ho glissato sull'idea di grandi coalizioni anti-ottomane,
lasciando il più possibile inalterati i grandi eventi come la guerra di
successione spagnola.
Certamente, verso la fine del XVIII secolo il realismo che cerco sempre di
portare avanti è un po' svanito su Napoleone, ma l'idea di collocarlo in Polonia
mi è venuta perchè ero di fronte a due alternative forse più affascinanti ma
complicate da gestire:
- Napoleone comandante ottomano che attua un colpo alla "Muhammad Alì" separando
l'Italia dal resto dell'Impero Ottomano, e diventandone in pratica il sovrano;
- Napoleone comandante ottomano che attua un colpo di stato e diventa lui
Sultano e Califfo.
Di fronte a queste due alternative, la Polonia mi è sembrata la meno strana:
Napoleone, diventando Re di Polonia, sposa la sua Maria Walewska (che
nell'ucronia però viene indicata con il cognome da nubile, questo era il nome
del primo marito), ha comunque modo di combattere la sua battaglia capolavoro,
quella di Austerlitz, e soprattutto finisce per bruciare i propri sogni
megalomani in Russia.
Chiaramente se rimuoviamo dall'ucronia l'idea di una Corsica ottomana la
digressione su Napoleone verrebbe a svanire, lasciando spazio a una evoluzione
più simile alla storia reale, con Napoleone francese. Anche quello potrebbe
essere uno scenario da esplorare, Napoleone come autore della riconquista oppure
che gira al largo dall'Italia (perché, interessato a sconfiggere le potenze
europee conservatrici, si sarebbe forse dedicato di più alla Germania o magari
alla Spagna)
Che ne pensate?
.
Perchè No? gli domanda:
Senti, non sarebbe possibile vedere i porti dell'Italia ottomana usata dai pirati barbareschi, o gli italiani stessi diventare dei pirati barbareschi? Quale sarebbe l'effetto sulla sicurezza marittima nel Mediterraneo occidentale? Si potrebbero immaginare degli attacchi proprio sulla Corsica ma anche fino alle Baleari?
Altra domanda. Non sarebbe possibile immaginare gli Italiani convertiti usati come fonte per produrre nuovi Giannizzeri?
.
E Alessio replica resto:
Per
Perchè No?: credo che alle
tue domande si potrebbe rispondere di sì, una lunga dominazione ottomana
potrebbe avere questo tipo di effetti.
Quanti italiani sarebbero diventati musulmani? La fuga del Papa (e forse di
molti altri alti prelati) potrebbe creare un vuoto e favorire le conversioni
all'islam? In Grecia e nei Balcani solo una piccola parte della popolazione si è
convertita, però in quei casi le varie chiese ortodosse erano rimaste intatte. A
Costantinopoli, in Serbia, in Bulgaria, continuava a esserci lo stesso clero
ortodosso che c'era prima dell'invasione ottomana. In alternativa, è possibile
che la fuga dell'alto clero avrebbe favorito l'evoluzione della chiesa italiana
in una firma diversa e inusuale, "non conforme" a quella cattolica standard?
Quanti musulmani sarebbero arrivati in Italia da altre parti dell'Impero
Ottomano? In Italia, diversamente dai Balcani, c'era un certo numero di grandi
città: Roma, Napoli, Firenze, Bari, Bologna, quindi un certo numero di mercanti
e artigiani musulmani sarebbe potuto arrivare e formare dei nuclei stabili di
popolazione musulmana.
Per *Bhrg'howidhHô(n-):
secondo me la tua ricostruzione somiglia alla tesi di Pirenne. Sai, quella
secondo cui il Sacro Romano Impero sarebbe nato principalmente per volere della
chiesa cattolica e a causa della minaccia musulmana. In questo caso, in seguito
alla caduta di Roma si manifesterebbe una determinante coesione tra sovrani e
dinastie che altrimenti in condizioni normali sarebbero state contrapposte. Sì,
penso sia plausibile sopratuttto perché in questa ucronia il Papato si
stabilisce ad Avignone (forse sarebbe stato più difficile in presenza di un
Papato "tedesco") però attenzione a non dimenticarci delle nazioni protestanti:
sono fortemente convinto che se per le nazioni cattoliche tutta la politica
estera sarebbe stata caratterizzata dal comune obiettivo della riscossa contro
l'Impero Ottomano, le nazioni protestanti avrebbero percepito la caduta di Roma
come una punizione divina contro i cattolici. Non ho capito perché per esempio
la Prussia, che era una nazione protestante avrebbe dovuto così facilmente fare
fronte comune con l'Austria. Quanto all'Inghilterra, la coalizione tra le
potenze cattoliche potrebbe far sentire ancora di più gli inglesi determinati a
seminare zizzania.
Ora, è possibile che l'unione d'intenti tra i cattolici avrebbe determinato un
più risoluto appoggio agli Stuart e una permanenza della dinastia (anche se
probabilmente con una forte opposizione interna protestante, ribellioni e
tentativi di colpi di stato). Guglielmo d'Orange, se non fosse mai diventato Re
di Gran Bretagna, non avrebbe forse rappresentato un così grande cruccio per le
scelte di Luigi XIV, ma mettiamo che ciò sia ininfluente e che in ogni caso la
guerra si successione spagnola non avvenga.
La Guerra dei Sette Anni, se la Gran Bretagna fosse stata ancora a guida
cattolica e la Francia fosse assente dal Nordamerica e dall'India (in HL in
Nordamerica c'erano ben coloni pochi francesi, in questa TL se la Francia si è
concentrata sulla conquista della Barberia potrebbero non essercene per nulla)
potrebbe a sua volta non verificarsi.
La storia di Napoleone, come detto ancora da (ri)scrivere potrebbe rappresentare
una svolta politica. La Francia rivoluzionaria, in netta contrapposizione a
quella monarchica, era anticlericale e antiasburgica. Non c'è motivo di pensare
che in questa ucronia sarebbe stato diverso, e quindi anche Napoleone (per
quanto le conquiste in oriente siano un'affascinante attrattiva) potrebbe fare
la stessa politica della HL, ma la spedizione in Egitto, senza rivalità con i
britannici perde senso. Anzi, i Gran Bretagna i malumori protestanti contro la
monarchia cattolica avrebbero potuto favorire un contagio rivoluzionario. In
questa TL potrebbe quindi accadere una cosa piuttosto originale, che la
Rivoluzione Inglese si verifichi con un secolo di ritardo, stimolata da quella
francese. In tal caso la Gran Bretagna e la Francia napoleonica potrebbero
essere alleate e non contro l'Impero Ottomano ma contro le potenze cristiane
conservatrici. Difficile capire come sarebbe stato l'equilibrio di forze ma
delle lotte tra regni cristiani l'Impero Ottomano potrebbe beneficiare per
respirare.
Difficile dire soprattutto se Napoleone sarebbe stato sconfitto: in Russia
certamente, ma ricordiamoci che il contributo britannico fu decisivo in HL, in
Spagna come a Waterloo...
.
Gli risponde *Bhrg'howidhHô(n-):
Dunque Prussia, Inghilterra e Francia. Andrei in ordine cronologico progressivo, cominciando quindi dall’Inghilterra.
In questa ucronia la grande divergenza sostanziale è una diversa area della Riforma Cattolica, donde l’interrogativo se l’Inghilterra ne sia coinvolta o no. Se sì, la conseguenza è chiara, ovvia e immediata: Filippo II. continua a essere Re d’Inghilterra (Francia) e Irlanda anche dopo la morte di Maria la Cattolica; se invece no, allora si deve arrivare almeno a Cromwell.
In tal caso, secondo dilemma: rimangono gli Stuart o no? Se sì, di nuovo la conseguenza è inaggirabile: Francesco Ferdinando Re di Gran Bretagna e Irlanda dal 1875; la Rivoluzione Francese non si estende all’Inghilterra (se non come invasione militare) così come non si è storicamente estesa ad altri Paesi cattolici (se non come invasione militare). Se invece non rimangono gli Stuart, allora Guglielmo d’Orange e gli Hannover, come nella Storia reale.
Prussia. Trattarla come una «Nazione» (diversa dall’Austria) presuppone che non esistesse alcun sentimento nazionale tedesco (e gallesco), che invece è ampiamente documentato ed è stato la principale causa del superamento delle Guerre di Religione (ossia di Successione ai Feudi Ecclesiastici nell’Impero) dopo il 1635: l’amputazione di due importantissime parti della Germania (Provincie Unite e Confederazione con gli Alleati Perpetui) a opera di due Invasori (Svezia e Francia) ha mostrato con crudissima chiarezza a che cosa ha portato il contrasto per i Feudi Ecclesiastici. Per molto meno, la Francia ha combattuto gli Asburgo per quasi mezzo millennio. Ho dunque preso la Prussia esattamente per quel che ha fatto nella Storia reale: alleata dell’Imperatore quando lo è stata davvero, nemica quando lo è stata davvero, né più né meno. Più nemica di così comporterebbe uno di questi due esiti sicuri (dato che erano o reali o imminenti): permanenza come Feudo della Polonia oppure annessione da parte della Svezia. Mi pare che le conseguenze siano inevitabili...
Rivoluzione Francese. Mi sono attenuto a quanto hai scritto e ai messaggi precedenti, quindi senza dubbio la Rivoluzione è anticattolica e antiasburgica. In questa ucronia, i confini nordorientali e sudoccidentali rimangono, per le ragioni esposte, come all’inizio del XVII. secolo; la grande espansione è verso Sud-Est, che prosegue nel XVIII. secolo con la Toscana e la metà settentrionale del Regno di Napoli, di fatto ponendo almeno metà del restaurato Stato della Chiesa – con Roma – (se non addirittura anche le Marche) sotto il controllo più o meno diretto di Parigi (più più che meno, per come conosciamo la Storia della Francia). La Francia confina dunque a Nord-Est con i Paesi Bassi austriaci, la Lorena (pure austriaca) e la Franca Contea (spagnola), poi con Ginevra e la Svizzera, a Sud delle Alpi con l’austriaca Lombardia e i Ducati Padani, nella Penisola con la metà spagnola del Regno di Sicilia Al di Qua del Faro, in Corsica con la Sardegna e lungo i Pirenei con l’Unione Iberica (ancora comprendente il Rossiglione): come avevamo già constatato, non c‘è nemmeno bisogno di una Prima Coalizione per circondare e stritolare la Francia rivoluzionaria, bastano l’Impero e i Dominî Asburgici diretti.
Ciò che storicamente ha sconfitto Napoleone è stata l’ampiezza della Coalizione: nelle precedenti guerre, la Francia aveva sempre avuto al proprio fianco una o più altre Potenze, mentre ogni volta che è rimasta sola contro tutti ha perso. In questa ucronia, come abbiamo visto, l’Inghilterra è asburgica o stuarda o hannoveriana: in tutti i casi, nemica della Rivoluzione, tanto più se si tenta di esportare quest’ultima con le armi.
La Spedizione in Egitto non era solo antibritannica: era, in origine, antiottomana e pensata per dare al Re-Sole una degna e gloriosa espansione che non avvenisse per l’ennesima volta ai danni dell’Impero e dell’Arcicasa (il progetto era infatti di Leibniz, non certo un cattolico asburgico). È per questo che, se la Francia non viene (del tutto) spartita dopo il disastro delle Guerre Rivoluzionarie, la restaurata Monarchia Borbonica avrà nell’Egitto l’unica via di riscossa (il pensiero di Bismarck anticipato).
Quanto all’America, nella Storia reale l’Impero Coloniale francese è stato costruito nonostante le continue guerre in Europa, che qui sono al contempo molte meno e molto più vittoriose; mi sentirei dunque di escludere che la Barberia comporti invece uno sforzo tale da annullare tali due vantaggi e addirittura peggiorare la situazione rispetto alla Storia reale. Piuttosto, ciò che intendevo era che la scarsità di Coloni avrà comunque gravi conseguenze sulla Guerra dei Sette Anni, ma, a differenza che in quest’ultima, il piano di riserva (la cessione dell’intera Louisiana alla Spagna) riuscirà immediatamente invece che passare, dimezzato, dalla Pace di Parigi del 1763.
.
Per partecipare alla discussione, scriveteci a questo indirizzo.
