![]()
È l'era più antica della storia della Terra, e, va dalle sue origini (4 miliardi e 500 milioni di anni fa), alla comparsa dei primi invertebrati con esoscheletro (542 milioni di anni fa). In termini di Anno della Terra, esso dura più o meno dal 1 gennaio al 18 novembre: dieci mesi e mezzo!!! Agli inizi le fu dato il nome di Azoica, cioè "priva di vita", perché tale si credeva fosse stata; quando invece sotto gli strati di rocce risalenti al periodo Cambriano vennero individuate tracce di vita primordiale, venne rinominata Archeozoica ("della vita remota") o Precambriana. I rarissimi fossili archeozoici appartengono a specie vegetali ed animali vissute nei mari: alghe, protozoi, celenterati, molluschi, echinodermi, artropodi.
|
|
|
Uno spaventoso paesaggio della crosta terrestre in formazione (dalla sigla del noto cartoon giapponese "Ryu, il ragazzo delle caverne") |
Il Precambriano è diviso in tre periodi:
![]()
Il periodo di tempo che va da quando si è formato l'ammasso gassoso da cui ha avuto origine la Terra alla sua trasformazione in un corpo solido (da 4,5 miliardi a 3,8 miliardi di anni fa) è chiamato Adeano o epoca pregeologica. In termini di Anno della Terra, esso è cominciato il 1 gennaio ed è terminato verso il 26 febbraio. Il suo nome significa "infernale", perchè esso rappresenta l'epoca durante la quale si formò la crosta terrestre, inizialmente incandescente; quindi, a quei tempi la superficie del nostro pianeta doveva apparire come un vero e proprio inferno. Questo nome venne introdotto per la prima volta nel 1972 dal geologo Preston Cloud (1912-1991), per indicare il periodo antecedente la formazione delle rocce più antiche sulla Terra.
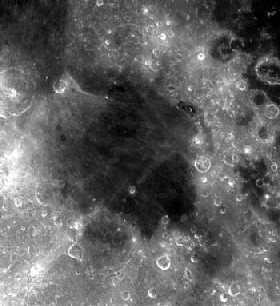 L'Adeano è suddiviso in tre periodi: Criptico,
Nettariano ed Imbriano.
Il primo deriva il suo nome ("nascosto") dal fatto che non ci è
pervenuta nessuna roccia terrestre né lunare risalente a quel periodo, terminato circa 4,1 miliardi
di anni fa (il 2 febbraio). Di recente però sono
stati ritrovati sulla Terra meteoriti le cui rocce si formarono proprio in
quell'epoca, come il raro "sasso spaziale" ritrovato per puro caso il 17 gennaio
2009 da Thomas Grau, un cacciatore di meteoriti per hobby, in un campo sull'isola danese di
Lolland:
la sua roccia si sarebbe formata proprio 4,5 miliardi di anni fa! Gli altri due
periodi invece traggono
il loro nome rispettivamente dal Mare Nectaris e
dal Mare Imbrium posti sulla superficie lunare, le
cui rocce si sarebbero appunto formate in quei periodi (e poi pervenute fino a
noi perchè sulla Luna non vi è erosione né attività
geologica). L'esistenza stessa di questo periodo non è però riconosciuta
dalla Commissione Internazionale
di Stratigrafia (ICS), per la quale il Precambriano è
diviso solo in Archeano e
Proterozoico.
L'Adeano è suddiviso in tre periodi: Criptico,
Nettariano ed Imbriano.
Il primo deriva il suo nome ("nascosto") dal fatto che non ci è
pervenuta nessuna roccia terrestre né lunare risalente a quel periodo, terminato circa 4,1 miliardi
di anni fa (il 2 febbraio). Di recente però sono
stati ritrovati sulla Terra meteoriti le cui rocce si formarono proprio in
quell'epoca, come il raro "sasso spaziale" ritrovato per puro caso il 17 gennaio
2009 da Thomas Grau, un cacciatore di meteoriti per hobby, in un campo sull'isola danese di
Lolland:
la sua roccia si sarebbe formata proprio 4,5 miliardi di anni fa! Gli altri due
periodi invece traggono
il loro nome rispettivamente dal Mare Nectaris e
dal Mare Imbrium posti sulla superficie lunare, le
cui rocce si sarebbero appunto formate in quei periodi (e poi pervenute fino a
noi perchè sulla Luna non vi è erosione né attività
geologica). L'esistenza stessa di questo periodo non è però riconosciuta
dalla Commissione Internazionale
di Stratigrafia (ICS), per la quale il Precambriano è
diviso solo in Archeano e
Proterozoico.
Lo sviluppo della crosta terrestre
Su questo processo lento e decisivo per la nostra storia non si hanno ancora certezze; si ritiene tuttavia che gli elementi pesanti, come il ferro, andarono a depositarsi al centro a causa della forza di gravità, mentre gli elementi più leggeri, i silicati, formarono un oceano incandescente alla superficie. Dopo circa 500 milioni di anni dalla nascita della Terra (il 10 febbraio), il paesaggio incandescente iniziò a raffreddarsi: la dissipazione di calore nello spazio diede inizio al raffreddamento del nostro pianeta, e nell'oceano di magma cominciarono a comparire lembi di rocce formate da minerali ad alto punto di fusione, una sorta di zattere roventi ma solide simili alla crosta sottile che vediamo formarsi alla superficie di una colata di lava, mentre questa sta ancora fluendo dal cratere. In quei tempi la Luna, ancora rovente, distava dalla Terra solo 16.000 Km contro i 384.000 attuali, per cui doveva invadere gran parte del cielo, dal quale meteoriti o addirittura piccoli protopianeti dovevano continuare ad abbattersi nell'oceano incandescente: un vero paesaggio da incubo!
Poi, l'abbassamento della temperatura al di sotto dei 1000 gradi consentì il consolidamento delle zone con temperature più basse che, divenute più stabili, avviarono la costruzione della futura crosta terrestre. Ma quei primissimi frammenti di crosta dovevano essere anche molto instabili, e dovevano venir facilmente riassorbiti dalla massa liquida e rifusi in profondità. Solo con l'ulteriore raffreddamento del pianeta, quei frammenti devono essere diventati abbastanza numerosi e grandi da formare un primo involucro solido, cioè una vera crosta primitiva. Quella prima crosta doveva apparire come una distesa di rocce caldissime (qualche centinaio di gradi Celsius), interrotta da numerose grandi fratture, dalle quali continuavano a risalire enormi quantità di magma.
Nel 2017 Jonathan O’Neil, dell'Università di Ottawa, e Richard W. Carlson, della Carnegie Institution for Science a Washington, hanno affermato di aver scoperto che alcune parti dello scudo canadese, la grande formazione rocciosa che comprende il Canada orientale e centrale e gli Stati Uniti settentrionali, contengono residui della crosta terrestre primordiale, risalente a oltre 4,2 miliardi di anni fa, cioè al 25 gennaio dell'Anno della Terra! I due scienziati hanno analizzato i rapporti isotopici di due terre rare, samario e neodimio, presenti in campioni di rocce raccolti nelle formazioni attorno alla baia di Hudson, fra cui le rocce di Nuvvuagittuq, dove di recente sono stati trovati resti di colonie di microganismi di 4 miliardi di anni fa (risalenti al 10 febbraio). Poiché il samario 147 decade in neodimio 143 con un tempo di dimezzamento noto, pari a ben 106 miliardi di anni, ed è pure noto il rapporto originario fra neodimio 143 e gli altri isotopi del neodimio, è possibile risalire all'età di formazione delle rocce. Le analisi hanno mostrato che gran parte delle rocce della regione sono il prodotto di rifusione e riconsolidamento della crosta primigenia, e risalgono ad "appena" 2,7 miliardi di anni fa (al 27 maggio: 4 mesi dopo!) Tuttavia, alcuni campioni hanno mostrato di risalire a un'epoca molto precedente, con un'età superiore ai 4,2 miliardi di anni. Si tratta verosimilmente di frammenti molto piccoli della crosta primordiale, che sono sfuggiti alla subsidenza nel mantello e hanno finito per rimanere inclusi nella nuova crosta.
Il grande bombardamento tardivo
C'è poi da dire che, nel corso dell'Adeano, il pianeta Terra fu interessato da un evento particolarmente distruttivo chiamato « grande bombardamento tardivo » (Late Heavy Bombardment, LHB): circa 3,9 miliardi di anni fa (il 18 febbraio) asteroidi di grandi dimensioni bombardarono il pianeta con una potenza incredibile, per via del fatto che in quell'epoca il giovane sistema solare era ancora molto affollato da piccoli oggetti, ed in virtù della forza di gravità i corpi maggiori andavano "ripulendo" le loro orbite da tutti i "sassi" spaziali che fino a quel periodo le infestavano. Questo attivissimo bombardamento meteoritico doveva aprire continuamente nuove lacerazioni nella crosta, subito invase dal magma. Il fenomeno sembra aver avuto origine da un’instabilità nella fascia degli asteroidi, a sua volta causata dalla migrazione dei pianeti giganti gassosi verso le loro orbite attuali. Le tracce di quell'intenso bombardamento meteoritico, protrattosi per almeno 700-800 milioni di anni, sono state quasi totalmente cancellate sulla Terra dall'erosione da parte degli agenti atmosferici, ma sono invece perfettamente conservate sulla Luna e su molti altri corpi del Sistema Solare, la cui evoluzione si è arrestata da lunghissimo tempo, sotto forma di crateri da impatto, a volte colmati di lava.
Due studi pubblicati nel 2012 hanno descritto in modo più preciso il fenomeno del « grande bombardamento tardivo »: William Bottke, del Southwest Research Institute e NASA Lunar Science Institute, e colleghi, hanno fornito stime al rialzo del numero di impatti che si sono verificati nel sistema Terra-Luna prima di 2 miliardi di anni fa, mentre B.C. Johnson e H.J. Melosh, della Purdue University di West Lafayette (Indiana), hanno valutato le dimensioni e la velocità dei bolidi che li hanno causati. Le memorie di questi giganteschi impatti si trovano in spessi strati rocciosi che ne contengono tuttora i frammenti, cioè sferule di roccia fusa dal calore sprigionato dalle collisioni. Naturalmente lo studio di questi resti è complicato dal fatto che le rocce adeane sono più rare di qualunque altro tipo di roccia sulla Terra, e che i segni delle sferule da impatto sono stati ritrovati solo in terreni in cui erano presenti condizioni ideali per la preservazione, come nei depositi di scisti sul fondo del mare. Oggi sono noti almeno 12 strati di sferule depositatisi tra 3,47 e 1,70 miliardi di anni fa (tra le 13.00 del 27 marzo e le 2.40 del 16 agosto). L'esteso bombardamento della Terra e della Luna, tuttavia, sarebbe durato solo da 100 a 200 milioni di anni (oltre 8 giorni dell'Anno della Terra), non abbastanza a lungo per spiegare le sferule rocciose. I ricercatori hanno allora simulato al computer che cosa sarebbe accaduto se fosse stata presente un'altra fonte di bolidi provenienti dal bordo più interno della fascia degli asteroidi tra le orbite di Marte e Giove, per effetto della riorganizzazione della posizione dei pianeti giganti. Dai risultati è emerso che questa struttura del sistema solare primordiale avrebbe prodotto un notevole numero di corpi in grado di colpire la Terra e la Luna. Secondo i nuovi calcoli, in quell'era remota la Terra fu bombardata da circa 70 bolidi di 10 chilometri di diametro. La frequenza stimata, inoltre, è compatibile con gli strati di sferule da impatto osservati sulla Terra.
La crosta primitiva doveva essere simile al basalto, una roccia vulcanica scura, con meno del 53 % in peso di SiO2, che si forma a spese del mantello, ma rispetto al quale ha una natura differente. Le rocce più antiche trovate sulla Luna, vecchie di circa 4 miliardi di anni, sono infatti proprio dei basalti ad alto contenuto in alluminio. Invece le pietre considerate più antiche mai ritrovate sulla Terra fanno parte di una formazione chiamata Gneiss del fiume Acasta, affiorano nell'Artico canadese 300 km a nord della città di Yellowknife e risalgono a 4,06 miliardi di anni fa (al pomeriggio del 5 febbraio!).
Bisogna però tenere conto di un fatto assai importante. L'impatto con un asteroide generalmente surriscalda la superficie di un pianeta fino a sterilizzarla, uccidendo ogni forma di vita su di essa. Ma lo stesso meccanismo di sterilizzazione potrebbe rappresentare una vera e propria occasione propizia per i microrganismi del sottosuolo: « Gli impatti possono fratturare la roccia degli strati più profondi della superficie, cosa che consente ai fluidi e ai nutrienti di insinuarsi », ha fatto notare Charles Cockell dell'Università di Edimburgo. Questi ha studiato un antico impatto avvenuto circa 35 milioni di anni fa a Chesapeake Bay. L'asteroide, del diametro di circa un chilometro, ha lasciato un cratere del diametro di 85 chilometri, e l'effetto di questo cataclisma fu così sconvolgente che secondo Cockell la biosfera sotterranea sta ancora cercando di recuperare dall'impatto. L'energia dell'impatto avrebbe riscaldato la roccia alla base del cratere ad oltre 350° C, uccidendo ogni forma di vita sopra e immediatamente sotto la superficie terrestre. Ma, con il raffreddamento della roccia, alcuni microrganismi hanno colto l'occasione per ripopolare l'area del disastro. I carotaggi nel sottosuolo dimostrano che, entro 450 metri di profondità, si trovano sedimenti più recenti rispetto alla data dell'impatto. Tra i 450 e i 1000 metri, invece, si raccoglie la maggior parte del materiale spostato dal cataclisma. Oltre il chilometro di profondità, lo strato roccioso mostra evidenti segni di shock e riscaldamento. Ed è proprio in questo strato che i ricercatori hanno scoperto una straordinaria densità di microrganismi: oltre un milione per grammo di materiale recuperato. « Nessuno ha mai osservato così tanti organismi a questa profondità », ha aggiunto Cockell. La densità di vita nel sottosuolo infatti tende a calare man mano che ci si spinge in profondità. Sembra che l'impatto dell'asteroide, tuttavia, abbia ampliato l'area in cui alcuni microrganismi sono capaci di diffondersi, creando fessure e fratture in cui si sono insinuati l'acqua e i nutrienti che hanno reso più "vivibile" quello strato di crosta terrestre. Questo potrebbe costringerci a cambiare la nostra visione degli impatti di asteroidi, vedendoli non più soltanto come eventi catastrofici, ma anche come meccanismi naturali per l'apertura di nicchie ecologiche per la comunità microscopica. I crateri da impatto su altri pianeti potrebbero quindi rappresentare località ideali per la ricerca di forme di vita. Se, sulla Terra, la distruzione portata da bolidi celesti ha contribuito alla creazione di nuove nicchie ecologiche, lo stesso potrebbe essere successo su altri pianeti come Marte. Queste considerazioni potrebbero quindi guidarci nella scelta di un sito di scavo durante una futura missione sul Pianeta Rosso.
Carbonio dallo spazio
Secondo Rajdeep Dasgupta e colleghi della Rice University di Houston e della Woods Hole Oceanographic Institution a Woods Hole, in Massachusetts, tutto o quasi il carbonio che è alla base della vita sulla Terra deriva da una collisione avvenuta 4,4 miliardi di anni fa (alle 02.40 del 9 gennaio) tra il nostro pianeta e un pianeta allo stato embrionale simile a Mercurio. La scoperta metterebbe fine a una questione dibattuta da molti anni sullo sviluppo della vita sulla Terra, dato che la maggior parte del carbonio che contiene avrebbe dovuto disperdersi nello spazio nelle fasi primordiali di evoluzione del nostro pianeta o rimanere intrappolato nel nucleo. Mantello, atmosfera e crosta terrestre si scambiano costantemente elementi chimici, compresi quelli necessari alla vita, ma se l'iniziale distribuzione di carbonio è evaporata nello spazio o si è concentrata nel nucleo, da dove viene il carbonio che si osserva nel mantello e nella biosfera? Secondo la vulgata comune, gli elementi volatili come carbonio, zolfo, azoto e idrogeno sarebbero arrivati sulla Terra con meteoriti e comete più di 100 milioni di anni dopo la formazione del sistema solare, evitando l'intenso calore dell'oceano di magma che ricopriva la Terra nelle epoche precedenti. Il problema di questa ipotesi è che, pur rendendo conto dell'abbondanza di molti di questi elementi, non sono noti meteoriti in grado di produrre il rapporto di elementi volatili osservati nella porzione di silicati del nostro pianeta.
Dasgupta e colleghi hanno ricreato in laboratorio con una pressa idraulica le condizioni di alte pressioni e temperature presenti all'interno della Terra, fino a circa 300 chilometri di profondità, oppure in corrispondenza dell'interfaccia nucleo-mantello di piccoli pianeti rocciosi come Mercurio. A partire dal 2013, in particolare, gli sforzi di questo gruppo di ricerca sono stati dedicati a capire in che modo potesse diminuire l'affinità del ferro per il carbonio, e quindi a spiegare perché questo elemento non è rimasto confinato nel nucleo. L'ispirazione è venuta dalla constatazione che Marte ha un nucleo ricco di zolfo, e che quello di Mercurio è ricco di silicio. Da qui l'ipotesi che questi elementi possano essere presenti anche nel nucleo terrestre, sfidando la visione corrente secondo cui esso sarebbe costituito solo da ferro, nichel e carbonio. Gli esperimenti hanno rivelato che il carbonio potrebbe essere stato escluso dal nucleo e relegato nel mantello di silicati se le leghe di ferro nel nucleo fossero state ricche sia di silicio sia di zolfo. Una volta spiegato come si distribuisce il carbonio tra nucleo e mantello, non restava che trovare una fonte plausibile per l'abbondanza osservata di questo elemento. « Uno scenario che spiega il rapporto tra carbonio e zolfo e l'abbondanza del carbonio è quello di un pianeta embrionale simile a Mercurio, che aveva già un nucleo ricco di silicio, entrato in collisione con la Terra, da cui alla fine è stato assorbito », ha concluso Dasgupta. « La dinamica dell'evento è stata tale che il nucleo di questo pianeta potrebbe essere finito direttamente nel nucleo della Terra, mentre il mantello ricco di carbonio si sarebbe miscelato con quello del nostro pianeta. »
Il ferro nel cuore della Terra
La chimica del ferro può raccontare molti particolari dell'evoluzione geochimica del nostro pianeta, in particolare di quella del nucleo; lo ha dimostrato uno studio di Anat Shahar della Carnegie Institution for Science, che ha riprodotto in laboratorio le condizioni di pressione elevatissima che caratterizzarono il processo noto come differenziazione planetaria. Quando la Terra, appena formatasi dall'aggregazione dei materiali che circondavano il Sole, era ancora una massa non solidificata, gli elementi più densi, come il ferro, sono sprofondati verso il centro, creando il nucleo terrestre e una struttura a strati che è sopravvissuta fino alla nostra epoca. Il ferro in particolare si è separato dai silicati, composti di silicio e ossigeno, che sono andati a costituire il mantello, subito sopra il nucleo, che a sua volta è stato ricoperto dalla crosta terrestre. In questo modello complessivo mancano però molti dettagli, essenzialmente per la difficoltà tecnica di ottenere campioni del nucleo terrestre. Un aiuto viene dai dati della propagazione delle onde sismiche attraverso i vari strati terrestri, che indicano inequivocabilmente che nel nucleo ci sono anche elementi più leggeri del ferro, sulla cui natura e concentrazione però è in corso un acceso dibattito. La questione di fondo è che il ferro nel suo moto verso l'interno della Terra ha interagito con elementi più leggeri, con cui si è legato formando composti. E per capire quali furono esattamente questi elementi bisognerebbe conoscere con precisione le condizioni in quel momento, in particolare pressione e temperatura.
Sahar e colleghi hanno affrontato il problema con un approccio originale. Hanno infatti riprodotto in laboratorio le condizioni di pressione esistenti nella fase primordiale di evoluzione geochimica della Terra e hanno studiato come influenzano nei diversi composti la presenza degli isotopi del ferro,secondo un fenomeno noto come frazionamento isotopico. In sostanza, gli scienziati hanno dimostrato che la pressione è una variabile cruciale per il frazionamento isotopico. In particolare, dallo studio è emerso che le reazioni tra ferro e due degli elementi leggeri ritenuti probabilmente presenti nel nucleo, idrogeno e carbonio, avrebbero dovuto lasciare nei silicati del mantello una firma isotopica che però non è stata trovata nei campioni disponibili. Ciò ha permesso di escludere questi elementi dalla lista dei potenziali elementi leggeri presenti nel nucleo. In questa lista però è rimasto l'ossigeno, mentre per capire se sono presenti silicio e zolfo occorreranno nuovi e più approfonditi studi. « Anche se la Terra è la nostra casa, c'è molto del suo interno che ancora non capiamo », ha concluso Shahar. « Le prove per cui la pressione estrema influenza la partizione isotopica secondo modalità che possiamo verificare nei campioni di roccia è un grande passo in avanti nella comprensione dell'evoluzione geochimica del pianeta. »
L'atmosfera primordiale
Dalle rocce incandescenti e dal mantello terrestre, soprattutto per opera dell'attività vulcanica, si sprigionavano ammoniaca, idrogeno, biossido di carbonio, metano, vapore acqueo ed altri elementi che, nel giro di 100 milioni di anni, gradualmente formarono l'atmosfera primordiale. Incredibilmente, essa era molto simile a quella attualmente visibile su Titano, il maggiore dei satelliti di Saturno, così come ce lo ha rivelato la missione Cassini-Huygens nel gennaio 2005, ed in ogni caso estremamente tossica per la vita che conosciamo ai nostri giorni, essendo costituita in gran parte da una fitta nebbia di sostanze organiche gassose. È questa la conclusione di Eric Wolf, ricercatore dell'Università del Colorado a Boulder, secondo cui l’atmosfera primordiale del nostro pianeta era costituita da una specie di aerosol di metano e composti dell’azoto, i quali avrebbero determinato un riscaldamento da gas serra, impedendo al pianeta di raggiungere temperature troppo basse. « Prima di questo studio, il modello più accreditato prevedeva un'atmosfera primordiale costituita da azoto con una minima percentuale di biossido di carbonio, metano, idrogeno e vapor d'acqua », ha spiegato Wolf; « la temperatura tuttavia non poteva essere più elevata solo per la presenza del biossido di carbonio, a causa dei suoi bassi livelli: avrebbero dovuto essere implicati anche altri gas serra. La spiegazione più logica è che vi fosse anche del metano, immesso in atmosfera dal rilascio dei gas durante le eruzioni vulcaniche ».
| Un oceano di idrocarburi su Titano. Immagine inviata dalla sonda europea Huygens il 14 gennaio 2005 (foto ESA) |
Il processo di raffreddamento e consolidamento della superficie terrestre dovette infatti essere accompagnato, come avviene tuttora nei vulcani, da un forte degasamento: così l'atmosfera si arricchì di metano (CH4), idrogeno (H2), azoto (N2) e vapore acqueo con tracce dl gas nobili e anidride carbonica. Insomma, l'intensa attività vulcanica della Terra bambina portò in superficie gli elementi leggeri, ma non tutti: grandi quantità di gas come elio ed argo, che tendono ad essere emessi durante il vulcanismo, rimasero intrappolate nelle viscere della Terra. Che cosa fece esalare al pianeta il suo "ultimo respiro"? La questione è controversa. L'opinione prevalente è quella che una porzione del mantello inferiore non si fuse mai, conservando la sua composizione primordiale. Tuttavia un team di scienziati della Rice University di Houston ha avanzato una nuova proposta: la terra di 4 miliardi di anni fa era molto più calda di quella attuale, e le particolari condizioni geofisiche determinarono una "trappola di densità" circa 400 Km sotto la superficie. Calore e pressione diedero così vita a una rarità geofisica, un'area in cui i liquidi erano... più densi dei solidi! Quindi, invece di salire in superficie dando vita a vulcani, come avviene oggi, essi cristallizzarono e affondarono assieme ai gas che contenevano. Un'ipotesi suggestiva, che attende ancora conferme. In ogni caso, comunque, la scarsa gravità liberò la Terra dal guscio di idrogeno, molto leggero, che invece fa da involucro ai pianeti gioviani, gli altri gas e vapori andavano invece concentrandosi; il vapore acqueo non arrivava però ancora a condensarsi, a causa delle temperature superficiali ancora molto elevate.
C'è però da tener conto che il campo magnetico terrestre un tempo era ben diverso da quello attuale. Secondo quanto studiato da alcuni scienziati dell'Università di Rochester e dell'Università del KwaZulu-Natal, tre miliardi e mezzo di anni fa esso aveva un'intensità pari alla metà di quello odierno, e ciò aveva fortissimi impatti sulla Terra primordiale. Infatti a quel tempo anche la nostra stella emetteva potentissimi venti solari, i quali probabilmente hanno "strappato" una notevole quantità di acqua dall'atmosfera del pianeta. Le prove? Il KwaZulu-Natal è una regione del Sudafrica particolarmente ricca di rocce ignee risalenti a oltre tre miliardi di anni fa, nelle quali sono contenuti piccoli cristalli di quarzo. Dentro di essi si possono rilevare minuscole inclusioni di materiali magnetici che conservavano tracce "congelate" del campo magnetico che esisteva al tempo della loro formazione. « Un campo magnetico più debole implica che il flusso di particelle solari raggiungeva molto più facilmente la Terra », ha spiegato John Tarduno, geofisico della Rochester University. « È estremamente probabile che i venti solari abbiano rimosso dall'atmosfera molecole volatili, come quelle di idrogeno, a un tasso molto più elevato di quello odierno. » E naturalmente la perdita di idrogeno implica anche una perdita di acqua, che perciò è presente attualmente sul nostro pianeta in quantità decisamente inferiori a quelle di un tempo.
Il vento solare è in grado di strappare a un pianeta la sua atmosfera, irradiandone così la superficie con radiazioni letali: Marte rappresenta il tipico esempio di un pianeta che ha verosimilmente perso molto presto la sua magnetosfera, permettendo alla radiazione solare di eroderne l'atmosfera. « C'è una forte correlazione fra l'età di una stella di tipo solare e la quantità di materia che viene asportata dai suoi venti », ha continuato Eric Mamajek, che ha partecipato allo studio. « Possiamo ipotizzare che, quando il Sole aveva l'età di un solo miliardo di anni, esso stesso perdeva materiale a una velocità cento volte superiore a quella che si osserva adesso, perciò il vento solare era almeno di un paio di ordini di grandezza più intenso. Con una magnetosfera più debole il punto di equilibrio far i due campi magnetici, la cosiddetta magnetopausa, si trovava probabilmente a meno di cinque raggi terrestri dal pianeta, ossia a meno della metà della distanza odierna, che è di 10,7 raggi terrestri ». La perdita di acqua doveva essere resa più elevata anche dal fatto che l'atmosfera terrestre era anche molto più ricca di vapore acqueo. In conseguenza di ciò in una normale notte di 3,5 miliardi di anni fa doveva essere possibile assistere a spettacolari aurore boreali molto più a sud di oggi, fino alla latitudine della nostra Italia!
La durata del giorno e l'ossigenazione dell'atmosfera
Ma in che modo, esattamente, la Terra è diventata l'unico pianeta conosciuto ad avere un'atmosfera ricca di ossigeno? Gli indizi geologici suggeriscono che i microbi potrebbero aver iniziato a rilasciare ossigeno con la fotosintesi già tre miliardi di anni fa (alle ore 16 del 2 maggio), ma è servito circa mezzo miliardo di anni affinché quell'ossigeno si accumulasse nell'atmosfera, e poi un altro miliardo affinché raggiungesse i livelli attuali e ponesse le basi per la vita complessa. Questi lunghissimi ritardi hanno sempre lasciato perplessi gli scienziati. Alcuni hanno proposto che le reazioni chimiche possano aver consumato gran parte del gas, o che una mancanza di nutrienti essenziali abbia limitato la sua produzione. Invece Judith Klatt, biogeochimica del Max-Planck-Institut per la microbiologia marina a Brema, ha proposto nel 2021 un'altra possibile spiegazione: i primi giorni della Terra erano semplicemente troppo brevi.
Come abbiamo già visto, con tutta probabilità poco dopo la formazione del sistema solare un corpo celeste delle dimensioni di Marte, chiamato Teia, si è schiantato sulla Terra provocando la formazione della Luna. Da allora, l'effetto mareale da parte del nostro satellite naturale ha gradualmente rallentato la rotazione del pianeta, aumentando la lunghezza del giorno dalle circa sei ore dell'Adeano alle 24 ore attuali. Studiando i tappeti colorati di microbi primitivi che vivono in una dolina sul fondo del lago Huron, al confine tra Canada e Stati Uniti, la Klatt e il suo collega Brian Arbic, oceanografo dell'Università del Michigan, si sono chiesti se la variazione della lunghezza del giorno può aver influito sulla fotosintesi nel corso del tempo geologico. Poiché è alimentata da acque sotterranee povere di ossigeno e ricche di zolfo, la dolina si avvicina alle condizioni della Terra primitiva, ospitando comunità di batteri microscopici che coprono il fondo del lago di tappeti viola e bianchi. Klatt e i suoi colleghi hanno esaminato in che modo i cianobatteri fotosintetici, che producono ossigeno, si nascondono sotto i loro competitori che consumano zolfo durante la notte, e come i due si scambiano le posizioni all'alba e al tramonto. I ricercatori hanno scoperto che il tempo che impiegano per scambiarsi di posto crea un ritardo tra quando sorge il Sole e quando inizia la fotosintesi, limitando la quantità di ossigeno che i tappeti possono generare nei giorni brevi. Judith Klatt ha dimostrato in laboratorio che i tappeti non producevano affatto ossigeno in giorni della durata di sole 12 ore, e che la produzione di ossigeno aumentava quando la lunghezza del giorno superava le 16 ore.
Anche se quello della dolina da lei studiato è un tipo molto speciale di comunità che potrebbe non essere esistita in una Terra primitiva, vi è però un altro fattore di cui tenere conto, che si applica a qualsiasi tipo di tappeto batterico, compresi quelli presenti sulla Terra antica: anche se la produzione di ossigeno rimaneva invariata, giorni più lunghi avrebbero permesso a più gas di diffondersi nell'acqua e infine entrare nell'atmosfera, giacché la quantità di ossigeno che lascia un tappeto è limitata da quanto velocemente le molecole di gas possono diffondersi al fuori di esso e da quanto ne viene consumato da altri tipi di batteri nel tappeto. I giorni più lunghi hanno un picco di luce solare prolungato, lasciando accumulare più ossigeno nel tappeto, il che ne aumenta la diffusione. Inoltre, i giorni più lunghi danno anche al gas più tempo per sfuggire prima della notte, quando i microbi che assorbono l'ossigeno consumano il resto. Questi meccanismi potrebbero aver avuto un forte impatto sui livelli di ossigeno atmosferico nella storia della Terra. Naturalmente rimangono aperte questioni importanti, per esempio se i primi batteri fotosintetici vivessero principalmente sul fondo del mare o fluttuassero liberi nell'acqua, dove avrebbero potuto rilasciare ossigeno più facilmente e senza molta dipendenza dalla diffusione. Altri possibili meccanismi che avrebbero contribuito a saturare l'atmosfera di ossigeno sono il cambiamento delle emissioni di gas dai vulcani che consumano ossigeno, come idrogeno e metano, e la disponibilità limitata di fosforo, un nutriente necessario per la fotosintesi. Ma l'ipotesi di Platt e Arbic è in perfetto accordo con la storia dell'ossigenazione atmosferica, compreso il famoso aumento in due fasi e i miliardi di anni intermedi quando i livelli di ossigeno sono andati scemando, e anche la lunghezza del giorno si è fermata a 21 ore.
Quando la Luna aveva un campo magnetico
Fra i 4,5 e i 3,56 miliardi di anni fa (tra il 1 gennaio e il 18 marzo dell'Anno della Terra) anche la Luna era dotata di una geodinamo che alimentava un campo magnetico globale. È questa la conclusione che Benjamin P. Weiss del Massachusetts Institute of Technology e Sonia M. Tikoo dell'Università della California a Berkeley hanno tratto dall'analisi dei dati ottenuti in una serie di studi recenti. Benché oggi la Luna non abbia un suo campo magnetico globale, già le missioni Apollo avevano permesso di rilevare nei campioni di rocce lunari una magnetizzazione residua, la quale dimostrava che un tempo anche il nostro satellite ne possedeva uno. Tuttavia, l'origine, intensità e la durata di questo antico campo sono rimasti a lungo incerti. Non era chiaro se fosse stato prodotto da una geodinamo dovuta al moto di un nucleo metallico del satellite, oppure se si trattasse di campi generati da plasmi da impatto.
Pressoché tutti i campioni raccolti erano infatti composti di regoliti, materiale superficiale dovuto all'aggregazione di residui di varia granulometria prodotti dall'impatto, per esempio, di meteoriti, e da esse è problematico ricavare l'orientazione originaria del campo magnetico. Inoltre le principali anomalie magnetiche mappate all'epoca, concentrate in bacini da impatto relativamente recenti, erano compatibili con entrambe le ipotesi, la geodinamo e la creazione di plasmi da impatto. Da allora però le tecniche analitiche in geocronologia, petrologia, e paleomagnetismo sono state notevolmente raffinate, facendo un balzo in avanti negli anni Duemila grazie allo sviluppo di una nuova generazione di analisi e di accurati modelli di simulazione dell'evoluzione termica del satellite, che hanno permesso la realizzazione di realistiche simulazioni della possibile geodinamo lunare.
In questo modo è stato possibile stabilire che il modello in migliore accordo con i dati disponibili è quello che vede, fra 4,5 e 3,56 miliardi di anni fa, la presenza di un campo magnetico di intensità simile a quella sulla superficie della Terra oggi, che sarebbe poi diminuita di almeno un ordine di grandezza entro i 3,3 miliardi di anni fa (l'8 aprile). L' elevata intensità iniziale del campo richiede un'alimentazione decisamente potente, quale quella che potrebbe essere fornita dal movimento differenziale fra il mantello e un nucleo ferroso, e in particolare la parte esterna fluida del nucleo. La definitiva conferma di questo scenario e la determinazione di quando la dinamo si è avviata e poi fermata saranno il compito di future esplorazioni, che permetteranno di ottenere misurazioni più accurate sulla paleointensità del campo magnetico. Particolarmente utili sarebbero campioni della crosta di tipo non regolitico, accoppiati a misurazioni in loco del loro orientamento. In questo modo si potrebbe infatti stabilire la geometria e la frequenza delle antiche inversioni del campo lunare.
E non basta. Com'è noto, gli astronomi hanno sempre considerato la Luna un corpo asciutto, totalmente privo di acqua. Più recentemente però i campioni lunari riportati dalle missioni Apollo sono stati studiati con nuovi strumenti, e le analisi hanno rivelato tracce di acqua nelle rocce del satellite terrestre. Non si tratta di acqua liquida: niente pozzanghere, fiumi, o laghi come sulla Terra. E non è neppure acqua ghiacciata: Si tratta invece di molecole intrappolate nelle rocce lunari. A causa dell'assenza di atmosfera e delle forti escursioni termiche della superficie lunare, la presenza di acqua come la conosciamo sulla Terra è praticamente impossibile. Si tratta insomma di una presenza di poche parti per milione, la cui origine è tuttora oggetto di dibattito per la comunità scientifica. Secondo alcuni potrebbe essere addirittura di origine "solare". Sarebbe stato infatti il vento solare, quel continuo flusso di ioni (tra cui idrogeno) che bombardano ogni pianeta del nostro Sistema, combinandosi con molecole all'interno delle rocce lunari, a formare molecole d'acqua che poi sarebbero rimaste intrappolate sotto la superficie. Un'altra ipotesi è che quest'acqua fosse presente già durante le fasi iniziali di accrescimento della Luna. La maggior parte della comunità scientifica è invece convinta che l'origine dell'acqua lunare sia legata agli impatti di comete. Se questo sia avvenuto in periodi più recenti (quando la superficie lunare era già ben consolidata) oppure nelle prime fasi della formazione del satellite terrestre, è un aspetto ancora da chiarire. Nel 2016 invece Jessica Barnes della Open University (Gran Bretagna) ha suggerito che l'acqua potrebbe essere giunta sulla Luna portata da asteroidi circa 4.5 miliardi di anni fa (ai primi di gennaio). Usando un sistema in cui combina modelli numerici e misure isotopiche dei campioni lunari, La Barnes h dimostrato che l'acqua è giunta trasportata da asteroidi particolari chiamati condriti carbonaticee. In questo scenario, solo circa il 20 % dell'acqua lunare sarebbe stata trasportata da comete. Cercare acqua sulla Luna e scoprirne l'origine rientra nel progetto Moon Base dell'Agenzia Spaziale Europea. Chi vivrà, vedrà.
Aggiungiamo che, a quanto pare, il nostro pianeta era dotato di un campo magnetico già 4,2 miliardi di anni fa (il 25 gennaio), e questo campo era già sufficientemente intenso da proteggere l'atmosfera terrestre e prevenire l'evaporazione dell'acqua, quando l'attività solare era sicuramente più intensa: lo ha scoperto John Tarduno, dell'Università di Rochester. In una ricerca precedente, Tarduno aveva mostrato che il campo geomagnetico attuale ha invece un'origine piuttosto recente, risalendo a 565 milioni di anni fa (alle 4 del mattino del 16 novembre), quando si formò il nucleo interno solido, e poté cosi avviarsi la dinamo generata dal moto del nucleo esterno composto da ferro liquido, che produsse le correnti necessarie ad alimentare il campo magnetico del nostro pianeta. Occorreva quindi trovare la sorgente del paleomagnetismo terrestre. Tarduno la ha individuata analizzando campioni raccolti in Australia di cristalli di zirconio, il materiale terrestre più antico. All'origine del campo paleomagnetico, secondo Tarduno e colleghi, ci sarebbe stata la precipitazione chimica all'interno della Terra dell'ossido di magnesio prodotto in conseguenza dell'impatto fra il nostro pianeta e il corpo planetario Teia da cui nacque la Luna.
La formazione degli oceani
Nello stesso tempo, sulla superficie terrestre cominciò a manifestarsi un'altra imponente serie di eventi, che portarono alla formazione delle rocce sedimentarie, attraverso processi di erosione, trasporto e accumulo. Tali processi divennero pienamente attivi non appena la superficie si raffreddò abbastanza da permettere l'instaurarsi del ciclo dell'acqua. Infatti la Terra primitiva rimase a lungo avvolta dalle tenebre, sotto una spessa cappa di dense nubi ardenti formate dal vapore acqueo continuamente riversato nell'atmosfera dalle esalazioni vulcaniche; quando la temperatura scese abbastanza, le nubi cominciarono a sciogliersi in pioggia, e l'atmosfera primordiale diede vita a tempeste di inimmaginabili proporzioni, sotto le quali la Terra gemeva e ribolliva. In un primo tempo, abbattendosi sulle rocce incandescenti, la pioggia svaporava, ma con il graduale raffreddamento della crosta solida l'evaporazione andò diminuendo finché l'acqua poté condensare nelle zone più depresse della superficie terrestre, formando i primi oceani, mentre gli altopiani rocciosi formarono i continenti. Su di essi si costituirono anche i primi reticoli fluviali, che trasportavano i detriti strappati alle zone più elevate e li riversavano sul fondo dei mari primordiali. Il metamorfismo e la rifusione dei prodotti dell'erosione, accompagnata da un certo punto in poi dal metamorfismo e dalla fusione di grossi spessori di sedimenti, produsse ulteriori magmi e lave sempre più ricchi in silice, e quindi di composizione differente rispetto a quella del mantello e della crosta primitiva. E così si sono formati magmi sempre più simili per composizione ai graniti, e perciò in grado di dare origine a rocce più leggere dei basalti, tanto da... « galleggiare » su questi ultimi.
A poco a poco il nostro pianeta assunse un aspetto a noi più familiare, con una zona gassosa ricca di nubi detta atmosfera, una liquida con oceani, laghi e fiumi, detta idrosfera, ed una solida indicata con il nome di litosfera, con i primi abbozzi di quelli che diventeranno i futuri continenti.
Tra l'altro, l'italiano Gaetano
di Achille, nato a Teramo ma che lavora all'Università della California
a Boulder, in Colorado, ha di recente dimostrato che circa tre miliardi e mezzo di anni fa
(il 23 marzo) un vasto oceano copriva anche il 36 %
circa della superficie del pianeta Marte. Negli ultimi
decenni l'ipotesi di un antico oceano marziano è stata più volte avanzata e contestata, ma questo è il primo lavoro
a fornire un solido supporto alla tesi, grazie ai dati ottenuti nel corso delle missioni
NASA ed ESA, e in particolare
ad una dettagliata analisi topografica del suolo del Pianeta Rosso. Infatti più della metà dei 52 depositi dei delta
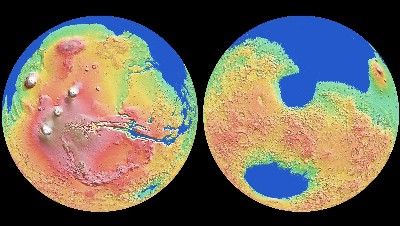 degli antichi fiumi identificati dai ricercatori si trovano alla stessa altezza, disegnando i confini del presumibile
oceano fossile. Esso avrebbe avuto un volume d'acqua di circa 125 milioni di chilometri cubi, ossia un decimo di quello occupato dagli oceani terrestri.
Oltre all'oceano su Marte doveva esserci anche una serie di grandi laghi, formatisi per lo più all'interno di crateri da
impatto: il gruppo di ricerca guidato da di Achille sostiene di aver identificato
almeno 40.000 valli scavate da fiumi. "Complessivamente, questi dati corroborano le attuali teorie sulla formazione di un antico oceano su Marte e implicano che le condizioni della sua superficie abbiano permesso la formazione di una idrosfera globale e attiva, in cui reti di valli, delta e il grande oceano erano componenti di un ciclo idrogeologico simile a quello
terrestre", ha osservato di Achille. "Sulla Terra i delta e i laghi sono eccellenti collettori e preservatori dei segni della vita
passata: se mai la vita è sorta su Marte, nei delta fossili potrebbe essere
possibile trovare la chiave per svelare il passato biologico di Marte."
Speriamo vivamente che sia così.
degli antichi fiumi identificati dai ricercatori si trovano alla stessa altezza, disegnando i confini del presumibile
oceano fossile. Esso avrebbe avuto un volume d'acqua di circa 125 milioni di chilometri cubi, ossia un decimo di quello occupato dagli oceani terrestri.
Oltre all'oceano su Marte doveva esserci anche una serie di grandi laghi, formatisi per lo più all'interno di crateri da
impatto: il gruppo di ricerca guidato da di Achille sostiene di aver identificato
almeno 40.000 valli scavate da fiumi. "Complessivamente, questi dati corroborano le attuali teorie sulla formazione di un antico oceano su Marte e implicano che le condizioni della sua superficie abbiano permesso la formazione di una idrosfera globale e attiva, in cui reti di valli, delta e il grande oceano erano componenti di un ciclo idrogeologico simile a quello
terrestre", ha osservato di Achille. "Sulla Terra i delta e i laghi sono eccellenti collettori e preservatori dei segni della vita
passata: se mai la vita è sorta su Marte, nei delta fossili potrebbe essere
possibile trovare la chiave per svelare il passato biologico di Marte."
Speriamo vivamente che sia così.
Ma non è tutto. Alexis Rodriguez del Planetary Institute di Tucson, in Arizona, ritiene che 3,4 miliardi di anni fa (alle 5.20 del 31 marzo) la superficie di Marte venne spazzata da enormi tsunami, alti in media 50 metri e tali da giungere a 120 metri in alcune zone, causati dall’impatto di asteroidi sul pianeta rosso, quando Marte possedeva ancora oceani di acqua liquida. I resti di quei lontani cataclismi sono visibili ancora oggi sotto forma di "lobi" di materiale più scuro che si estendono fino a 250 km, testimonianza delle antiche inondazioni, grazie alle immagini scattate dai satelliti che orbitano intorno al Pianeta Rosso. Secondo gli studiosi, un primo impatto generò uno tsunami che riuscì a spostare massi fino a 10 metri di diametro, poi l’acqua ritornò nel mare scavando dei canali sulla terra riempiti di depositi. Passarono alcuni milioni di anni, forse tre, quando un altro asteroide colpì Marte. Ma nel frattempo la temperatura del pianeta si era fortemente abbassata, e questa volta l’acqua dello tsunami gelò quasi all’istante e sulla terraferma si propagò come un ghiacciaio in rapidissimo movimento. Quando raggiunse il punto di massima espansione, il ghiaccio si stabilizzò e non ritornò più indietro nell’oceano. Lasciando i grandi lobi scuri che ora sono stati notati. I grandi tsunami su Marte furono facilitati dal fatto che la gravità sul pianeta rosso è circa un terzo di quella sulla Terra: 10 litri di acqua, che sulla Terra pesano 10 kg, su Marte pesano solo 3,80 kg. Rodriguez e collaboratori hanno calcolato che l’area inondata dal primo tsunami doveva avere un’estensione di 800 mila chilometri quadrati, quella del secondo un milione di km2. Gli impatti degli asteroidi potrebbero aver prodotto crateri di 30 km di diametro. L’idea che quei giganteschi tsunami precambriani abbiano potuto scavare dei canali su Marte è quasi ironica, perché l’ipotesi che il Pianeta Rosso fosse popolato da alieni nacque proprio a partire dalla presunta scoperta da parte dell’astronomo piemontese Giovanni Schiaparelli (1835-1910) di canali artificiali sulla superficie di Marte, avvenuta durante la grande opposizione del 1877. Peccato che i presunti canali fossero dovuti solo all’astigmatismo di cui Schiaparelli soffriva...
Le ere geologiche di Marte
A questo proposito, possiamo aggiungere che anche la storia geologica del pianeta Marte è stata divisa in ere, come quella terrestre:
Noachiano
Esperiano
Amazzoniano
Il Noachiano, da 4,1 a 3,7 miliardi di anni fa (dalle 10.40 del 2 febbraio alle 21.20 del 6 marzo), trae nome dalla Noachis Terra, formazione geologica databile a quest'epoca, ed è caratterizzato da un'alta frequenza di impatti di meteoriti e asteroidi e dalla possibile presenza di abbondante acqua sulla superficie marziana. Durante il Noachiano l'atmosfera di Marte era più densa di quanto non lo sia nell'era attuale, e il clima era probabilmente più caldo, tanto da consentire la caduta di pioggia; grandi laghi e fiumi erano presenti nell'emisfero meridionale e un oceano potrebbe aver ricoperto le pianure settentrionali basse. La superficie originaria di quest'era è privilegiata per l'atterraggio di veicoli spaziali per la ricerca di fossili come prova di una vita extraterrestre passata.
L'Esperiano, da 3,7 a 3 miliardi di anni fa (dalle 21.20 del 6 marzo alle 16.00 del 2 maggio), prende il nome dalla Hesperia Planum e rappresenta un periodo intermedio della vita del pianeta, caratterizzato dal minore tasso di impatti meteorici e dalla riduzione dei tassi medi di erosione. L'attività geologica dell'Esperiano viene dominata da un vasto vulcanismo, tettonica, creazione dei canali di deflusso, formazione delle pianure settentrionali e degli accumuli polari e la deposizione di frane e di spostamenti di materiale lungo la zona di transizione tra altopiani e pianure. Un'età insomma in cui Marte era geologicamente molto attivo.
L'Amazzoniano, da 3 miliardi di anni fa a oggi (dalle 16.00 del 2 maggio ad ora), prende il nome dall'Amazonis Planitia e comprende i due terzi della storia geologica del pianeta: dura insomma dalla prima parte dell'Archeano terrestre fino al presente. Quest'era vede Marte trasformarsi in un ambiente freddo, secco e ossidante. Nonostante la sua lunga durata, i cambiamenti geomorfologici superficiali sono stati modesti e sporadici, come la craterizzazione da impatto concentrato a livello regionale. Il vulcanismo, assieme all'attività fluviale e glaciale, suggerisce che i tassi deposizionali di materiale e le quantità cumulative di modificazione geologica rispetto alle epoche dell'Esperiano siano state significativamente ridotte, così come è avvenuto per i diminuiti tassi di erosione, di pari passo con il costante degrado atmosferico. I grandi vulcani della regione di Tharsis si sono innalzati in questo periodo.
Se tutto questo può sembrarvi incredibile, ebbene, i dati dalle sonde spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA dimostrano inequivocabilmente che Marte fu ricco di fiumi e oceani per centinaia di milioni di anni. Sono le conclusioni dello studio guidato da Francesco Salese, dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Pescara e Chieti. Con certezza si sapeva già che il clima caldo e umido di quel primo periodo mutò trasformando il pianeta in un gelido deserto privo di acqua liquida in superficie. I tempi di questa radicale trasformazione sono però oggetto di dibattito, e secondo alcune teorie la fase umida potrebbe essere durata poche migliaia di anni, troppo poco per permettere la nascita di forme di vita. Ma i dati della sonda europea Mars Express e dell'americana Mars Reconnaissance Orbiter (Mro) relativi al bacino Hellas, uno dei più grandi crateri da impatto dell'intero Sistema Solare, offrono nuove indicazioni. Le analisi dimostrano infatti la presenza anche di uno strato di rocce sedimentarie, materiali formati da depositi in ambienti acquatici, parzialmente portati alla luce dall'erosione. Depositi risalenti a 3,8 miliardi di anni fa (alle 19 del 26 febbraio) i quali dimostrano che la presenza di acqua deve essere durata per un lungo periodo di tempo, nell'ordine di centinaia di milioni di anni. Il sito dimostrerebbe quindi che Marte ospitò molto lungo condizioni favorevoli allo sviluppo della vita.
Ma se l'acqua scorreva su Marte, esso aveva anche un'atmosfera in grado di sostenerla, mentre oggi non ce l'ha quasi più. Ora, come fa un pianeta a perdere la sua atmosfera? I meccanismi possibili sono diversi. Alcune reazioni chimiche, per esempio, possono intrappolare i gas nelle rocce di superficie. Oppure l'atmosfera può essere erosa dalla radiazione e dal vento di particelle emesse dal Sole. E proprio quest'ultimo processo, probabilmente, è quello che ha privato Marte di gran parte della sua atmosfera, come afferma uno studio pubblicato nel 2017 da Bruce Jakosky dell'Università del Colorado a Boulder e colleghi di altri istituti statunitensi in base ai dati raccolti dalla missione Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) della NASA, lanciata nel 2013 ed entrata in orbita intorno al Pianeta Rosso nel 2014. Il vento solare è un flusso di particelle cariche che soffia costantemente dalla superficie del Sole verso ogni direzione. Le stelle giovani producono venti più intensi, e perciò la perdita di atmosfera a causa di questi processi procede con un tasso elevato, tanto da influenzare a lungo termine anche il clima. Un indicatore significativo dell'influenza del vento solare è il gas argo, che possiede due isotopi: l'argo-36, più leggero, e l'argo-38, più pesante. Il primo è più abbondante della sua controparte negli strati più alti dell'atmosfera, e quindi viene strappato dal vento solare con più facilità, lasciando un'atmosfera più ricca dell'isotopo 38. Misurando l'abbondanza dei due isotopi alle diverse quote atmosferiche, è così possibile avere una stima di quanto gas è andato disperso nello spazio rispetto alle condizioni primordiali. Grazie alle misurazioni condotte dalla sonda MAVEN, Jakosky e colleghi hanno potuto stimare che, a partire dalla formazione del pianeta, l'atmosfera ha perso il 66 % dell'argo. Sulla base di questo dato hanno poi stimato la perdita di altri gas con lo stesso meccanismo, fino a ottenere un modello dell'antica atmosfera marziana. Con tutta probabilità, essa era densa quanto quella terrestre e costituita principalmente da anidride carbonica; la maggior parte di essa poi è andata perduta, determinando enormi cambiamenti nel clima del pianeta, i cui esiti sono ora evidenti.
Un altro tassello del puzzle è stato aggiunto nel 2021, quando Timothy A. Goudge dell'Università del Texas ad Austin, insieme ad alcuni colleghi statunitensi e canadesi, ha pubblicato uno studio dal quale emerge che, nella notte dei tempi, catastrofiche inondazioni dovute allo straripamento di laghi sembrano aver causato circa un quarto dell'erosione delle antiche valli fluviali che si osservano tuttora sul pianeta Marte. Circa 200 di questi laghi (che potevano avere le dimensioni di piccoli mari terrestri) erano riempiti da abbastanza acqua da causare occasionalmente una tracimazione di vaste proporzioni, in grado di scavare profondi canyon; all'erosione dovuta a questa rete di bacini fluviali e lacustri si sovrapponevano poi processi erosivi più persistenti e graduali, dovuti al ciclo dell'acqua distribuito su tutto il pianeta. Goudge e colleghi hanno studiato le formazioni geologiche del paesaggio marziano nelle aree in cui l'acqua allo stato liquido scorreva probabilmente attraverso antiche valli fluviali, e si sono concentrati sulle valli collegate ad antichi bacini lacustri, con particolare attenzione ai canyon il cui fondo si trovava a una quota più elevata rispetto al fondo dei bacini lacustri a cui erano connessi, in base all'idea che proprio queste caratteristiche siano indice dell'erosione dovuta allo straripamento dei laghi. Considerando la forma e le dimensioni delle formazioni geologiche, gli scienziati hanno stimato i volumi che queste inondazioni hanno probabilmente scavato: si tratta di circa 57.000 chilometri cubi! Questa quantità equivale ad almeno il 24 % del volume totale delle valli su Marte, nonostante il fatto che i canyon scavati dalle inondazioni rappresentino solo il 3 % circa della lunghezza totale delle valli analizzate dai ricercatori. In altre parole, circa una quarto del volume dei canyon marziani è stato scavato nell'arco di giorni, mesi o anni, invece che nell'arco di centinaia o migliaia di anni, come avviene nel caso dell'erosione a lungo termine. Gli autori dello studio hanno concluso che questi eventi di inondazione non sono solo stati importanti per l'erosione delle valli in termini di puro contributo volumetrico, ma hanno anche successivamente influenzato l'evoluzione del più ampio paesaggio marziano, in particolare quello degli altopiani punteggiati di crateri. Tali eventi dovrebbero quindi essere tenuti in considerazione quando si studiano le proprietà delle valli fluviali marziane, e il modo in cui i fiumi hanno influenzato le caratteristiche del paesaggio marziano, utilizzando i sistemi geomorfologici ricavati da studi sulla Terra.
I supervulcani marziani
E non basta. Infatti risale ai primi del 2016 la scoperta che Marte fu sconvolto, 3,7 miliardi di anni fa (alle 21.20 del 6 marzo), da catastrofiche eruzioni vulcaniche, talmente potenti da modificarne l'asse di rotazione. La dobbiamo a Sylvain Bouley, dell'Università di Parigi-Sud, il quale ha ridisegnato la storia geologica del pianeta rosso in seguito alla nascita della regione di Tharsis, la grande area montuosa che comprende alcuni dei più grandi vulcani del Sistema Solare. Secondo Bouley tra i 4 e 3,5 miliardi di anni fa (tra le 13.20 del 10 febbraio e le 02.40 del 23 marzo) su Marte avvennero potenti eruzioni che portarono alla nascita di una vasta serie di vulcani localizzati in quella che viene chiamata regione di Tharsis. La catena montuosa ospita tre grandi vulcani, il più alto dei quali è il monte Ascraeus con ben 18 chilometri di altezza e un diametro di 400 chilometri. A 1200 chilometri di distanza da esso è presente anche la più alta vetta dell'intero Sistema Solare, il monte Olimpo, alto ben 27 chilometri! Dei giganti rispetto a quelli del nostro pianeta, dove il più grande è il Mauna Lao nelle Hawaii, con una struttura complessiva grande meno della metà di quelli marziani (ma la gravità terrestre è assai maggiore di quella marziana). Usando immagini satellitari, dati geologici e simulazioni al computer Bouley e colleghi sono riusciti a ricostruire la storia di questa regione, scoprendo che la nascita di queste montagne portò al cambiamento dell'asse di rotazione del pianeta. A testimoniarlo sono gli orientamenti di molte valli formatesi sul pianeta prima della nascita di questi vulcani e i segni lasciati dal ghiaccio che copriva le regioni polari originarie. Lo sbilanciamento dovuto alle grandi masse vulcaniche fece ruotare gradualmente l'asse di rotazione, spostando così le regioni polari.
« La mia nostra ipotesi è che Tharsis si sia formato rapidamente e precocemente, invece che in modo graduale, e che gli oceani siano nati in conseguenza di essa », ha aggiunto Michael Manga, geofisico dell’Università della California a Berkeley. Infatti è probabile che Tharsis abbia emesso in atmosfera un’enorme quantità di anidride carbonica. L’effetto serra che ne derivò produsse un riscaldamento globale di Marte, che creò le condizioni per la presenza di acqua liquida. Le stesse eruzioni vulcaniche crearono canali che permisero all’acqua sotterranea di raggiungere la superficie e riempire le pianure settentrionali del Pianeta Rosso. Questa proposta può spiegare anche l’irregolarità delle presunte linee di costa degli oceani marziani, con differenze di altezza nei diversi punti anche di un chilometro, una caratteristica geologica spesso utilizzata come argomentazione dai detrattori dell’ipotesi degli antichi oceani marziani, perché l’erosione determina tendenzialmente linee di costa più lisce, come si osserva sulla Terra. Secondo Manga, l’irregolarità può essere spiegata ipotizzando che un primo oceano marziano, chiamato Arabia, iniziò a formarsi circa quattro miliardi di anni fa, e continuò a esistere, per periodi intermittenti, per gran parte del primo 20 % del tempo necessario al sollevamento di Tharsis. Questo fenomeno produsse una depressione del terreno e deformò nel tempo la linea di costa, il che potrebbe spiegare le differenze di altezza della linea di costa di Arabia. Allo stesso modo, la linea di costa irregolare di un oceano successivo chiamato Deuteronilus potrebbe essere spiegata se si fosse formato nell’ultimo 17 % del periodo di crescita di Tharsis, circa 3,6 miliardi di anni fa (alla mezzanotte del 15 marzo). Le discussioni in merito sono tuttora in corso.
La tendenza della vita al suicidio
Se un tempo Marte ha ospitato la vita, come molti sospettano (anche se finora nessuno ne ha trovato le prove inconfutabili), è lecito domandarsi: che impatto hanno avuto queste forme di vita sul pianeta, e dove possiamo trovare le prove della sua esistenza passata? Ebbene, secondo alcuni una eventuale biosfera marziana potrebbe essere stata determinante proprio per trasformare il pianeta nell'attuale mondo inospitale che le sonde automatiche ci hanno mostrato. Le analisi suggeriscono che alcune regioni di Marte, come il cratere Jezero, dove è al lavoro il rover Perseverance della NASA, sono i luoghi migliori per la ricerca di segni di vita sul pianeta, e lasciano pensare che la vita potrebbe essere il peggior nemico di se stessa sui mondi di tutto il cosmo. Infatti, usando modelli climatici e geologi per ricreare l'aspetto di Marte come era quattro miliardi di anni fa, alcuni ricercatori francesi guidati da Boris Sauterey della Sorbona di Parigi, hanno concluso che un tempo i microbi potevano prosperare a pochi centimetri sotto gran parte della superficie del Pianeta Rosso, protetti dalle penetranti radiazioni cosmiche grazie al suolo sovrastante. Ma questa biosfera sepolta si sarebbe alla fine ritirata più in profondità nel pianeta, forse verso la sua fine, spinta da temperature gelide che essa stessa aveva creato.
Infatti gli ipotetici microbi marziani vissuti nella notte dei tempi avrebbero assorbito idrogeno e anidride carbonica dall'atmosfera marziana e, a loro volta, prodotto metano. Tutte queste sostanze possono agire come gas serra che catturano il calore, e dunque cambiamenti nell'abbondanza di ciascuna di esse possono avere effetti significativi sulla temperatura superficiale di un pianeta. In questo caso, la riduzione netta dei gas serra atmosferici da parte di quella presunta biosfera "metanogena" avrebbe innescato un raffreddamento globale che ha ricoperto di ghiaccio la maggior parte della superficie di Marte, contribuendo a creare l'attuale stato inospitale e sterile del pianeta. Anche sulla Terra qualcosa del genere è avvenuto molto spesso, assai prima che arrivasse l'uomo a devastare scientemente l'ecosistema in cui abita; ad esempio, durante il cosiddetto "Grande Evento di Ossidazione" (vedi sotto), occorso circa 2,4 miliardi di anni fa (il 20 giugno), i cianobatteri fotosintetici hanno saturato di ossigeno l'atmosfera terrestre, che fino a quel momento era quasi priva di questo gas altamente reattivo, e questo portò inevitabilmente all'annientamento dei precedenti padroni del pianeta, cioè i batteri metanogeni e altri organismi per i quali l'ossigeno era tossico. In pratica la vita, quando appare su un pianeta, potrebbe benissimo essere autodistruttiva, e proprio tale tendenza all'autodistruzione potrebbe limitare la capacità della vita di emergere ampiamente nell'universo, impedendo cioè di avere una galassia che letteralmente pullula di specie senzienti, come si vede nell'universo di "Star Trek" o in quello di "Star Wars"!
Tuttavia, c'è un'altra interessante conclusione che possiamo trarre da questa ipotesi a dir poco catastrofica: l'abbondanza di vita microbica della Terra primordiale e la conseguente flessibilità evolutiva nel riprendersi da cambiamenti ambientali altrimenti catastrofici potrebbero essere i motivi per cui l'elaborata biosfera terrestre è sopravvissuta fino ad oggi, mentre quella presumibilmente più semplice di Marte si è rapidamente estinta. Secondo Sauterey, l'ascesa verso una complessità sempre maggiore potrebbe aiutare una biosfera a evitare il destino disastroso occorso a quella marziana, Un'ultima domanda però resta aperta: per qualsiasi pianeta che ospiti la vita, l'evoluzione dell'intelligenza potrebbe essere la via di salvezza, perché grazie ad essa potrebbero emergere soluzioni tecnologiche atte a mitigare la tendenza della vita a rendere inabitabile il proprio pianeta natale, o gli esseri "intelligenti" (si fa per dire) come noi rappresenterebbero il colpo di grazia che accelererebbe il precipitare della vita verso la definitiva estinzione? Il dubbio rimane.
Quando l'asse di rotazione della Luna cambiò
Un gruppo di ricercatori del Planetary Science Institute a Tucson e del California Institute of Technology a Pasadena ha dimostrato che nell'Adeano l'asse della Luna si è spostato di circa 6 gradi: dunque la faccia del nostro satellite che vediamo oggi non è quella che mostrava alla Terra miliardi di anni fa. Lo studio di M. A. Siegler e colleghi è partito dall'osservazione che la distribuzione dei piccoli depositi di idrogeno (verosimilmente intrappolati sotto forma di ghiaccio d'acqua) che sono stati rilevati dagli strumenti a bordo delle sonde delle missioni Lunar Prospector e Lunar Reconnaissance Orbiter non è quella che ci si potrebbe aspettare. Da decenni è stato ipotizzato che sulla Luna possano essersi accumulati depositi di composti volatili come l'acqua, bloccati dal gelo che caratterizza alcuni suoi crateri polari, dove si possono toccare temperature inferiori a quelle di Plutone. Ciò perché l'asse di rotazione della Luna è quasi perpendicolare alla linea che collega la Luna e il Sole, i cui raggi non raggiungono mai il fondo di quei crateri. I depositi di ghiaccio scoperto non si trovano però ai poli, ma sono leggermente spostati, in una posizione in cui quell'accumulo oggi non può formarsi. Inoltre, questi depositi sono disposti in modo perfettamente simmetrico e sono congiunti da una linea che passa attraverso il centro del satellite. L'ipotesi degli scienziati è che questi accumuli di ghiaccio identifichino i poli Nord e Sud di qualche miliardo di anni fa, prima del cambiamento dell'orientamento dell'asse di rotazione. Il ghiaccio formatosi in quel lontano periodo sarebbe poi riuscito a sopravvivere, almeno in parte, nonostante l'attuale relativa esposizione a una certa quantità di luce solare.
Ma quale può essere stato il meccanismo che ha prodotto questa variazione dell'asse di rotazione? Secondo gli autori lo spostamento potrebbe essere stato innescato dallo sviluppo di un'anomalia termica all'interno della Luna, legata all'intenso vulcanismo che caratterizzò un tempo il Procellarum KREEP Terrane (PKT), nell'Oceano delle Tempeste, che è anche la zona più radioattiva di tutto il satellite. Radioattività e vulcanismo implicano però che un tempo questa regione doveva essere più calda, e quindi meno densa dei suoi dintorni. La variazione di densità in questa area potrebbe aver innescato il processo. I corpi celesti possono infatti cambiare il loro orientamento se cambia la distribuzione interna della massa: le regioni di materiale denso tendono a disporsi in prossimità dell'equatore così da ridurre al minimo l'energia di rotazione, mentre quelle meno dense si dispongono verso i poli.
Acqua e vento solare
Un gruppo di ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory e del Lawrence Berkeley National Laboratory ha scoperto che il vento solare induce la formazione di acqua nelle polveri interstellari. La scoperta potrebbe avere un risvolto significativo sulla probabile origine dell'acqua sul nostro e su altri pianeti: considerato infatti l'ingente flusso di polveri che raggiunge la Terra, fra le 30.000 e le 40.000 tonnellate all'anno, l'apporto dell'acqua "fabbricata" dal vento solare è paragonabile, e forse superiore, a quello delle comete. In particolare, gli ioni idrogeno di cui è costituita buona parte del vento solare, impattando sui minerali ricchi di ossigeno presenti nelle polveri interstellari, ne alterano la struttura, portando alla formazione di molecole di acqua. Queste molecole restano intrappolate appena al di sotto della superficie dei grani di polvere, su cui producono minuscole strutture da impatto dello spessore fino a 150 nanometri.
Fino ad ora, l'analisi di queste formazioni sulle conditi che hanno raggiunto la Terra, su polveri cosmiche e su campioni di minerali provenienti dalla Luna e dall'asteroide Itokawa non aveva permesso di rilevare segni di formazione di acqua, ma neppure di escluderla, dato che i livelli di acqua ipotizzabili in quei campioni erano comunque ai limiti delle capacità di rilevazione degli strumenti. Nel nuovo studio John P. Bradley e colleghi hanno prima osservato con un microscopio elettronico a scansione i campioni di polveri interstellari, per poi analizzarne la composizione con la spettroscopia di perdita di energia di elettroni di valenza (VEELS), una sofisticata tecnica spettroscopica che permette una accurata caratterizzazione delle specie chimiche presento nel campione e del loro stato di ossidazione. In questo modo i ricercatori sono riusciti a dimostrare la presenza di acqua, sia pure su scala nanometrica. Questi risultati sono stati poi confrontati con quelli ottenuti in laboratorio attraverso il bombardamento con flussi di ioni idrogeno ed elio di campioni di minerali di composizione analoga a quella di polveri e rocce provenienti dallo spazio.
Il fatto che le minuscole quantità di acqua nelle polveri cosmiche restino sigillate all'interno di "vescicole" minerali formatesi in corrispondenza dei punti colpiti dagli ioni idrogeno spiega perché l'acqua riesca ad arrivare a terra: nell'attraversare l'atmosfera queste polveri infatti non sviluppano un calore sufficiente a far disperdere il loro contenuto idrico.
L'acqua venuta dallo spazio
Ancor di più ha fatto rumore, nel 2014, la scoperta secondo cui l'acqua che si trova sulla Terra e in tutto il sistema solare sarebbe... più vecchia del Sole, e avrebbe avuto origine negli spazi interstellari! La notizia è stata diffusa da un gruppo di astrofisici, chimici e planetologi dell'Università del Michigan e dell'Università di Exeter, che hanno ricostruito la storia dei ghiacci del sistema solare. L'acqua è ampiamente presente nel sistema solare: nei minerali della Luna e di Marte, nei crateri della parte oscura di Mercurio e soprattutto nelle comete e nelle meteoriti, ma la sua origine è molto dibattuta. Secondo la teoria oggi più diffusa, il ghiaccio d'acqua di tutti questi corpi si sarebbe formato all'interno del disco protoplanetario di gas e polveri che circondava il Sole all'epoca della sua nascita. Conel M. O’D. Alexander, uno degli autori dello studio, è però di avviso contrario. « Se l'acqua nel sistema solare primigenio è stata in gran parte "ereditata" dal ghiaccio dello spazio interstellare », ha dichiarato, « è probabile che ghiacci simili, e la materia organica prebiotica che contengono, siano abbondanti in gran parte dei dischi protoplanetari delle stelle in formazione; se invece è il risultato di processi chimici avvenuti localmente durante la nascita del Sole, la presenza di acqua in altri sistemi solari potrebbe essere molto diversa, e inferiore, con ovvie implicazioni per la possibile nascita della vita altrove. »
Per ricostruire la storia del ghiaccio, i ricercatori si sono concentrati sul rapporto del suo contenuto in acqua e acqua pesante, quella molecola d'acqua nella quale al posto dell'idrogeno c'è il suo isotopo deuterio, il cui nucleo è costituito da un protone e un neutrone, invece che da un solo protone. Queste caratteristiche fanno sì che le condizioni in cui si possono formare i due tipi di acqua siano differenti. Alexander e colleghi hanno sviluppato sofisticati modelli per simulare i processi chimici che potevano avvenire all'interno del disco protoplanetario del sistema solare, e stabilire il valore del rapporto fra l'acqua e l'acqua pesante che poteva formarsi in quelle condizioni. Confrontando i risultati delle simulazioni con i livelli di acqua pesante presenti negli oceani della Terra, nelle comete e nei campioni di meteoriti arrivati fino a noi, gli scienziati hanno scoperto che sono troppo alti per aver avuto origine dal disco protoplanetario. Di conseguenza, una percentuale significativa dell'acqua (dal 30 al 50 % di quella degli oceani terrestri e dal 60 al 100 % di quella delle comete) deve essersi formata negli spazi interstellari. La scoperta suggerisce che l'acqua sia abbondante anche in altri sistemi solari, aumentando quindi le probabilità di sviluppo di forme viventi extraterrestri!
La teoria secondo cui l’acqua sarebbe arrivata sulla Terra relativamente tardi, trasportata da comete e asteroidi, è stata però messa in dubbio da più di un planetologo. A corroborare tali dubbi sono venuti i dati raccolti nel 2020 da un gruppo di ricercatori dell'Università della Lorena guidati da Laurette Piani, che raccontano un’altra storia: l'acqua sarebbe stata presente sul pianeta fin dalla sua formazione. I ricercatori hanno analizzato un tipo di molto raro di meteorite, la condrite enstatite, che costituisce appena il 2 % circa delle meteoriti raccolte sulla Terra. Nonostante questo, è particolarmente significativa per la sua composizione, poiché contiene isotopi di ossigeno, titanio e calcio molto simili a quelli della Terra, suggerendo che le condriti estatiti abbiano la stessa origine delle componenti fondamentali del nostro pianeta. Applicando una speciale procedura per evitare le contaminazioni di acqua terrestre, e grazie a due diverse tecniche di misurazione, la spettrometria di massa convenzionale e la spettrometria di massa ionica secondaria (SIMS), sono stati determinati con precisione il contenuto e la composizione delle piccole quantità di acqua nelle meteoriti. Piani e colleghi hanno così scoperto che essa contiene idrogeno sufficiente a fornire almeno tre volte la quantità di acqua contenuta negli oceani, e probabilmente molta di più! Insomma, « i costituenti fondamentali della Terra potrebbero aver contribuito in modo significativo all'acqua del pianeta », ha concluso Piani. « Il materiale contenente idrogeno era presente nel sistema solare interno, anche se le temperature erano troppo alte perché l'acqua si condensasse. » Inoltre, l'idrogeno di queste meteoriti ha la stessa composizione isotopica dell'acqua immagazzinata nel mantello terrestre, mentre la composizione isotopica degli oceani è coerente con una miscela contenente il 95 % di acqua proveniente dalle condriti enstatiti e solo il 5 % di acqua fornita dalle comete o dagli asteroidi ricchi di acqua. Infine, lo studio propone che anche una grande quantità di azoto atmosferico, la componente più abbondante dell'atmosfera terrestre, potrebbe provenire dalle condriti enstatiti.
L'acqua venuta dal Sole
Un gruppo di ricercatori guidato da Luke Daly dell'Università di Glasgow e Michelle Thompson della Purdue University nello stato dell'Indiana ha formulato invece un'altra ipotesi: per la sua acqua la Terra sarebbe debitrice, almeno in parte, al Sole. L'acqua delle meteoriti note come condriti carbonacee ha una composizione isotopica dell'idrogeno quasi corrispondente a quello terrestre: il rapporto tra il deuterio (H2) e il protio (H1) è circa uguale a quello dell'acqua terrestre. Tuttavia, la corrispondenza non è perfetta: in particolare, l'acqua nel mantello terrestre è un po' più leggera, contiene cioè meno deuterio. Alla ricerca di ulteriori prove, Daly, Thompson e colleghi hanno esaminato campioni dell'asteroide di tipo S Itokawa, prelevati dalla sonda giapponese Hayabusa e trasportati sulla Terra nel 2010. In questa analisi, i ricercatori hanno cercato di rispondere in particolare a questa domanda: è possibile che il vento solare stia modificando la superficie dell'asteroide, e quindi anche la riserva d'acqua della roccia?
In effetti, sembra essere proprio così, come mostra l'analisi dello strato superiore di 50 nanometri di spessore all'esterno delle briciole di polvere di Itokawa. In particolare, la polvere in quello strato è abbastanza umida: se l'intero asteroide avesse una composizione simile a quella, ogni metro cubo conterrebbe 20 litri di acqua, le cui molecole contengono protio, non deuterio. Quest'acqua si forma in un processo astrochimico nel corso del tempo, quando gli atomi di idrogeno del vento solare reagiscono con l'ossigeno della roccia silicatica per formare acqua. Tutto ciò è stato confermato anche dagli esperimenti nel laboratorio del gruppo, in cui, dopo aver bombardato le rocce con protoni, gli scienziati sono stati poi in grado di rilevare le molecole d'acqua. Insomma, ovunque la roccia silicatica sia esposta al vento solare, si formerà acqua: anche, per esempio, sulla Luna. In un futuro lontano, questo potrebbe rendere più facile rifornire gli astronauti di acqua sul nostro satellite o su altri corpi rocciosi. In questo scenario, l'acqua leggera formata in seguito al bombardamento da parte del vento solare si sarebbe mescolata con la miscela più pesante dovuta alle condriti carbonacee. L'acqua della Terra proviene quindi da diverse fonti, e il Sole ha almeno contribuito con il suo idrogeno.
Un dono del cielo?
Spesso chi sulla Terra trova metalli preziosi e rari come oro, platino, palladio, iridio e simili li definisce un "dono del cielo". Ebbene, quest'affermazione potrebbe essere più veritiera di quanto non si pensi, se ha ragione l'astrofisico tedesco Gerhard Schmidt, dell'Università Johannes Gutenberg di Mainz. Questi ha infatti ipotizzato nel settembre 2008 che essi ci sono arrivati dentro a veri e propri scrigni cosmici vaganti nello spazio extraterrestre: i meteoriti metallici, un tempo molto più abbondanti di oggi, al punto che durante il grande bombardamento tardivo la loro caduta sulla Terra era pressoché continua. L'originale ipotesi è stata avanzata dopo 12 anni di ricerche sperimentali, nel corso delle quali ha studiato centinaia di siti in cui sono caduti e sono stati recuperati meteoriti grandi e piccoli, effettuando analisi quantitative delle tracce dei metalli preziosi presenti. Il metodico professore tedesco ha effettuato poi analoghe analisi su campioni di rocce provenienti dal mantello terrestre, sui frammenti di rocce lunari portate dagli astronauti delle missioni Apollo nei primi anni '70, e su meteoriti di origine marziana.
Alla fine, Schmidt si è convinto che l'oro e gli altri metalli preziosi, chiamati anche « siderofili » per la loro affinità a combinarsi col ferro, non appartengono alla storia evolutiva della Terra, ma hanno un'« origine cosmochimica », nel senso che si sono formati in quel più vasto crogiolo naturale degli elementi che è rappresentato dallo spazio cosmico. Per rifornire la Terra delle quantità di metalli preziosi che oggi vi si riscontrano, secondo Schmidt sarebbero stati sufficienti circa 160 asteroidi metallici del diametro di 20 km ciascuno. Dopo la formazione della Terra, quando il nostro pianeta assunse la consistenza di un corpo sferico dotato di grande massa, la sua forza gravitazionale cominciò ad attrarre gli asteroidi e gli altri corpi minori che le passavano vicini, che erano assai più abbondanti rispetto a oggi, e fra i quali vi erano meteoriti di natura metallica; e così la Terra si arricchì dei metalli preziosi che poi migrarono nella crosta terrestre attraverso vari processi di concentrazione. (secondo alcune stime oggi nella crosta terrestre esistono ancora 50.000 tonnellate di oro da estrarre). Un'ipotesi senz'altro affascinante, se venisse confermata.
Il problema del sole debole
Nel 1972, gli scienziati americani Carl Sagan (1934-1996) e George Mullen formularono una celebre teoria oggi nota come "paradosso del debole sole primordiale" (FYSP, Faint Young Sun Paradox), secondo cui il clima della Terra è rimasto pressoché costante durante oltre tre dei 4,5 miliardi di anni di vita del pianeta, nonostante il fatto che la radiazione della nostra stella abbia subito un incremento del 25-30 %. In base a questo dato, durante il suo fragile periodo iniziale la superficie della Terra avrebbe dovuto essere del tutto ricoperta di ghiaccio, visto che i raggi del sole erano molto più deboli di quanto siano oggi, circostanza che invece dagli studi geologici non risulta di sicuro. Una risposta plausibile fu proposta nel 1993 dal fisico dell'atmosfera James Kasting (1953-vivente), della Pennsylvania State University, il quale propose che il 30 % dell'atmosfera terrestre di quattro miliardi di anni fa fosse costituita da CO2. Questa grande quantità di gas serra avrebbe costituito uno strato protettivo nei confronti del pianeta, prevenendo così il congelamento degli oceani.
Nel 2010 tuttavia Christian Bjerrum, del Dipartimento di Geografia e Geologia dell'Università di Copenhagen, e Minik Rosing, del Museo di Storia Naturale della Danimarca, insieme con alcuno colleghi della Stanford University in California, hanno annunciato di aver scoperto la vera ragione del "ghiaccio mancante", dopo aver analizzato campioni di rocce risalenti a 3,8 miliardi di anni fa (il 26 febbraio dell'Anno della Terra) provenienti da uno dei siti geologici più antichi del pianeta, quello di Isua in Groenlandia. « Ciò che impedì un'era glaciale in quei tempi remoti non fu l'alta concentrazione di CO2 in atmosfera, ma il fatto che lo strato di nubi era molto più sottile di quanto sia oggi », ha spiegato Rosing sulla rivista Nature. « Inoltre la superficie terrestre era ricoperta da acqua. Ciò significa che i raggi del Sole potevano scaldare gli oceani senza ostacoli, e che essi avrebbero poi restituito il calore gradualmente, impedendo alla superficie terrestre di ghiacciare ». La mancanza di nubi può essere spiegata con il processo grazie al quale esse si formano, il quale richiede la presenza di sostanze chimiche prodotte da alghe e piante, sostanze che a quel tempo non esistevano. Questi processi chimici sarebbero stati in grado di formare un denso strato di nubi, che a loro volta avrebbero riflesso nel cosmo i raggi del Sole, impedendo così il riscaldamento degli oceani della Terra. Se la teoria è vera, un altro dei grandi enigmi del lontano passato del nostro pianeta può così dirsi risolto.
L'enigma degli zirconi australiani
Prima di procedere con l'Archeano, è bene riferire di un'importante scoperta pubblicata da John W. Valley, docente di geologia presso l'Università del Wisconsin, che ha trascorso molti anni a studiare le formazioni rocciose più antiche dell'intero pianeta Terra: le rocce sedimentarie delle Jack Hills, in Australia Occidentale 800 Km a nord di Perth, la più isolata delle grandi città australiane. Queste rocce hanno la bellezza di 4,4 miliardi di anni di età (risalgono dunque addirittura al 9 gennaio dell'Anno della Terra!), e contengono minuscoli cristalli di zircone (ZrSiO4), facilmente databili perchè a volte gli atomi di uranio si sostituiscono nella struttura cristallina a quelli di altri elementi e, confrontando la percentuale di uranio e di piombo nella miscela naturale e negli zirconi, è possibile determinare la loro età con uno scarto massimo di 40 milioni di anni (per rocce così antiche è pochissimo).
Come
riferisce l'autore sul numero di dicembre 2005 di "Le
Scienze", edizione italiana di "Scientific American", questi
zirconi sono in grado di intrappolare il più antico ossigeno della Terra, ed
usando il rapporto tra i diversi isotopi dell'ossigeno si può stimare a quale
profondità nel mantello terrestre le rocce si sono formate, giacché esso
dipende dalla temperatura di formazione delle rocce. Il rapporto isotopico tra O16
ed O18 (quest'ultimo raro in natura) è ad esempio perfettamente
conosciuto per il mantello terrestre. Rapportando tale rapporto isotopico
all'acqua di mare (per cui si assume il valore zero), quello del mantello
terrestre è pari a 5,3. Dunque, se gli zirconi si
sono formati dentro rocce antichissime rifuse dentro il mantello terrestre in
seguito a subduzione, anche in
essi si dovrebbe registrare questo valore. Invece, stime accuratissime hanno
fornito il sorprendente valore di 7,4. Questo è
tipicamente il valore che si riscontra in rocce a bassa
temperatura, presenti sulla superficie della Terra, che reagiscono con la
pioggia o con l'acqua dell'oceano acquisendo un alto rapporto isotopico tra O16
ed O18. 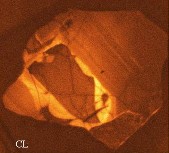 Dunque esso richiede la presenza sulla superficie terrestre
di acqua allo stato liquido e basse temperature; nessun altro processo
conosciuto è in grado di fare altrettanto. In pratica, questi zirconi
australiani verrebbero a dirci che, appena 100 milioni di
anni (una settimana dell'Anno della Terra)
dopo la formazione del nostro pianeta, su di esso esistevano già le condizioni
adatte all'instaurarsi del ciclo dell'acqua.
Tanto più che la maggior parte dei cristalli di zircone delle Jack Hills
presentano superfici arrotondate e prive di spigoli vivi, come se il vento le
avesse trascinate a lungo sulla superficie di un continente solido. Ad
avvalorare queste tesi contribuiscono le pubblicazioni di Mark Harrison,
professore di geochimica all'Ucla (University of California Los
Angeles), il quale ha stabilito che gli zirconi australiani si sono formati in una zona in cui il flusso di calore era di 75
milliWatt per metro quadro, di gran lunga inferiore a 200-300 milliWatt al metro quadro previsto per quel periodo geologico. L'unico ambiente possibile per la formazione di zirconi con un flusso di calore così basso è quello della zona di collisione tra
placche tettoniche, grazie anche a temperature di fusione inferiori dovute alla grande presenza di acqua nelle rocce.
Finora, come
si è detto, si era sempre creduto che l'Adeano (come il
suo stesso nome attesta) fosse un periodo assolutamente privo di crosta
terrestre allo stato solido e di acqua allo stato liquido; incredibilmente, i
minuscoli zirconi australiani (pochi decimi di millimetro di dimensione)
testimonierebbero un ambiente primordiale assai più temperato,
caratterizzato da vaste estensioni di acqua liquida (oceani o almeno mari) e rocce già solidificate, quindi un ambiente molto diverso da un pianeta infernale di vulcani, colate di lava e rocce
bollenti; ed in esso la vita potrebbe essere nata molto prima di quanto noi ci aspettiamo.
Incredibilmente, le pietruzze studiate dal professor Valley potrebbero essere i
resti fossili del più antico continente
della storia!
Dunque esso richiede la presenza sulla superficie terrestre
di acqua allo stato liquido e basse temperature; nessun altro processo
conosciuto è in grado di fare altrettanto. In pratica, questi zirconi
australiani verrebbero a dirci che, appena 100 milioni di
anni (una settimana dell'Anno della Terra)
dopo la formazione del nostro pianeta, su di esso esistevano già le condizioni
adatte all'instaurarsi del ciclo dell'acqua.
Tanto più che la maggior parte dei cristalli di zircone delle Jack Hills
presentano superfici arrotondate e prive di spigoli vivi, come se il vento le
avesse trascinate a lungo sulla superficie di un continente solido. Ad
avvalorare queste tesi contribuiscono le pubblicazioni di Mark Harrison,
professore di geochimica all'Ucla (University of California Los
Angeles), il quale ha stabilito che gli zirconi australiani si sono formati in una zona in cui il flusso di calore era di 75
milliWatt per metro quadro, di gran lunga inferiore a 200-300 milliWatt al metro quadro previsto per quel periodo geologico. L'unico ambiente possibile per la formazione di zirconi con un flusso di calore così basso è quello della zona di collisione tra
placche tettoniche, grazie anche a temperature di fusione inferiori dovute alla grande presenza di acqua nelle rocce.
Finora, come
si è detto, si era sempre creduto che l'Adeano (come il
suo stesso nome attesta) fosse un periodo assolutamente privo di crosta
terrestre allo stato solido e di acqua allo stato liquido; incredibilmente, i
minuscoli zirconi australiani (pochi decimi di millimetro di dimensione)
testimonierebbero un ambiente primordiale assai più temperato,
caratterizzato da vaste estensioni di acqua liquida (oceani o almeno mari) e rocce già solidificate, quindi un ambiente molto diverso da un pianeta infernale di vulcani, colate di lava e rocce
bollenti; ed in esso la vita potrebbe essere nata molto prima di quanto noi ci aspettiamo.
Incredibilmente, le pietruzze studiate dal professor Valley potrebbero essere i
resti fossili del più antico continente
della storia!
Naturalmente le domande che restano aperte sono tante. Com'è possibile che questi cristalli, pur avendo viaggiato per centinaia di chilometri sospinti dal vento, siano ancor oggi concentrati in una regione così ristretta? E come hanno evitato di essere seppelliti e fusi all'interno del mantello terrestre, prima che la crosta continentale fosse abbastanza stabile? Inoltre la parte interna dei cristalli di zircone sembra avere 4,3 miliardi di anni, mentre quella più esterna sembra averne 3,7 (risale cioè al 30 marzo dell'Anno della Terra). È normale che uno zircone diventi via via più giovane mano a mano che ci si sposta verso l'esterno, perchè questi cristalli crescono per accrezione, come le perle dentro un'ostrica. Ma il fatto che le età del centro e del bordo degli zirconi siano concentrate in questi due periodi topici sembra indicare la presenza di due eventi distinti nella loro storia, separati da un lungo intervallo di tempo e concentrati attorno a queste due date. Ma quali eventi? Negli zirconi più giovani questa differenza di età è solitamente dovuta a processi tettonici nei quali si ha la fusione della crosta continentale ed il "riciclaggio" degli zirconi in essa contenuti. Si sta lavorando per capire se anche gli zirconi delle Jack Hills hanno avuto un simile destino. Inoltre, le scoperte di zirconi analoghi a questi si sono moltiplicate in varie zone dell'Australia; si lavora sperando di trovare anche fuori dall'Australia degli zirconi più vecchi di 4 miliardi di anni.
All'inizio del 2014 lo stesso professor Valley ha rinvenuto in Australia uno zircone risalente a 4,374 miliardi anni fa (al primo mattino dell'11 gennaio): si tratta della prove definitiva del fatto che la crosta terrestre si è formata solo 100 milioni di anni dopo che il nostro pianeta è stato coinvolto nell'impatto di grandi proporzioni che ha dato origine alla Luna. Ne consegue che il sistema Terra-Luna avrebbe un'età compresa tra 4,5 e 4,4 miliardi di anni, mentre i primi oggetti di grandi dimensioni orbitanti intorno al Sole si sarebbero formati 4,567 miliardi danni fa, come testimoniano le meteoriti piombate sulla Terra.
Le teorie di John Valley potrebbero essere avvalorate da un ulteriore studio, condotto presso l'Università del Colorado a Boulder e pubblicato su Nature. Già si è detto che, nel corso dell' Adeano, il pianeta Terra fu interessato da un bombardamento meteoritico senza precedenti, che secondo tutti gli scienziati sarebbe sufficiente per estinguere ogni forma di vita dal pianeta, se si ripetesse oggi (grazie a Dio è impossibile). Le nuove ricerche però mostrano che il calore sviluppato dal grande bombardamento tardivo riuscì a fondere meno dal 25 % della crosta terrestre, e dunque, se fossero già comparsi, alcuni microrganismi avrebbero potuto sopravvivere negli habitat presenti al di sotto della superficie, protetti dalla distruzione venuta dal cielo.
Anzi, le condizioni prodotte dal bombardamento potrebbero aver favorito la vita di eventuali batteri termofili, cioè di microrganismi simili a quelli che si trovano ora nelle sorgenti idrotermali a temperature tra 80 e 110 gradi Celsius. « Questi risultati retrodatano il possibile inizio della vita sulla Terra a prima di 3,9 miliardi di anni fa », ha spiegato Oleg Abramov, uno degli autori della ricerca, « e suggeriscono che la vita possa aver avuto origine già 4,4 miliardi di anni fa, all'epoca della formazione degli oceani ». Un'altra ipotesi veramente accattivante: davvero quelle minuscole "capsule del tempo" fatte di zircone potrebbero rivoluzionare la geologia e la paleontologia del ventunesimo secolo.
|
|
| Le inclusioni di grafite in un cristallo di zircone di 4,1 miliardi di anni fa (Fonte: Ucla) |
L'eone monotono
Una piatta distesa d'acqua che si estendeva a perdita d'occhio, interrotta qua e là da piccole e sporadiche isole: era questo il paesaggio della Terra nell'Adeano secondo la ricostruzione di Antony D. Burnham e A.J. Berry dell’Australian National University, che hanno analizzato le rocce più antiche del pianeta, cioè i granuli di zircone trovati nella formazione delle Jack Hills, in Australia, che risalgono a circa 4,4 miliardi di anni fa (alle 3 del mattino del 9 gennaio). Nonostante gli studi approfonditi su questi granuli, in precedenza non si era mai riusciti a stabilirne l’origine geochimica, e più precisamente se avessero origine dalla rifusione di rocce ignee, derivate dal magma primordiale, oppure da rocce sedimentarie. Questa distinzione ha una conseguenza diretta su come doveva essere il paesaggio dell'epoca: un’origine sedimentaria presuppone infatti che ci siano delle montagne da cui piogge o fiumi possano dilavare particelle di roccia. E ancor prima, presuppone l'esistenza di fenomeni tettonici che abbiano formato quelle montagne.
Per risolvere il problema, nel 2017 Burnham e Berry hanno analizzato le variazioni degli elementi in traccia negli zirconi delle Jack Hills, che, come era emerso da studi precedenti sui graniti, hanno una composizione differente e caratteristica a seconda della loro origine. Si è così scoperto che quei granuli recano la "firma" della fusione di rocce ignee più antiche e non di rocce sedimentarie. La fusione del sedimento è caratteristica delle più imponenti collisioni continentali, come quelle che hanno originato le Alpi e l'Himalaya. Ma a quanto pare eventi simili non sono avvenuti durante queste prime fasi della storia della Terra. Durante i suoi primi 700 milioni di anni di esistenza, la Terra era un posto molto più tranquillo e noioso di quanto non appaia oggi. Ma le discussioni su questo punto continuano tuttora in modo molto animato.
Forme di vita nell'Adeano?
Vi è chi dice che la vita sulla Terra potrebbe essere stata presente già 4,1 miliardi di anni fa (alle 10.40 del 2 febbraio), spostando indietro il limite di 300 milioni di anni rispetto a quanto finora ritenuto (cioè di 24 giorni dell'Anno della Terra). È il risultato dello studio sulle inclusioni di grafite in un cristallo di zircone rinvenuto nelle Jack Hills, in Australia occidentale, e datato con il sistema del decadimento radioattivo uranio-piombo da una squadra di ricerche guidata da Mark Harrison ed Elizabeth Bell dell’Università della California a Los Angeles.
Dopo la scoperta dei suddetti cristalli di zircone databili a oltre 4 miliardi di anni fa, derivati da antiche rocce vulcaniche smantellate dall’erosione e poi inglobali in sedimenti più recenti, a Elizabeth Bell è venuto in mente di cercare nelle remote colline dell’Australia occidentale zirconi contenenti inclusioni che potessero essere accostate alla presenza di tracce di vita. Ne sono stati raccolti circa 10 mila, molti dei quali di grandezza microscopica. Di questi ne sono stati identificati 656 con inclusioni più scure promettenti, e 79 sono stati sottoposti ad analisi sofisticate con la spettroscopia Raman, una tecnica che consente di evidenziare in tre dimensioni la struttura chimica e molecolare di antichi microrganismi. Uno di questi 79 conteneva grafite (carbonio puro, come il diamante ma con una diversa struttura cristallina). « Non esistono valide spiegazioni alternative non biologiche per la presenza di grafite in uno zircone di quella età », ha affermato Harrison. La grafite, quindi, poiché è inclusa nello zircone, sarebbe anche più antica di 4,1 miliardi di anni, e possiede un rapporto tra due isotopi di carbonio (12C e 13C) caratteristico delle forme di vita.
Una conferma che le prime forme di vita sulla Terra risalgono a circa 4 miliardi di anni fa (alle 13.20 del 10 febbtaio) è venuta dall’analisi isotopica di alcuni microgranuli di grafite presenti in una delle più antiche formazioni rocciose del pianeta, la formazione di Saglek Block, nel Labrador settentrionale. Tsuyoshi Komiya e colleghi dell'Università di Tokyo, studiando le più antiche rocce della formazione di Saglek Block, si sono imbattuti in microgranuli di grafite, un materiale di possibile origine biologica che finora non era mai stato rilevato nelle altre formazioni coeve. L’analisi della composizione isotopica dei microgranuli e della loro concentrazione ha indicato che hanno effettivamente un’origine biogenica, e le successive analisi delle rocce in cui erano contenuti e di quelle circostanti hanno confermato che non sono il prodotto di contaminazioni successive.
Questa scoperta, se confermata, avrà importantissime implicazioni sull’origine della vita sul nostro pianeta. La vita sulla Terra infatti sarebbe apparsa già molto presto, appena 450 milioni di anni dopo la formazione del pianeta (36 giorni dell'Anno della Terra), facendo ipotizzare che iniziò appena ci furono le condizioni favorevoli. Sarebbe inoltre una conferma che la Terra 4 miliardi di anni fa non era una sorta di « inferno » di magma ribollente, arida e con alte temperature dell’atmosfera, come per molto tempo ritenuto, ma già si erano formati gli oceani e piccole porzioni di terre emerse. Inoltre la vita era presente prima del Grande Bombardamento Tardivo, il quale sconvolse la crosta terrestre a tal punto che oggi è rarissimo trovare rocce più vecchie di 3,8 miliardi di anni (prima quindi del 26 febbraio). Evidentemente l'Adeano ci riserva ancora molte sorprese.
![]()
Al periodo Archeano ("antico") risalgono le formazioni rocciose più antiche oggi superstiti sulla Terra, e proprio la scarsità di testimonianze rende incerta la nostra conoscenza di questo periodo, il quale copre l'arco di tempo che va da 3,8 miliardi a 1,6 miliardi di anni fa; in termini di Anno della Terra, esso è cominciato il 26 febbraio ed è terminato il mattino del 24 agosto. Sei mesi, dunque: la metà del nostro Anno della Terra. Con molta fantasia, esso è stato diviso in Eoarcheano, Paleoarcheano, Mesoarcheano e Neoarcheano; un tempo invece era suddiviso in Ontariano ed Huroniano. Molto discussa è l'ulteriore suddivisione di questi in sottoperiodi.
I cratoni e i protocontinenti
Al principio di quest'epoca il nostro pianeta aveva già una crosta solida, in cui si distinguevano ampie aree depresse, coperte dagli oceani, e alcuni settori emersi, in cui lo spessore della crosta era andato aumentando per il formarsi e accumularsi di rocce simili al granito. Oltre che in Australia e in Groenlandia, dove affiorano le più antiche testimonianza di quelle lontane fasi di evoluzione della Terra, rocce di età compresa tra i 3,4 e i 3 miliardi di anni, di origine sedimentaria, sono state trovate in Sudafrica, e rocce analoghe per natura ed età sono state riconosciute anche in Africa, in Siberia e nel Sudamerica. Si tratta delle aree note come scudi o cratoni, che comprendono i frammenti più antichi dei continenti attuali, di difficile interpretazione perché consistono di complesse successioni di rocce metamorfiche che sono state in molti casi intruse da grandi corpi ignei nel rincorrersi delle ere geologiche. Ecco come sono distribuiti sulla superficie della Terra:
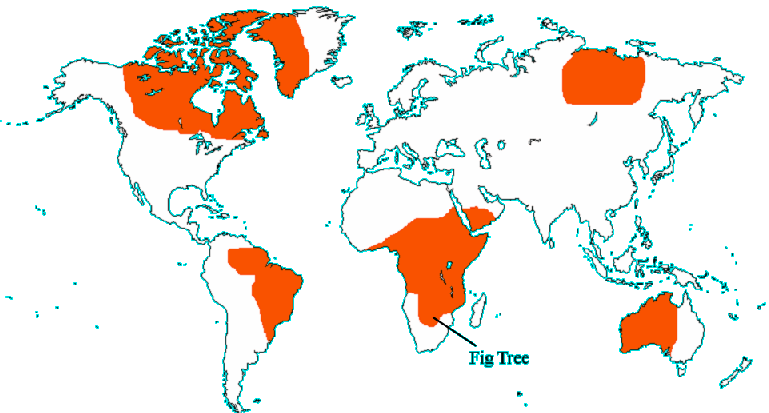
Durante l'Archeano sono stati ritrovati i resti delle primissime orogenesi, che hanno formato imponenti catene montuose, da tempo totalmente spianate dall'erosione; rimangono solo le rocce dei loro nuclei, profondamente metamorfosate. Si sono riconosciute rocce di origine desertica ed estesi depositi morenici distribuiti in molti punti del globo, testimonianze di profondi mutamenti climatici su scala mondiale, analoghi a quelli messi in luce, con molti più dettagli, per età più recenti. In alcuni scudi, tra le rocce di antiche orogenesi, compaiono le ofioliti o rocce verdi, cioè resti di crosta oceanica: questo significa che già da allora i bacini oceanici si aprivano e si richiudevano, mentre i continenti si allontanavano o si avvicinavano, come accade tuttora in seguito alla deriva dei continenti, e come si è detto nell'approfondimento a parte. Tra le prime orogenesi va annoverato il cosiddetto corrugamento Huroniano, che ebbe luogo tra 2700 e 1800 milioni di anni fa (dal 27 maggio all'8 agosto); ormai è quasi completamente cancellato dall'erosione degli agenti atmosferici, ma ancora oggi è responsabile dell'esistenza dello scudo canadese e delle colline australiane.
Quando le placche tettoniche hanno cominciato a svegliarsi e a spostarsi, dando vita alla deriva dei continenti, è ancora oggetto di dibattito. Nicolas Greber, geologo dell'Università di Chicago, h analizzato 78 strati di sedimenti differenti per individuare il rapporto fra rocce felsiche e rocce mafiche. Le rocce felsiche si formano quando quelle mafiche sono spinte in profondità all'interno della Terra, cioè quando una placca tettonica scivola sotto un'altra nel processo chiamato subduzione. Greber in particolare ha sfruttato il titanio: anche se questo elemento metallico è presente in entrambi i tipi di roccia, la percentuale dei suoi isotopi varia quando la roccia cambia da mafica a felsica. Greber si aspettava che i primi sedimenti dei suoi campioni, che risalgono a 3,5 miliardi di anni fa (alle 02.40 del 23 marzo), sarebbero stati composti principalmente da particelle mafiche. Invece, con sua sorpresa, circa la metà delle particelle contenute all'interno erano felsiche. Supponendo che queste rocce si siano formate in zone di subduzione, questo significa che a quell'epoca le placche tettoniche erano già in movimento in quell'era così remota. Invece Paul Tackley, geofisico dell'ETH di Zurigo, sostiene che le rocce felsiche possono formare in qualsiasi momento rocce mafiche nelle profondità della Terra, e non solo lungo le zone di subduzione: questo processo può avvenire anche su una placca immobile. Se per esempio un vulcano erutta, la lava appena emersa spingerà verso il basso le rocce mafiche finché queste non saranno sepolte così in profondità da fondersi per effetto delle elevate pressioni e temperature sotterranee, trasformandosi in rocce felsiche. Greber però ribatte che un elevato tasso di rocce felsiche non può essere spiegato dal solo modello di Tackley. Ad esempio in Islanda. un'isola lontana da qualsiasi zona di subduzione, semplicemente non si forma un numero elevato di rocce felsiche, ed è per questo che il paesaggio islandese è dominato dai campi di lava nera che hanno spinto molti registi di Hollywood ad usarle come set per film di fantascienza ambientati su pianeti brulli e senza vita. Greber sostiene che gli alti tassi di rocce felsiche scoperte nei suoi sedimenti possono solo significare che la tettonica a placche è cominciata presto nella storia del nostro pianeta. Il dibattito è tuttora aperto.
Una cosa però è certa: al principio dell'Archeano risalgono i primissimi indizi dell'esistenza di continenti emersi. Si pensa che il più antico in assoluto sia il continente di Vaalbara, il cui nome deriverebbe da quelli della regione sudafricana del Kaapvaal e dell'area di Pilbara (Australia Occidentale), in cui si trovano ancora racchiuse come reliquie le loro antichissime rocce: Vaalbara sarebbe già esistito circa 3,3 miliardi di anni fa (l'8 aprile dell'Anno della Terra). Poco dopo di esso è attestata la formazione del continente di Ur, il cui nome nulla ha a che fare con la biblica patria di Abramo, ma deriva dal tedesco Urkontinent ("continente ancestrale"), e che sarebbe emerso circa 3 miliardi di anni fa (il 2 maggio). Ma come essi si sono formati esattamente? Un'ipotesi è che essi siano nati per accrezione, cioè per sovrapposizione successiva delle cosiddette "Cinture di Greenstone" (Greenstone Belt), che a partire dagli anni settanta sono state interpretale dalla maggior parte dei geologi come antichissimi archi di isole vulcaniche formatisi lungo i margini delle placche tettoniche in collisione, e successivamente diventati parte degli attuali continenti. Infatti, quando un oceano si chiude, la crosta oceanica più pesante si immerge nel mantello scivolando sotto la crosta oceanica, e formando profonde fosse di subduzione: è ciò che accade alla Placca di Nazca, che sta scivolando sotto la Placca Sudamericana dando vita all'imponente sistema montuoso delle Ande: questo scontro ha tra l'altro provocato il catastrofico terremoto di 8,8 gradi Richter che il 27 febbraio 2010 ha colpito il Cile. La fusione della crosta basaltica scivolata in profondità provoca la riemersione di magma, che dà vita a grandi archi vulcanici lungo il margine di una fossa oceanica: in questo modo si sono formate le isole giapponesi, parallele alla profonda fossa del Giappone siccome il fondo del Pacifico sta scivolando sotto la placca asiatica. Quando l'oceano si chiude, le isole così formate non vengono trascinate nel mantello insieme al resto delta crosta, ma vanno a scontrarsi contro la placca continentale già esistente e si uniscono ad essa. Questo è il caso del cosiddetto "continente di Avalonia", un arco insulare esistente nel Paleozoico nell'Oceano Giapeto, il precursore dell'attuale Oceano Atlantico; quando esso si chiuse dando vita al supercontinente Pangea, Avalonia venne schiacciato contro Nordamerica ed Europa, ed oggi le sue rocce costituiscono parte del New England, dell'isola di Terranova, dell'Irlanda, l'Inghilterra ed il Galles, il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania settentrionale e la Polonia nordoccidentale (come si vede, dopo l'apertura dell'Oceano Atlantico parte di Avalonia restò su una delle sue sponde e parte sull'altra).
Secondo alcuni però questo modello di crescita continentale non spiega tutte le caratteristiche geologiche osservate nelle formazioni sudafricane e australiane che sarebbero appartenute ai continenti di Vaalbara e di Ur. Infatti Andrew Y. Glikson, dell'Australian National University di Canberra, ha scoperto che i segmenti più antichi delle Greenstone Belt di queste aree, di età compresa tra i 3,5 e i 3 miliardi di anni, sembravano accumulati verticalmente, come se strati di materiale eroso si fossero depositati a più riprese tra masse di magma granitico deformate dalle forze provenienti dal mantello, e non orizzontalmente, come dovrebbero presentarsi le formazioni geologiche che presentano i segni tipici delta subduzione. Come spiegare tutto ciò?
I continenti ebbero un'origine violenta?
Nel 1986, durante una spedizione sulle Barberton Mountains, in Sudafrica, i geologi statunitensi Donald R. Lowe, della Stanford University, e Gary R. Byerly, della Louisiana State University, scoprirono uno strato sottile di antichi sedimenti marini contenente migliaia di microscopiche sfere cave, fatte di un materiale simile al vetro. Esse potevano avere una sola origine: l'impatto con la Terra di un asteroide colossale, avvenuto 3,4 miliardi di anni fa. L'incredibile calore dell'impatto non solo fuse, ma addirittura vaporizzò la roccia, che fu dispersa dal vento su tutto il globo. Raffreddandosi repentinamente, il vapore di roccia solidificò così rapidamente da dar vita a forme prive di struttura cristallina, della consistenza appunto del vetro e dalla forma di piccole gocce: esse sono chiamate sferule da impatto o tectiti. In seguito Bruce M. Simonson dell'Oberlin College (Ohio) scoprì dei depositi di sferule a Pilbara e li mise in relazione con quelli trovati da Lowe e Byerly, dato che la catastrofe le dovette distribuire su tutto il pianeta, ma queste risalivano a 2,5 miliardi di anni. Ciò significava che la Terra era stata colpita da enormi sassi di origine spaziale (oggi sappiamo che gli impatti dovettero essere almeno nove) durante tutto il corso dell'Archeano. In base alla composizione delle tectiti, ricche di magnesio e di ferro, Lowe e Byerly dedussero che molto probabilmente gli asteroidi erano decisamente grandi, tra 20 e 50 chilometri di diametro, e colpirono la roccia densa di un bacino oceanico, assai lontano dalle aree dove poi le sferule si depositarono. I segni di maremoti planetari che accompagnano ogni deposito di sferule hanno rafforzalo l'ipotesi secondo cui gli impatti avvennero in mare, e non sulla terraferma.
Ora, Andrew Glikson
si e convinto che alcuni impatti con oggetti extraterrestri abbiano
addirittura contribuito alla formazione dei primissimi
continenti, a partire da quelli i cui resti sono conservati come reliquie
dentro le rocce del Sudafrica e 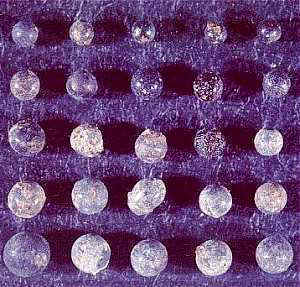 dell'Australia Occidentale. Egli infatti ha notalo che l'epoca di
questi impatti coincide con la formazione nelle rocce del Pilbara di un gran numero di massi spigolosi, con blocchi larghi fino a 250
metri: essi sarebbero il risultato del sollevamento e del successivo collasso delta superficie terrestre
in seguito all'impatto con un grande asteroide. Le dimensioni stimate di quest'ultimo hanno
suggerito a Glikson un possibile ruolo degli asteroidi archeanici nella formazione dei
protocontinenti, visto che l'epoca di questi impatti coinciderebbe proprio con l'emersione di
queste aree al di sopra del livello del mare. Inoltre le rocce formatesi prima degli impatti consistono in spessi strati di crosta oceanica e in sedimenti che normalmente si formano sul fondo
marino, mentre durante il periodo degli impatti questi strati basaltici sono deformati, sollevati ed erosi: il tipo di
trasformazioni che si possono associare facilmente all'impatto con un oggetto
extraterrestre. Tutte le rocce formatesi successivamente agli impatti, invece,
risultano composte dai resti erosi di rocce che si potevano formare soltanto sulla
terraferma. Questo cambiamento fa pensare che, poco dopo gli impatti, grandi forze dall'interno del mantello abbiano
sollevato la crosta al di sopra della superficie del mare, formando graniti e altri tipi di
crosta continentale che poi sono stati erosi.
dell'Australia Occidentale. Egli infatti ha notalo che l'epoca di
questi impatti coincide con la formazione nelle rocce del Pilbara di un gran numero di massi spigolosi, con blocchi larghi fino a 250
metri: essi sarebbero il risultato del sollevamento e del successivo collasso delta superficie terrestre
in seguito all'impatto con un grande asteroide. Le dimensioni stimate di quest'ultimo hanno
suggerito a Glikson un possibile ruolo degli asteroidi archeanici nella formazione dei
protocontinenti, visto che l'epoca di questi impatti coinciderebbe proprio con l'emersione di
queste aree al di sopra del livello del mare. Inoltre le rocce formatesi prima degli impatti consistono in spessi strati di crosta oceanica e in sedimenti che normalmente si formano sul fondo
marino, mentre durante il periodo degli impatti questi strati basaltici sono deformati, sollevati ed erosi: il tipo di
trasformazioni che si possono associare facilmente all'impatto con un oggetto
extraterrestre. Tutte le rocce formatesi successivamente agli impatti, invece,
risultano composte dai resti erosi di rocce che si potevano formare soltanto sulla
terraferma. Questo cambiamento fa pensare che, poco dopo gli impatti, grandi forze dall'interno del mantello abbiano
sollevato la crosta al di sopra della superficie del mare, formando graniti e altri tipi di
crosta continentale che poi sono stati erosi.
Ma non basta: Glikson ha suggerito che potrebbero essere stati proprio gli asteroidi a causare quei sollevamenti. Egli ha infatti analizzato le grandi intrusioni di magmi granitici risalenti a circa 3,2 miliardi di anni fa, presenti sia nel Pilbara che nelle Barberton Mountains. La vicinanza temporale degli impatti e della formazione del magma secondo lui non sarebbe una coincidenza: sarebbe stata la forza distruttiva di impatti ad alterare i movimenti convettivi del mantello, dando origine a nuovi pennacchi caldi di magma che riscaldarono e modificarono la crosta, come testimoniano le intrusioni di magmi granitici. La plausibilità dell'ipotesi dipende sostanzialmente dalle dimensioni degli asteroidi considerate. Se confrontato con le dimensioni della Terra, un asteroide delle stesse dimensioni di quello che si pensa abbia causato l'estinzione dei dinosauri (10 o 15 Km di diametro) sarebbe stato « poco più che un moscerino sul parabrezza », come ha commentato Simonson. Dimensioni doppie però potevano produrre effetti più devastanti, e secondo Jay Melosh, geofisico della Purdue University, un asteroide di almeno 50 chilometri di diametro poteva effettivamente alterare i flussi di calore interni alla Terra. Basandosi su simulazioni al computer, Melosh è riuscito a descrivere le conseguenze sulla geologia terrestre di un bolide del genere: esso si sarebbe schiantato su un bacino oceanico a circa 20 chilometri al secondo, generando non un cratere, ma genera un enorme mare di roccia fusa ampio almeno 500 chilometri. Se un simile lago di magma si fosse formalo in corrispondenza di un pennacchio, il suo intenso calore avrebbe soffocalo il pennacchio stesso, deviandolo verso le regioni circostanti: sotto la densa crosta oceanica, dove avrebbe generalo nuove isole che poi sarebbero migrate verso una zona di subduzione, contribuendo all'accrescimento di un continente, oppure sotto un protocontinente esistente di roccia poco densa, dove il suo calore sarebbe stato sufficiente a produrre nuove emissioni di magma granitico, simili a quelle rinvenute in Australia e Sudafrica, aumentando lo spessore del continente.
Lo stesso Melosh però ha avvertito che uno scenario del genere sarebbe assai difficile da dimostrare: è praticamente impossibile provare che un asteroide abbia devialo i pennacchi nel mantello, generando gli embrioni degli attuali continenti, visto che ormai i crateri lasciati dagli asteroidi dell'Archeano sono stati cancellati dall'erosione da lunghissimo tempo. Inoltre, se anche il granito delle Barberton Mountains fosse effettivamente stato prodotto da un pennacchio, è possibile che esso fosse già attivo assai prima dell'impatto. In definitiva, quella di Glikson è « un'ipotesi mollo probabile su ciò che potrebbe essere accaduto, ma è solo una delle possibili interpretazioni », ha affermato Donald Lowe. Senza dubbio comunque alcuni impatti hanno interrotto la dinamica interna della Terra, e la loro violenza potrebbe non essere stata esclusivamente distruttiva.
Il continente di Mauritia
Nel 2016 un gruppo di ricercatori dell'Università del Witwatersrand, a Johannesburg, in Sud Africa, ha analizzato numerosi cristalli di zircone trovati sulle spiagge dell'isola di Mauritius (Oceano Indiano), che sono risultati risalenti a un periodo compreso fra 3 e 2,5 miliardi di anni fa (tra le 16 del 2 maggio e le 5 del mattino del 12 giugno). Secondo loro sotto l'isola c'è un frammento della crosta di un antichissimo continente chiamato Mauritia, che un tempo era compreso tra India e Madagascar. Esso si estenderebbe per 4000-4500 chilometri quadrati, con uno spessore medio di 33 chilometri. L'ipotesi dell'esistenza di questo antico continente era nata anni fa in seguito alla rilevazione di anomalie gravimetriche nell'area dell'Oceano Indiano attorno a Mauritius, che deponevano a favore della presenza sul fondo di uno strato di crosta più spesso e denso di quello tipico della crosta oceanica. Il sospetto è stato poi accentuato dal ritrovamento, avvenuto nel 2013 sempre a Mauritius, di cristalli di zircone, le cui condizioni di formazione sono differenti da quelle presenti nelle giovani lave provenienti dalla crosta oceanica che hanno portato alla formazione dell'isola. Inoltre quei cristalli erano databili fra i 2 miliardi e i 660 milioni di anni fa (tra le 18.30 del 22 luglio e le 11.10 dell'8 novembre). Pur molto significativo, il ritrovamento non era stato però ritenuto una prova decisiva dell'antica esistenza di Mauritia.
L'analisi dei nuovi e ancor più antichi reperti cambia la situazione: la loro struttura è infatti risultata pressoché identica a quella di cristalli di zircone presenti nel Madagascar centro-orientale. Questa scoperta ha permesso ai ricercatori di tracciare la storia di Mauritia. Le rocce del continente scomparso si devono essere formate già nell'Archeano per poi confluire nel corso di centinaia di milioni di anni, e superando indenni molte traversie geologiche, nel supercontinente Rodinia. Quando questo antico supercontinente iniziò a frantumarsi, una parte di esso, comprendente le masse continentali che oggi costituiscono il Madagascar e l'India, si separò, dando origine a Mauritia. Successivamente, in seguito a numerosi eventi tettonici e vulcanici, circa 85 milioni di anni fa (alle 02.32 del 25 dicembre), l'India iniziò a separarsi dal Madagascar, mentre il resto del continente finì per essere sommerso dalle acque. La leggenda di Lemuria che si fa realtà?
L'atmosfera della Luna
Debra Needham e David Kring del Center for Lunar Science and Exploration, Lunar and Planetary Institute di Houston, in Texas, si sono basati su alcune stime degli strati di roccia della superficie lunare e dei campioni di vetro vulcanico raccolti sulla Luna dagli astronauti durante le missioni Apollo della NASA degli anni settanta per stabilire che il nostro satellite possedeva anticamente un’atmosfera molto rarefatta: si formò circa 3,5 miliardi di anni fa (alle tre di notte del 23 marzo) in seguito a massicce eruzioni vulcaniche, che rilasciarono ingenti quantità di gas. Durò circa 70 milioni di anni (quasi sei giorni dell'Anno della Terra), per poi lasciare il posto all'attuale esosfera, un insieme di particelle volatili talmente rarefatto da non comportarsi nemmeno come un gas. Viene così confermata la teoria emersa in anni recenti secondo cui l’oceano di magma che ricopriva la superficie della Luna appena formata avrebbe potuto produrre vapori di sodio e silice, che si sarebbero accumulati formando una vera e propria atmosfera.
Needham e Kring hanno verificato questa teoria studiando gli strati di roccia basaltica che sulla superficie della Luna formano le ampie pianure di colore scuro chiamate mari. In primo luogo, hanno stimato il volume di questi strati basaltici. Sono note infatti sia la loro estensione superficiale sia la loro profondità, stimata in sette chilometri circa, grazie alle recenti misurazioni del Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) e del Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL). Sulla base di queste stime dei volumi basaltici, i due ricercatori hanno calcolato i volumi di lava eruttata, pari a 5,3 milioni di chilometri cubi. Da questi hanno potuto calcolare anche la quantità di gas rilasciato, 10.000 miliardi di tonnellate, quanto basta per produrre una tenue atmosfera caratterizzata da una pressione pari all’1 % di quella dell’atmosfera attuale sulla Terra. I due ricercatori hanno poi analizzato i campioni di vetro vulcanico delle missioni Apollo, riscontrando la presenza di sostanze volatili come acqua, monossido di carbonio, zolfo, fluoro e cloro, confermando l'ipotesi di un'atmosfera ben più consistente di quella attuale.
Se ci fossero state differenze di temperature sulla superficie lunare, potrebbe esserci stato del vento, e con una quantità di polveri sufficienti, si possono immaginare delle dune. Ma, nell’arco di 70 milioni di anni il gas atmosferico è sfuggito o si è condensato in forma di brina sui poli lunari, e di quelle formazioni non è sopravvissuto nulla. Un'altra ipotesi è che il processo di accumulo di questa atmosfera potrebbe essere stato responsabile della diffusione dell'acqua e di altre sostanze volatili su tutta la superficie della Luna. E potrebbe spiegare anche perché l'interno del satellite si sia impoverito di queste sostanze.
Un tempo Venere era abitabile
E Venere? Poiché Venere è circa 41.000 mila chilometri più vicino al Sole della Terra, riceve il doppio della luce solare. Ma tre miliardi di anni fa un Sole un po' più debole avrebbe permesso a Venere di essere relativamente freddo e di ospitare acqua liquida in vasti oceani in grado di accogliere la vita, mantenendola tale molto a lungo. Lo suggeriscono Michael Way, del Goddard Institute for Space Studies della NASA, e colleghi, che hanno applicato il primo modello climatico tridimensionale (le stesse simulazioni al computer utilizzate per prevedere i cambiamenti climatici causati dall'uomo sulla Terra) alle condizioni primordiali di Venere. Quell'epoca così remota ha richiesto ai ricercatori di fare alcune ipotesi plausibili sulle fasi primordiali del pianeta: per esempio, postulare che avesse un oceano profondo solo il 10 per cento del volume della Terra attuale. E i risultati sono stati chiari: 2,9 miliardi anni fa (alle 18.40 del 10 maggio) il secondo pianeta a partire dal Sole avrebbe potuto avere una temperatura mite, simile a quella terrestre, intorno a 11 gradi Celsius.
Il gruppo di ricercatori ha poi fatto girare il modello per le condizioni presenti su Venere circa 715 milioni anni fa (alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre), e ha scoperto che anche sotto il calore aumentato del Sole il pianeta si sarebbe riscaldato di soli 4 gradi Celsius rispetto all'epoca precedente. Un aumento così lieve della temperatura avrebbe permesso all'oceano liquido del pianeta di permanere per miliardi di anni. Che cosa ha permesso a Venere di rimanere umido per così tanto tempo? Secondo i modelli, le nuvole hanno giocato un ruolo cruciale. Probabilmente sono rimaste ammassate sul lato diurno del pianeta, agendo come uno scudo luminoso in grado di riflettere la luce solare in arrivo, e non si sono mai formate sul lato notturno, lasciando che il calore irradiasse nello spazio. Queste condizioni di freddo, tuttavia, dipendono dal fatto che Venere nella sua giovinezza era simile a com'è attualmente: anche se i ricercatori hanno aggiunto un oceano, il pianeta ha mantenuto intatta la sua topografia e continua a muoversi lentamente, impiegando 243 giorni terrestri per completare una singola rotazione.
Poiché le risposte sono piuttosto incerte, il gruppo di ricerca ha modellizzato anche come doveva essere il clima di Venere 2,9 miliardi di anni fa, nel caso avesse avuto una topografia simile alla Terra o ruotasse su se stesso a un ritmo leggermente più veloce. Le differenze sono enormi. Con catene montuose e bacini oceanici simili a quelli terrestri, la temperatura sarebbe stata di 12 gradi più elevata che con la topografia di Venere. E se la velocità di rotazione fosse stata di 16 giorni terrestri, la temperatura sarebbe schizzata a un valore di 45 gradi superiore al livello corrispondente alla sua velocità di rotazione attuale. Gli schemi delle nubi che hanno mantenuto il clima fresco avrebbero potuto formarsi solo se il pianeta avesse ruotato lentamente. E questo risultato ha vaste implicazioni la ricerca degli esopianeti: secondo Way, la comunità scientifica non dovrebbe ignorare i pianeti che sono molto vicini alle loro stelle, come quelli simili a Venere: se alcune caratteristiche cruciali come la topografia di un pianeta extrasolare e la sua velocità di rotazione sono solo quelli corretti, allora il limite interno della zona abitabile, la regione in un sistema planetario in cui possono determinarsi condizioni favorevoli alla vita, sarà vicino alla stella più di quanto si pensi comunemente.
|
|
|
Il Monte Maat sulla superficie di Venere ripreso con il radar (Foto NASA/JPL) |
La bassa pressione della giovane Terra
Come ha dimostrato un gruppo di geologi dell'Università di Washington a Seattle, la pressione atmosferica della Terra primordiale fra 3,5 e 2,5 miliardi di anni fa (tra le 02.40 del 23 marzo e le 05.20 del 12 giugno) era straordinariamente bassa: 230 millibar, cioè nemmeno un quarto di quella odierna. Questa scoperta elimina una delle due ipotesi che erano state avanzate per spiegare il cosiddetto paradosso del Sole debole. In quel remoto passato, infatti, la Terra era calda e aveva acqua allo stato liquido benché la radiazione emessa dal giovane Sole fosse molto debole. Ciò significa che era in atto un potente effetto serra che, in carenza di ossigeno e di CO2, poteva essere dovuto o a tassi elevati di metano oppure a un'atmosfera ricca di azoto, ma di spessore e pressione più elevati di oggi.
Stimare la pressione atmosferica di un'era geologica passata è tutt'altro che semplice, dato che in generale non lascia alcuna traccia negli strati di roccia. A fare eccezione alla regola sono solo i flussi lavici, che si raffreddano rapidamente dall'alto e dal basso con la formazione di bolle, che nella parte inferiore sono più piccole di quelle in alto. Il rapporto fra le dimensioni di queste bolle permette di risalire alla pressione dell'aria che gravava sulla lava. Ma per stabilire la pressione atmosferica è necessario essere certi che il flusso lavico che ha dato origine a una particolare roccia sia avvenuto, all'epoca, a livello del mare. Ora, Sanjoy M. Som e colleghi sono riusciti a individuare nel cratone di Pilbara, in Australia occidentale, una formazione rocciosa risalente a 2,7 miliardi di anni fa (la mezzanotte del 27 maggio), le cui micro-inclusioni dimostrano che, nel momento della sua solidificazione, era entrata in contatto con acqua marina.
La scansione con microtomografia a raggi X di una serie di campioni ha poi permesso di stabilire i rapporti dimensionali fra le minuscole bollicine presenti e di risalire alla pressione atmosferica a livello del mare dell'epoca, che è risultata compresa fra meno di 200 millibar e 500 millibar, con un valore medio di 230 millibar. A questa pressione, il punto di ebollizione dell'acqua è di appena 58°C, un valore che rappresenta quindi anche il valore limite della temperatura ambientale del tempo.
Antichi supercontinenti
Naturalmente, subito dopo la loro nascita, i continenti cominciarono ad andare alla deriva sul mantello fluido sottostante. I dati paleomagnetici hanno permesso di ricostruire, sia pure con molte incertezze, la posizione reciproca delle aree continentali, che nel loro vagabondare sono entrati più volte in collisione, saldandosi in un'unica vasta massa, per disarticolarsi però ben presto in nuovi frammenti alla deriva. Nel corso dell'eone Archeano abbiamo indizi dell'esistenza di almeno tre supercontinenti formatisi e disgregatisi in continuazione, ecco i loro nomi:
Kenorlandia, fra 2,7 e 2,2 miliardi di anni fa (fra il 27 maggio e il 6 luglio), che comprendeva la Laurentia (il nucleo di quello che oggi sono il Nord America e la Groenlandia), la Baltica (l'attuale Scandinavia e i paesi baltici), l'Australia occidentale e il Kalahari;
Columbia o Hudsonia, tra 1,8 ed 1,5 miliardi di anni fa (fra l'8 agosto e il 1 settembre), che comprendeva Laurentia, Baltica, Siberia, Ucraina, Amazzonia, Australia, il Nord della Cina e il Kalahari, e si estendeva per ben 13.000 km lungo l'asse nord-sud;
Rodinia (dal russo rodit, "generare"), tra 1,3 e un miliardo di anni fa (tra il 17 settembre e l'11 ottobre), centrata probabilmente a sud dell'equatore e ricoperta da vaste calotte glaciali per buona parte della sua storia.
Molte porzioni di crosta archeana racchiudono inoltre importanti giacimenti minerari di ferro, nichel, rame, cromo, oro, argento e uranio, e sono state appunto le ricerche di tali giacimenti per ovvi motivi economici a fornire molte delle informazioni su cui si basano le nostre conoscenze geologiche dell'Archeano. È significativo il fatto che all'Archeano medio o Mesoarcheano (da 3,2 a 2,8 miliardi di anni fa, cioè dal 16 aprile al 18 maggio) risale la maggior parte dei principali giacimenti di ferro, soprattutto in forma di ematite (Fe2O3). Questi giacimenti, di origine sedimentaria, corrispondono al momento della storia della Terra in cui, grazie alla comparsa di organismi in grado di realizzare la fotosintesi, cominciò a formarsi ossigeno libero che, reagendo con il ferro presente allora in soluzione nelle acque, provocò la sua precipitazione sotto forma di ossido, insolubile. Solo dopo che la maggior parte del ferro presente in soluzione fu rimosso da questo processo, cessò la formazione di tali giacimenti e cominciò ad aumentare la concentrazione di ossigeno libero nelle acque e nell'atmosfera. L'esistenza dei depositi di ferro archeani è pertanto un indice di un processo fotosintetico in atto, e quindi una prova che, al tempo della loro formazione, la vita si era abbondantemente stabilita nelle acque.
Peraltro, come ha rivelato uno studio del 2022 eseguito da un team internazionale guidato da Ziyi Zhu dell'Australian National University di Canberra, le montagne potrebbero aver svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della vita sulla Terra. In particolare un ruolo cruciale sarebbe stato svolto dalle cosiddette "supermontagne", cioè catene montuose giganti, alte almeno quanto l'Himalaya ed estese fino ad 8.000 chilometri attraverso interi supercontinenti. Le più gigantesche di queste supermontagne si sono formate solo due volte nella storia della Terra: la prima tra 2.000 e 1.800 milioni di anni fa (fra il 22 luglio e l'8 agosto), e la seconda tra 650 e 500 milioni di anni fa (tra il 9 e il 21 novembre). In quelle finestre di tempo si sono formate catene di anche 8000 km di lunghezza e 1000 di larghezza. L'erosione di una di queste, la cosiddetta Transgondwanan Supermountain, in circa 260 milioni di anni ha prodotto tanto materiale da poter coprire tutti i 50 stati degli USA con circa 10 km di sedimenti! Le due fasi di innalzamento delle supermontagne coincide con due eventi cruciali: uno è legato alla comparsa di grandi cellule complesse, e l'altro alla comparsa degli animali. Infatti, erodendosi, queste catene hanno fornito agli oceani una quantità colossale di sostanze nutritive essenziali come il fosforo, il ferro, e il calcio, alimentando i cicli biologici e spingendo l'evoluzione verso una maggiore complessità. Le supermontagne potrebbero anche aver aumentato i livelli di ossigeno nell'atmosfera, necessari alla respirazione della vita complessa; infatti, una delle fasi di aumento dei livelli di ossigeno atmosferico coinciderebbe con il sollevamento delle supermontagne. Tra le due fasi orogenetiche intercorre l'intervallo di tempo tra 1.800 e 800 milioni di anni fa. Questo lungo periodo è noto come "il Miliardo Noioso", perché nel corso di esso i progressi nell'evoluzione sono stati scarsi. Sempre secondo gli autori dello studio, quella fase di rallentamento dell'evoluzione è attribuibile all'assenza di supermontagne, che ha ridotto l'apporto di nutrienti agli oceani!
Esiste anche una bizzarra ipotesi, avanzata da Chris Kirkland, geologo della Curtin University in Australia, secondo cui la Terra sarebbe stata plasmata anche da potenti forze che hanno origine ben oltre il sistema solare: infatti la crosta continentale del nostro pianeta avrebbe sperimentato un'importante crescita quando il sistema solare primordiale stava attraversando i quattro bracci principali della spirale della Via Lattea. Questi passaggi galattici avrebbero innescato una pioggia di comete sulla Terra, e i loro impatti giganti avrebbero dato vita a nuova crosta. Kirkland e i suoi colleghi hanno confrontato le datazioni geologiche dell'accrescimento della crosta terrestre con i tempi tipici dei movimenti galattici (il Sole impiega 225 milioni di anni a compiere un giro completo intorno alla Galassia), e hanno collegato tali tempi agli impatti delle comete grazie a tracce di cristalli e minuscole perle di vetro nel terreno che hanno conservato i dettagli di collisioni del genere. Si tratta di minuscoli cristalli di soli 100 micrometri di diametro, depositatisi in luoghi in cui si è conservata la prima storia continentale della Terra: antichissimi frammenti di crosta in Groenlandia e in Australia. Ma un tempo essi si trovavano nel vasto oceano ribollente di magma nelle profondità del sottosuolo, prima di risalire verso l'alto, intrappolati in una massa fusa che si è riversata in superficie e si è indurita in una nuova crosta. Nonostante il viaggio travagliato, i cristalli hanno conservato un’impronta precisa della loro origine: al loro interno si trovano elementi radioattivi come l'uranio, che consentono agli scienziati di datarli. Usando questi cristalli, Kirkland ha dedotto che durante un periodo che va da circa 3,8 miliardi a 2,8 miliardi di anni fa (dal 26 febbraio al 18 maggio dell'Anno della Terra), il magma ha perforato la superficie e prodotto nuova crosta ogni 170-200 milioni di anni. Questo schema corrisponde alla frequenza con cui la Terra attraversa i bracci della spirale della nostra galassia: quando il sistema solare si muove in un braccio a spirale, la maggiore densità stellare nel braccio trascinerebbe via le comete dalla nube di Oort. mandandone alcune su una traiettoria verso la Terra. Il bombardamento di comete avrebbe scavato grandi volumi di superficie terrestre, creando un enorme calore ma rilasciando pressione al di sotto. Lo strato rocciosa in alto agirebbe come una valvola su una pentola a pressione: quando la pressione è diminuita, questo cambiamento avrebbe abbassato il punto di fusione del mantello, causando la formazione di enormi quantità di magma. Il magma galleggiante sarebbe poi salito in superficie, dove si sarebbe solidificato sotto forma di basalto. Lo strato di basalto sarebbe stato così spesso (probabilmente decine di chilometri) che la base sarebbe stata incandescente, tanto da indurre una nuova fusione e la formazione di granito, una roccia di colore chiaro che avrebbe galleggiato su tutto il resto. Una spiegazione brillante, ma anche parecchio controversa, avendo ignorato spiegazioni più semplici che coinvolgono il solo ambiente terrestre, come il fenomeno della subduzione: il ciclo di 170-200 milioni di anni è esattamente il tempo necessario a una lastra di crosta per spostarsi dalla superficie fino al confine tra nucleo e mantello. Inoltre i planetologi non hanno trovato prove di pesantissimi impatti cometari nel sistema solare interno: le piogge di comete sono piuttosto rare, mentre invece gli asteroidi, che trasportano meno energia, sono gli oggetti in caduta più tipici, come ben sanno i dinosauri. Anche se è vero che le piogge di comete sono innescate da stelle di passaggio che perturbano la nube di Oort interna, una stella di questo tipo deve arrivare relativamente vicina al Sole affinché si verifichino questo tipo di piogge, e questi eventi si verificano molto raramente, persino durante il passaggio di un braccio della spirale galattica. Nella scienza vale senz'altro la pena di essere ambiziosi, ma non dobbiamo mai dimenticare il celebre Rasoio di Occam: tra tante spiegazioni possibili di un determinato evento, quelle più semplici sono sempre anche le più probabili; e se abbiamo già spiegazioni pronte dai cicli della Terra, abbiamo davvero bisogno di altre teorie che coinvolgono addirittura i bracci della spirale galattica?
L'evento più straordinario della storia del nostro pianeta si compì nelle acque degli oceani dell'Eoarcheano circa 3 miliardi ed 800 milioni di anni fa (il 26 febbraio), allorché comparve il primo essere vivente unicellulare. Infatti sulla giovane Terra si instaurò assai presto un ciclo dell'acqua: le piogge trasportavano i composti venefici dell'atmosfera primigenia (CO2, CH4, NH3, H2S...) nei fiumi e quindi nel mare. Qui essi subivano grandi apporti di energia dalle scariche elettriche dei fulmini, assai frequenti in quei remotissimi acquazzoni, dai vulcani di cui la crosta solida abbondava, e forse dall'azione dei raggi ultravioletti del Sole (non vi era certo lo strato di ozono a proteggere il mondo) e dall'attività dei materiali radioattivi, certamente a quei tempi assai maggiore dell'attuale. Ciò provocò la reazione dei semplici composti sopra citati a formare molecole più complesse: gli aminoacidi, che non sono altro che le basi chimiche della vita. Infatti il citoplasma cellulare consiste di molecole di proteine, a loro volta formate da varie combinazioni di molecole di amminoacidi unite in serie fra loro, mentre il materiale genetico è formato da lunghe molecole di acidi nucleici, formati da diverse combinazioni di unità molecolari molto più semplici, i nucleotidi, anch'essi uniti in serie. Tutto questo fa comprendere come la comparsa di organismi viventi debba essere stata preceduta dalla formazione di un complesso ambiente chimico detto comunemente « brodo primordiale », e descritto come una soluzione di sostanze organiche formatesi in seguito a processi non biologici. Ma quali?
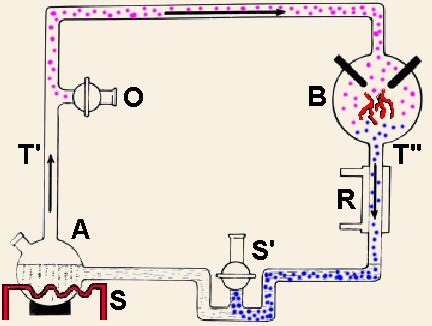
|
La possibilità teorica di un passaggio da quelle sostanze inorganiche ai primi composti organici fu indagata a lungo da Harold C. Urey (1893-1981), autore della teoria secondo la quale i raggi ultravioletti del Sole e le violente scariche elettriche nell'atmosfera primordiale avrebbero innescato le reazioni chimiche necessarie alla formazione del brodo primordiale. Nel 1953 un giovane collaboratore di Urey, il chimico americano Stanley L. Miller (1930-2007), in un esperimento divenuto famoso tentò la verifica di tale teoria. Nel bollitore A di vetro era contenuta dell'acqua in ebollizione grazie alla serpentina S. In O il vapore acqueo veniva arricchito di una miscela di sostanze gassose (in viola) che, secondo Urey, costituivano l'antichissima atmosfera terrestre, e cioè idrogeno, ammoniaca, metano e anidride carbonica, quindi entrava nella boccia B dove era sottoposto per alcuni giorni a una serie di piccole scariche elettriche (vedi figura sopra); al termine dell'esperimento il vapore, incanalato in T", era convogliato in un condensatore R che lo faceva tornare acqua liquida; il filtro S' intrappolava la soluzione di sostanze (in blu) formatesi nell'acqua, la cui analisi dimostrò la formazione di vari tipi di composti organici, tra cui sei amminoacidi.
Alcuni studiosi negli anni successivi misero in discussione i risultati ottenuti da Miller, sostenendo che l'atmosfera primigenia era più povera di idrogeno di quanto Miller ed Urey avevano ritenuto. Ma di recente nuovi studi fanno pensare che potrebbero essere stati i vulcani ad immettere nell'atmosfera di allora i gas necessari alla sintesi degli aminoacidi. Inoltre, nell'estate 2008 Jeffrey Bada, ricercatore alla Scripps Institutions of Oceanography a San Diego (California) e ultimo studente di Miller, che ha conservato fino ad oggi le 11 provette rimaste dal famoso esperimento del 1953, decise di analizzare di nuovo i vecchi campioni; grazie alle tecniche odierne, molto migliorate dagli anni cinquanta ad oggi, sono emersi dati molto più ricchi rispetto al passato. Bada e collaboratori hanno trovato ben 22 aminoacidi, 10 dei quali non erano stati stati individuati da Miller. Incredibilmente sembra aver avuto ragione la scrittrice Mary Shelley (1797-1851) che, nel suo romanzo horror "Frankenstein" (1818), ipotizzò che la vita sulla Terra sia stata creata dall'azione dei fulmini (tanto che il protagonista li usa per ridare vita a un cadavere)!
Successivamente, un altro gruppo di ricercatori dell'Akademie věd České republiky, l'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, ha trovato una via diversa per spiegare la comparsa dei primi amminoacidi: essi infatti sono riusciti ad ottenere la sintesi di quattro delle basi azotate che costituiscono i mattoni della vita a partire da un plasma contenente formammide, ricostruendo le condizioni della Terra primordiale durante l'ultimo intenso bombardamento meteoritico, o LHB (Late Heavy Bombardment), subito dal nostro pianeta. I passaggi fondamentali dei processi che hanno portarono alla creazione di composti organici complessi, e in particolare dei nucleotidi che formano l'RNA e il DNA, sono ormai stati compresi, ma diversi passaggi delle reazioni coinvolte continuano a essere oscuri. In particolare, non è ancora chiaro quale sia stata la fonte di energia che ha permesso una formazione di quei composti quasi contemporanea, e abbastanza diffusa da innescare lo sviluppo della vita.
Svatopluk Civis e colleghi hanno dimostrato che quell'energia può essere stata fornita dal flusso particolarmente intenso di piccoli corpi cometari e meteoriti che investì la Terra circa quattro miliardi di anni fa (il 10 febbraio), quando il sistema solare era ancora in una fase di relativa instabilità. In quel periodo, sul nostro pianeta piovvero fino a dieci miliardi di tonnellate di materiale extraterrestre all'anno, con velocità d'impatto comprese fra i 9 e i 21 chilometri al secondo. Civis e colleghi hanno ricreato in laboratorio, con l'aiuto di uno dei più potenti impianti laser d'Europa, il PALS di Praga, gli effetti dell'impatto di questi corpi extraterrestri, mostrando che potevano provocare localmente un aumento di temperatura fino a 4500 K, con la formazione di una significativa onda d'urto e la genesi di un plasma, a sua volta fonte di una radiazione secondaria sotto forma di raggi ultravioletti, luce e raggi X. Gli esperimenti hanno dimostrato che, nelle condizioni che si vengono così a determinare, le molecole organiche semplici presenti nell'ambiente reagiscono e si ricombinano, portando prima alla formazione di alcuni composti intermedi e infine alla formazione delle basi azotate, quattro delle quali (adenina, guanina, citosina e uracile) sono state sintetizzate dai ricercatori sminuzzando continuamente con una macchina apposita la sabbia cui erano miscelati i composti di partenza. Si tratta davvero di una scoperta eccezionale, che getta nuova luce sull'origine della vita. Che noi siamo... figli delle stelle?
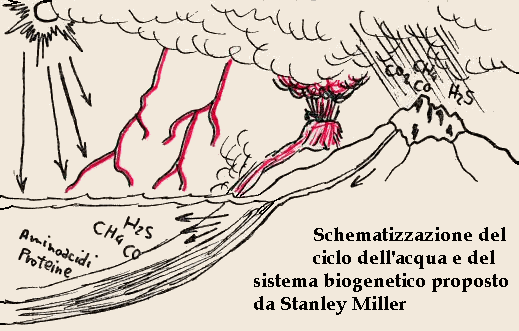
|
La questione è ancora controversa. Certo è solo che la formazione e la diffusione di sostanze organiche deve aver richiesto milioni di anni e innumerevoli combinazioni chimiche tra le sostanze presenti sia sulla superficie terrestre, sia nelle acque calde degli oceani, alla fine delle quali gli oceani si ritrovarono ricchi del "brodo primordiale" formato da amminoacidi e nucleotidi; in che modo però all'interno di esso possano essersi formate le proteine, i virus, le cellule e quindi tutti gli esseri oggi viventi sulla Terra, è mistero fitto. Oggigiorno le principali teorie sull'origine della vita ipotizzano l'esistenza di un "mondo a RNA": molecole dì acido ribonucleico capaci di replicarsi ed evolversi, che sarebbero state le progenitrici delle prime cellule. La biochimica di tutti i viventi oggi però si basa pressoché interamente sulle proteine, molecole capaci di raffinate catalisi chimiche, mentre 1'RNA è, nella maggior parte dei casi, relegato a moli di messaggero o modulatore dell'informazione genetica. Ma a sua volta la sintesi delle proteine è un raro caso di processo biochimico fondamentale che dipende in modo molto stretto da numerosi tipi di molecole di RNA. È possibile quindi che questi due "universi biochimici" abbiano un'antica e stretta connessione evolutiva? Come è avvenuto questo passaggio fondamentale? Esperimenti effettuati alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera da Thomas Carell e colleghi nel 2021 suggeriscono un legame diretto tra "mondo a RNA" e sintesi delle proteine. La chiave sta in alcuni nucleotidi chimicamente modificati, tuttora parte degli RNA coinvolti nell'algoritmo di sintesi proteica. Questi nucleotidi possono catalizzare la formazione di piccole proteine legate allo scheletro di RNA, permettendo a quest'ultimo una versatilità chimica molto più ampia. Inoltre la sintesi di proteine è influenzata dalla complementarietà tra basi azotate dell'RNA, un aspetto che ricorda la complementarietà tra RNA messaggero ed RNA transfer che guida la sintesi proteica degli organismi moderni. Gli esperimenti suggeriscono dunque che al mondo a RNA possa essere seguito un mondo di molecole miste RNA-proteine, che poi si sarebbe evoluto nella biochimica degli organismi viventi in cui la catalisi delle reazioni chimiche è quasi interamente svolta dalle molecole proteiche.
Fin qui, quello che sappiamo, ma nessuno finora è mai riuscito a riprodurre "cellule artificiali" in laboratorio, né sappiamo se mai qualcuno ci riuscirà. Più di uno scienziato si è spinto anche ad ammettere la possibilità di un intervento soprannaturale all'origine della vita, ma in ogni caso io non prenderò posizione sull'argomento, perché questo problema esula dai compiti della scienza, e quindi dai limiti che questo ipertesto si è imposto. Mi limito a riportare il parere dello scienziato singalese Chandra Wickramasinghe (1939-vivente): « Un vento impetuoso che soffiasse su delle carcasse di aereo avrebbe più probabilità di comporre un Boeing 747 nuovo di zecca, pur partendo da questi rottami, di quante non ve ne siano di generare la vita mettendo insieme a caso gli elementi che la compongono! »
La vita è nata... dal Sole
Vale la pena di riportare qui la tesi sostenuta nel 2016 da Vladimir Airapetian e colleghi del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland: secondo loro, gigantesche eruzioni solari, denominate superbrillamenti (supeflare), che si verificavano con frequenza sul Sole alcuni miliardi di anni fa, potrebbero esser stati tra gli ingredienti fondamentali per dare inizio alla vita sul nostro pianeta. Gli scienziati suddetti infatti hanno trovato una risposta convincente a una questione fondamentale: la disponibilità di azoto sulla Terra primordiale. Questo elemento era presente sul nostro pianeta solo nella forma molecolare, composta da due atomi di azoto legati tra loro, che non è chimicamente reattiva; è probabile quindi che a un certo punto sia intervenuto un fenomeno molto energetico per rompere questa molecola nell'atmosfera, consentendo agli atomi di azoto di ricombinarsi con altri elementi e formare così molecole differenti.
Nelle osservazioni da telescopio delle tempeste stellari che avvengono su stelle simili al Sole, è possibile evidenziare i superflare, accompagnati da massicce emissioni di particelle energetiche, che potrebbero essersi verificate frequentemente anche durante l'infanzia del Sole. È emersa quindi l'ipotesi che queste particelle energetiche abbiano interagito con l'atmosfera primordiale della Terra, alimentando diversi processi chimici. Le simulazioni effettuate dagli autori sulle interazioni tra superflare e Terra indicano che questi processi solari deformano il campo magnetico terrestre che, in condizioni normali, protegge il nostro pianeta come uno scudo dalle emissioni di particelle cariche provenienti dallo spazio. I superflare invece determinano la formazione di ampi buchi intorno ai poli, attraverso i quali è possibile il transito delle particelle.
Questo studio mostra anche che le particelle energetiche interagiscono con le componenti dell'atmosfera terrestre generando protossido di azoto e cianuro di idrogeno. Proprio questa ultima molecola, secondo gli autori, potrebbe essere stata la fonte d'azoto necessaria per la formazione di molecole biologiche come gli aminoacidi. Il protossido di azoto è invece un potente gas serra, e potrebbe aver facilitato il riscaldamento della superficie terrestre fino a una temperatura in grado di supportare la presenza di acqua allo stato liquido e l'inizio della vita. Un'ipotesi affascinante, non è vero?
Le prime cellule
Comunque siano andate le cose, è un dato di fatto che l'RNA ed il DNA si sono formati; questi aggregarono altre proteine, bolle d'aria, molecole d'acqua ed una pellicola esterna di zuccheri e proteine. Ebbe così origine una struttura complessa cui è stato dato il nome di coacervato ("ammucchiato"): un'aggregazione sferica di molecole lipidiche che formano un'inclusione colloidale, tenute insieme da forze di natura idrofobica. I coacervati misurano da 1 a 100 micrometri, possiedono proprietà osmotiche e si formano spontaneamente in alcune soluzioni organiche diluite. Si arriva in tal modo ai protobionti, come li ha chiamati il biochimico russo Alexander Oparin (1894-1980), che negli anni trenta del secolo scorso fu tra i primi a studiare la genesi della vita. I protobionti dovevano essere organismi microscopici, forse simili ai batteri attuali del tipo cocchi, ed erano eterotrofi, cioè non erano in grado di sintetizzare in modo autonomo le sostanze nutritive organiche loro necessarie, ma si trovavano costretti ad assumerle direttamente dall'ambiente circostante. Tutto questo richiede naturalmente che l'organismo eterotrofo sia immerso costantemente in acqua o almeno in un ambiente umido, indispensabile veicolo per far penetrare quelle sostanze in soluzione attraverso una primitiva specie di membrana.
 |
Sulla base delle tracce fossili di Fig Tree, nello Swaziland, nelle quali (vedi figura sopra) fu ritrovato il più antico microrganismo fossile conosciuto, si può inferire che, ad un solo miliardo di anni di distanza dall'origine della Terra, sulla superficie del nostro pianeta erano già comparsi i primi organismi viventi. Tutto questo fa ben sperare circa la possibilità che anche su altri pianeti si sia innescato lo stesso processo, e quindi ci incoraggia a proseguire la ricerca di forme di vita extraterrestri, a partire dagli altri pianeti del Sistema Solare.
Una questione molto dibattuta è se tutti gli organismi viventi oggi sulla Terra discendano da un unico essere o se, come sostengono alcuni scienziati, la vita è sorta da diversi antenati indipendenti. In questo caso, la vita sarebbe nata in diversi punti della superficie terrestre e in diverse epoche indipendentemente l'una dall'altra. Per risolvere la questione Douglas Theobald, un biochimico della Brandeis University di Waltham (Massachusetts), ha studiato un gruppo di 23 proteine essenziali, presenti in tutti gli organismi conosciuti, prendendo in esame veri organismi rappresentativi degli eucarioti, dei batteri e degli archea, i tre principali gruppi di esseri viventi, e analizzando i possibili percorsi che hanno portato a variazioni nella loro struttura. Tutto questo ha richiesto complesse analisi statistiche e la messa in campo di una notevolissima potenza di calcolo, ma alla fine Theobald ritiene che i suoi calcoli suffraghino in misura massiccia la teoria dell'antenato comune, che sarebbe milioni di volte più probabile della teoria che prevede più antenati indipendenti. « Ciò non esclude che la vita si sia originata indipendentemente più volte », ha osservato Theobald, « ma in tal caso nell'evoluzione vi è stato un collo di bottiglia tale da far sopravvivere fino al presente i discendenti di una sola di questi alberi della vita tra loro indipendenti. Oppure, in alternativa, popolazioni separate potrebbero essersi mescolate, scambiandosi nel corso del tempo abbastanza materiale genetico da diventare un'unica famiglia che alla fine è diventata l'antenato di tutti noi. In entrambi i casi, tutte le forme di vita sono geneticamente correlate tra loro. »
La vita è nata fra le tenebre?
Non manca però chi pensa che l'origine della vita non sia da ricercare nel tiepido "brodo primordiale" degli oceani primigeni, bensì nelle oscure e paurose profondità marine, là dove la luce del sole non giunge da miliardi di anni. In effetti, sulle terre emerse e nei mari poco profondi i luoghi rimasti da esplorare sono davvero ben pochi, mentre il 75 % della superficie terrestre coperto dagli oceani è in larga parte sconosciuto. Paradossalmente, conosciamo meglio la superficie di Marte che quelle tenebrose e fredde profondità abissali. Ebbene, nel 1977 presso le isole Galapagos di darwiniana memoria un piccolo sommergibile battezzato Alvin osservò l'esistenza di forti sorgenti idrotermali battezzate fumarole nere o black smoker. Esse si formano quando acqua a temperatura altissima (oltre i 400 °C) proveniente da sotto la crosta terrestre trova uno sbocco attraverso il fondo dell'oceano. L'acqua surriscaldata è ricca di minerali in soluzione (soprattutto solfuri, ferro, rame e zinco) provenienti dalla crosta, che cristallizzano formando intorno alle sorgenti una struttura rocciosa simile a un camino. Quando l'acqua surriscaldata viene a contatto con la freddissima acqua oceanica, molti minerali precipitano dando origine al caratteristico colore nero, da cui il nome. L'acqua emessa peraltro è estremamente acida: il suo pH può scendere fino a 2,8 (pari a quello del succo di limone). Nel novembre 2009 Bramley Murton, ricercatore del National Oceanography Centre di Southampton, ha scoperto nei Caraibi la fumarola nera più profonda del mondo, che emette acqua bollente a ritmo continuo ad oltre 5.000 metri sotto la superficie marina nella fossa delle Cayman, ed ha subito commentato che « esplorare questa zona mediante un sottomarino telecomandato è stato come vagare sulla superficie di un altro mondo ». A dispetto della chimica ostile, però, le aree che circondano simili camini brulicano di vita, per lo più estremamente esotica: ad esempio vi prospera la Riftia pachyptila, un verme gigante senza né bocca né intestino, che sopravvive grazie alla simbiosi con batteri in grado di consumare il velenoso acido solfidrico che esce dalle fumarole. Nell'Oceano Indiano è stato addirittura scoperto un gasteropode corazzato che per la sua corazza usa solfuri di ferro (pirite e greigite) invece del comune carbonato di calcio! In habitat così estremi la luce solare è completamente assente, e gli organismi che vi vivono trasformano in energia il calore, il metano e i composti solforati attraverso un processo detto chemiosintesi. Più d'uno ha dunque pensato che la vita potrebbe essere nata proprio nelle vicinanze di queste ostili bocche idrotermali, quando la superficie di terre e mari era ancora inabitabile, per poi migrare in ambienti meno ostili, dando inizio all'esplosione della vita.
Nel dicembre del 2000 alle fumarole nere si sono aggiunte quelle bianche. Infatti una spedizione che stava cartografando una montagna sommersa sul fondo dell'Oceano Atlantico, nota con l'evocativo nome di Massiccio di Atlantide, 15 chilometri a ovest della dorsale medio-oceanica e a 800 metri di profondità, scoprì una colonna di roccia bianca alta come un palazzo di venti piani che si innalzava dal fondo del mare. Quella era solo una delle tantissime strutture analoghe che pullulavano nella zona: era stata scoperta un'area ricca di sorgenti calde sottomarine che, per assonanza con la perduta Atlantide, fu battezzata Lost City (la Città Perduta), un luogo completamente diverso da ogni altro fino ad allora studiato, incluse le fumarole nere. Le osservazioni compiute nel 2003 dalla geologa Deborah S. Kelley dell'Università di Washington permisero di rivedere alcune idee molto radicate sulla chimica che potrebbe aver dato origine alla vita, e di ampliare addirittura le ipotesi sulla possibile presenza di vita fuori dal nostro pianeta. Confrontati con il rigoglioso ambiente delle fumarole nere, i camini di Lost City appaiono stranamente tranquilli: il magma della dorsale medio-atlantica è troppo lontano per riscaldare i fluidi in risalita fino alle centinaia di gradi delle fumarole nere, e le temperature lì non superano i 90° C. Inoltre le emissioni della Città Perdute non sono acide bensì basiche, con un pH tra 9 e 11, simile a quello delle soluzioni di ammoniaca normalmente in commercio. Non potendo le acque dissolvere rapidamente alte concentrazioni di metalli come ferro e zinco, qui non ci sono i pennacchi di fumo tipici delle fumarole nere, e Lost City è invece ricca di calcio, il quale dà vita ad enormi camini di calcare, dal colore incredibilmente bianco, alti fino a 60 metri, quindi più di ogni fumarola nera nota. E l'ambiente della Città Perduta è estremamente riducente. Perchè questo è così importante?
Perchè, dopo il suddetto esperimento di Stanley Miller, si è fatta strada in modo prepotente l'ipotesi che i gas riducenti abbiano avuto un ruolo fondamentale nella nascita della vita sulla Terra. Ora, il biologo inglese John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) negli anni venti del secolo scorso suggerì che l'atmosfera primitiva della Terra potrebbe aver avuto un'altissima concentrazione di gas riducenti (atti cioè a cedere elettroni ad altre molecole) come idrogeno, ammoniaca e metano; in questo caso, come visto, gli elementi necessari alla vita si sarebbero formati spontaneamente. Nei decenni successivi però è apparso chiaro che l'atmosfera primitiva non era così riducente come ipotizzato da Haldane, e forse le condizioni previste da Miller e collaboratori non si erano mai realizzate. I gas riducenti però abbondano proprio nei camini idrotermali di Lost City. Molte ere geologiche fa fumarole simili a queste potrebbero aver creato proprio le condizioni più adatte per la nascita della vita, laggiù, molto lontano dal calore vivificante del Sole. Sistemi idrotermali come quello potrebbero essere state le fabbriche ideali per produrre straordinarie quantità di metano, semplici composti organici come il formiato e l'acetato, e forse addirittura i primi acidi grassi, componenti essenziali della membrana cellulare di tutti gli organismi conosciuti. Molti dei microrganismi scoperti a Lost City sono infatti metanogeni, appartenenti alla famiglia dei Metanosarcina, che sopravvivono in modo del tutto indipendente dalla luce del Sole.
Aggiungiamo che nel 2021 un gruppo internazionale di ricerca guidato da Barbara Cavalazzi, dell’Università di Bologna, ha scoperto i resti fossili di batteri coinvolti nel ciclo del metano che sono vissuti 3,4 miliardi di anni fa (alle ore 5.20 del 31 marzo) all'interno di un sistema idrotermale sotto la superficie del mare. Si tratta della più antica testimonianza di questo tipo di microrganismi mai rinvenuta: un passo avanti importante che amplia le frontiere degli habitat che avrebbero potuto ospitare le prime forme di vita sul nostro pianeta. E potrebbe rivelarsi utile anche per la ricerca di tracce di vita su altri pianeti, a partire da Marte. Lo studio nasce dall’analisi di campioni rinvenuti all’interno di due sottili strati di una roccia prelevata dalla Barberton Greenston Belt, una località nel Sudafrica orientale, vicino al confine con l’Eswatini e il Mozambico, dove affiorano rocce sedimentarie tra le più antiche e meglio conservate sul nostro pianeta. Quelli rinvenuti sono esemplari di microbi fossili straordinariamente ben conservati che erano probabilmente diffusi lungo le pareti di cavità create, diversi metri sotto il livello del mare, da flussi di acqua calda animati da sistemi idrotermali sotterranei. Quelle ritrovate potrebbero le più antiche testimonianze mai rinvenute di forme di vita nate in ambienti alimentati dall’attività vulcanica sottomarina, e non dalla luce del sole.
I microfossili in esame sono composti da una parte esterna ricca di carbonio e un nucleo interno distinto sia dal punto di vista chimico che strutturale: una configurazione che richiama la suddivisione tipica delle cellule, tra membrana cellulare e materiale intracellulare. Le strutture individuate hanno la forma di filamenti: singoli filamenti di dimensioni submicormetriche erano distribuiti sulla parte inferiore della cavità sottomarina, mentre gruppi di filamenti occupavano piccole anse scavate sulla parte superiore. Dalle analisi chimiche realizzate in situ sulle strutture fossili è emersa la presenza di gran parte degli elementi necessari per la vita. In particolare, sono state individuate similitudini con i moderni Archea, organismi unicellulari che vivono in assenza di ossigeno e usano il metano per il loro metabolismo. Questa potrebbe essere anche la prima testimonianza di Archea fossili risalenti al periodo in cui la vita emerse per la prima volta sul nostro pianeta, e sappiamo che su Marte sono esistiti ambienti simili a quelli nei quali sono stati ritrovati questi microrganismi.
I ribosomi, gli organelli che le cellule usano per tradurre in proteine l'informazione contenuta negli acidi nucleici (DNA ed RNA), sono composti di RNA e proteine; ebbene, confrontando le sequenze dei componenti fondamentali dell'RNA ribosomiale è stato possibile costruire l'albero genealogico visibile qui sopra, nel quale sono ipotizzate le parentele tra tutte le forme di vita esistenti sulla Terra e a noi note. Alla radice dell'albero c'è il cosiddetto « Ultimo Antenato Comune Universale », (LUCA, Last Universal Common Ancestor), l'antenato comune più recente dal quale tutti gli organismi attuali discenderebbero. Si pensa sia vissuto tra 4,1 e 3,6 miliardi di anni fa (tra il 2 febbraio e il 15 marzo). Attenzione, perchè il misterioso LUCA non è né il primo organismo vivente mai comparso sulla Terra né il progenitore comune di tutti gli esseri viventi fossili, giacché non si può scartare il fatto che si possano identificare resti di altri esseri viventi ancora più arcaici di esso; inoltre, non è vero che in principio esisteva soltanto questo organismo, ma esso è l'unico, tra i suoi contemporanei, ad aver lasciato discendenti sino ad oggi.
Ebbene, molti degli organismi che si trovano vicini alla radice dell'albero (ed indicati in esso in colore blu) consumano idrogeno, ed abitano le sorgenti calde in superficie o sul fondo del mare, indicando che l'antenato universale comune a tutti i viventi terrestri potrebbe aver abitato anch'esso una sorgente calda, forse in un ambiente simile a quello di Lost City. Tra l'altro, una recente scoperta ha confutato l'idea, finora ben consolidata, che gli unici esseri viventi in grado di prosperare in condizioni di anossia fossero da catalogare fra gli archea, i batteri e i virus: un gruppo di ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona e del Museo di storia naturale di Copenaghen ha scoperto ben tre specie marine pluricellulari che compiono il loro intero ciclo di vita in assenza di ossigeno e circondati da nuvole di sostanze velenose come i solfuri, derivati dell'acido solfidrico. La scoperta è il risultato di tre spedizioni oceanografiche condotte fra il 1998 e il 2008, durante le quali sono stati analizzati i fondali del bacino dell'Atalante, al largo delle coste meridionali della Grecia, a una profondità di oltre 3000 metri: un bacino buio, profondo, ipersalino e anossico (la concentrazione salina dell' acqua è dieci volte superiore a quella dell'acqua di mare, quindi vicina al punto di saturazione), formatosi nel Miocene, circa 6 milioni di anni fa, quando si chiuse la comunicazione tra Atlantico e Mediterraneo e una gran quantità di sali si depositò sul fondo del Mare Nostrum, e rimasto in queste condizioni almeno negli ultimi 50.000 anni. Proprio in questo ambiente, uno dei più inospitali della Terra, sono stati individuati tre organismi (Spinoloricus, Rugiloricus e Pliciloricus) catalogati nel philum dei Loriciferi, i quali, al posto dei mitocondri, gli organelli delle cellule deputati tra l'altro a generare energia dall'ossigeno, presentano delle strutture simili agli idrogenosomi, le forme anaerobiche di mitocondri osservati in organismi unicellulari che vivono in ambienti privi di ossigeno. « La scoperta », ha dichiarato William Martin dell'Università Heinrich Heine di Düsseldorf, « ci fornisce un esempio di come poteva essere la vita nei mari e negli oceani del Pianeta 600 milioni di anni fa ». Secondo alcuni, paradossalmente, le tre specie potrebbero rappresentare il futuro della vita negli oceani, poiché vengono date in espansione le cosiddette "zone morte", aree marine profonde in cui l'ossigeno è assente o scarsissimo a causa del dilagante inquinamento. In ogni caso, i meccanismi evolutivi ed adattativi che hanno portato alla colonizzazione di simili ambienti estremi restano ancora un enigma.
I geologi hanno seri motivi per sospettare che ecosistemi come Lost City fossero comuni sulla Terra in un passato remoto, e quindi condizioni basiche e tiepide come quelle della Perduta Città potrebbero aver costituito l'incubatrice delle primissime forme di vita. Inoltre ciò rafforza la speranza di trovare vita anche fuori del nostro pianeta, in ambienti poveri di luce solare ma ricchi di acqua liquida, tiepida e basica, come Europa, la luna di Giove che sotto una spessa crosta ghiacciata potrebbe nascondere un oceano riscaldato dal forte campo gravitazionale del quinto pianeta. Ed anche nell'attuale atmosfera di Marte sono state rintracciate tracce di metano, che secondo alcuni sarebbe di origine organica, prodotto cioè da batteri come quelli di Lost City: le future missioni spaziali verso il Pianeta Rosso, attrezzate con veri e propri laboratori chimici, potranno dirci qualcosa di più in proposito.
Victor Sojo, Nick Lane e altri ricercatori dell'University College di Londra hanno inoltre definito un modello evolutivo delle membrane degli organismi terrestri, secondo il quale LUCA aveva una membrana porosa. La scoperta permette di spiegare alcuni quesiti irrisolti della storia dell'evoluzione, e in particolare perché i due tipi di organismi che rappresentano le forme più antiche di vita, i batteri e gli archea, abbiano membrane cellulari radicalmente diverse, e perché tutte le cellule usino lo stesso complesso meccanismo per rifornirsi di energia. Secondo la ricostruzione di Sojo, Lane e colleghi, l'organismo ancestrale avrebbe sfruttato la differenza di concentrazione dei protoni tra le bocche idrotermali, povere di quelle particelle, e le acque oceaniche più ricche di protoni, per procurarsi l'energia necessaria alla produzione di adenosintrifosfato (ATP), la molecola che ancora oggi alimenta la crescita delle cellule. Questo meccanismo funziona, però, solo se la cellula è dotata di una membrana “porosa”, permettendo un flusso naturale di protoni sia in entrata, sia in uscita. Per colonizzare ambienti differenti dalle fumarole, LUCA ha però dovuto adattare la sua membrana in modo da pompare attivamente i protoni fuori dalla cella e consentire il flusso di protoni e la produzione dI ATP. Gli studiosi suggeriscono che batteri e archea abbiano sviluppato strutture della membrana cellulare e pompe protoniche completamente differenti, pur mantenendo gli stessi macchinari per alimentare la crescita. Ciò spiegherebbe anche perché i due tipi di organismi differiscano per tratti fondamentali che dipendono dalla membrana, come appunto la replicazione del DNA.
L'albero genealogico dei viventi qui sopra riportato potrebbe però avere ulteriori diramazioni. Infatti, utilizzando tecniche di sequenziamento e di metagenomica, un gruppo di ricercatori diretto da Jonathan Eisen dell'Università della California a Davis ha identificato, in una serie di campioni di organismi marini provenienti dalle campagne di prelievo della Global Ocean Sampling Expedition, una serie di sequenze che appartengono a due superfamiglie di geni note come recA e rpoB. Queste sequenze, la prima coinvolta nel riarrangiamento del genoma, la seconda nella sua trascrizione sotto forma di RNA, sono pressoché onnipresenti e vengono utilizzate per definire i rapporti filogenetici sulla base delle specificità che manifestano. Eisen e collaboratori hanno però scoperto che la loro struttura è del tutto peculiare, e questo potrebbe essere spiegato o dal fatto che ci si trova di fronte a un nuovo ramo dell'albero della vita, da affiancare a eucarioti, batteri e archea. Diversi ricercatori ritengono che già i mimivirus potrebbero rappresentare un quarto dominio: sono i virus più grandi attualmente conosciuti, i quali possiedono alcuni geni che si trovano solamente in organismi cellulari. Se così fosse, le nuove sequenze identificate dal gruppo di ricerca di Eisen potrebbero addirittura rappresentare un quinto ramo fondamentale della vita. Non si può naturalmente escludere che le sequenze provengano da una contaminazione con organismi cellulari che vivono nell'ambiente di queste strane creature; questo sarà l'oggetto del proseguimento della ricerca.
Ma, se secondo molti scienziati LUCA non era molto di più di un assemblaggio di molecole in una zuppa primordiale, altri ritengono che esso avesse già una struttura alquanto complessa, simile a una cellula, e Manfred Seufferheld dell'Università dell'Illinois ritiene che i suoi studi più recenti facciano pendere la bilancia a favore di quest'ultima possibilità. Secondo lui, l'elemento chiave è rappresentato da un organello presente in tutti e tre i domini della vita: batteri, archea ed eucarioti. « L'esistenza di un organello nei batteri va contro la definizione classica di questi organismi », ha osservato Seufferheld: « era un dogma della microbiologia che gli organelli non fossero presenti nei batteri ». Ma nel 2003 Seufferheld e colleghi hanno mostrato, lavorando su Agrobacterium tumefaciens, che nei batteri la struttura di stoccaggio dei polifosfati è fisicamente, chimicamente e funzionalmente la stessa di un organello presente in molti eucarioti unicellulari, l'acidocalcisoma. Questa eccezionale scoperta indica che gli acidocalcisomi potrebbero essere sorti prima della divergenza delle linee filogenetiche dei (batteri) e degli eucarioti. Il nuovo studio di Seufferheld suggerisce che le origini dell'organello siamo ancora più antiche, tracciando la storia evolutiva di un enzima (la H+-pirofosfatasi vacuolare) comune negli acidocalcisomi delle cellule eucariotiche e batteriche, ma presente anche negli Archaea. Mettendo a confronto le sequenze genetiche relative a questo enzima in centinaia di organismi che rappresentano i tre domini della vita, Seufferheld ha ricostruito un albero genealogico che mostra le relazioni delle sue diverse versioni in organismi diversi, ed esso è straordinariamente simile all'albero della vita universale da noi riportato qui sopra. L'enzima e l'acidocalcisoma sono quindi molto antichi e risalgono a LUCA, ossia a prima della separazione dei tre rami principali dell'albero della vita.
« Ci sono molti possibili scenari che potrebbero spiegare questo dato, ma il migliore, il più economico e più probabile è che l'enzima fosse già presente anche prima della diversificazione iniziata sulla Terra », hanno dichiarato i coautori della ricerca Gustavo Caetano-Anollés e James Whitfield. « Alcuni hanno sostenuto che la ragione per cui i batteri sono così semplici è perché devono vivere in ambienti estremi e si devono riprodurre in modo molto rapido. Così potrebbero in effetti possedere versioni ridotte di quello che c'era in origine. In questa prospettiva sarebbero diventati geneticamente e strutturalmente più snelli di quanto non lo fossero originariamente. Forse abbiamo sottovalutato quanto possa in realtà essere complesso questo antenato comune. »
Il "grande evento di ossidazione"
Come si è detto, i primi esseri viventi erano eterotrofi, ma tale condizione, semplice e a prima vista molto conveniente, sarebbe risultata a lungo andare controproducente: una volta esaurite le « scorte alimentari » dell'ambiente circostante, gli eterotrofi si sarebbero infatti necessariamente estinti. Il processo evolutivo superò questo ostacolo con la realizzazione di un meccanismo di nutrizione più sofisticato: alcuni batteri primitivi (cianobatteri) diedero infatti vita ai primi organismi autotrofi, cioè capaci di sintetizzare in modo autonomo le sostanze nutritive organiche a partire da semplici sostanze inorganiche, come l'anidride carbonica e l'acqua, mediante un processo detto fotosintesi, che sfrutta direttamente l'energia della luce solare. In tal modo, con lo sviluppo degli autotrofi, gli eterotrofi hanno potuto proseguire la loro evoluzione, avendo a disposizione gli autotrofi come nutrimento. Non sappiamo come questo sia avvenuto, ma sappiamo con certezza che era già avvenuto circa 2,4 miliardi di anni fa (il 20 giugno): a quell'età risalgono infatti le rocce sedimentarie (selci) di Gunflint in Canada, nelle quali compaiono le primissime e semplici cellule procariote, cioè prive di un nucleo delimitato da una vera e propria membrana, ed il cui materiale dnatico è semplicemente contenuto nel citoplasma della cellula. Questi organismi pionieri furono le alghe verdazzurre.
La clorofilla le rendeva capaci di trasformare l'anidride carbonica, di cui l'atmosfera abbondava, in ossigeno, che esse riversarono negli oceani e nell'atmosfera. Furono proprio quelle prime, eroiche alghe unicellulari, viventi in un ambiente ostile e tenebroso, a cambiare per sempre il volto del pianeta, perché la produzione di ossigeno rese l'atmosfera respirabile, e ciò avrebbe permesso alla vita di diffondersi ovunque, invadendo tutti gli ambienti. La produzione d'ossigeno da parte di questi organismi vegetali, inoltre, cambiò la composizione degli strati gassosi che avvolgevano la crosta terrestre, formando lo strato d'ozono che ancora oggi, a dispetto delle azioni dell'uomo, protegge la Terra dalle radiazioni solari nocive alla vita. Questo notevole aumento della concentrazione di O2 libero è stato chiamato dai geologi il "grande evento di ossidazione". L'ossigeno libero permise l'evoluzione di strutture più complesse (le cosiddette cellule eucariote), con un nucleo che conteneva il materiale genetico e incorporati altri organelli che rendevano più efficiente il processo respiratorio.
Secondo alcuni geologi poi l'atmosfera terrestre è ricca di ossigeno grazie all'evoluzione geochimica della crosta terrestre. Matthijs A. Smit, dell'Università della British Columbia, e Klaus Mezger, dell'Università di Berna, hanno studiato i risultati delle analisi di oltre 48.000 campioni di roccia risalenti a miliardi di anni fa, ricostruendo la geochimica delle formazioni da cui provengono. Prima del grande evento di ossidazione, i continenti erano composti da rocce povere di silice e ricche di magnesio, simili a quelle che si trovano oggi in luoghi come l'Islanda e le Isole Fær Øer, che però contenevano livelli elevati di olivina, un minerale che a contatto con l'acqua reagisce catturando l'ossigeno che vi è presente. L'ossigeno prodotto dai cianobatteri all'inizio della storia della Terra non poteva quindi accumularsi negli oceani. Ma via via che la crosta continentale si è evoluta, grazie in primo luogo alla tettonica delle placche, per assumere una composizione sempre più simile a quella odierna, l'olivina è quasi scomparsa. Senza quel minerale, l'ossigeno si è rapidamente accumulato negli oceani e quando questi sono divenuti saturi, l'ossigeno ha iniziato a diffondersi nell'atmosfera. Dopo questo cambiamento la Terra è diventata molto più abitabile e adatta all'evoluzione della vita complessa.
Di quell'epoca remota in cui l'atmosfera era quasi priva d'ossigeno ci restano le stromatoliti, la più antica delle quali è stata trovata a Isua, in Groenlandia, da Allen Nutman dell'Università di Wollongong (Australia), e risale a 3 miliardi e 700 milioni di anni fa (alle nove di sera del 6 marzo): si tratta di veri e propri cuscini rocciosi formati da alghe fossili fortemente legate le une alle altre nei bassi fondali marini dove la luce solare consentiva loro la fotosintesi: come si è già detto ce ne restano delle testimonianze in Australia, presso la Shark Bay. Nonostante tutto questo, comunque, la Terra dell'Archeano appariva al più come una grande distesa deserta di acque, senza pesci né cetacei né uccelli ad animarla, dalla quale emergevano isole e protocontinenti, anch'essi senza una traccia di vegetazione sulle nude e aguzze rocce. Nella notte dei tempi, insomma, il mondo appariva come un desolato deserto, rosolato dai raggi di un sole assai più grande e caldo dell'attuale, e flagellato da violente tempeste che frantumavano le rocce vulcaniche, dando vita ai primi strati sedimentari ed alle prime arenarie. Il giorno durava solo otto ore, perchè la Terra girava su se stessa assai più rapidamente di quanto non fa ora, e la Luna era ancora molto vicina alla sua superficie, provocando accentuati effetti mareali. La scintilla della vita era confinata negli oceani, sotto forma di alghe verdazzurre, ed un esploratore alieno avventuratosi sul nostro pianeta in quell'era remota probabilmente non la avrebbe individuata senza analisi approfondite degli oceani, e se ne sarebbe andato catalogando la Terra tra i mondi aridi e disabitati, indegni di una citazione qualunque sull'Enciclopedia Galattica.
Eppure alcuni non concordano con una visione così desolante dell'eone archeano, durato ben 180 giorni del nostro Anno della Terra. Nel marzo 2006 infatti, sulla nota rivista internazionale di geoscienze « Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology » (Vol. 232, pag. 99), alcuni ricercatori del « Nordic Center for Earth Evolution » dell'Università di Copenaghen, guidati dal professor Minik Rosing, hanno pubblicato una teoria rivoluzionaria, secondo la quale i continenti primigenii si sarebbero formati circa 3,8 miliardi di anni fa (il 26 febbraio dell'Anno della Terra), non esclusivamente per effetto dei grandi processi geodinamici sopra descritti come si pensava finora, ma grazie all’energia chimica fornita dai primi microorganismi viventi. Rosing e i suoi collaboratori, che hanno già acquistato fama internazionale alcuni anni fa per avere localizzato i più antichi resti fossili di organismi fotosintetici a Isua, nella Groenlandia meridionale, affermano che « sarebbero stati proprio le alghe e i batteri fotosintetici a modificare i cicli geochimici della giovane Terra, avviando il processo di trasformazione di parte dei basalti in graniti, rocce a più bassa densità, che sono emerse formando i protocontinenti ». L’ipotesi è piuttosto ardita, sicuramente affascinante ma anche priva (almeno per ora) di alcun riscontro sul campo. « L’idea è innovativa e immaginativa », hanno commentato infatti molti insigni geologi, « ma le evidenze per sostenere un così decisivo ruolo della nascente vita nella formazione dei continenti sono per ora troppo deboli ».
|
|
|
Panorama della Terra durante il Precambriano, acquerello di Sandro Degiani |
Inside-out
In che modo le cellule alla base di ogni forma di vita complessa, le cosiddette cellule eucariote, si sarebbero evolute da cellule più semplici, le cosiddette cellule procariote? La teoria attualmente più accreditata fu proposta nel 1967 da Lynn Margulis (1938-2011): le cellule eucariote, composte da numerosi organelli e da un nucleo dotato di una propria membrana interna, si sarebbero sviluppate in seguito a un processo di endosimbiosi, cioè all'adattamento alla vita all'interno di una cellula procariota, come un batterio (o più probabilmente un archeobatterio), di altri organismi unicellulari. La teoria della Margulis offre una buona spiegazione della formazione dei mitocondri, che hanno un DNA distinto da quello della cellula che li ospita, segno del fatto che un tempo erano organismi separati e autonomi. Tuttavia, la stessa teoria non chiarisce l'origine degli altri organelli cellulari come il reticolo endoplasmatico e l'apparato di Golgi, né la presenza della membrana del nucleo, né l'assenza di forme cellulari intermedie dotate di alcuni ma non di tutti gli organelli delle cellule eucariote.
Queste difficoltà, osservano i cugini Buzz e David Baum, rispettivamente dello University College di Londra e dell'Università del Wisconsin, possono essere superate se si immagina un processo inverso, descritto dalla teoria che i due scienziati chiamano "inside-out". Il nome è dovuto al fatto che secondo la loro teoria gli eventi determinanti per la formazione della cellula eucariota sarebbero avvenuti al di fuori della cellula ancestrale, e non dentro di essa. La differenza tra la teoria dell'endosimbiosi e quella dell'inside-out è spiegata da David Baum con una metafora: « Una cellula procariota può essere immaginata come una fabbrica composta da un grande edificio aperto in cui manager, operai, impiegati, inservienti lavorano tutti fianco a fianco; una cellula eucariotica è invece come un complesso industriale composto da spazi di lavoro diversi collegati: un'unica sala di controllo e diverse sale specializzate per ricezione, produzione, trasporto, smaltimento dei rifiuti. Le teorie tradizionali propongono che il complesso industriale sia sorto quando all'interno di un singolo grande edificio sono state costruite diverse partizioni. La teoria inside-out, al contrario, immagina che intorno a un edificio centrale originario, poi diventato la sala di controllo, sia stata aggiunta una serie di ampliamenti, con il progressivo trasferimento di molte funzioni nei nuovi spazi specializzati. »
Secondo i Baum, tutto sarebbe iniziato con un archeobatterio la cui membrana era dotata di protuberanze, in cui potevano rimanere intrappolati batteri. Grazie all'energia acquisita stando a stretto contatto con questi batteri e allo sfruttamento di lipidi di derivazione batterica, questi archeobatteri sarebbero stati in grado di ingrandirsi e creare protuberanze di maggiori dimensioni. Dalla fusione di protuberanze fra loro vicine sarebbe quindi nata la membrana cellulare, mentre dalla parte esterna della membrana ai lati delle protuberanze si sarebbe formato il reticolo endoplasmatico e da quella interna la membrana esterna del nucleo. La membrana esterna originale dell'archeobatterio invece sarebbe diventata quella che chiamiamo membrana nucleare interna.
Un'altra ipotesi rivoluzionaria è stata avanzata da Abderrazak El Albani dell'Università di Poitiers, sulla base della scoperta, avvenuta nel 2010 in Gabon, di 250 fossili in ottimo stato di conservazione: a giudicare da essi, i primi organismi pluricellulari sarebbero comparsi sulla Terra già 2,1 miliardi di anni fa (nel pomeriggio del 14 luglio), mentre fino ad oggi si pensava che fossero apparsi solo un miliardo e mezzo di anni dopo (quattro mesi dopo), nel Proterozoico. Secondo i ricercatori è possibile che a consentire lo sviluppo e la sopravvivenza delle nuove forme di vita multicellulari scoperte in Gabon sia stato proprio il Grande Evento di Ossidazione descritto sopra. Abderrazak El Albani e collaboratori hanno fatto ricorso a una sofisticata tecnica di scansione tridimensionale, la microtomografia a raggi X, per ricostruire con buona precisione la struttura interna dei fossili senza danneggiarli. La struttura regolare e chiaramente definita ha mostrato la natura multicellulare di questi organismi che vivevano in colonie. Studiando le rocce sedimentarie del sito di rinvenimento, i ricercatori hanno appurato che questi organismi vivevano in un ambiente marino a una profondità piuttosto bassa, fra i 20 e i 30 metri, solitamente tranquillo, ma periodicamente soggetto all'effetto combinato di maree, onde e tempeste. Se sarà confermata, si tratterà di una scoperta davvero esplosiva!
Ma c'è anche chi si è spinto più in là. In un articolo pubblicato su "Nature" nel 2004 William Dietrich, dell'Università della California a Berkeley, si è chiesto quale sarebbe l'aspetto della Terra se non avesse mai ospitato la vita. Dietrich ipotizza che la vita sulla Terra abbia potuto avere effetti molto più profondi del semplice cambiamento della composizione dell'atmosfera (l'immissione di ossigeno mediante la fotosintesi) e della formazione delle rocce fossilifere. « Sulla Terra, i processi descritti dalla tettonica a zolle dipendono da una zona a bassa viscosità del mantello superiore su cui le zolle possono scivolare, e si è ipotizzato che questa zona emerge dalle iniezioni di acqua in corrispondenza delle zone di subduzione. È possibile che la comparsa della vita sulla Terra abbia impedito lo sviluppo di condizioni atmosferiche favorevoli all'erosione del vento solare, mantenendo "umido" il pianeta e consentendo la dinamica della tettonica a zolle? La dinamica della Terra e una conseguenza della vita sulla Terra? »
Se l'ipotesi fosse corretta, la vita potrebbe aver salvato la Terra dal trasformarsi in un'altra Venere: accumulando milioni di tonnellate di anidride carbonica nelle loro conchiglie, innumerevoli milioni di miliardi di minuscole creature marine potrebbero aver impedito, nel corso degli eoni, un massiccio aumento di CO2 nell'atmosfera e il conseguente, incontrollabile, effetto serra, che sembra essere accaduto su Venere. Forse si potrebbe davvero considerare la Terra un pianeta "vivo", cioè un sistema biologico legato agli organismi che vivono sulla sua superficie dalla stessa relazione che lega la conchiglia alla chiocciola!
I microbi che riscaldarono la Terra
Sulla Terra primordiale c'erano oceani liquidi, eppure il nostro Pianeta avrebbe dovuto essere interamente ghiacciato, dato che la radiazione solare dell’epoca era molto inferiore di quella attuale. Il paradosso, formulato dall’astronomo Carl Sagan (1934-1996), ha trovato a fine 2019 una possibile soluzione: a scaldare il pianeta, rendendo la temperatura abbastanza alta da sostenere la vita, sarebbe stato l'effetto serra dovuto a un'alta concentrazione di metano, prodotto da alcuni microbi dell'epoca trasformando la biomassa lasciata da altri microbi, insieme a ingenti depositi di ferro. A sostenerlo è stata una collaborazione internazionale di ricercatori guidati da Sean Crowe, dell’Università di Alberta a Vancouver, in Canada, che ha studiato alcuni batteri che vivono in un lago ricco di ferro nella Repubblica Democratica del Congo. Questi batteri hanno la capacità di sopravvivere in un ambiente privo di ossigeno, convertendo l’energia solare in ossido ferrico e biomassa, grazie a una reazione fotosintetica chiamata fotoferrotropia.
Grazie a una serie di sperimentazioni con batteri fotoferrotropi, Crowe e colleghi hanno scoperto che, in condizioni di alte concentrazioni di silicio come quelle degli oceani di miliardi di anni fa, questi batteri espellono l’ossido ferrico. Questo avrebbe portato alla formazione di ampi depositi di ferro (i cosiddetti banded iron bed, visibili ancora oggi) e di biomassa lungo le coste. Altri microbi avrebbero poi convertito questa biomassa in metano, che probabilmente ha mantenuto calda l’atmosfera terrestre primordiale, anche se il Sole era molto meno luminoso di oggi.
Trova così conferma sperimentale un’ipotesi formulata originariamente nel 1987 da James Walker, fisico dell’atmosfera dell’Università del Michigan, secondo cui, durante l'Archeano, sulla Terra si sarebbe formata un’atmosfera ricca di metano in concomitanza con la costituzione di depositi di ferro su larga scala. Questi studi che utilizzano moderni strumenti e tecniche geomicrobiologiche stanno trasformando la nostra visione della storia antica della Terra e dei processi che hanno portato a un pianeta abitabile dalla vita complessa, compresi gli esseri umani. La conoscenza dei processi chimici e fisici attraverso i quali i batteri interagiscono con l'ambiente circostante può anche essere utilizzata per sviluppare nuovi processi per il recupero delle risorse, nuovi materiali da costruzione e nuovi approcci terapeutici per le malattie.
E se l'energia nucleare avesse svolto un ruolo nel passato remoto del pianeta? L'ipotesi suggestiva è stata proposta da Jay Cullen dell'Università di Victoria, nella British Columbia canadese. Tra 3 e 2,5 miliardi di anni fa l'ossigeno prodotto dai batteri presenti nelle acque delta Terra ha iniziato a raggiungere l'atmosfera, e l'uraninite o pechblenda, un minerale dell'uranio di formula chimica UO2, ha iniziato a scomparire. Secondo Cullen i due eventi sono collegati: l'ossigeno avrebbe dissolto l'uraninite, liberando uranio a sufficienza da innescare diversi reattori nucleari naturali, come quello scoperto a Oklo, in Gabon, che avrebbero fornito calore alle prime forme di vita dell'epoca. Se fosse vero, sarebbe un'incredibile riabilitazione postuma dell'energia nucleare, dopo l'ostracismo cui è stata costretta negli ultimi anni!

|
| Una roccia vecchia di 2,7 miliardi di anni del cratone australiano di Pilbara (Cortesia Roger Buick, Università di Washington) |
Non basta. Nel 2020 uno studio condotto da Timmons M. Erickson, del Johnson Space Center della NASA, e colleghi della Curtin University di Perth, ha dimostrato che il cratere di Yarrabubba, situato in Australia, non lontano dalla costa occidentale dell'isola, è il cratere da impatto più antico della Terra, con un'età di due miliardi e 229 milioni di anni (risale alle cinque del mattino del 4 luglio). Il cratere è poco visibile, sebbene abbia un diametro di 70 chilometri, perché i suoi bordi sono stati erosi dagli agenti atmosferici. A tenere traccia della sua storia, però, ci sono le impattiti, rocce fuse nel momento dell'impatto con il meteorite e nuovamente cristallizzatesi poco dopo. I ricercatori hanno studiato le concentrazioni di uranio e piombo in queste rocce, in particolare negli zirconi, e così, risalendo al periodo della cristallizzazione, hanno potuto datare l'impatto. Ma c'è di più: l'età di Yarrabubba coincide con la fine delle glaciazioni a metà dell'Archeano, circa 2,5 miliardi di anni fa. I modelli rivelano che, vista la grandezza del cratere, il meteorite potrebbe aver generato l'emissione di oltre 200.000 miliardi di chilogrammi di vapore acqueo in atmosfera, modificando il clima e contribuendo al riscaldamento del pianeta e alla fine dell'era glaciale.
La taglia della vita
Prima di passare al Proterozoico vale la pena di affrontare un problema oggi molto dibattuto tra gli studiosi. Da quando è documentata l'esistenza della vita sulla Terra, le dimensioni degli organismi viventi sono passate da quelle microscopiche dei batteri a quelle delle sequoie giganti e delle balene. Indubbiamente è stata un'evoluzione dal semplice al complesso. Quello che ha messo in evidenza però una ricerca condotta con la collaborazione di una decina di istituzioni scientifiche internazionali, tra cui la Stanford University (Palo Alto, California), è che l'incremento delle dimensioni degli organismi viventi non è stato affatto graduale, ma ha avuto due distinti scatti, durante le ere geologiche, in cui ha subito una brusca accelerazione. E questo è accaduto in corrispondenza di due incrementi dell'ossigeno libero nell'atmosfera. Questi due intervalli di tempo, in cui la vita è diventata "più grande", occupano soltanto il 20 % di tutta l'intera storia degli esseri viventi sulla Terra. La maggior parte del tempo è trascorso "mantenendo le posizioni" ma senza sostanziali accrescimenti. « Abbiamo rivisto tutte le conoscenze esistenti dai più vecchi e ancora controversi fossili di batteri nelle rocce di 3,5 miliardi di anni fa ai più grandi animali e piante di oggi », dice Michal Kowalewski dell'Università della Virginia. « È stata una vera sorpresa osservare che quasi tutti gli incrementi delle dimensioni delle specie viventi sono avvenute in due distinti intervalli di tempo che hanno seguito i due maggiori eventi in cui sulla Terra si è avuto un aumento della concentrazione di ossigeno atmosferico ». Ecco cosa è accaduto: da circa 3,5 miliardi a 2,4 miliardi di anni fa (dal 23 marzo al 20 giugno) sono stati trovati solo batteri fossili. Le massime dimensioni che i batteri possono raggiungere sono molto limitate, di conseguenza anche le massime dimensioni della vita non poterono cambiare finché non si evolsero organismi più complessi. E questo accadde appunto 2,4 miliardi di anni fa.
A quest'epoca risalgono infatti il "grande evento di ossidazione" e l'ascesa degli eucarioti. Ebbene, questi ultimi hanno potuto raggiungere dimensioni anche un milione di volte maggiori di ogni altro organismo che li aveva preceduti, passando in 200 milioni di anni da esseri invisibili a occhio nudo, quali i batteri, a esseri grandi come una moneta. La vita però languì per un altro miliardo di anni (sulla Terra erano presenti solo unicellulari), finché intorno a 540 milioni di anni fa (il 18 novembre) l'ossigeno atmosferico ebbe un ulteriore incremento raggiungendo la concentrazione di circa il 10 % rispetto a quello attuale. L'evento permise processi metabolici più efficienti: gli esseri viventi divennero pluricellulari. La loro taglia passò, in circa 100 milioni di anni da quella di una moneta a quella dei calamari giganti marini, lunghi oltre 10 metri, con un altro incremento di circa un milione di volte. E già allora si raggiunsero dimensioni delle forme viventi paragonabili sia a quelle dei dinosauri che a quelle degli esseri più grandi oggi esistenti sulla Terra: la balenottera azzurra e le sequoie giganti (la massima conosciuta misura 112,11 metri). Da allora, per quanto riguarda le dimensioni, non ci sono più stati grandi balzi. Per il futuro, i ricercatori giungono alla conclusione che gli esseri viventi sono sostanzialmente già giunti ai limiti massimi imposti dalle dimensioni stesse del pianeta, per cui è improbabile che si ingrandiranno ancora.
Il ruolo del nichel
In realtà, com'è facile intuire, gli antenati delle odierne piante avevano iniziato a produrre ossigeno grazie ai processi di fotosintesi molto prima del "grande evento di ossidazione", ma esso veniva costantemente eliminato nel corso di reazioni con le rocce e soprattutto con i gas emessi dai vulcani. Perchè invece circa 2,4 miliardi di anni fa il tasso di ossigeno nell'atmosfera subì un notevole balzo in avanti, stabilizzandosi attorno all'attuale 21 % ? Le cause di questo "balzo" non erano mai state completamente chiarite, fino alla ricerca di alcuni geologi della Carnegie Institution e dell'Università dell'Alberta di Edmonton, in Canada, guidati da Kurt Konhauser. Essi hanno scoperto che per facilitarlo è stato determinante il crollo dei livelli di nichel nelle acque marine. Come hanno spiegato in un articolo pubblicato su Nature, i ricercatori hanno analizzato gli elementi in traccia nelle rocce sedimentarie note come formazioni di ferro a bande (BIF, Banded-Iron Formations) di decine di differenti località sparse per il mondo e di età compresa i 3800 e i 550 milioni di anni (dal 26 febbraio al 17 novembre). La formazioni di ferro a bande sono depositi lasciati dall'acqua pressoché unici, che si ritrovano in strati di rocce estremamente antiche, formatesi prima che l'atmosfera terrestre e gli oceani si arricchissero di ossigeno. Come dice il loro nome, si tratta di strati alternati di ferro e silicati che contengono anche piccole quantità di nichel e di altri elementi.
Oggi il nichel è presente nelle acque degli oceani solamente in traccia, ma negli oceani primordiali esso era fino a 400 volte più abbondante. In un ambiente di questo tipo, i microrganismi produttori di metano, detti metanogeni, devono avere prosperato: a loro volta gli elevati livelli di metano in atmosfera da essi prodotti impedivano l'accumulo di ossigeno in atmosfera, reagendo con esso per dare origine a biossido di carbonio e acqua. Un crollo nella concentrazione del nichel può aver portato a uno stato di "denutrizione" i batteri metanogeni, che hanno bisogno di questo elemento per la produzione di enzimi chiave nei loro processi metabolici.
I microrganismi fotosintetici produttori di ossigeno, che sfruttano altri enzimi, sarebbero stati invece molto meno influenzati dalla diminuzione del nichel. In questo modo il livello di metano atmosferico sarebbe molto diminuito, mentre continuava l'aumento della percentuale di ossigeno. Konhauser e colleghi hanno scoperto che i livelli di nichel hanno iniziato a diminuire circa 2,7 miliardi di anni fa (il 27 maggio), e che 2,5 miliardi di anni fa (il 12 giugno) erano già ridotti alla metà del loro valore originario. "La linea temporale corrisponde perfettamente: il crollo del nichel può avere aperto al strada al grande evento di ossidazione. E, per quanto sappiamo degli organismi metanogeni, i bassi livelli di nichel devono avere drasticamente ridotto la produzione di metano", ha dichiarato Konhauser.
All'origine del crollo delle concentrazioni di nichel c'è stato probabilmente il progressivo raffreddamento del mantello terrestre, che ha determinato un cambiamento nella composizione delle lave eruttate dai vulcani e quindi dilavate negli oceani. "La concentrazione di nichel non era stata finora presa in considerazione: oggi è solo un elemento in traccia, ma i nostri studi indicano che esso ha avuto un enorme impatto sull'ambiente terrestre e sulla storia della vita", ha concluso Konhauser.
Il ruolo del molibdeno
Ma esiste anche una teoria diametralmente contraria. Secondo Clint Scott dell'università della California a Riverside, La vita animale sulla Terra sarebbe comparsa con un ritardo di due miliardi di anni a causa di una deficienza di ossigeno e di un metallo pesante, il molibdeno, nelle profondità dell'oceano. Scott e il suo gruppo di ricerca hanno raccolto dati relativi al molibdeno, un metallo oligonutriente necessario a molte forme di vita, e ai materiali organici contenuti nei campioni di argillite nera prelevata negli oceani, una roccia che, contenendo resti di questi due materiali, è preziosissima per ricostruire la storia dell'ossidazione degli oceani. Dopo la crescita dell'ossigeno nell'atmosfera, 2,4 miliardi di anni fa (il 20 giugno dell'Anno della Terra), cominciò anche l'aumento dell'ossigenazione degli oceani per supportare la domanda di questo gas da parte dei microrganismi. Tuttavia, la varietà di queste singole forme di vita monocellulari restò bassa e i loro discendenti pluricellulari non comparvero prima di 600 milioni di anni fa (il 13 novembre). Monitorando le quantità di molibdeno negli antichi sedimenti marini nel tempo, Scott ha trovato che l'intervallo fra i primi organismi monocellulari e le forme di vita più complesse è coinciso con una significativa diminuzione del molibdeno negli oceani confrontata agli alti livelli misurati oggi. Inoltre lo studio ha evidenziato che bisogna aspettare la fine del Precambriano perché le profondità degli oceani diventino più ossigenate e i cicli biochimici si stabilizzino, così da creare i presupposti per la comparsa dei primi grandi organismi pluricellulari e dare l'avvio all'evoluzione della vita sulla Terra. Una proposta davvero affascinante, che ci fa interrogare su quante variabili hanno influito davvero sull'evoluzione della vita sulla Terra.
I risultati di tutte queste ricerche sono rilevanti per gli studi sull'ambiente e sul clima odierno, in quanto ci aiutano a comprendere le interazioni fra biologia, geologia e composizione dell'atmosfera, ma hanno profonde implicazioni anche nella ricerca della vita su altri pianeti all'esterno del nostro sistema solare. Infatti l'unico modo in cui potremo cercare prove dell'esistenza di vita in luoghi così remoti è quello di cercare le "impronte digitali" di fenomeni biologici nella composizione delle loro atmosfere.
Un reattore nucleare nel Precambriano
Il 2 giugno 1972 nell’impianto nucleare francese di
Pierrelatte si scoprì che alcuni campioni di
minerale di uranio proveniente dalla miniera di Oklo, nel Gabon,
conteneva lo 0,44 % di Uranio 235 (fissile), mentre
invece il normale rapporto isotopico tra Uranio 235 e Uranio 238 riscontrabile
in natura è dello 0,72 % (infatti la  maggior
parte dei reattori nucleari moderni richiede che l'uranio sia
"arricchito" in fissile fino al 3 %.
Questo anomalo rapporto isotopico, caratteristico del combustibile esausto
estratto dai noccioli dei moderni reattori, può avere una sola spiegazione:
l'Uranio 235 mancante era stato "bruciato" in un reattore nucleare nel
lontano passato geologico della Terra.
maggior
parte dei reattori nucleari moderni richiede che l'uranio sia
"arricchito" in fissile fino al 3 %.
Questo anomalo rapporto isotopico, caratteristico del combustibile esausto
estratto dai noccioli dei moderni reattori, può avere una sola spiegazione:
l'Uranio 235 mancante era stato "bruciato" in un reattore nucleare nel
lontano passato geologico della Terra.
Tale spiegazione può apparire quanto meno bizzarra, ma non è necessario ipotizzare extraterrestri intelligenti che nell'Archeano abbiano colonizzato il nostro pianeta allestendovi addirittura un reattore nucleare. Infatti l'Uranio 235 e l'Uranio 238 hanno differenti periodi di dimezzamento, rispettivamente 704 milioni e 4,47 miliardi di anni. Pertanto, visto che il 235 decade più in fretta del 238, ne consegue che la composizione isotopica dell'uranio è variabile nel tempo. Un facile calcolo rivela che circa due miliardi di anni fa (il 22 luglio dell'Anno della Terra) la percentuale di Uranio 235 era pari proprio al 3 %, ossia all'incirca quella degli odierni reattori nucleari ad acqua. A quel tempo il luogo dove oggi si trova la miniera di Oklo doveva essere ricco d'acqua, una sorta di palude che disciolse i sali di uranio (essi sono insolubile in acqua priva di ossigeno, ma evidentemente la palude pullulava di batteri ossigeno-produttori); l'acqua di palude agì da moderatore, cioè rallentò i neutroni prodotti dalle fissioni spontanee dell'Uranio 235 fino a un'energia tale da permettere loro di innescare una reazione a catena, reazione che è alla base del funzionamento di ogni moderno reattore. La prova definitiva del funzionamento del paleoreattore nucleare è stata fornita dalla scoperta, nelle rocce uranifere, di isotopi del neodimio (in particolare Neodimio 142 e Neodimio 143) e del rutenio (in particolare il Rutenio 99 e Rutenio 100), la cui abbondanza isotopica era molto vicina a quella originata dalla fissione dell'Uranio 235.
Si è scoperto così che ad Oklo sono entrati in funzione ben 17 reattori nucleari naturali, ed hanno subito fissione nucleare circa 5 tonnellate di Uranio 235, con una produzione di 6 tonnellate di prodotti di fissione e 2,5 tonnellate di Plutonio, rilasciando un'energia di circa 108 MegaWattora, vale a dire l'energia elettrica che un impianto da 1000 MegaWatt elettrici produce in oltre 11 anni di funzionamento! Probabilmente i reattori di Oklo hanno lavorato "ad intermittenza" per un periodo di tempo superiore al milione di anni: il calore sviluppato dalle reazioni provocava l'evaporazione dell'acqua che aveva funto da moderatore, interrompendo la reazione che ripartiva solo quando la riserva di acqua si era ricostituita. Successivamente è stato scoperto un altro paleoreattore nucleare a Bangombe, sempre nel Gabon, a 35 Km dal sito di Oklo.
I reattori di Oklo costituiscono un fenomeno naturale raro ed affascinante, il quale tra l'altro prova l'affidabilità del deposito geologico delle scorie nucleari in antiche miniere esauste, visto che molti prodotti delle reazioni nucleari, soprattutto quelli più pericolosi e a vita più lunga, sono rimasti praticamente immobilizzati nel sito fino ad oggi (tra l'altro il sito di Oklo non è certo ideale per il deposito geologico di scorie, a causa dell'alta porosità delle rocce e delle grandi quantità di acqua fluente, capace di sciogliere i pericolosissimi rubidio e cesio). Oggi un reattore naturale come quello di Oklo non potrebbe più assolutamente funzionare, poiché la percentuale isotopica è scesa abbondantemente sotto il livello minimo di innesco di una reazione moderata ad acqua. Tra l'altro lo studio del sito di Oklo ha di recente consentito una scoperta che, se confermata, scuoterebbe la nostra Fisica dalle fondamenta: un team di ricercatori del Los Alamos National Laboratory ha ipotizzato che la costante di struttura fine, inversamente proporzionale alla velocità della luce che è stata supposta fino ad oggi una costante immutabile della natura, avrebbe subito una riduzione; questo implicherebbe quindi che la velocità della luce avrebbe subito un’accelerazione! Solo il ventunesimo secolo potrà confermare o smentire queste rivoluzionarie ipotesi, scaturite dai resti geologici di un reattore nucleare avviatosi da solo nella notte dell'Archeano.
![]()
Il nome del periodo Proterozoico significa "della vita primitiva". In passato era noto anche come Algonchiano, dal nome della tribù degli Algonchini che abitava il territorio canadese dell’Ontario, dove per la prima volta sono state studiate rocce risalenti a questo periodo. Esso non è di facile datazione, ma sicuramente è durato molto a lungo, come si può dedurre dagli spessori medi delle sedimentazioni, pari a circa 20 chilometri. È diviso in tre periodi, a loro volta divisi in sottoperiodi che, come tutti quelli delle ere successive, traggono il loro nome da siti di riferimento:
| Proterozoico superiore o Paleoproterozoico | Proterozoico medio o Mesoproterozoico | Proterozoico inferiore o Neoproterozoico |
|
Sideriano |
Calymmiano |
Toniano |
|
Rhyaciano |
Ectasiano |
Criogeniano |
| Orosiriano |
Steniano |
Ediacarano |
| Statheriano |
|
|
La Commissione Internazionale di Stratigrafia (ICS). sta però ancora discutendo sulla durata cronologica e sulla divisione di questi periodi. Un tempo il Proterozoico veniva suddiviso invece in Careliano e Jotniano secondo alcuni, in Rifeano e Siniano secondo altri. In termini di Anno della Terra, esso dura più o meno dal 24 agosto alla mezzanotte del 17 novembre.
Il Medioevo geologico
Durante questo periodo l'attività vulcanica, testimoniata da formazioni laviche di migliaia di metri di spessore, fu sicuramente meno intensa del periodo Archeano. Le masse continentali risultanti dalla disgregazione di Rodinia si riunificarono alla fine del periodo in un nuovo supercontinente, detto Pannotia ("tutto a mezzogiorno") perchè arroccato attorno al polo sud terrestre, che però ebbe vita effimera.
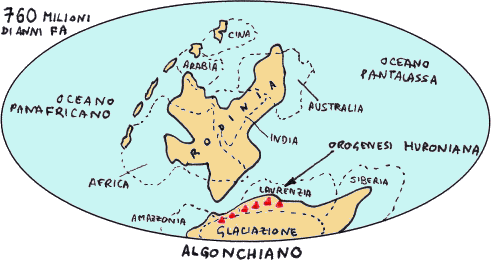
Negli oceani la proliferazione degli organismi autotrofi portò ad un forte incremento di ossigeno libero, che dall'idrosfera passava all'atmosfera: secondo alcune stime, verso la fine del Proterozoico la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera doveva essere tra l'1 % ed il 10 % di quella attuale. Nel corso del Proterozoico inferiore o Neoproterozoico, un periodo durato da 717 a 635 milioni di anni fa (dalle 20 del 3 novembre al mezzogiorno del 10 novembre), si sono verificate almeno due glaciazioni, rispettivamente note come glaciazione Sturtiana e Marinoana, così imponenti che il ghiaccio ha raggiunto addirittura le latitudini equatoriali.
Durante il Proterozoico, come vedremo, si situano alcune tappe essenziali della vita sulla Terra: la comparsa delle cellule eucariote, quella dei primi organismi pluricellulari e l'apparizione dei primi animali. Tuttavia, nel corso di esso la formazione di nuove montagne, fondamentali per alimentare il ciclo dei nutrienti, conobbe un lunghissimo periodo di stasi lungo quasi un miliardo di anni, cioè ben 80 giorni dell'Anno della Terra. Lo ha scoperto nel 2020 il geochimico cinese Ming Tang dell'Università di Pechino. In termini di tempo geologico, l'orogenesi è un processo pressoché effimero, i cui effetti sono presto vanificati dall'erosione degli agenti atmosferici, che permette la distribuzione dei nutrienti e dunque il sostentamento della vita. Tuttavia, dato che la crosta è in continua evoluzione, risalire al suo spessore di miliardi di anni fa è piuttosto difficoltoso. Per riuscirci, Ming Tang e colleghi hanno messo a punto un metodo di analisi basato sulle anomalie dell'europio, elemento chimico inglobato negli antichissimi zirconi. I risultati suggeriscono che, a differenza del precedente Archeano e del successivo Paleozoico, il Proterozoico fu caratterizzato da un'attività tettonica piuttosto pigra, che portò all'inesorabile erosione di quelle antichissime montagne, e quindi ad un costante declino dello spessore della crosta terrestre. Secondo Ming Tang, questa quiescenza potrebbe essere spiegata dalla presenza del supercontinente Rodinia, che avrebbe alterato la struttura termica del mantello terrestre. Venuto a mancare l'apporto di nuove sostanze nutritive, tra 1800 e 800 milioni di anni or sono (tra l'8 agosto e il 28 ottobre) negli oceani potrebbe essersi verificata una prolungata carestia, che avrebbe ritardato l'evoluzione della vita di quasi un miliardo di anni. Per questo il Proterozoico è stato definito anche il "Medioevo geologico della Terra".
Quando il giorno durava diciotto ore
Circa 1,4 miliardi di anni fa (alle 10.40 del 9 settembre), quando la Luna era molto più vicina al nostro pianeta di quanto non sia ora, un giorno terrestre durava solo 18 ore. È uno dei risultati dell’approfondita ricostruzione dell’antico passato della Terra e in particolare dell’evoluzione dell’orbita lunare, pubblicata nel 2018 da Stephen Meyers dell’Università del Wisconsin-Madison e colleghi. Per via della conservazione del momento angolare, infatti, via via che la Luna si allontana, la rotazione della Terra si fa più lenta. L’interazione gravitazionale con gli altri oggetti astronomici, siano essi i pianeti o la Luna, influisce in realtà su tutti i parametri della rotazione e della rivoluzione terrestre: l’eccentricità dell’orbita, l’inclinazione dell’asse e la sua precessione. Tutte queste variazioni sono note come cicli di Milanković, dal nome dell'ingegnere serbo Milutin Milanković (1879-1958), che determinano in che modo la luce solare si distribuisce sulla superficie del pianeta, e quindi l’alternanza di cicli climatici freddi (glaciazioni) e caldi (periodi interglaciali). E i ricercatori come Meyers osservano questi ritmi climatici nelle registrazioni geologiche nell’arco di centinaia di milioni di anni. « Una nostra ambizione era usare l’astrocronologia per raccontare il tempo nel passato più remoto, per sviluppare scale temporali geologiche molto antiche », ha affermato Meyers, « così da essere in grado di studiare rocce che hanno miliardi di anni in modo simile a quello che facciamo con i moderni processi geologici ».
Il problema per questo tipo di ricerche è sempre stato affrontare scale temporali più ampie, dell’ordine di miliardi di anni. Gli strumenti degli studi, in questo caso, non hanno la precisione necessaria per identificare i cicli. Inoltre il tutto è complicato dalla mancanza di conoscenza della storia della Luna e da quello che è chiamato il caos del sistema solare, una teoria elaborata nel 1989 dall’astronomo francese Jacques Laskar (1955-). In questa teoria il sistema solare, costituito da molte parti diverse, piccole variazioni nei movimenti possono dare origine a grandi cambiamenti nell’arco di milioni di anni. Meyers e colleghi hanno interpretato il caos del sistema solare in uno studio sui sedimenti di una formazione geologica di 90 milioni di anni fa (alle 16.48 del 24 dicembre), che registrava l’alternanza dei cicli climatici. Ma, ancora una volta, andando sempre più indietro nel tempo, il metodo forniva risultati poco affidabili. Per esempio, si stima che la Luna si stia allontanando dalla Terra al ritmo di 3,82 centimetri all’anno. Andando indietro nel tempo fino a 1,5 miliardi di anni fa (alle 8.00 del 1 settembre), la vicinanza sarebbe stata tale che l’interazione gravitazionale della Terra avrebbe fatto a pezzi la Luna, che però ha 4,5 miliardi di anni. La soluzione al problema è stata trovata da Meyers applicando un metodo da lui stesso sviluppato nel 2015 che combina teoria astronomica, dati astronomici e dati geologici, a due formazioni geologiche antiche: la prima della regione di Xiamaling, nel nord della Cina, risalente a 1,4 miliardi di anni fa, la seconda della Dorsale Walvis, nell’Atlantico meridionale, risalente a 55 milioni di anni fa (alle 9.20 del 17 novembre). Con questo approccio, Meyers e colleghi hanno potuto valutare in modo affidabile la correlazione tra variazioni degli strati geologici e cambiamenti nella direzione dell’asse di rotazione terrestre sia in epoche recenti sia in quelle remote miliardi di anni, fino a stimare con precisione la lunghezza del giorno terrestre di 1,4 miliardi di anni fa.
La Terra come una palla di neve
Vi sono indizi che in questo periodo geologico, 716,5 milioni di anni fa (le 21.13 del 3 novembre dell'Anno della Terra), si sia verificata sul nostro pianeta la più forte glaciazione mai verificatasi in tutta la storia della Terra, detta glaciazione Sturtiana, che avrebbe trasformato tutti gli oceani in una colossale banchisa, e tutti i continenti in una sterminata distesa di ghiacci; a quel periodo è stato assegnato il significativo nome di Criogeniano. I sostenitori di questa teoria la definiscono "Snowball Earth", cioè "Terra a palla di neve". Essi ritengono che tale glaciazione avrebbe avuto origine dagli sconvolgimenti tettonici dovuti alla transizione tra Rodinia e Pannotia: dalle rift valley e dalle dorsali oceaniche sarebbe fuoriuscita lava basaltica proveniente dal mantello terrestre, tale da ricoprire gran parte del granito che formava la superficie continentale. Ma il basalto, essendo una roccia porosa, viene eroso molto più facilmente del granito e pertanto, a parità di tempo, la quantità di basalto asportata dai fiumi è molto maggiore della corrispettiva in granito. Una volta dissolte in acqua, le componenti minerali delle rocce assorbono di norma una parte dell'anidride carbonica disciolta nell'acqua stessa; dopo essersi legati ad essa, i minerali tendono a precipitare sul fondale marino sotto forma di sedimenti. Questo fenomeno provocherebbe una carenza di anidride carbonica nelle acque marine, che verrebbe compensata dallo scioglimento in acqua di una grossa quantità di anidride carbonica proveniente dall'atmosfera: in pratica il mare la assorbirebbe come una vera e propria "spugna".
Ora, in seguito alla frantumazione di Rodinia, il consumo di anidride carbonica provocato dall'erosione del basalto sarebbe aumentato ad un livello tale da superare il quantitativo emesso nello stesso tempo dalle eruzioni vulcaniche, provocando così una netta diminuzione dell'effetto serra sul pianeta, dato che l'anidride carbonica è uno dei cosiddetti "gas serra", e quindi un generale raffreddamento delle temperature, sufficiente, secondo i calcoli, per congelare l'intero pianeta. Il ghiaccio, riflettendo la luce solare, avrebbe accelerato ulteriormente il raffreddamento del pianeta; così, più la superficie terrestre veniva coperta dal ghiaccio, più la temperatura sarebbe scesa, finché il ghiaccio sarebbe arrivato perfino all’equatore, poiché i modelli climatologici hanno previsto che se il ghiaccio marino si dovesse estendere entro 30 gradi di latitudine dall'Equatore, l’intero oceano ghiaccerebbe. La glaciazione Sturtiana sarebbe durata la bellezza di cinque milioni di anni (quasi dieci ore!).
Secondo i geologi della Harvard University, invece, all'origine della "Terra a palla di neve" ci sarebbe stato un effetto di "rimbalzo" successivo a un periodo di intesa attività vulcanica. Alan D. Rooney e colleghi hanno esaminato un affioramento dell'era Neoproterozoica sui Monti Mackenzie, nel Canada nord-occidentale, analizzando i sedimenti glaciologici per determinare non solo i livelli degli isotopi di uranio e piombo, secondo la classica tecnica di datazione geologica sulla base dei tempi di decadimento radioattivo dell'uranio 238 in piombo 206, ma anche quelli relativi ai tempi di decadimento del renio in osmio, elementi molto rari nella crosta terrestre, ma più abbondanti nel mantello, e quelli di stronzio. Grazie ai dati raccolti, i ricercatori sostengono che la glaciazione Sturtiana sarebbe durata ben 55 milioni di anni (quattro giorni e mezzo!), dai 717 a 662 milioni di anni fa! (dalle ore 20 del 3 novembre alle ore 7 dell'8 novembre) Il confronto con i dati relativi alle dinamiche di questi elementi nei sedimenti oceanici ha portato Rooney e colleghi a ipotizzare che la roccia fuoriuscita da grandi eruzioni di magma nel periodo precedente alla glaciazione Sturtiana si sia legata con l'anidride carbonica dell'atmosfera, che poi, così intrappolata, abbia finito per essere dilavata dalle acque e per depositarsi negli oceani. La rimozione di questo gas serra, che sarebbe durata molto tempo grazie alla progressiva erosione degli strati superficiali della roccia vulcanica e la messa a nudo di nuovi strati, si sarebbe quindi tradotta in una parallela rimozione di calore dall'atmosfera, portando così a un raffreddamento globale.
In uno studio pubblicato nel 2003 sulla rivista "Nature" il geologo Ganqing Jiang dell'Università della California di Riverside ha spiegato come il pianeta potrebbe essere uscito da questo periodo inospitale. Secondo Jiang, fu un forte rilascio di gas metano, e non di anidride carbonica, a innescare il meccanismo che ha consentito nuovamente il riscaldamento della Terra. Questo benedetto metano sarebbe venuto probabilmente da depositi oceanici diffusi nei sedimenti depositati in condizioni molto fredde, che sarebbero stati liberati sotto forma gassosa alla fine dell'era glaciale, riscaldando rapidamente il clima terrestre; Ganqing Jiang è convinto di averne trovato le prove dentro rocce raccolte nel sud della Cina. Del resto la sua teoria è in accordo con un'altra, proposta dai geologi Martin Kennedy e Nicholas Christie-Blick, secondo cui le caratteristiche da loro osservate in antichi sedimenti indicherebbero che proprio in quel periodo sarebbe avvenuto il più grande rilascio di metano della storia della Terra.
Non tutti ritengono possibile veramente che l'intera superficie terrestre possa essersi congelata senza spazzare via per intero la vita: ad esempio, secondo Richard Peltier dell'Università di Toronto, in quel periodo anzi la concentrazione dell'anidride carbonica atmosferica sarebbe addirittura aumentata, dando impulso ad un effetto serra che avrebbe impedito alla Terra di ghiacciarsi. Tuttavia Francis Macdonald, geologo della Harvard University, e collaboratori hanno pubblicato nel marzo 2010 un articolo sulla rivista "Science", nel quale sostengono di aver trovato le prove della "palla di neve", analizzando alcune formazioni rocciose presenti nel nordovest del Canada con tracce di morene glaciali: la misurazione del magnetismo e della composizione di tali rocce dimostrerebbe che al tempo della glaciazione Sturtiana esse si trovavano al livello del mare a circa 10 gradi di latitudine, quindi ai tropici.
I sostenitori della "Snowball Earth" sono a loro volta divisi tra quanti ritengono che essa abbia causato una terrificante estinzione di massa, la prima di una lunga serie, a scapito delle specie batteriche allora presenti nei mari terrestri, e quanti ritengono invece che da qualche parte sul pianeta la superficie marina doveva essere libera dai ghiacci, come suggerisce la sopravvivenza di organismi eucarioti. Secondo i primi, addirittura il 99 % delle forme di vita esistenti sulla Terra, per lo più batteri, si sarebbe estinta, mentre il restante 1 % sarebbe sopravvissuto grazie alle sorgenti calde sottomarine; secondo gli altri, invece, anche nel pieno della glaciazione Sturtiana sulla superficie terrestre erano presenti gradienti di temperatura, ed il ghiaccio marino lasciava spazio qua e là per il nascere della vita. In particolare Francis Macdonald ha affermato che « le registrazioni fossili fanno ipotizzare che tutti i maggiori gruppi eucarioti, con la possibile eccezione degli animali, esistevano già prima della glaciazione sturtiana. Anzi, forse fu proprio la glaciazione sturtiana a stimolare l'evoluzione e l'origine degli animali? Da una prospettiva evolutiva, sappiamo che per la vita sulla Terra non è negativo affrontare gravi stress. »
Infatti c'è chi ritiene che proprio la glaciazione Sturtiana potrebbe essere stata determinante per lo sviluppo e la diversificazione delle prime specie animali. Tra questi, un gruppo di ricercatori dell'Università della California a Riverside guidati da Noah Planavsky ritiene di aver trovato le prove geologiche di tutto ciò. Essi hanno tracciato le concentrazioni di fosforo nel corso della storia del pianeta, analizzando la composizione dei precipitati ricchi di ferro che si accumulano sul fondo dei mari asportando fosforo dall'acqua marina. Queste analisi hanno rivelato un marcato picco di concentrazione subito dopo l'evento glaciale Sturtiano. Per spiegare queste concentrazioni stranamente alte, essi hanno ipotizzato che l'aumento dell'erosione e del dilavamento dalle terre emerse collegati alla "Snowball Earth" siano stati i fattori che hanno portato all'accumulo di fosforo nell'oceano. L'abbondanza di questo nutriente essenziale per la vita, a sua volta, avrebbe portato a un picco nella produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi, e al suo accumulo in atmosfera, agevolando lo sviluppo degli animali e la loro diversificazione ecologica. Suggerendo un legame fra le estese glaciazioni del Proterozoico e l'inizio dell'evoluzione animale, questo lavoro ci induce a pensare che forse, oltre che della famosa "pozza calda", noi potremmo essere figli anche di una palla di neve...
Quando la Terra fu sul punto di perdere il campo magnetico
Un gruppo di ricercatori dell'Università di Rochester e dell'Università della California a Santa Cruz hanno scoperto che circa 565 milioni di anni fa (alle 4 del mattino del 16 novembre) il campo magnetico della Terra raggiunse la sua intensità più bassa, avvicinandosi al collasso: un evento che sarebbe stato catastrofico per lo sviluppo della vita, dato che è proprio la magnetosfera a proteggere il pianeta dalla letale pioggia di raggi cosmici e solari. Fortunatamente, la solidificazione del nucleo interno permise il riavvio della dinamo naturale che lo genera.
La storia termica della Terra, che governa numerosi processi, dal vulcanismo alla tettonica delle zolle alla generazione del campo geomagnetico, ha ancora diverse lacune, in particolare riguardo al momento in cui si sarebbe solidificato il nucleo interno. Quando le rocce magmatiche si solidificano, i minerali magnetizzabili che contengono conservano traccia dell'intensità e della direzione del campo magnetico terrestre a cui erano esposti in quel momento. Lo studio delle rocce formatesi in una certa epoca permette dunque di ricostruire qual era allora il campo magnetico terrestre (paleomagnetismo). Ebbene, analizzando frammenti di rocce provenienti da una delle più antiche formazioni rocciose esistenti, in Quebec, Richard K. Bono e colleghi hanno trovato all'interno di alcuni cristalli formatisi 565 milioni di anni fa alcune piccole inclusioni magnetiche. Dalla misurazione dell'intensità e della direzione del campo di queste inclusioni sono quindi risaliti al campo magnetico della Terra, scoprendo che in quella lontana epoca aveva raggiunto un'intensità estremamente bassa, mai riscontrata in precedenza, e apparentemente sulla strada dell'azzeramento.
Approfondendo le analisi hanno poi scoperto che in quel periodo il campo magnetico aveva avuto un comportamento anomalo sia per numero che per frequenza di inversioni. Le simulazioni eseguite dai ricercatori hanno mostrato che questi dati sono compatibili con uno scenario di solidificazione del nucleo interno, che ha così trovato una sua datazione. Secondo questa ricostruzione, quando il ferro fluido presente nel nucleo interno della Terra ha iniziato a solidificarsi, ha espulso gli elementi più leggeri, come il silicio e l'ossigeno, sospingendoli verso l'alto, nel nucleo esterno. Questo ha prodotto un movimento convettivo di risalita degli strati fluidi più leggeri del nucleo esterno. I moti convettivi sono poi diventati intensi con l'aumentare delle dimensioni del nucleo interno solido. A sua volta questo processo ha rimesso in moto la geodinamo terrestre, tornando a far aumentare l'intensità del campo magnetico. Per nostra fortuna, bisogna aggiungere!
L'eone criptozoico
Per tutta la durata dell'Archeano e del Proterozoico, la vita rimase per così dire "nascosta" nei proto-oceani ed a livello poco più che unicellulare, per cui quest'era è detta anche l'EONE CRIPTOZOICO ("della vita nascosta"). A partire dall'inizio del periodo Proterozoico è certa sulla Terra l'esistenza di batteri eucarioti, dei quali non si hanno testimonianze fossili precedenti. Essi possedevano una pellicola intorno al materiale genetico, e quindi un vero e proprio nucleo, oltre ai vacùoli di riserva, mentre la protezione di lipidi si era ridotta ad una parete più sottile e permeabile. Da alcuni di essi derivarono specie più complesse molto simili alle Cianofite, particolari tipi di alghe azzurre i cui fossili sono stati ritrovati a Bitter Springs (Australia), e che attualmente vivono nelle sorgenti termali, dove producono depositi ricchi di calcio e zolfo. Le cellule eucariote sono il preludio indispensabile per la comparsa di forme animali e di piante più complesse: infatti, a differenza di quanto avviene nei procarioti, negli eucarioti la forma di riproduzione comune è quella sessuale che, comportando uno scambio di materiale genetico, accresce la variabilità genetica delle popolazioni e crea pertanto un terreno molto favorevole all'evoluzione della vita.
Altre cellule si evolsero senza clorofilla, con una membrana cellulare senza parete cellulosica: erano i primi Protozoi, cioè in definitiva i primissimi Animali, conosciuti anche come Metazoi. La separazione di esseri viventi animali da quelli vegetali è avvenuta da 1,5 ad 1 miliardo di anni fa. Tale processo non può che essere stato lento, per cui, in un certo momento dell'evoluzione, si sono evolute forme di vita con caratteristiche né completamente vegetali, né completamente animali. Di questo processo si ha tutt'oggi testimonianza in esseri viventi di volta in volta catalogati come Protisti, Cromisti, Monere, ben distinti dagli animali e dai vegetali. A questo proposito sarà bene effettuare una breve carrellata sulla definizione successiva dei cosiddetti Regni della Natura.
|
Classificazione secondo: |
Procarioti |
Eucarioti |
|||||
|
Linneo (1735) |
ignoti |
Vegetali |
Animali |
||||
|
Haeckel (1894) |
Protisti |
Vegetali |
Animali |
||||
|
Whittaker (1969) |
Monere |
Protisti |
Funghi |
Vegetali |
Animali |
||
|
Woese (1977) |
Archea |
Batteri |
Protisti |
Funghi |
Vegetali |
Animali |
|
|
Cavalier-Smith (2004) |
Batteri |
Protozoi |
Cromisti |
Funghi |
Vegetali |
Animali |
|
Alle scuole elementari tutti ci hanno parlato di Regno Animale, Regno Vegetale e Regno Minerale. Ma, fatta eccezione per questi ultimi che non sono viventi, fin dai tempi di Linneo stesso ci si accorse che non tutti gli esseri viventi potevano essere catalogati nella stessa congregazione delle betulle o dei coccodrilli. Già nel 1894 il biologo tedesco Ernst Haeckel (1834-1919) decise di introdurre un terzo Regno, quello dei Protozoi o Protisti (dal greco Protos, "primo"), che lui riteneva i primissimi esseri viventi comparsi sul pianeta Terra. La suddivisione fu accettata fino al 1969, quando il botanico statunitense Robert Harding Whittaker (1920-1980) propose di scindere i Protisti in due, scorporando da esso il regno delle Monere, che comprendeva gli organismi procarioti, mentre gli eucarioti continuavano a chiamarsi Protisti o Protozoi; Whittaker elevò a regno anche i Funghi, ritenendoli troppo diversi dai vegetali per includerli nello stesso regno; e così i regni divennero cinque. Stavolta la classificazione andò bene solo fino al 1977, quando l biologi statunitensi Carl Richard Woese (1928-vivente) e George Edward Fox (1945-vivente) decisero di spezzare a sua volta in due il regno delle Monere, dividendolo in Batteri ed Archea; questi ultimi sono procarioti con caratteristiche biochimiche uniche, specialmente per quanto riguarda la composizione della membrana cellulare, ed in genere vivono e prosperano in condizioni ambientali estreme per chimica, pH, pressione e temperatura (sono tali i batteri termofili, estremofili, ecc.) Infine, nel 2004 il biologo inglese Thomas Cavalier-Smith (1942-vivente) propose di creare all'interno dei Protisti un'ulteriore suddivisione tra il Regno dei Protozoi e quello dei Cromisti o Cromalveolati, eucarioti unicellulari o pluricellulari per la maggior parte fotosintetici, con caratteristiche morfologiche proprie rispetto ai Protozoi; ma l'elevazione di questo gruppo a regno è controversa, visto che secondo alcuni è polifiletico (cioè formato da organismi senza vera parentela evolutiva tra di loro). Sempre Cavalier-Smith non accetta il regno degli Archea, facendolo confluire in quello dei Batteri, ma i più continuano a considerarlo un regno separato. I più comunque oggi suddividono gli esseri viventi in tre grandi domini: Archea, Batteri ed Eucarioti (e questa è anche la suddivisione adottata nell'albero genealogico che abbiamo analizzato in precedenza), dividendo questi ultimi a loro volta nei regni di Protozoi, Cromisti, Funghi, Vegetali e Animali. Ad essi andrebbe poi aggiunto un altro regno, quello dei Virus, dei quali però al momento attuale si ignora totalmente l'origine e la storia evolutiva.
Vi è però un modello alternativo a quello da noi fin qui presentato, secondo cui l'albero filogenetico degli eucarioti si è separato da un antenato procariota in comune con gli Archaea. Tutti gli organismi intermedi di questo lungo ramo però si sarebbero estinti senza lasciare traccia, e per questo gli eucarioti appaiono come gli unici detentori di un certo grado di complessità cellulare. Un nuovo modello prevede invece due soli domini: il ramo degli eucarioti avrebbe avuto origine dagli Archea, e in particolare da un ipotetico superphylum denominato TACK (acronimo dei quattro phyla da cui è composto: Thaumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota e Korarchaeota), di cui però finora non si trovava riscontro. Secondo un gruppo di ricercatori guidati da Anja Spang dell'Università di Uppsala, in Svezia, un nuovo microrganismo da loro scoperto sul fondo dell'oceano potrebbe rappresentare proprio l'"anello di congiunzione" tra gli organismi più semplici e gli organismi cellulari complessi. Si tratta di un esemplare di Lokiarchaeota, una nuova famiglia di Archea che consente di chiarire una serie di punti finora oscuri di un passaggio fondamentale dell'evoluzione della vita: l'origine degli organismi eucarioti. Spang e colleghi hanno identificato nuovi Archea nei sedimenti marini profondi, in corrispondenza delle sorgenti idrotermali della dorsale medio-oceanica artica, a 5000 metri di profondità. Denominati Lokiarchaeota, sono i procarioti più vicini agli eucarioti mai scoperti finora e apparterrebbero proprio al TACK. Le analisi hanno infatti mostrato che i Lokiarchaeota hanno geni che codificano per proteine, trovate finora solo negli eucarioti, e che sono implicate nella costruzione del citoscheletro. Queste caratteristiche genetiche possono aver fornito ai primi eucarioti ancestrali la base di partenza per un salto nella complessità cellulare caratteristica degli eucarioti attuali.
|
|
|
L'origine degli esseri viventi pluricellulari, disegno dell'autore |
L'anello di ricongiunzione tra archea, batteri ed eucarioti
Secondo Gautam Dey e Buzz Baum, dell'University College di Londra, e Mukund Thattai, del National Centre for Biological Sciences a Bangalore, in India, sarebbe stata una lunga e lenta serie di acquisizioni di geni dai batteri a permettere la trasformazione di alcuni archea nelle prime complesse cellule eucariote. I tre sono giunti a questa conclusione in seguito all'analisi del genoma di un nuovo tipo di archea, Lokiarchaeum, la cui esistenza è stata scoperta nel 2015 analizzando campioni di sedimenti prelevati dal campo di bocche idrotermali sottomarine di Loki Castle, nella dorsale medio-oceanica dell'Artico. Si ritiene che gli eucarioti si siano evoluti in seguito a una fusione simbiotica tra archea e batteri, ma a lungo c'è stato disaccordo sul modo in cui sarebbe avvenuta questa fusione e sulle caratteristiche del primo organismo eucariota, dato che non si conoscono organismi intermedi (presenti o passati) che colmino il grande divario di dimensioni e complessità tra procarioti ed eucarioti.
Ebbene, i tre ricercatori hanno scoperto che il genoma di Lokiarchaeum contiene un notevole numero di proteine simili a quelle prodotte dalle cellule eucariote (proteine ESP, da "eukaryotic signature proteins"), molte di più di qualsiasi altro procariota noto. In particolare, contiene alcune proteine che nelle cellule eucariote hanno un ruolo critico nel dirigere il traffico molecolare fra i vari comparti all'interno della cellula. Secondo i tre ricercatori, è molto improbabile che le ESP di Lokiarchaeum svolgano le stesse funzioni che hanno negli eucarioti, dato che il microrganismo appena scoperto non sembra avere alcuni enzimi necessari al funzionamento dell'apparato che nella cellula eucariota regola il traffico molecolare attraverso le membrane intracelulari. Tuttavia il suo genoma può essere considerato pronto per far scattare il passaggio da archea a eucariota. A una cellula di questo tipo basterebbe acquisire alcuni geni chiave e alcuni lipidi da un simbionte batterico per evolvere una compartimentazione intracellulare e un apparato per il traffico molecolare attraverso le membrane di quei comparti. Gli studi futuri ci diranno se Lokiarchaeum ha un aspetto più simile a un archaea o a un proto-eucariota, e se ha o meno compartimentazioni interne.
La prima alga
Ma non è tutto. Nel 2016 negli strati di roccia sedimentaria di Chitrakoot, nell'India centrale, è stato scoperto un piccolo fossile che potrebbe cambiare la nostra ricostruzione delle prime fasi della vita sulla Terra. Si tratta infatti dei resti di un'alga rossa vissuta 1,6 miliardi di anni fa (alle 5 del mattino del 24 agosto), il che indica che probabilmente gli organismi unicellulari si svilupparono sul nostro pianeta molto prima di quanto ritenuto finora.
Come si è visto, tra organismi procarioti ed eucarioti c'è un buco di diversi miliardi di anni: ma quando apparvero le prime cellule eucariote? Le tracce di questi organismi rimaste fino a noi sono sporadiche e difficili da interpretare e collocare nel grande albero dell'evoluzione della vita. Finora, il più antico esemplare fossile noto di alga rossa era datato a 1,2 miliardi di anni fa (alle 16 del 25 settembre). Il fossile indiano è dunque più antico di 400 milioni di anni (un intero mese dell'Anno della Terra!), quindi il più antico del tipo simile alle piante ritrovato finora, e secondo Stefan Bengtson, professore emerito di paleozoologia del Museo Svedese di Storia Naturale e coautore dello studio, i paleontologi dovrebbero rivedere l'intera cronologia della vita sulla Terra.
Il campione delle presunte alghe rosse si trovava all'interno di uno strato fossile di cianobatteri, inserito a sua volta in un roccia sedimentaria chiamata fosforite. L'analisi delle stromatoliti ha rivelato la presenza di strutture filamentose molto più complesse, che hanno spinto Bengtson e colleghi ad approfondire lo studio con uno strumento molto sofisticato: la microscopia tomografica a raggi X di sincrotrone. L'analisi strumentale ha rivelato la presenza in ogni cellula di minuscole strutture appiattite che si ritiene facciano parte dei cloroplasti, gli organelli che nelle cellule vegetali sono responsabili del processo di fotosintesi clorofilliana, e di strutture regolari al centro di ciascuna membrana cellulare che sono tipiche delle alghe rosse.
Gli oceani rosa del « miliardo noioso »
Il periodo fra 1,8 e 0,8 miliardi di anni fa (dall'8 agosto alle 2.40 del 28 ottobre dell'Anno della Terra) è stato chiamato dai biologi « il miliardo noioso », perchè dopo l'apparizione dei primi batteri fotosintetici e lo sterminio di quelli anaerobi da parte dell'ossigeno prodotto dai fotosintetici, la vita sembrò quasi smettere di evolversi. Nur Gueneli, dell'Australian National University a Canberra, ha macinato rocce prelevate in Mauritania, formatesi sul fondo di un oceano di 1,1 miliardi di anni fa (alle 18.40 del 3 ottobre), e ne ha estratto i componenti organici contenuti. Il risultato, divulgato nel 2018, è stata una soluzione color rosa brillante, che si è rivelata un mix di porfirine, molecole colorate della famiglia della clorofilla. È il pigmento biologico più antico mai trovato, forse il primo in assoluto.
Le porfirine permettono ai cianobatteri di catturare 1'energia solare: i mari del miliardo noioso, quindi, ne erano pieni al punto che si possono ancora trovare nelle rocce. E il fatto che i cianobatteri monopolizzassero la vita oceanica spiega il « miliardo noioso »: i cianobatteri sono troppo piccoli per essere una fonte di cibo, occorreva aspettare l'evoluzione di alghe con cellule dotate di nucleo, 1000 volte più grandi dei batteri, affinché si evolvessero i primi animali filtratori, circa 620 milioni di anni fa (alle 17 dell'11 novembre).
I pluricellulari
A questo punto, però, sulla Terra non esisteva ancora neppure un organismo pluricellulare. Il fatto è che, proprio in questo periodo, alcune cellule cominciano a riprodursi, restando però unite. Perché? Perché l'unione fa la forza, oggi come nel periodo Proterozoico. Così nacquero i primi aggregati cellulari. Alcune cellule si svilupparono più di altre, differenziandosi e specializzandosi per svolgere determinati compiti. Per esempio, alcune cellule furono deputate al rivestimento esterno, altre al movimento, eccetera. I primi pluricellulari furono semplici organismi con una cavità interna a scopo gastrico; vi era una sola apertura, che serviva contemporaneamente da bocca e da ano; solo in seguito si formò un rudimentale apparato digerente.
Secondo i sostenitori della "Snowball Earth", sarebbe stata proprio la superglaciazione ad innescare la nascita dei pluricellulari per resistere meglio alle avverse condizioni climatiche. Comunque sia andata, dopo miliardi di anni in cui la Terra era stata popolata solo da organismi unicellulari, nel giro di poche centinaia di milioni di anni comparvero e si moltiplicarono gli organismi pluricellulari: una quantità enorme di invertebrati, differenziati in modo incredibile, si diffuse ovunque, alla conquista di ogni nicchia ecologica. Tra le alghe pluricellulari primitive, la Collenia produsse vere e proprie praterie sottomarine, ed a poco a poco divennero frequenti i rappresentanti di fauna inferiore come Spugne (o Parazoi), Crinoidi, Echinodermi e Ctenofori. È proprio questa diffusione della vita su tutto il globo, testimoniata da fossili sempre più abbondanti, che ha permesso di ricostruire con dettagli sempre maggiori l'ultimo mezzo miliardo di anni di storia del nostro pianeta, cioè gli ultimi quaranta giorni dell'Anno della Terra.
Secondo Casey Dunn della Brown University di Providence (Rhode Island, USA), autore di una ricerca pubblicata su Nature, il primo vero pluricellulare apparso sulla Terra in quei lontanissimi giorni sarebbe stato uno ctenoforo, un organismo che ricorda vagamente una medusa. Il suo nome deriva dal greco "ktenos", pettine, e "phoros", portare, perché lungo il suo corpo gelatinoso e a forma di sacco si trovano otto file di bande meridiane, provviste ciascuna di una serie di "pettini": per pettine si intende una paletta vibratile munita di ciglia che, battendo coordinatamente assieme alle altre, permette all'organismo di spostarsi lentamente nell'ambiente acquatico. Per ottenere questo risultato, Dunn e i suoi collaboratori hanno analizzato una massa enorme di dati genetici, che hanno consentito loro di percorrere a ritroso l'albero evolutivo della vita sulla Terra, simile al ramo centrale di quello da noi raffigurato sopra, sino ad arrivare a quel primissimo progenitore di tutti gli animali, che il grande poeta Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), appassionato di scienza, aveva battezzato « urtypus ». Invece Davide Pisani dell'Università di Bristol sostiene, prove alla mano, che la più antica stirpe di animali viventi sulla Terra fu quella dei poriferi, cioè delle spugne, per via della semplicità di questi organismi. La questione non è oziosa, perché il fatto che siano venuti prima le spugne o gli ctenofori suggerisce storie evolutive diverse per i principali sistemi degli organismi, per esempio il sistema nervoso e quello digestivo; conoscere il corretto ordine di ramificazione alla radice dell'albero della vita animale è perciò fondamentale per capire l'origine delle caratteristiche chiave dell'anatomia.
Si dovette attendere comunque molto a lungo prima che l'evoluzione desse origine a forme di vita animale meno primitive. Erano esseri invertebrati, privi cioè di scheletro, simili agli attuali Anellidi marini ed in grado di scavare nel fondo sabbioso del mare. Essi diedero probabilmente origine ai protoartropodi, di cui non si hanno testimonianze fossili, e successivamente ai Trilobiti. I primi invertebrati veri e propri furono millepiedi marini vissuti circa 630 milioni di anni fa. In termini di Anno della Terra, ciò accade soltanto la sera del 9 novembre!
Le innumerevoli testimonianze fossili di Molluschi risalenti al successivo periodo Cambriano autorizzano, anche senza documentazioni fossili, a ritenere che anche questi organismi fecero la prima comparsa già prima della fine del Precambriano. Si trattava in particolare degli antenati degli attuali gasteropodi, viventi in lunghe conchiglie di forma conica. Anche i cefalopodi ed i ricci di mare comparvero verso la fine del periodo Proterozoico.
A questo punto però mi sembra impossibile tralasciare una notizia sorprendente. Com’è noto, la corteccia cerebrale è considerata la parte più caratteristica del cervello umano, perché in essa risiedono tutte le facoltà cognitive ed intellettuali, che ci distinguono dagli altri animali. Ma quando si sviluppò la corteccia nel corso dell'evoluzione? Finora si riteneva che gli esseri umani condividessero questa parte del cervello solo con alcuni vertebrati, ma una nuova ricerca svolta svolta da Raju Tomer e colleghi dell’European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg ha compiuto una scoperta strabiliante, trovando un analogo della corteccia in un invertebrato, Platynereis dumerilii, un verme marino il cui ultimo antenato in comune con l'uomo risale a circa 600 milioni di anni fa (al mattino del 13 novembre). I ricercatori hanno analizzato le aree cerebrali responsabili dell'elaborazione delle sue informazioni olfattive, i corpi fungiformi, grazie a una nuova tecnica da loro sviluppata denominata PrImR (profiling by image registration), che permette di studiare un enorme numero di geni in un cervello di piccole dimensioni determinando quali di essi sono attivi. Tale tecnica ha permesso di individuare l'"impronta molecolare" di ogni cellula. « Le conclusioni sorprendenti dello studio sono due », ha dichiarato Tomer: « in primo luogo la corteccia è molto più antica di quanto chiunque abbia ipotizzato finora, probabilmente più degli stessi animali superiori. In secondo luogo, essa è un adattamento delle prime forme di vita marina agli oceani del Precambriano. Dal confronto dei profili molecolari dei corpi fungiformi in fase di sviluppo con le informazioni esistenti sulla corteccia dei vertebrati, è apparso chiaro che esse sono troppo simili tra loro per avere un'origine indipendente, e che devono condividere un precursore evolutivo. »
|
|
|
Impronta fossile di Dickinsonia costata |
I primi funghi
A quanto pare, il fungo più antico del mondo risale a circa 800 milioni di anni fa (alle 02.40 del 28 ottobre) ed è stato ritrovato nella Repubblica Democratica del Congo, conservato in una roccia nei pressi della città di Mbuji-Mayi. La scoperta è stata compiuta nel 2019 da un team di ricercatori dell'Università di Bruxelles guidati da Steeve Bonneville. Secondo tali paleontologi, i funghi hanno svolto un ruolo chiave nella storia della vita sul nostro pianeta, aiutando a creare un terreno primordiale che avrebbe poi permesso alle piante di approdare sulla terraferma. Questa scoperta potrebbe costringerci a riconsiderare le nostre conoscenze sull'evoluzione degli organismi sulla Terra.
I resti fossilizzati del micelio sono stati trovati in alcune rocce risalenti a un periodo compreso fra 810 e 715 milioni di anni fa (tra le 07.12 del 27 ottobre e la mezzanotte del 4 novembre), esposte al Museo Reale dell'Africa Centrale di Tervuren, in Belgio, e originarie di un'area di transizione tra acqua e terra. Questo ci porta a credere che tali funghi siano stati decisivi per la colonizzazione della superficie terrestre avvenuta circa 500 milioni di anni fa. L'origine dei funghi è stata fonte di interrogativi per secoli, e per la loro delicata natura è sempre stato molto difficile trovare dei fossili in buono stato di conservazione e distinguerli da altri microrganismi. Il team di Bonneville ha analizzato il fossile grazie a dispositivi di scansione all'avanguardia che hanno permesso di identificarne la composizione molecolare, rilevando tracce di chitina, un composto molto resistente che si trova nelle pareti cellulari dei funghi. Di sicuro si tratta di un rinvenimento eccezionale.
Il selenio e l'ossigenazione del pianeta
Nel 2015 uno studio di Philip Pogge von Strandmann, dello University College London, e colleghi ha dimostrato che sono stati necessari 100 milioni di anni (più di otto giorni dell'Anno della Terra) affinché le concentrazioni di ossigeno negli oceani e nell'atmosfera della Terra del remoto passato raggiungessero livelli sufficienti a provocare l'esplosione della vita animale. L'incremento è iniziato insomma molto prima di quanto stimato, ed è avvenuto in diverse fasi ed epoche iniziando circa 600 milioni di anni fa (alle 8 del mattino del 13 novembre). Tutto questo ha una conseguenza importante: è probabile che sia stato l'incremento della concentrazione di ossigeno a innescare la comparsa dei primi animali, e non viceversa. Nel corso del periodo Proterozoico il nostro pianeta ha conosciuto un profondo cambiamento, passando per diverse glaciazioni, per il processo di ossigenazione dell'atmosfera e per la comparsa degli animali. Tuttavia, finora è sfuggita una comprensione completa di questi eventi, in parte perché sono mancate le prove che potessero documentare la cronologia degli eventi. Pogge e colleghi hanno studiato campioni di roccia raccolti in Stati Uniti, Canada e Cina per ricostruire le condizioni della Terra tra 770 e 520 milioni di anni fa (tra le 13 del 30 ottobre e le 20 del 19 novembre). Durante questo arco di tempo sono avvenute tre grandi glaciazioni: oltre a quella Sturtiana, di cui già abbiamo parlato, si annoverano quella Marinoana (circa 635 milioni di anni fa, verso il mezzogiorno del 10 novembre) e quella Gaskiersiana (circa 580 milioni di anni fa, alle 23 del 14 novembre), durante le quali le terre emerse erano ricoperte da ghiaccio e la maggior parte degli oceani erano ghiacciati dai poli ai tropici. Nei periodi interglaciali, l'incremento della temperatura provocò la fusione di enormi masse di ghiaccio, portando una grande quantità di nutrienti negli oceani e causando un aumento dei livelli di ossigeno nei mari fino a notevoli profondità. L'incremento dei nutrienti a sua volta innescò un aumento del plancton che, dopo la morte, raggiungeva il fondo, portando con sé il carbonio fissato nei composti organici. La fissazione del carbonio ha avuto come conseguenza un notevole incremento dell'ossigeno.
Uno dei più importanti indici di tipo chimico-fisico per ricostruire questa cronologia è proprio la presenza di maggiore ossigeno nei mari che, cambiando le condizioni per le reazioni coinvolte, ha determinato una variazione nell'abbondanza di alcuni metalli in tracce. Pogge e colleghi hanno analizzato in particolare le concentrazioni degli isotopi di selenio, concludendo che la grande ossigenazione è iniziata dopo la glaciazione Marinoana, e non dopo la glaciazione Gaskiersiana, come ritenuto finora. Il risultato quindi retrodata notevolmente questo passaggio fondamentale per la vita sulla Terra. « L'ossigeno è stato la miccia dell'esplosione della vita animale: 635 milioni di anni fa, era appena sufficiente per sostenere la vita di piccole spugne e 580 milioni di anni fa solo per la comparsa di pochi altri organismi; 50 milioni di anni più tardi, gli antenati dei vertebrati nuotavano in acque ricche di ossigeno », ha commentato David Catling, coautore dello studio. « Capire come è aumentata la concentrazione dell'ossigeno è il primo passo per capire perché il processo è stato così lungo ».
Gli animali ossigenatori?
Vi è invece chi pensa che i primi animali apparsi sulla Terra possano essere stati agenti attivi nella creazione del mondo ricco di ossigeno che conosciamo oggi, e non una semplice risposta passiva ai crescenti livelli di questo gas in atmosfera, che hanno iniziato a manifestarsi circa 600 milioni di anni fa. Questa proposta è stata avanzata nel 2014 da un gruppo di ricercatori delle Università di Exeter e di Cambridge, e dell'University College di Londra, i quali hanno analizzato i meccanismi attraverso i quali potrebbe essere avvenuta l'ossigenazione delle profondità dell'oceano durante il Proterozoico, pur in presenza dei bassi livelli di ossigeno in atmosfera che caratterizzavano quel periodo geologico.
« Per oltre 1,5 miliardi di anni prima che si evolvessero i primi animali, nelle acque superficiali oceaniche c'erano livelli di ossigeno relativamente elevati, erano le oscure profondità dell'oceano a essere rimaste prive di ossigeno. Noi sosteniamo che l'evoluzione dei primi animali potrebbe aver giocato un ruolo chiave nella diffusione dell'ossigenazione degli oceani profondi, che a sua volta ha facilitato l'evoluzione di forme animali più complesse e più mobili », ha dichiarato in proposito Timothy M. Lenton dell'Università di Exeter. A determinare i livelli di ossigeno nelle acque profonde è il bilancio fra le quantità di ossigeno che vi arrivano dagli strati superficiali e e quello che viene prelevato attraverso diversi meccanismi, il più importante dei quali è rappresentato dai processi di decadimento del materiale organico che vi sprofonda quando le forme di vita a vicine alla superficie muoiono. Studi recenti hanno dimostrato che le prime spugne, che fecero la loro comparsa 750 milioni di anni fa (alle 4 del mattino del giorno di Ognissanti), sono in grado di prosperare anche con livelli ridotti di ossigeno. Secondo i modelli sviluppati dai ricercatori, la diffusione di questi animali filtratori avrebbe ridotto considerevolmente le quantità di residui organici finiti a maggiori profondità, dove quindi si è abbassata la domanda di ossigeno, portando a un progressivo aumento dei suoi livelli. Per avere maggiori risposte in proposito sarà necessario che i geochimici trovino nuovi modi per decifrare i livelli di ossigeno della Terra primordiale.
Il contributo della vita alla mineralogia terrestre
L'impatto della geologia terrestre sulla vita è facile da constatare: gli organismi viventi si sono adattati agli ambienti più disparati come deserti, montagne, foreste e oceani. L'impatto complessivo della vita sulla geologia, per contro, può facilmente essere sottovalutato. Nel 2022 però alcune approfondite ricerche hanno in parte colmato questa lacuna, fornendo la prova che circa la metà di tutta la diversità minerale è il risultato diretto o indiretto degli esseri viventi e dei loro sottoprodotti. I ricercatori Robert Hazen, Shaunna Morrison e i loro collaboratori della Carnegie Institution hanno delineato un nuovo sistema tassonomico per la classificazione dei minerali, che attribuisce importanza al modo in cui i minerali si formano e non solo al loro aspetto. La nuova tassonomia, basata su un'analisi algoritmica di migliaia di articoli scientifici, individua ben 10.556 tipi diversi di minerali, un numero quasi doppio rispetto alle circa 5800 "specie" di minerali della tassonomia classica dell'Associazione Mineralogica Internazionale (IMA), che si concentra esclusivamente sulla struttura cristallina e sulla composizione chimica di un minerale. Il mastodontico lavoro, iniziato nel 2008, ha dimostrato che molte specie di minerali sono il risultato di più processi distinti. Prendiamo, per esempio, i cristalli di pirite: si formano in ben 21 modi fondamentalmente diversi! Alcuni si formano quando depositi di ferro ricchi di cloruri presenti in profondità nel sottosuolo si riscaldano nel corso di milioni di anni, altri si formano nei sedimenti oceanici freddi come sottoprodotto dei batteri che decompongono la materia organica sul fondo del mare, altri ancora sono associati all'attività vulcanica, alle infiltrazioni di acque sotterranee o alle miniere di carbone; e così via. « Ognuno di questi tipi di pirite ci dice qualcosa di diverso sul nostro pianeta, sulla sua origine, sulla vita e su come è cambiata nel tempo », ha dichiarato Hazen. Per questo motivo, i nuovi articoli classificano i minerali per "tipo", un termine che Hazen e Morrison definiscono come una combinazione della specie minerale e del suo meccanismo di origine. Morrison e Hazen hanno anche identificato 57 processi che, singolarmente o in combinazione, hanno creato tutti i minerali conosciuti. Questi processi includono vari tipi di agenti atmosferici, precipitazioni chimiche, trasformazioni metamorfiche all'interno del mantello terrestre, fulmini, radiazioni, ossidazione, impatti massicci durante la formazione della Terra e persino condensazioni nello spazio interstellare prima della formazione del pianeta. Hanno così confermato che il più grande fattore di diversità minerale sulla Terra è l'acqua, che attraverso una serie di processi chimici e fisici contribuisce a generare più dell'80 % dei minerali a noi noti.
Ma hanno anche scoperto che la vita è un fattore chiave: un terzo di tutti i tipi di minerali si forma esclusivamente come parte o sottoprodotto di esseri viventi, come pezzi di ossa, denti, coralli e calcoli renali (tutti ricchi di minerali) o feci, legno, tappeti microbici e altri materiali organici che, su tempi geologici, possono assorbire elementi dall'ambiente circostante e trasformarsi in qualcosa di più simile alla roccia. Migliaia di minerali sono modellati dall'attività della vita in altri modi, come i composti di germanio che si formano nella combustione industriale del carbone. Includendo le sostanze create tramite le interazioni con i sottoprodotti della vita, come l'ossigeno prodotto nella fotosintesi, le impronte della vita sono presenti su circa la metà di tutti i minerali. Storicamente, gli scienziati hanno tracciato artificialmente una linea di demarcazione tra geochimica e biochimica, ma in realtà il confine tra animale, vegetale e minerale è molto più fluido. Il corpo umano, per esempio, contiene circa il due per cento di minerali in peso, la maggior parte dei quali è racchiusa nella struttura di denti e ossa costituita da fosfato di calcio. Naturalmente molti geologi sono restii ad adottare la nuova tassonomia dei minerali, non solo per motivi di inerzia mentale, ma anche perché la vecchia tassonomia IMA è stata sviluppata a scopi applicativi, come la chimica, l'estrazione mineraria e l'ingegneria, e funziona ancora bene in questi settori. Tuttavia le esigenze degli scienziati stanno cambiando anche a causa di attività come l'esplorazione spaziale.
Un'implicazione delle scoperte di Hazen e Morrison infatti è che il nostro pianeta, ricco di acqua e di forme di vita, è probabilmente molto più ricco di minerali rispetto ad altri corpi rocciosi del sistema solare. « Ci sono molti minerali che semplicemente non potrebbero formarsi su Marte », ha dichiarato Hazen, « perchè lassù non ci sono pinguini che defecano su minerali di argilla, non ci sono pipistrelli nelle grotte, non ci sono cactus in decomposizione né altro del genere. » Tuttavia, Hazen e Morrison sperano che la loro tassonomia possa un giorno essere usata per decodificare la storia geologica di altri pianeti o satelliti naturali e per cercare indizi di vita, passata o presente, anche lassù. Quando si esamina un cristallo marziano, per esempio, i ricercatori potrebbero usare il nuovo quadro mineralogico per esaminare caratteristiche come la dimensione dei grani e i difetti di struttura per determinare se possa essere stato prodotto da un antico microbo piuttosto che da un mare morente o da un colpo di meteorite. Hazen ritiene addirittura che la nuova tassonomia potrebbe aiutare a rilevare la vita su pianeti intorno a stelle lontane. La luce degli esopianeti rilevati dal telescopio spaziale James Webb e da altri strumenti sofisticati potrebbe essere analizzata per determinare la composizione chimica delle loro atmosfere; in base al contenuto di ossigeno misurabile, alla presenza o all'assenza di vapore acqueo, alle concentrazioni relative di carbonio e ad altri dati, i ricercatori potrebbero cercare di prevedere quali tipi di minerali è probabile che si formino a distanza di anni luce. Speriamo proprio che sia così.
La fauna di Ediacara
Alcuni fossili testimoniano l'esistenza di organismi pluricellulari che vivevano nei mari tra 700 e 580 milioni di anni fa (tra il 5 e il 14 novembre), al confine tra le ere Archeozoica e Paleozoica: si tratta della fauna di Ediacara, dal nome della località dell'Australia meridionale dove nel 1946 il geologo australiano Reginald Sprigg (1919-1994) ritrovò le sue impronte fossili, e da cui trae il nome l'ultimo sottoperiodo del Proterozoico Inferiore, l'Ediacarano, durato da 635 a 542 milioni di anni fa (tra il 10 e il 18 novembre). L'attuale Ediacara un tempo era un tratto di mare vicino alla riva, come testimoniano i ripple marks, cioè le piccole dune sul fondo del mare, fossilizzatesi perfettamente: probabilmente furono ricoperte da sedimenti portati dalle maree. I paleontologi sostengono che la fauna di Ediacara fosse divisa in due grandi categorie: alcuni erano animali a tutti gli effetti, e ricordavano ad esempio animali marini a corpo molle come le meduse; altri sembrano rappresentare un primo "esperimento" per l'evoluzione di gruppi come Celenterati o Anellidi; altri ancora invece erano strane creature battezzate Vendozoi, prive di apparato digerente e di organi di locomozione e forse anche di organi di senso, che probabilmente si nutrivano assorbendo microrganismi. Organismi semplici e indolenti, insomma, del tutto dissimili da quelli attuali. Tra gli esseri ritrovati ricordiamo la Dickinsonia, con corpo piatto e lungo fino a un metro, e con venature che la fanno sembrare una foglia; la Parvancorina, che presenta uno scudo poco mineralizzato sul cranio, cinque paia di appendici posteriori e venti paia di anteriori, meno robuste; e la Spriggina, che sembra metà trilobite e metà anellide. Animali simili a quelli di Ediacara si ritrovano in Namibia, Inghilterra, Russia e Ucraina, il che fa pensare ad una diffusione su scala mondiale di esseri simili nel periodo Proterozoico.
|
|
|
Ricostruzione della fauna di Ediacara, disegno dell'autore |
Non è ancora chiaro che significato abbiano questi fossili nella storia dell'evoluzione della vita, e se abbiano lasciato qualche discendente. Di sicuro all'inizio del Cambriano essi scomparvero in un'estinzione di massa, lasciando campo libero ai progenitori delle specie a noi familiari come artropodi, molluschi o vertebrati. Per molto tempo si è ritenuto dunque che la fauna di Ediacara fosse stata un bizzarro vicolo cieco evolutivo, un tentativo fallito spazzato via da qualche cataclisma ancora ignoto, simile a quello che ha condotto all'estinzione dei dinosauri. Non è raro infatti che la storia della vita sulla Terra proceda talora attraverso tentativi rapidi e bizzarri, che non sempre sono destinati ad andare a buon fine. Giovanni Mussini dell'Università dì Cambridge e Frances S. Dunn dell'Università di Oxford hanno invece proposto che la fauna di Ediacara non sia stata annientata da sconvolgimenti geologici o impatti dí asteroidi, ma abbia posto le basi della sua stessa scomparsa, innescando l'evoluzione della vita animale come la conosciamo. Negli oceani del Precambriano, fino ad allora abitati quasi solo da un tappeto omogeneo di microrganismi, gli animali di Ediacara erano nuove ed eccellenti fonti di cibo; ma per nutrirsene bisognava raggiungerli e consumarli in fretta. È stato quindi quasi inevitabile, secondo i due ricercatori, che si evolvessero esseri con un nuovo stile di vita in grado di approfittarne: creature attive, capaci di camminare, nuotare e afferrare le prede. I nuovi arrivati alterarono però irrimediabilmente l'ambiente, per esempio scavando tane nei fondali e distruggendo i tappeti microbici di cui gli organismi di Ediacara si nutrivano. Se così fosse la fine di Ediacara sarebbe l'unica (se escludiamo l'attuale crisi ecologica) estinzione globale di massa a noi nota provocata dall'evoluzione di nuove forme di vita!
Ma non c'era solo la fauna di Ediacara. Alcuni ricercatori cinesi dell’Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanjing e dell’Accademia delle Scienze Cinese, in collaborazione con i colleghi statunitensi del Virginia Tech, hanno scoperta quella che senza dubbio è la più antica traccia fossile attribuibile a un animale, risale al periodo Ediacarano e non si può neanche pensare che sia stata prodotta da zampe. Più probabilmente, si è trattato di qualcosa di più arcaico, ovvero di appendici usate per la locomozione. Ritrovata nella Formazione Dengying, risalente a un periodo compreso tra 551 e 541 milioni di anni fa (tra le 7.23 del 17 novembre e le 2.51 del giorno successivo), e situata nelle gole del fiume Yangtze, nella Cina meridionale, la traccia consiste in una serie di segni organizzati su due file parallele che indicherebbero un organismo delle dimensioni di alcuni millimetri, con simmetria bilaterale e dotato di appendici in grado di tenere sollevato il corpo appena sopra la superficie di separazione tra l’acqua in cui viveva e lo strato di sedimenti sottostante. Le tracce appaiono collegate da minuscoli cunicoli, il che, secondo gli autori, è indice di un comportamento abbastanza complesso: le minuscole creature probabilmente scavavano nei sedimenti, colonizzati da batteri e dagli archea, in cerca di cibo e di ossigeno. La scoperta di questa traccia fossile rappresenta in parte una novità e in parte una conferma del quadro di teorie sull’avvento degli animali a simmetria bilaterale, un gruppo che ha avuto un enorme successo evolutivo, testimoniato dalla grande diversificazione delle specie che vi appartengono. Una teoria attribuisce l’avvento degli animali con questa simmetria, in particolare degli artropodi e degli anellidi, alla cosiddetta esplosione del Cambriano, nel corso della quale ebbe origine la maggior parte dei rami filogenetici degli animali attuali. Esistono però indicazioni che la simmetria bilaterale possa essere emersa in un’epoca precedente, in pieno Ediacarano, o ancora prima, come ha sostenuto tra gli altri Douglas Erwin del Museo Nazionale di Storia Naturale a Washington, basandosi sul confronto di registrazioni fossili e studi molecolari.
Nell'Ediacarano, periodo che ha preso nome proprio dall'enigmatica fauna di Ediacara, è vissuto anche l'animale più antico dotato di scheletro, scoperto nel Sud dell'Australia da un gruppo di paleontologi dell'università della California a Riverside: è un organismo marino simile a una spugna chiamato Coronacollina acula ed è vissuto più di 550 milioni di anni fa, poco prima della fine dell'eone Precambriano. Era un organismo incapace di muoversi che viveva in colonie sul fondale marino. La sua impronta fossile ce lo mostra formato da un corpo principale, simile a un tronco di cono alto da 3 ai 5 centimetri, da cui partivano almeno quattro aghi chiamati spicole, lunghi fino a 40 centimetri, che servivano da sostegno strutturale. « Fino ad oggi pensavamo che gli animali vissuti prima del Cambriano avessero solo corpi molli, non dotati di strutture rigide », ha spiegato la coordinatrice del gruppo di ricerca Mary Droser. « Ora abbiamo invece trovato un organismo con parti del corpo rigide apparso prima del Paleozoico: una grande innovazione per gli animali. È una scoperta emozionante, perché si tratta della prima apparizione di una delle più grandi novità dell'evoluzione animale. »
Nella riserva ecologica di Mistaken Point sull'isola di Terranova (Canada) è stata effettuata nel 2012 una scoperta eccezionale: una vera e propria "nursery" di piccoli animali dell'ordine dei rangeomorfi, vissuti 579 milioni di anni fa (alla mezzanotte del 15 novembre), preservati dalla cenere di un'eruzione vulcanica, per la quale qualcuno ha parlato di "Pompei di Terranova". Essa ha ricoperto e conservato perfettamente fino ad oggi un cimitero di organismi multicellulari nelle prime fasi di vita, come si deduce dalle dimensioni ridotte degli animali, dai 6 millimetri ai 3 centimetri. La scoperta, effettuata dai paleontologi delle università britanniche di Oxford e Cambridge, ha davvero dell'eccezionale, considerando l'antichità dei reperti. Si pensa che gli stessi animali, da adulti, potessero raggiungere anche i due metri di lunghezza. I rangeomorfi erano organismi molto particolari e ancora oggi rappresentano un rompicapo per gli studiosi, che non riescono ad attribuire loro una collocazione precisa nell'albero dell'evoluzione. Avevano un aspetto simile a quello delle attuali penne marine (Pennatulacea) e vivevano al buio, nelle profondità dell'oceano. Non erano vegetali, ma non presentavano nemmeno tutte le caratteristiche tipiche degli animali. Questa scoperta rafforza l'ipotesi secondo cui gli animali iniziarono ad incrementare le proprie dimensioni proprio 580 milioni di anni fa.
E non è tutto. Nel 2014 un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge ha ricostruito in tre dimensioni la particolare forma geometrica dei rangeomorfi mediante un modello computazionale, fornendo alcune informazioni sulla loro crescita, evoluzione ed estinzione. I rangeomorfi erano composti da elementi simili a fronde, ciascuna costituita da "rami" morbidi che intessevano una struttura regolare e ripetuta, simile a quella dei frattali, figure geometriche la cui forma si riproduce uguale a se stessa su diverse scale di grandezza all'interno del medesimo oggetto. Questa forma è caratteristica di numerosi oggetti ramificati, e in natura esistono diversi esempi di frattali (alberi, foglie, fiocchi di neve, rami di un fiume...). Il modello che riproduce la morfologia dei rangeomorfi ha messo in mostra una ramificazione assiale, apicale, alternata e auto-somigliante. Dall'analisi in tre dimensioni, gli organismi massimizzavano l'area della superficie esterna, riempiendo completamente lo spazio intorno al proprio corpo: in questo modo essi riuscivano ad assorbire la massima quantità di nutrienti attraverso l'acqua, ottimizzando la capacità di alimentarsi.
I rangeomorfi risultano tra i primi esseri viventi di grandi dimensioni apparsi sul nostro pianeta: la loro altezza era nella maggior parte dei casi pari a circa di 10 centimetri, ma alcuni raggiungevano anche i due metri, in un'epoca in cui la maggior parte delle specie assumeva dimensioni microscopiche. Le condizioni ecologiche e geochimiche uniche nel tardo Proterozoico hanno favorito il successo di questi grandi animali sottomarini. « Gli oceani durante il periodo Ediacarano erano simili a una zuppa debole piena di nutrienti quali il carbonio organico, mentre oggi le particelle di cibo sospese in acqua vengono rapidamente raccolte da una miriade di animali », ha spiegato il professor Simon Conway Morris (1951-), coautore dello studio. Nel successivo Cambriano i rangeomorfi « si estinsero proprio perché non riuscivano a competere con gli altri animali nella lotta ai nutrienti, e non si è osservato più niente simile a questi organismi », ha spiegato Hoyal Cuthill, sottolineando come la morfologia di questi organismi non è stata mai più rintracciata in altri macrorganismi complessi. Un esempio paleontologico unico, quello dei rangeomorfi, straordinariamente ben adattati al loro ambiente, dato che all'epoca gli oceani abbondavano di sostanze nutritive e presentavano bassi livelli di competizione.
Apparterrebbero però a un verme vissuto circa 550 milioni di anni fa (alle 9.20 del 17 novembre) le tracce più antiche di un animale in grado di muoversi autonomamente. Si chiama Yilingia spiciformis ed è stato scoperto dal gruppo dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanchino dell'Accademia Cinese delle Scienze, coordinato da Zhe Chen, e del college di Scienza americano della Virginia Tech, coordinato da Shuhai Xiao. Questi paleontologi hanno rinvenuto 35 tracce fossili nel Sud della Cina, vicino la città di Yiling, località che dà il nome all'animale. Si tratta di solchi lasciati da un verme non molto diverso da un millepiedi. Secondo le prime analisi, l'animale aveva un diametro compreso tra 5 e 26 millimetri, ed era lungo fino a 27 centimetri, con il corpo diviso in 50 segmenti. Le tracce indicherebbero che questi vermi erano capaci di compiere dei movimenti, e che furono tra i primi a farlo: il loro studio e la loro corretta classificazione, ancora in corso, potrebbero raccontarci come si è sviluppata ed evoluta nel tempo la capacità degli animali di muoversi sul terreno, cambiando per sempre il volto del nostro pianeta.
|
|
|
Tracce di Yilingia, ritenuto il primo organismo precambriano in grado di muoversi autonomamente (foto della Virginia Tech) |
Rappresentano un vero rebus anche i misteriosi fossili venuti alla luce nel sito di Doushantuo, in Cina, risalenti a 570 milioni di anni fa (alle 18.24 del 15 novembre): si trattava di animali o batteri? Secondo le ultime tecniche di scansione tridimensionale, potrebbe non essere vera nessuna delle due ipotesi. I fossili di Doushantuo si presentano infatti come granelli di sabbia spezzati in due: ciascuna delle due parti sembra lo "stampo" di una cellula animale. Questa circostanza, insieme con le strutture visibili all'interno, simili a nuclei cellulari, ha portato i paleontologi ad interpretare i fossili come embrioni di antichi animali in fase di divisione. Altri studiosi invece hanno sostenuto trattarsi di fossili di Thiomargarita, batteri giganti in grado di ossidare lo zolfo che esistono tuttora, che possono crescere fino a circa un millimetro di diametro, e che talvolta appaiono simili ad altri organismi nelle registrazioni fossili.
Per dirimere la questione un gruppo di ricercatori guidati da Philip Donoghue, palaeontologo dell'Università di Bristol, e Stefan Bengtson, paleontologo del Museo Svedese di Storia Naturale di Stoccolma, ha utilizzato una tecnica di tomografia microscopica a raggi X per produrre immagini tridimensionali dell'interno di questi fossili. Ebbene, degli oltre 450 fossili analizzati, 14 contenevano strutture simili a nuclei cellulari; in uno dei campioni, tre delle otto strutture avevano anche una forma allungata, la stessa che si osserva nei nuclei delle cellule degli organismi moderni dopo la loro replicazione, il che fa pensare che l'organismo sia morto durante la divisione cellulare. Quando i ricercatori hanno analizzato i campioni più approfonditamente, hanno scoperto che quelli che apparivano in uno stadio di sviluppo più avanzato contenevano centinaia di migliaia di minuscole cellule, e che gli involucri più esterni sembravano come... scoppiati. Sulla base di questa osservazione, Donoghue e Bengtson hanno ipotizzato che le creature siano simili agli attuali mesomicetozoi, microrganismi unicellulari che non sono né batteri né animali. Essi si riproducono creando migliaia di spore all'interno di un involucro protettivo che alla fine esplode, permettendo alle spore di diffondersi nell'ambiente. Una volta insediatesi, queste cellule creano un nuovo involucro e ricomincia il ciclo riproduttivo.
La più antica simmetria bilaterale
Anche Yilingia però dovrà forse cedere il record a un altro organismo vissuto in un passato ancora più remoto. Un minuscolo vermicello di nome Ikaria wariootia, identificato nel 2020 in un mucchietto di fossili australiani scoperti oltre un decennio prima, con i suoi 555 milioni di anni (è vissuto poco prima della mezzanotte del 16 novembre) sarebbe infatti il più antico organismo bilaterale, cioè dotato di un fronte e un retro, di due aperture connesse da un tratto digerente e di due lati simmetrici. Secondo i suoi scopritori, sarebbe addirittura un lontanissimo progenitore di quasi tutti gli animali, tra cui pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, esseri umani compresi. La paternità della presunta scoperta appartiene ad un’équipe di scienziati dello Smithsonian National Museum of Natural History, guidata da Scott Evans. Questi si è spinto ad affermare: « Si tratta del più antico organismo bilaterale mai rinvenuto, e dal momento che anche gli esseri umani sono bilaterali, possiamo dire senza tema di smentita che questo organismo è un nostro antenato e, probabilmente, uno dei primi esemplari del ramo dei bilaterali sull’albero della vita ». In realtà il sillogismo non sembra inattaccabile, tuttavia è certo che finora non sono mai stati scoperti organismi bilaterali più antichi dell'Ikaria wariootia. Il nome "Ikaria" deriva da ikara, che in lingua adnyamathanha, parlata dagli aborigeni che abitano quella regione dell’Australia, vuol dire "luogo di incontro", mentre "wariootia" deriva da Wariota Creek, il nome della catena montuosa sulla quale è stata effettuata la scoperta.
I primi organismi multicellulari, come spugne e alghe, avevano forme molto variabili, e mancavano di caratteristiche proprie della maggior parte degli animali moderni, tra cui la presenza della bocca o dell’intestino. Uno dei passi cruciali per l’evoluzione della vita animale è stato proprio lo sviluppo della simmetria bilaterale, in virtù della quale le forme di vita sono state in grado di muoversi in modo funzionale e di sviluppare un’organizzazione "razionale" degli organi interni. I biologi evoluzionisti che studiano la genetica degli animali moderni sospettavano da tempo che il primo antenato degli organismi bilaterali sarebbe stato un essere piuttosto piccolo, con organi di senso appena abbozzati; tuttavia fino a questo momento nessuno era riuscito a identificare i resti fossilizzati di un organismo con tutte queste caratteristiche. La storia è cambiata quando Evans e colleghi, analizzando attentamente dei fossili scoperti quindici anni prima a Nilpena, in Australia meridionale, hanno notato microscopiche escissioni di forma ovale. A questo punto gli scienziati si sono serviti di uno scanner laser tridimensionale, che ha svelato la presenza di minuscoli corpi cilindrici, grandi più o meno come un chicco di riso, dotati di una "testa" e di una "coda" distinte e di una muscolatura scanalata, ovvero di una struttura compatibile con le escissioni rinvenute sui fossili, che a questo punto è ragionevole supporre fossero le "tane" scavate dagli animali. « Abbiamo sempre saputo che questi animali sarebbero stati molto difficili da riconoscere », ha commentato Evans: « ci sono volute le scansioni tridimensionali per scovarli ».
Effettivamente Ikaria wariootia, nonostante le sue piccole dimensioni, è un organismo abbastanza complesso, in grado di nascondersi sotto sottili strati di sabbia in cerca di materia organica e di muoversi contraendo i muscoli del corpo in un modo simile a quello usato dai vermi moderni. « Ikaria si presenta esattamente come previsto dai biologi evoluzionisti », ha concluso orgoglioso l’autore della scoperta. Nonostante il suo entusiasmo, non ci sono prove reali che da quel minuscolo essere siano derivati tutti gli animali dotati di organi di movimento proprio, ma sognare di aver trovato davvero l'antenato comune di tutti noi non costa nulla.
L'esplosione ediacarana?
Bisogna però aggiungere che, a partire dalla fine degli anni Duemiladieci, tra i paleontologi è andata diffondendosi l'opinione che l'esplosione del Cambriano, di cui parleremo a proposito del primo periodo del Paleozoico, sia in realtà iniziata molto prima, e cioè proprio nell'Ediacarano. Infatti il fondo dei mari cominciò a popolarsi di animali sempre più complessi proprio in questo periodo, preparando il terreno al fiorire della vita animale come noi la conosciamo oggi. La prova più antica possibile dell'esistenza di animali in tempi remoti non viene da fossili riconoscibili ma da resti di composti organici chiamati biomarcatori, come una forma particolare di sterano, idrocarburo aliciclico ritrovato nelle rocce di Huqf, in Oman, che hanno almeno 650 milioni di anni, in pieno periodo Criogeniano. Secondo alcuni esso sarebbe l'ultimo resto di un tipo particolare di spugne, che dunque sarebbero vissute già in quell'epoca remota (alle 6.40 del 9 novembre), anche se altri ritengono che siano traccia di forme di vita unicellulari come le amebe. I fossili più antichi proposti come esempi di animali vengono dalla Cina meridionale, la cosiddetta formazione di Lantian, e rappresentano forme di vita a corpo molle che potrebbero essere imparentate con i coralli e le meduse e risalirebbero a 635 milioni di anni fa (alle 11.52 del 10 novembre), ma le condizioni di conservazione dei fossili non sono abbastanza chiare da permettere un'identificazione univoca, per cui la loro interpretazione resta contestata. I più antichi resti animali che mettono d'accordo tutti sono i rangeomorfi di Terranova di cui abbiamo parlato sopra. L'iniziale modesta varietà di fauna tipo Ediacara sarebbe rimasta prevalente per almeno dieci milioni di anni, ma poi il tasso dell'evoluzione animale avrebbe iniziato rapidamente ad accelerare. Secondo Rachel A. Wood. paleontologa e geologa dell'Università di Edimburgo, la documentazione fossile in nostro possesso indica che a partire da circa 560 milioni di anni fa (alle 13.52 del 16 novembre) la biosfera ediacarana iniziò a diversificarsi notevolmente. Alcuni resti conservano segni di graffi i quali suggeriscono che gli animali in questione, come la Yilingia spiciformis citata sopra, si nutrissero brucando le praterie di alghe tra le quali si muovevano, non limitandosi più a restare appiccicati al fondo marino e ad assorbire i nutrienti con l'intera superficie del corpo direttamente dall'acqua. Inoltre sono state trovate le tracce fossili di possibili tane e gallerie scavate nei fondali da un animale ignoto battezzato Treptichnus pedum. Come visto sopra, i primi fossili che presentano resti di scheletri esterni o interni risalgono a circa 550 milioni di anni fa (alle 9.20 del 17 novembre), sul finire del Precambriano. In siti distribuiti in molte parti del mondo, dalla Namibia alla Siberia, sono stati trovati esemplari di Cloudina, scoperti per la prima volta nel 1972 e in grado di costruirsi delicati scheletri tubolari lunghi fino a 7 cm, che somigliavano a una serie di coni gelato impilati gli uni sopra gli altri. Probabilmente i singoli esemplari potevano cementarsi tra di loro a formare strutture simili a barriere o reef. Non è chiaro se Cloudina fosse imparentato con i moderni costruttori di reef come i coralli, tuttavia come i coralli viveva in simbiosi con altri animali dell'epoca, come la spugna Namapoikia. Gli animali si costruiscono uno scheletro per molte ragioni, ma quella di gran lunga più comune è la necessità di proteggersi dai predatori. Anche se non ci sono prove fossili dell'esistenza di predatori nell'Ediacarano, è ragionevole credere che la comparsa degli scheletri rifletta il primo caso di animali che si pappavano altri animali.
Insomma, sta diventando sempre più chiaro che il Cambriano non rappresentò una linea di separazione improvvisa e drammatica tra un oceano popolato solo da monotoni unicellulari e uno pullulante di forme di vita animali. I ricercatori hanno cominciato a raccogliere prove secondo cui gli animali avevano cominciato a sviluppare scheletri e a costruire reef molto prima di quanto si pensasse fino a pochi anni prima. Sono stati costruiti modelli di ecosistemi ediacarani che avevano molto in comune con quelli cambriani. Insomma, come ha scritto Rachel A. Wood, l'esplosione cambriana ebbe un periodo di innesco molto più lungo di quanto creduto in precedenza. Anzi, un gruppo di ricerca cinese e tedesco ha dimostrato che Cloudina ha continuato ad esistere nel Cambriano, e in alcune rocce del periodo Ediacarano sono stati trovati fossili che prima si ritenevano tipici solo del Cambriano. Insomma, il confine tra Precambriano e Paleozoico è molto più sfumato di quanto si pensasse. E per risolvere il mistero dell'esplosione cambriana bisogna capire le dinamiche del mondo ediacarano in cui quegli animali hanno avuto origine. In particolare sono dibattuti i cambiamenti della disponibilità di ossigeno nei mari, inizialmente troppo ridotta. Gli animali hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere, ed è opinione di molti che la diversificazione evolutiva che iniziò nell'Ediacarano avvenne in epoche in cui oscillavano fortemente i livelli di ossigeno nei mari, ricostruibili mediante metodi geochimici tra cui lo studio delle proprietà dei diversi composti del ferro, che si comportano in maniera differente a seconda dell'abbondanza o della scarsità di ossigeno, L'analisi dei composti degli isotopi di carbonio nelle rocce ediacarane dimostrano che in tale periodo il ciclo del carbonio era instabile ed in continua evoluzione, mentre lo studio dei composti ferrosi nelle stesse rocce mostra che probabilmente durante l'Ediacarano l'ossigeno disciolto negli oceani raggiunse una serie di soglie che permisero agli animali di diversificarsi, perchè la quantità di ossigeno disponibile rispondeva al loro fabbisogno metabolico che aumentava via via che essi diventavano più attivi. Oggi i geologi ritengono che gli oceani divennero più ricchi di ossigeno non in modo lento e graduale, ma tramite una serie di aumenti episodici, che a quanto pare coincidono con le variazioni degli isotopi del carbonio, per poi stabilizzarsi solo durante il Cambriano. In tal modo, a lunghe ere in cui l'ossigeno era presente solo negli strati più superficiali dell'acqua degli oceani si alternarono picchi in cui l'ossigeno si sciolse fino a profondità assai maggiori, per poi ritornare solo in superficie, e così via. Ad esempio sembra che gli animali a corpo molle possano costruire un esoscheletro solo quando la concentrazione di ossigeno nell'acqua supera le dieci micromoli per litro, un livello che dovette essere superato varie volte durante l'Ediacarano. Di quel remoto periodo sappiamo ancora troppo poco, ma è ormai quasi certo che l'esplosione della vita cominciò nel corso di esso. Appare quasi certo che i phyla degli ctenofori, dei poriferi (le spugne) e degli cnidari (meduse e polipi corallini) non comparvero nel Cambriano, ma fossero già ampiamente diffusi nell'Ediacarano.
Del resto, già Charles Darwin, l'ideatore dell'evoluzionismo moderno, riteneva che la visione secondo cui il Cambriano era stata l'epoca in cui la vita era stata « creata » tutta d'un colpo fosse una sorta di « illusione ottica » dei paleontologi, semplicemente perchè le parti molli dei corpi dei pluricellulari Precambriani non si erano potuti fossilizzare. Il Cambriano, insomma, non rappresentava l'inizio della vita in sé, ma l'inizio della vita fossilizzabile, dotata cioè di parti dure e di conchiglie delle quale potesse restarci traccia. L'esplosione cambriana, in altre parole, non sarebbe stata un'esplosione di vita animale, ma di tracce fossili. Da qui l'idea di chiamare Fanerozoico, cioè "era della vita visibile", l'eone iniziato 542 milioni di anni fa e tuttora in corso. E anche in questo il grande scienziato aveva visto giusto.
Cliccate qui per leggere come può mutare la superficie della Terra; cliccate qui per accedere alla Tavola sinottica riassuntiva; invece cliccate qui se preferite proseguire il nostro ideale viaggio sulla macchina del tempo attraverso l'Anno della Terra.
| ARCHEOZ. | PALEOZOICO | MESOZ. | CENOZOICO | NEOZ. | ||||||||||||||
| Ad. | Ar. | Pr. | Ca. | Or. | Si. | De. | Cb. | Pe. | Tr. | Gi. | Cr. | Pa. | Eo. | Ol. | Mi. | Pli. | Ple. | Ol. |