

"Fuoco", dipinto di Luigi Righi
Iris
Ssh… Silenzio… Buio. Sono ore che aspetti qui
rannicchiata, abbracciando le tue ginocchia. Fuori è buio e anche dentro di te;
è una tenebra fitta, densa… Talmente densa che nulla la trafigge o la scalfisce,
è viva. Ti avvolge come una morbida coperta, scivola sulle tue braccia fredde,
sui tuoi fianchi. Silenzio. E’ una gigantesca anaconda che ti avvolge,
lentamente, tra le sue spire. Non puoi sapere quanti giri farà intorno al tuo
corpo prima di sferrare l’attacco mortale. Aspetti, consapevole del tuo destino
e consapevole di essere assolutamente impotente nei suoi riguardi: non lo puoi
cambiare, lo puoi solo alterare in superficie e credere che le cose sarebbero
andate diversamente ma, è solo un gioco sadico della tua mente, un trucchetto
sciocco che essa elabora per la tua anima infelice. E puoi raccontarti tutte le
bugie che vuoi e argomentare tutte le scuse di cui sei capace, pur di rendere
meno atroce quello che stai facendo, e che hai fatto, ma sei sempre qui: seduta
sul fondo freddo della vasca da bagno, sera dopo sera, con rivoli di sangue che
ti colano lungo il braccio, dall’interno del gomito verso le dita della mano,
una goccia grossa densa, di un colore rosso cupo, quasi viola. Scorre,
lentamente, ogni centimetro di pelle che incontra non ha scampo. Continua a
scorrere inesorabile nella sua frenetica discesa verso il basso. In una mano
tieni ancora saldo, nel palmo, il mezzo da te prescelto per compiere tale gesto.
Aspetti. In silenzio attendi una morte che non vuole arrivare e che ti congederà
da una vita che, per quanto dolorosa, angosciante e tetra, ancora tu esiti
dall’abbandonare. Aspetti ancora. Per l’occasione ti sei vestita bene: hai messo
quel completo di pizzo bianco che per anni è rimasto inerme sul fondo del
cassetto; hai avvolto quelle tue esili ed eleganti spalle e quei bei fianchi,
pieni e aggraziati, nella tua vestaglia di seta anch’essa bianca che ora giace
afflosciata ai piedi della vasca. I capelli, lunghi e neri, li hai lasciati
sciolti sulle spalle e i piccoli piedi, nudi. Sembri una sposa alla sua prima
notte di nozze: beata e felice per la nuova vita che abbraccia, ma che ha anche
gli occhi velati di una lontana tristezza per la vita che invece si è lasciata
alle spalle. E tu, sta sera, così ben vestita, la tua bellezza è fuori luogo.
Perché così agghindata a festa, ma profondamente infelice, sembri l’esule e
magnifica sposa della morte, che con il passo di bimba coglie nel sonno e
stronca vite ancora sul nascere o solleva dal peso della vita involucri ormai
inutili, incapaci di servire le anime che per tanto tempo li hanno abitati.
Aspetti penosamente che questo accada ma contro ogni tua previsione non succede:
il sangue scorre veloce, ma tu non muori. Perché non muori? Dovresti aver almeno
perso conoscenza ma non lo fai.
E allora è come la sera prima: stessi gesti, stesse bugie. Prendi in fretta i
lacci, il disinfettante e un asciugamano, e tamponi le ferite, fai fermare il
sangue. Con il soffione della doccia lo sciacqui via dalle mani, dalle braccia e
dal fondo della vasca. Ti guardi per un po’ con aria truce e ad un tempo
affranta come a dire: “Sei una povera incapace; talmente vile da non riuscire
nemmeno a morire, troppo egoista per accettare di doverti congedare da questo
mondo. Riesci solo a fare del male a chi più vuoi bene, costringendoli ad
allontanarsi da te. Sei come una flebile increspatura sulla superficie
dell’oceano: troppo piccola e vigliacca per essere onda, ma non abbastanza per
smettere di esistere e semplicemente dissolverti. Orgogliosamente presente ma
sempre in difetto… Come la bellezza cupa dei papaveri che sbocciano in un campo
di morti. E ora rivestiti; tanto lo sai tu come lo so io che domani sera si
riaccenderanno le luci e verrà messa in scena la solita tragedia, con attori
ormai stanchi e trame ormai sciolte che si ripetono sullo stesso palcoscenico da
troppo tempo.” Rassegnata, a occhi bassi, fasci quei solchi nell’incavo del
gomito. Raccogli dal pavimento la tua vestaglia come se fosse il triste cencio
logoro di un fantasma errante. Ti vesti con abiti leggeri, ancora autunnali,
decisamente inadatti al freddo che fa fuori, e rigorosamente di nero: jeans
attillati, anfibi, maglietta e maglioncino di cotone, poi il chiodo di pelle
nera.
Esci. Fuori fa freddo ma è nulla in confronto al freddo che senti nel cuore.
Cominci a vagare a passo lento per le strade deserte di una città addormentata,
spettralmente bella e illuminata dalla luce cupa e fredda dei lampioni. A poco a
poco ti allontani dal centro della città, ti inoltri in vicoli bui, sinistri e
senza nome, talmente scuri che non si può sapere se siano abitati dai vivi o dai
morti. Quasi come in trance ti trascini fino alla stazione. Non è un posto dove
una ragazza di appena vent’anni dovrebbe stare alle tre di notte; non è un posto
per gente per bene a quest’ora, ma tu non lo sei. Ci sono dei ragazzi che
potrebbero avere la tua età o poco più; stanno fumando sdraiati su vecchi
materassi abbandonati ai lati dei binari. Sono disposti a semicerchio attorno a
un fuocherello e quando si accorgono di te sicuramente pensano che sei capitata
a proposito e non si fanno ulteriori domande. Uno di loro ti viene incontro,
forse ti trova carina o, quanto meno, appetibile: fisicamente sei attraente e, a
quanto pare, è sufficiente. Chi sei davvero in queste situazioni non conta;
conta solo quanto sei fatto o depresso o entrambe le cose…Ti sei tolta il
giubbotto e lo hai lasciato cadere a terra come se fosse stato un’appendice
inutile e ingombrante di te stessa; chi sei e chi sei stata sono state
abbandonate insieme al giubbotto. Tiri su fino al gomito il maglioncino e scopri
i grossi cerotti che ti sei messa poco fa. Probabilmente il ragazzo, vedendoli,
ha creduto che ti sia drogata. Ti prende per mano; le tue, bianche e gelate, si
scaldano un po’ nelle sue. Ti fa sedere accanto al fuoco insieme ai suoi
compagni: ti stavano aspettando, o forse stavano aspettando solo una come te.
Dipende solo da cosa preferisci credere.
Non sai ancora cosa sta per succedere, ma alla fine non lo vuoi sapere. Stanotte
hai deciso che sei di loro proprietà, sei il loro giocattolo, il loro
passatempo. Non sei riuscita a capire bene da chi sia partita l’iniziativa; se
dal biondino con il montgomery che ti ha portato qui, o dal ragazzo con i dread,
o ancora da quell’altro, più fatto dei suoi amici, tutto vestito di nero, con
dei grossi anfibi che ti fissa di sottecchi da quando sei arrivata. Cominciano a
svestirti e a toccarti, uno per volta, con una sorta di gentilezza quasi… I
seni, le spalle, i fianchi, tra le gambe… Tu li lasci fare, indifferente. Non
hai più voglia né tantomeno la forza di opporti. Loro abusano di te ma non ti
importa, rimani ferma, marmorea: con gli occhi fissi nel vuoto, le pupille vacue
e le iridi sbiadite. Il tuo corpo risponde agli stimoli esterni ma la tua mente
è sprofondata nell’oblio, le parole e i versi dei ragazzi risuonano come una eco
lontana al tuo orecchio.
E li lasci fare inesorabili.
Quando hanno finito ti lasciano lì: nuda e ferita in più punti, su quel
materasso pidocchioso e sporco. I tuoi occhi sono fissi da qualche parte ma di
sicuro non qui sulla terra, ormai la meta del tuo sguardo è l’oblio. Loro hanno
finito e non hanno più bisogno di te, potevi essere tu come chiunque altra. Non
ti hanno scelta, ti hanno trovata. Ti rivesti piano e scopri segni di abrasioni,
lividi e tagli sparsi su tutto il corpo.
Ti rivesti e riprendi il tuo vagabondaggio per le vie più tetre e isolate della
città. Quelle di cui nessuno si cura mai, quelle che i più non sanno nemmeno che
esistano. Per questo ti piacciono così tanto: in fin dei conti sono esattamente
come te. Continui così finché non albeggia, e allora Fantasma di un ricordo
passato te ne vai insieme a tutte le ombre della notte. Te ne vai a passo
leggero verso un’alba che non perdona, stremata ma soddisfatta, finalmente in
pace trovi il coraggio di congedarti da questa vita per abbracciare il tuo
eterno consorte.
.
Dalia
Non alzarti! Rimani lì, a terra. Aspetta. Tra
poco lui se ne andrà, come al solito; rimani ferma ancora un po'.
Sulle bianche piastrelle del bagno il tuo corpo rimane afflosciato. Lui ti
guarda sprezzante ancora un po', sputa su di te, poi si volta e se ne va a passo
pesante e fiero. Indossa il suo giaccone ed esce di casa sbattendo la porta.
Finalmente.
Non tornerà prima di cinque o sei ore e tu hai il tempo di essere te stessa per
un po'. Ti alzi lentamente perché ti gira la testa e ti accorgi di avere un
labbro rotto e sanguinante. Non te ne eri nemmeno accorta, ormai il dolore lo
senti come una eco lontana, un grido dal passato che si sperde nel tempo e
giunge all'orecchio, solo come un flebile sussurro.
Hai lividi su tutto il corpo, alcuni ancora freschi altri meno recenti, si
confondono con i tuoi bellissimi tatuaggi. Quale oscura natura hanno quei
meravigliosi fiori che hai indelebili sul corpo! Rose, Orchidee, Margherite,
Gigli, Papaveri... tutti i fiori di tutti i colori sono sbocciati su gambe,
braccia, polsi, cosce, schiena, caviglie, piedi... per nascondere profonde
cicatrici che bruciano ancora l'anima da sotto l'inchiostro.
I fiori; è bizzarro che te li sia tatuata, in casa non li hai mai potuti vedere,
come anche ogni tipo di pianta. Quante contraddizioni, ma sei bella anche per
questo: spettinata di sogni e malata di fantasia, aggrovigliata su te stessa e
inesplicabile.
Così diceva lui.
Però ora sei qui, davanti allo specchio, piena dei segni del suo amore. Perché
tu sei bella e lui ti vuole solo per sé. E' un amore morboso il suo, malato,
possessivo. Tu lo sai che non è ciò che vuoi, non è questa la vita che avevi
sognato e per la quale avevi combattuto; è invece esattamente la vita da cui
avevi cercato di scappare, disperatamente e confusamente, senza accorgerti che
sputavi in faccia e baciavi allo stesso destino.
Pur di fuggire dal tuo passato non ti sei resa conto di quale futuro sceglievi.
Così ti sei aggrappata, come all'unica cosa in grado di non farti affondare,
alle poderose braccia di lui; quelle stesse braccia e quelle stesse mani che ora
imprimono il loro amore sul tuo esile corpo candido. Sei una vittima che ama il
suo carnefice: è come una droga potente, sai perfettamente che ti reca danni
irreversibili ma non riesci a farne a meno, non riesci a non perdonarlo ogni
volta che ti picchia, ogni volta che ti violenta.
Chiudi la porta del bagno e con movimenti lenti apri al cassetta delle medicine
e tiri fuori un pacchetto di Marlboro e uno zippo di quando avevi sedici anni.
Cominci a fumare. Accendi la prima sigaretta e ampie volute di fumo azzurrino si
librano nell'aria intorno a te, che sei seduta sulle fredde piastrelle del
bagno.
Fumi lentamente, aspiri ampie boccate e i riccioli di fumo ti si impigliano tra
i capelli. Una dietro l'altra fumi tutte le sigarette del pacchetto.
Dopo quasi due ore sei ancora seduta in bagno con le gambe rannicchiate la
petto, respirando un aria satura e malsana.
Poi ti alzi di colpo in piedi ed esci dal bagno. Sai di avere ancora molto tempo
prima che lui torni ma non riesci a sbloccare la mente e a concentrarti su
altro. Allora prendi un coltello con la punta affilatissima. Torni in bagno, ti
siedi sul piatto della doccia e con la punta del coltello cominci a incidere la
tua morbida pelle di carta velina, seguendo linee immaginarie disegni un grande
fiore con centinaia di petali piccoli piccoli sulla coscia destra, dove non
avevi ancora fatto tatuaggi. "Questo non lo voglio coprire" pensi, hai fatto del
dolore un arte e di una cicatrice un quadro. Con un panno tiepido tamponi le
ferite e quando hai finito fasci con cura tutta la coscia così che le cicatrici
siano uniformi e rimangano intatte nel tempo.
Sono passate altre due ore e il tempo che hai a disposizione è sempre meno; sai
perfettamente cosa vorrà una volta tornato a casa e non se lo prenderà con
gentilezza.
Con le pupille vacue e lo sguardo perso nel vuoto indossi i vestiti più sexy che
hai e ti prepari sul letto, in attesa che lui arrivi e soddisfi su di te i suoi
istinti. Appagarlo ti fa sentire meglio, ti fa sentire importante e ti sembra
quasi che ti ami, ma in realtà ti sta solo sfruttando.
Sono mesi ormai che non esci più di casa, la tua vecchia amica era preoccupata
ma, tu non le hai voluto raccontare ciò che ti stava succedendo e hai gettato
alle ortiche l'unica possibilità che avevi di uscirne. Lei ormai non si chiede
più come stai, cosa fai, dove sei... per lei sei solo un ombra del passato che
fugace scomparsa all’improvviso.
Non hai avuto un'infanzia come le altre bambine: fin da quando andavi alle
elementari hai sempre avuto uno strano gusto per il macabro, giocavi spesso con
lucertole e grossi insetti: li torturavi, solo per vedere quanto resistevano.
Tutti ti consideravano una bambina strana, solitaria e crudele. Ma nessuno
arrivò mai a pensare che ciò che facevi agli insetti fosse in realtà lo specchio
di ciò che subivi a casa.
Tua madre era una donna giovane e bella, e tu le somigli molto; ti aveva avuta
da un uomo che dopo una notte non rivide più. Lei aveva la pessima abitudine di
saltare da un uomo all'altro come nel gioco della cavallina; la sera era sempre
fuori e non aveva mai un impiego stabile. La topaia in cui vivevate era buia e
polverosa; nessuno faceva mai le pulizie o metteva in ordine e tu eri di certo
troppo piccola per farlo, e in ogni caso non c’era nessuno che avrebbe potuto
insegarti dal momento che nemmeno tua madre sapeva fare le pulizie. Tua madre
pagava l’affitto a mesi alterni e a volte nemmeno dopo tre mesi a causa dei
numerosi licenziamenti e dei lavori sempre provvisori; il proprietario non vi
sfrattava solo perché tua madre gli faceva dei favori.
Gli uomini che portava a casa erano tutti ubriaconi, che la picchiavano e si
drogavano; spesso e volentieri coinvolgevano anche te nei loro "giochi", così ti
dicevano per convincerti a stare buona e a subire, tua madre era sempre troppo
sbronza per rendersi conto di quello che succedeva. Avevano rapporti sia con te
sia con lei e ti picchiavano, ma tu non avevi il coraggio né la forza di
sottrarti o di opporti.
Avevi solo quattro anni.
Fino al tuo sedicesimo compleanno. A sedici anni eri ormai una donna e potevi
andartene se volevi. In quel periodo avevi un fidanzato; lui sembrava un bravo
ragazzo, dopo tanti sempre più simili agli uomini che portava a casa sua madre.
Ti accarezzava ed era dolce e gentile. Aveva vent'anni quando tu ne avevi e un
giorno decidesti di scappare con lui, lontano, lontano da tutto e da tutti.
Ma la dolcezza e la gentilezza sono boccioli di rosa che appena colti
appassiscono e muoiono anzi tempo. Egli si rivelò negli anni non migliore dei
tuoi antichi carnefici ma... ma tu lo amavi, con ogni cellula del tuo corpo lo
amavi e non lo avresti lasciato andare, per nessuno motivo.
Il tuo tempo sta scadendo cara dolce Dalia, tra un’ora lui sarà di ritorno.
Chissà che cosa dirà della tua nuova incisione, forse gli piacerà. In realtà lui
non vorrebbe che tu ti incidessi la carne col coltello per fare quei disegni,
che poi, disgustata, copri con dei tatuaggi. Spesso avete litigato pesantemente,
in passato, a causa di questa tua inclinazione ma ora sembra che si sia
rassegnato.
Hai preparato tutto nei minimi particolari, ormai sei una maestra nel
trasformare il luogo di uno sfruttamento in un dolce nido solo per mascherare a
lui, ma soprattutto a te stessa, il dolore che ti provoca la sua ingombrante
presenza nel letto.
Quando lui arriva tu sei pronta ad aspettarlo sul letto. Lo senti entrare in
casa con quel suo passo pesante e foderato dalle scarpe. Lui butta sul divano il
giaccone senza troppa cura, si toglie le scarpe e le lascia di fianco alla porta
di ingresso. Poi va in bagno, sa che lo stai aspettando, si toglie la maglietta
e i pantaloni e li butta nella cesta dei panni sporchi. Si lava le mani e il
volto, la doccia la farà dopo.
Entra in camera e ti trova sdraiata sul letto. Senza dire una parola si avvicina
a te e tu, che gli dai le spalle, sai che sta arrivando, che è lui, ma non lo
guardi. Non lo guardi più da tempo ormai. A lui non sembra importare, sei
ridotta ad un oggetto che risponde e reagisce ai suoi stimoli, sei un muscolo
ben addestrato, un attore che recita sempre lo stesso copione.
Lui ti piomba addosso da dietro, ti mette due dita in bocca e ti possiede con
brutale violenza. In breve tutto si conclude, lui esce e va a lavarsi.
Il tutto è durato non più di pochi minuti, non gli serve nulla di più. Non gli
serve che tu faccia nulla. Tu resta ferma e obbedisci; o forse sarebbe meglio
dire: resta ferma e subisci. Dopo che lui se n’è andato in bagno tu sei rimasta
sdraiata sul letto, un rigagnolo bianco ti è colato sulla gamba ma tu quasi non
lo hai sentito.
Pur di non soffrire, la tua coscienza è riuscita a liberarsi momentaneamente dal
corpo, tu vivi queste esperienze praticamente a livello subconscio, non ne
conservi quasi ricordo. Poi lentamente riprendi padronanza di te stessa e del
tuo corpo e ti rendi conto di ciò che è successo. Non te lo ricordi ma puoi
benissimo immaginare cosa può aver fatto.
Non vuoi ricordare, mai più.
Ti alzi barcollando dal letto e vai in bagno dove lui si sta facendo una doccia.
Ti lavi dal corpo le tracce di quel gesto, di quell’abuso. Ti vesti con il
pigiama e torni a letto, sotto le coperte. Aspetti che lui finisca la sua doccia
e venga anche lui a dormire.
Voi due non parlate più, non vi confidate più. Non vi raccontate come sono
andate le rispettive giornate quando lui torna a casa dal lavoro, non vi
confidate più i segreti più nascosti. Quasi nemmeno vi guardate mentre vi
muovete per casa. Provate ribrezzo l’uno per l’altra ma tu continui ad amarlo
anche nel disprezzo, anche se lui non ti ama più. Ha solo troppa paura di
ammettere a se stesso che non può lasciarti, solo perché gli servi. E tu non
vuoi ammettere a te stessa che senza di lui godresti di una salute e di una
bellezza invidiabili ma, preferisci che lui ti distrugga con le sue mani
piuttosto che trovare il coraggio di andartene e ricostruire ciò che uno stolto
ha distrutto senza aver mai saputo il vero valore di ciò che aveva, e che
rovinava. Siete finiti per essere due estranei l’uno per l’altra.
E la cosa peggiore è che siete due estranei che non sanno più di esserlo. Ormai
l'agonia per te è diventata parte della routine giornaliera e lui, che sa di
averti salvata dal tuo passato, non sa di esserne l'estensione nel tuo presente.
Proprio non se ne rende conto. Anzi, consapevole di averti fatto un favore
sposandoti, si sente per questo in diritto di farti questo. Tu lo sai però, ma
in quel misero corpo che trascini debolmente in questo mondo non sono rimaste le
forze per opporsi. Vivete nella stessa casa, mangiate dallo stesso piatto,
dormite nello stesso letto; ma non vi parlate quasi più, nemmeno per le cose di
prima necessità pratica, e non sapete, ma forse non lo volete sapere, le persone
che in questi anni siete diventati. E non vi siete nemmeno mai chiesti chi siete
diventati l'uno per l'altra, semplicemente perché chiederlo costa troppa fatica
e rispondere sinceramente fa troppo male. E nessuno dei due ha né forza né
intenzione di fare domande dalle risposte tanto complicate e faticose: lui per
mancanza di coraggio, tu per mancanza di forza.
.
Narcissa
E mentre la guardavo lei rimaneva lì, ferma,
in piedi davanti a me, con gli occhi bassi. Quando litigavamo noi non gridavamo
mai, non facevamo inutili scenate, solo... lei rimaneva lì davanti a me, e
fissava le punte delle sue scarpe. Non diceva nulla ma era come se mi spiegasse
tutto, e io capivo. Non avevo bisogno di inutili perifrasi per sapere come
stava, era come se fosse sempre stata parte di me e io la capivo e la conoscevo
come me stesso. Poi improvvisamente, mentre rimaneva a fissarsi le scarpe, una
densa lacrima salata cadeva a terra, in silenzio. E a quel punto era come se
diventasse piccolissima, come se tornasse bambina; si faceva piccola in quel suo
maglione troppo grande e si vedeva che per lei quello sfogo era imbarazzante e
che, molto probabilmente, era l’unica rara occasione in cui si concedeva una
sola lacrima davanti a qualcuno. Non era abituata a mostrare le sue fragilità
perché ciò che la vita le aveva riservato fino a che la incontrai, e anche dopo,
l’avevano sempre voluta forte. Aveva sempre dovuto trattenere il pianto, perché
nessuno la vedesse indifesa di fronte a se stessa, e sfogarlo solo dopo, quando
fa più male.
Quando litigavamo non riuscivo ad essere davvero arrabbiato con lei; non perché
mi facesse pena o altro, anzi, litigare con lei era come prendere una lametta e
sfregiarmi le braccia. Non riuscivo ad arrabbiarmi davvero perché sentivo che
lei era una persona diversa da qualunque altra; era talmente fragile che
sembrava fatta di sottilissimo cristallo e a volte anche un abbraccio troppo
stretto o un bacio troppo passionale potevano ferirla; era una ragazza piena di
insicurezze, ma con le quali si era costruita un’armatura tanto spessa da
sembrare agli altri una ragazza che era l’opposto di com’era lei realmente; e
sapevo che qualunque cosa potesse cercare di fare non poteva cambiare se stessa,
nemmeno per amore. Ma io sì. Io potevo cambiare per amore, potevo cambiare per
lei. A volte, quando capitava che restassimo in silenzio pur essendo nella
stessa stanza, mi prendeva una strana angoscia, e non riuscivo più a muovermi o
a respirare o a pensare. L’unica cosa che avevo in mente era la sua fragilità,
ed era come se mi contagiasse. Avevo paura di spezzare il suo cuore di vetro
esattamente com’ero riuscito a mandare in frantumi la sua spessa scorza di
diamante. Poi quando riuscivo a riprendere fiato e a pensare lucidamente, allora
mi buttavo su di lei e l’abbracciavo, e la stingevo sul mio petto come se in
tutto quel tempo fossi stato altrove e lei non fosse stata mia. Lei mi guardava
un po’ stranita ma contenta di questo gesto improvviso e spontaneo e mi
abbracciava forte anche lei.
Quando litigavamo, dopo aver assistito alla fuga di quell’unica lacrima, io mi
avvicinavo a lei lentamente, e la prendevo tra le mie braccia, la stringevo
forte al petto ma con la delicatezza di chi prende tra le mani un uccellino
ferito. Lei rimaneva ferma, scossa solo dai singhiozzi del pianto che ormai,
irrefrenabile, le rigava le guance.
Era bellissima. Non so come facesse, lei non se ne rendeva conto, ma quando
soffriva era molto più bella del solito. Era come se il dolore la illuminasse di
una luce nuova, cupa, molto cupa, ma rendeva meravigliosa e di conseguenza tutto
ciò che faceva e diceva era tutto bellissimo; ma pregno d una tristezza
disarmante; e sapeva essere così bella solo quando era scossa da emozioni
altrettanto forti, come l’amore. Però quando era così bella senza soffrire, era
come se soffrisse lo stesso, come se quelle emozioni fortissime, che la
rendevano bellissima, la rendessero così bella proprio perché, in un qualche
modo che era difficile da definire, la ferivano. Sì, lei era talmente fragile
che veniva uccisa da qualunque emozione forte; eppure era sorprendentement3e
capace di sopportare l’esplosione di tutte contemporaneamente. In quei momenti
era così indifesa che avrei potuto prenderla sul palmo della mia mano e
stringerla fino ad ucciderla, ma invece sceglievo di amala.
Come diceva Emily Dickinson: A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza aver
avuto il privilegio di aver sofferto altrettanto. Ebbene io per questo mi
sentivo ogni volta come se stessi violando qualcosa di quasi sacro e di certo
molto, molto prezioso. E non mi sentivo all’altezza.
.
Lily
Soffia lenta la morbida brezza del primo
inverno. Alle tue spalle, sulle tue spalle. E tu immobile, rimani a guardare i
piccoli cerchi infiniti che si formano sul pelo dell'acqua. Guardi giù, fisso.
I tuoi capelli castani, un po' mossi, seguono le sinuose forse del vento.
Tieni le tue candide mani di porcellana unite, sulla ringhiera fredda e
metallica, le dita intrecciate tra loro. Il tuo esile corpo sembra essere tenuto
in piedi solo dall'effimera brezza che ti sposta i capelli. Quel tuo maglione
grigio ha delle maniche troppo lunghe. A te piace così ma quasi non ti si vedono
le mani. Non sono sempre state così lunghe quelle maniche; con il tempo, a furia
di tirarle sulle mani, si sono rassegnate a resisterti e si sono lasciate
andare, inermi sulle tue braccia. Tutto ciò che indossi è sempre estremamente
largo, quasi volessi seppellirti sotto una montagna di vestiti: felpe grandi,
maglioni larghi, scarpe slacciate, solo i pantaloni sono jeans attillati, che
cercano di mostrare ciò che tu ti ostini a nascondere.
Tu sei sempre sola. E' questa la tua condanna, la tua maledizione. Sei sempre
sola. Sei uno spirito errante in questa dimensione, ma capitatoci per caso e
rimastoci intrappolato; impantanato fino al collo. Sei capitata in questo corpo
per sbaglio, "errore umano" lo chiamano, ma se l'è mai chiesto qualcuno cosa
volevi tu? Te lo sei mai chiesta che cosa volevi tu?
Ogni millimetro di pelle ti separa, ti separa da tutto il resto. Potresti
giacere nuda in mezzo a una folla e saresti comunque isolata, protetta da tutto
ciò che sta fuori di te. La tua è una pelle infinita, spessissima, ma fragile
come carta velina, quasi trasparente eppure... Eppure è come un muro, una
fortezza. E nonostante la tua invalicabile fortezza ti copri, anche di più se
possibile, aggiungendo strati su strati.
E non ti accorgi di quanto sei bella, di quella bellezza pura che non sa di
esserlo. Una bellezza che non si aspetta di essere tale e non si cerca, e non si
fa cercare. Una bellezza fragile, data dal precario equilibrio tra l'armonia
delle forme e il dolore.
E rimani lì ferma, con la punta dei piedi fuori dal bordo; questo inclemente
cielo plumbeo è una pesante cappa scura, che opprime le creature che vivono
sotto di esso.
La morbida brezza è diventata un gelido vento di spilli, che sferzano rabbiosi
le tue spalle, ti pungono in ogni punto, in ogni momento. E' in nemico crudele,
sleale: è un arciere che si nasconde e ti colpisce da lontano, vedendo senza
essere visto. E tu non puoi difenderti. E lentamente cadi sotto i suoi colpi. E
questo inclemente cielo plumbeo non ha ancora finito di soffocarti: a poco a
poco comincia a piovere.
Tu, immobile, come incapace perfino di respirare. Le piccole gocce d'acqua si
tuffano nel fiume sotto i tuoi piedi.
E tu che cosa ci fai ancora qui? Su questo ponte di ferro che spietato è come
una spina nel fianco di questo fiume. Tutt'intorno c'è il deserto. C'è
un'immensa città che produce solo scarti, e con i suoi fumi uccide e soffoca
ogni vita che ardisca di dirsi libera. E questa passerella di ferro su cui stai
con i piedi penzoloni, è tutto ciò che ti separa dal tuo inferno, è il tuo
limbo.
Quei grandi occhiali neri che porti sempre, riflettono ora tutto il vuoto che
hai dentro, tutto il vuoto che ti circonda.
Quando sei morta esattamente? Chi lo sa... Forse un giorno grigio come tanti
uguali. E semplicemente hai smesso di essere qui con tutti gli altri, tu sei già
dall'altra parte. Ma il tuo corpo è ancora qui, cosa c'è dall'altra parte?
Raccontalo anche agli altri, forse capiranno, forse cambieranno. Perché scuoti
la testa pessimista? Tu lo sai, lo sai che sono solo menzogne; sono solo automi
programmati per funzionare in un certo modo. Non possono capire, e allora cosa
vuoi fare qui su questo ponte? Vuoi andartene, per sempre, tornare a casa.
E' il tuo ponte, è il tuo limbo. Puoi scegliere: o su, o giù. Puoi tornare nel
tuo inferno oppure tornare a casa.
E allora ti alzi in piedi, la tua scelta è chiara. Un po' teatrale il modo che
hai scelto per tornare a casa, un po' letterario. Quanti metri saranno da qui al
pelo dell'acqua? Forse troppi, forse troppo pochi.
Appoggi delicatamente i piedi, foderati in quegli anfibi più pesanti di quello
che ammetti. Poi d'un tratto è come se ti avessero tolto un peso; cadi come cade
un burattino a cui abbiano tagliati tutti i fili. Con le braccia aperte come un
angelo che stia spiccando il volo. Ma cadi, non voli.
Ti sei completamente abbandonata alla vertigine, a quel cupo desiderio di cadere
che spaventa, ma non te. Tu gli sei corsa incontro e ti sei abbandonata al suo
abbraccio.
Cadi perdendo il tuo peso metro dopo metro.
Cadi e i tuoi bei capelli castani si scompigliano al vento della gravità. Gli
spilli di ghiaccio ormai non sono più nulla sulla tua pelle, sono come diventati
lievi fiocchi di una neve inesistente. Continuava a piovere incessantemente e
mentre cadi sei già inzuppata, bagnata fradicia, affogata prima di affogare.
Precipiti dell'oblio a occhi chiusi, pregustando il piacere della liberazione,
dal peso immane di questo mondo ignorante.
La morte è solo una porta, una soglia da oltrepassare per giungere dove non
possiamo immaginare e dove non ricorderemo chi eravamo. Sarai altro spirito,
altra materia, altro mondo. Le acque di questo fiume sono il tuo portale, il tuo
passaggio, e continua a cadere inesorabile e impaziente verso quel mondo che non
sai.
Sei bagnata fradicia fino alle ossa, il freddo di questo inverno ti sta
arrivando fin nel cuore; il tuo povero cuore che si è indurito a causa del
cinismo crudele di questa città, di questa aria, di questo mondo.
Cadi, e il tuo corpo produce un tonfo sordo che nessuno ode quando ti immetti
nell'acqua gelida del fiume, quando la tua anima varca la soglia. Quel corpo che
tu ebbi l'illusione di vedere amato, da un uomo che non poteva amare nessuno
all'infuori di se stesso e di ciò che faceva per se stesso.
Sei sempre stata diversa da tutto ciò che ti circondava, un errore su sette
miliardi nella catena di montaggio. I tuoi bei capelli castani, sciolti sulla
spalle, sono ora in balìa delle piccole correnti del fiume; il tuo viso candido
di madreperla conserva i suoi bei lineamenti cerei, le tue labbra rosse e
sottili, leggermente schiuse.
Ti lasci dolcemente affogare, piano piano, senza fretta, e con la pazienza che
solo nella morte si può avere, oltrepassi il varco, ti cedi completamente a
un'altra realtà.
Risuona nell'aria un tonfo sordo quando cadi in acqua, ma questa città così
operosa, un po' colpevole, non si accorge di aver pestato un piccolo fiorellino
indifeso. E questa città un po' colpevole non ha il tempo di fermarsi, non può.
Un tonfo sordo risuona nell'aria quando precipiti, e solo questo temporale
implacabile ti dedica un minuto di silenzio.
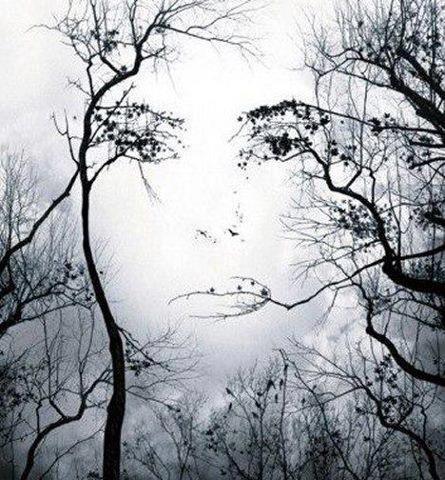
.
Acantha
E' una grigia giornata di nuvole spesse e
gravose sul destino degli uomini... è un triste giorno di un inverno che gela il
cuore e sferza gli animi. Nessuna speranza è rimasta per le anime dannate che su
questa terra vagano, costrette dai propri corpi, a stare le une con le altre in
un vincolo mortale.
Perché in così tanti credono che la vita sia un dono? Non è detto che sia
l'unica che abbiamo, forse è l'unica di cui abbiamo coscienza; e se ciò deve
derivarci solo dolore, non è forse meglio vivere senza saperlo? In fin dei conti
siamo l'unico essere vivente sulla terra che comprende, anche inconsciamente,
nella maniera più primitiva, il trascorrere del tempo, la vita e la morte
all'interno di esso. E a causa di questa innata capacità ci struggiamo perché
comprendiamo anche la nostra impotenza nei riguardi della vita e della morte.
Cerchiamo ragioni, carnefici, creatori, un destino; qualunque cosa che ci sembri
possa servire a rallentare il naturale processo e qualunque cosa che ci sembri
possa dare un senso a questa ricerca. Inventiamo religioni, combattiamo guerre
in nome di esse, inventiamo ideologie, correnti di pensiero, stili di vita... E
poi, come se non fossimo consapevoli di tutto ciò, e lo scoprissimo di nuovo per
la prima volta, inventiamo scuole, università, licei e istituti per studiare ciò
che abbiamo inventato come se provenisse dall'alto, da un dio che non c'è. Tutto
questo solo perché non sappiamo come occupare il tempo di questa misera
esistenza a cui non sappiamo dare un senso; perché le nostre piccole e fragili
menti non sono in grado di accettare che non c'è nessun piano, nessun disegno,
nessun creatore; siamo solo un errore maturato troppo in fretta, all'interno di
un granello di sabbia nell'immenso universo; una formica ai confini di un
burrone. Non siamo in grado di sopportare il peso della delusione nello scoprire
che il gelido universo non si cura dell'uomo, e che le stelle brilleranno
comunque, anche se non ci siamo noi a guardarle.
La città sono piene di sfollati provenienti dalle campagne in esubero; le nuove
industrie, che hanno distrutto parte della vegetazione rigogliosa della pianura,
danno molti impieghi ma la gente è sempre di più e non si sa cosa fare. Eppure
di ragazze come me non ne mancano, anzi sospetto che ce ne saranno sempre di
più, le donne come noi hanno un destino diverso dalle altre: donne strane,
isolate, perdute, che in questo triste giorno stanno per lasciare il loro
vincolo per sempre per tornare libere e leggere alla loro primitiva materia.
Lasciano questa terra e questo corpo senza rimpianti; perché siamo donne e
ragazze infinitamente tristi e sconsolate, in grado di fare del bene e del male
insieme e nessuno ne sa il motivo... ci disprezzano ma gli serviamo, e non lo
vogliono ammettere perché gli fa più comodo condannare un plausibile innocente,
piuttosto che cercare il vero colpevole. Ci condannano consapevoli che non
abbiamo colpa, se non quella di essere diverse da tutte le altre. Noi non saremo
mai mogliettine remissive e riflessive, non saremo mai sottomesse; siamo donne
emancipate, diverse, indipendenti... sole. Ma finalmente saremo libere un
giorno, e quel giorno, per noi, è oggi. Oggi è il giorno del compimento del
nostro destino su questa terra, stiamo per passare a un altro mondo dove potremo
essere noi stesse senza nasconderci, un mondo dove tutti sono egualmente degni
de egualmente punibili, e nessuno è condannato o discriminato o perseguitato per
le proprie differenze. Siamo donne tristi, ma questa corda sarà il nostro
passe-partout per quel mondo tanto agognato.
Le strade di Liverpool puzzano di urina, l'aria è satura e umida. La folla si è
radunata nella piazza principale, sotto il palazzo del governatore sono
posizionate le forche di legno. Dieci cappi pendono
inerti, dieci botole sono chiuse sotto di essi. Dieci ragazze vestite di nero
con un sacco di iuta in mano stanno in piedi, con lo sguardo perso
all'orizzonte, ritte, in attesa della loro sorte.
L'aria pesante è ferma e nessun suono o rumore la disturba.
La gente si è radunata a centinaia sotto le forche, ci sono intere famiglie:
uomini e donne con figli, li hanno portati a vedere la pubblica esecuzione per
dar loro l'esempio. I corpi poi rimarranno appesi, esposti alle intemperie e
alla folla per una settimana; dopo di che verranno i frati che seppelliranno i
corpi nelle campagne. Tra la folla c'è chi sputa e chi le guarda bieco, il
disprezzo regna sovrano.
Loro impassibili fissano la loro folla di carnefici, che ignoranti e gretti,
acconsentono al massacro e anzi ne esultano. Sì, perché di questo che si tratta,
un massacro. E’ un massacro scelto dalle vittime, una condanna che loro stesse
hanno emesso. Si sono liberamente condannate nel momento in cui hanno deciso di
intraprendere quella strada, erano pienamente consapevoli di ciò che un giorno
avrebbero dovuto fare, e hanno accolto il loro destino con condiscendenza e
pace.
Ora, nel silenzio più assoluto, nella piazza principale di Liverpool, tutte
insieme intonano un canto in una lingua sconosciuta. E' una lenta e malinconica
litania, che parla di morte, che parla di un dio e delle sue malvage creazioni,
un canto che è un richiamo e un riconoscimento, una melodia triste che fa da
colonna sonora al momento del varco. Le note della nostra melodia maledetta
risuonano per tutti i vicoli della città, i più nascosti, i più luridi, i più
perduti e dimenticati, rivivono sulle note del nostro canto.
Il boia, vestito di nero, sale sulla prima forca.
Noi ragazze avanziamo tutte di un passo, all'unisono, senza smettere di cantare.
Il boia si avvicina alla prima di noi e fa calare sul suo volto il sacco di iuta
e sul suo fragile collo il cappio di corda. Noi continuiamo a cantare, canteremo
fino alla fine, nemmeno la morte potrà soffocare il nostro inno. Un minuto di
silenzio da parte della folla, e solo il nostro canto come sottofondo a questo
scenario, di morte voluta. Il boia, senza guardare direttamente la condannata,
aziona la leva della botola. Si ode un tonfo sordo. Poi il levarsi in aria di
decine di corvi. Il corpo della nostra compagna pende inerte dalla forca.
Lentamente il boia si sposta alla seconda forca, poi alla terza, alla quarta...
sempre la stessa danza, sempre gli stessi gesti meccanici, sempre senza
guardarci, forse per disprezzo o forse solo per pena. Ora è arrivato alla
settima, tra non molto toccherà a me; sono pronta, la morte non mi coglie di
sorpresa, fino ad oggi le ho sempre corso in contro, passo dopo passo, senza
tradirla mai. Mia amica. I corpi delle mie compagne pendono tutti nello stesso
modo, quasi, non si distinguono le identità delle une e delle altre, uguali
nella morte, come mai lo siamo state in vita, quando invece ostentavamo e ci
gloriavamo delle nostre differenze. Ma proprio a causa di quelle differenze ci
hanno emarginato, sfruttato, perseguitato persino e schiavizzato. Ma non siamo
rimaste ferme a guardare, non gli abbiamo permesso di strapparci la nostra anima
immortale. E ora, come cupe stelle, risplendiamo per l'ultima volta. Ora è
finalmente arrivato il mio turno, il boia si allontana dalla forca accanto alla
mia e si dirige versi la leva della mia botola. Si avvicina a me, da dietro, mi
mette un braccio intorno alla vita, m immobilizza, prende dalla mia mano il
sacco di iuta e me lo cala sul volto; poi afferra con le sue mani nerborute il
cappio e me lo cala attorno al collo. Infine, sempre senza guardare, come ha
fatto con le altre, aziona la leva della botola. Si sente il cigolio aspro e
acuto delle giunture della botola per un secondo mi sento mancare la terra sotto
i piedi.
Buio. Fine.
Gli altri odono il tonfo sordo, la corda si è tesa e il cappio si è stretto. Il
mio collo, spezzato.
Ciondolo, appesa alla forca, vestita di nero come se fossi in lutto. Come tante
altre cose nella mia vita, mi hanno imposto anche questo, ma io non sono triste,
come suggerisce il mio abito; sono felice e libera come non lo sono mai stata.
.
Viola
Diciannove e diciannove.
Apri lentamente gli occhi, ma rimani folgorata dalla luce bianca e fredda della
lampada al neon, appesa sopra il tuo letto. Li richiudi. Le palpebre sono
pesanti ed emaciate e i tuoi occhi, che una volta erano stati di un bel verde
brillante, sono ora opachi specchi della tua dolorosa realtà e della tua giovane
anima appannata dalla delusione e dal ribrezzo. Nella stanza c'è un silenzio
spettrale, e un candore innaturale nella luce, accentuato dal colore delle
pareti delle pareti e della tua vista limitata e appannata.
La porta era di un colore azzurro-verde molto elettrico come anche la coperta
posta sopra le tue ginocchia e il contorno del soffitto: una sottile striscia di
vernice azzurro-verde che percorre il perimetro della stanza. Tutto il resto è
bianco. Gli unici oggetti presenti nella stanza sono il letto si cui giaci, un
comò con un paio di cassetti e delle boccette poggiate sopra, e una siringa
monouso scartata ma immacolata. Le imposte che chiudono l'unica finestra della
stanza sono di un grigio chiaro, quasi elettrico. Era come se tutto nella stanza
fosse elettrificato da una scarica invisibile di elettricità che rendeva tutto
quasi vivo, pulsante. Le luci al neon sono talmente forti che sembra quasi
giorno, e invece, in questa serata invernale, è già buio diciassette. Sotto la
finestra c'è un calorifero bianco ma tu non lo vedi; è acceso, ma tu non
percepisci il suo calore sulla pelle, sei seduta su questo letto d'ospedale,
sostenuta da tre grossi cuscini bianchi, avvolta nel lenzuolo di cotone e nella
coperta azzurra. L'infermiera te l'ha messa sulle ginocchia e ora ti arriva a
mezzo busto, le braccia te le ha lasciate fuori: emaciate e livide, deboli e
inerti si sono abbandonate sul letto. Nel braccio destro hai il grosso ago della
flebo, tenuto fermo con un po' di scotch di carta da medicazioni; su entrambe le
spalle presenti i segni di contusioni, ematomi e lividi che stanno ingiallendo,
piano piano, cercano di guarire. Nell'incavo del gomito sinistro hai la flebo
della morfina e nella mano debole e senza forza hai il piccolo pulsante che
aziona il dosaggio. Di fronte al letto c'è un grosso orologio digitale che segna
le diciannove e venti. Il tempo in ospedale è dilatato al punto di da non
rendersi conto se è il tempo della terra o quello di un altro frammento nella
linea spezzata del tempo. E' passato solo un minuto ma è sembrato un'ora, forse
molto di più.
Ti senti la testa pesante, e ti sembra di non poterti muovere. Inizi a provare
con le dita, prima piedi, poi le mani, le muovi una per una lentamente. Ti
assicuri che ci siano tutte. Poi provi a muovere le gambe, piegare le ginocchia,
sempre molto lentamente. Quando però provi a piegare i gomiti senti una dolorosa
fitta: ti accorgi di avere le flebo, prima di allora non te ne eri accorta,
quasi non le sentivi. Riesci però a portare le tue sottili dita di seta al viso,
nonostante le fitte causate dalle flebo. Non trovi quella che ricordavi essere
la tua pelle, ma trovi una superficie ruvida e percorsa da centinaia di vie che
si incontrino e si sovrappongono: hai il volto fasciato in una maschera di
garze.
Porti le tue dolci dita, sottili come fili d'erba, sul collo, sul petto, sul
seno, sulla pancia, le infili sotto il bianco camicione da ospedale. Ti accorgi
con orrido stupore di essere ferita e sfregiata in volto. Ma come ci sei finita
in ospedale? Il tuo ultimo pensiero è stato la certezza di morire, ma invece sei
viva e respiri; come sei arrivata qui? Chi ti ci ha portata?
La luce al neon è accecante e non riesci ad aprire gli occhi, le tue palpebre
sono ustionate e di un colore violaceo, sono troppo pesanti da sollevare. Ma in
quei pochi secondi in cui hai aperto gli occhi sei riuscita
a scorgere qualche ombra, per poter delineare una vaga mappa degli oggetti
presenti nella stanza e per rilevare l'eventuale presenza di visitatori o
infermiere o medici.
Non c'era nessuno.
Ti accorgi di che ore sono ma la percezione del tempo si è tramutata in un
concetto astratto, non ricordi molto di ciò che ti ha portata qui, né di quanto
tempo tu abbia passato priva di coscienza. Vuoi chiamare un'infermiera per
sapere che giorno è, in che condizioni se, quanto dovrai stare ancora in
ospedale, chi ti ha portata lì e perché si è reso necessario che mi portasse in
ospedale; ma scopri con orrore di non poter parlare, avverti improvvisamente un
intenso bruciore alle labbra e ti accorgi di avere le garze anche sopra la
bocca, a cavallo del naso, intorno agli occhi. Probabilmente non hai più le
sopracciglia né parte delle ciglia.
Aspetti. Non potendo muoverti dal letto e senza poter chiamare un'infermiera,
rimani ferma con gli occhi chiusi sperando che qualcuno entri da quella porta.
Dopo ore di immobilità e lancinante silenzio si sente aprire la porta. Entra un
uomo alto, moro, vestito di bianco ma con una maglietta dello stesso colore
della porta e del profilo della stanza. Pare abbia una cartellina in mano o
qualcosa di simile. Si avvicina al capezzale del letto e ci si siede,
appoggiando una delle sue grandi mani sulla tua, piccola e macilenta. Ti scuote
con delicatezza credendo che dormissi. Con non poca fatica cerchi di aprire gli
occhi; notando che ti dava fastidio la luce forte sposta la lampada. Allora
riesci finalmente a vedere bene, a distinguere con chiarezza i contorni degli
oggetti e i colori. Dopo esserti fatta un'idea di dove ti trovi, fissi i tuoi
occhi verdi in quelli inaspettatamente azzurri del gentile dottore. Lui ti
guarda sorridente e speranzoso come se aspettasse che tu dicessi qualcosa. Poi
si ricordò della benda che avevi sulla bocca; allora si alzò in piedi lentamente
e ti sciolse il nodo che ti aveva fatto il giorno prima dietro alla nuca. Aveva
portato con sé una valigetta bianca che conteneva delle bende, altrettanto
bianche, del cotone idrofilo, delle pinze e del disinfettante. Con estrema
delicatezza cominciò a sciogliere le bende che avevi sul volto, mostrando a poco
a poco la carne ustionata e in parte corrosa dall'acido. In assoluto silenzio il
dottore la disinfettava, la sciacquava e la ribendava. Lei si lasciava fare
docile e ubbidiente come un agnellino. Nessuno dei due aveva parlato nemmeno un
secondo: il dottore si limitava a sorriderle amabilmente e lei lo fissava con
occhi sgranati, che sembravano anche più grandi, a causa dell'assenza di pelle
attorno agli occhi. Dopo averti medicata il dottore se ne va lasciando solo una
luce molto bassa accesa, così da poterti lasciare dormire. Lui se ne va e tu
resti seduta sul letto a fissare un punto indefinito sul muro.
Sera dopo sera, sempre alla stessa ora, il dottore entrava nella stanza, si
sedeva sul letto, ti sorrideva, lentamente ma con gesti decisi e precisi ti
sbandava, ti disinfettava e poi ti medicava di nuovo. A volte ti parlava ma non
sempre tu lo ascoltavi. Se parlava e tu lo stavi a sentire, ti accorgevi con
disperazione di volergli rispondere e di non poterlo fare. Lui se ne accorgeva e
sorrideva; diceva che ci sarebbe voluto un po' di tempo, ma che saresti tornata
bella come prima.
Quando aveva voglia di parlare ti raccontava un po' di lui, dei suoi figli; ti
diceva che non vedeva l'ora che tu guarissi, perché un sacco di amici venivano
in ospedale a chiedere di te e lui non poteva farteli incontrare. Mentre ti
sbendava, una sera, ti aveva raccontato di come eri arrivata qui, due mesi
prima.
Una notte buia e fredda era caduta sulla città prima del solito quel giorno, e
il pronto soccorso era deserto. Lui aveva finito il suo turno ma era rimasto per
sostituire all'ultimo un collega. All'improvviso era entrato nell'atrio del
pronto soccorso un uomo sulla cinquantina tutto trafelato, che teneva sotto
braccio e sosteneva una donna assolutamente sconvolta che si teneva il volto tra
le mani. Quando si tolse le mani dal viso il dottore la prese i braccio di peso
e la adagiò su una barella per portarla in terapia intensiva. L'uomo venne prima
visitato accuratamente e poi venne rassicurato sul destino della giovane; a
parte un evidente stato di shock l'uomo era in salute. Nonostante stesse bene
non volle lasciare l'atrio del pronto soccorso. Solo la mattina dopo,
svegliatosi sulle sedie della sala d'aspetto, si era deciso ad andarsene, anche
se non completamente rassegnato. Dal giorno in cui ti aveva portata in ospedale,
lui veniva tutte le mattine i buon'ora, si sedeva nella sala d'aspetto con un
mazzo di fiori, e chiedeva di te alla prima infermiera che vedeva. L'infermiera,
come suo dovere, lo informava tutte le mattine che non avresti potuto ricevere
visite, ma lui non si rassegnava a venire. Si faceva indicare a tutti i costi la
tua camera e si sedeva sulle sedie accanto alla porta, con i fiori in mano.
Osservava il via vai di medici e infermiere, e poi verso sera si alzava,
lasciava i fiori nella prima stanza che incontrava sulla strada verso l'uscita e
tornava a casa, pe ricominciare da capo il mattino seguente.
Dalle parole del medico si capiva che provava compassione per quell'uomo e
avrebbe voluto davvero fare qualcosa per lui. Ti aveva chiesto che era tuo
padre. Ma avevi scosso la testa.
Al medico sembravi ogni giorno più irreale ed evanescente, ti era capitata una
cosa terribile e lui non sapeva chi contattare. Sembravi non avere né parenti né
amici, nemmeno conoscenti, solo quel simpatico signore che continuava a chiedere
assiduamente di te. Avrebbe voluto aiutarti ma non sapeva che fare. L'unica cosa
che gli era venuta in mente di poter fare, dopo averti operata, era stata
denunciare un’aggressione con dell'acido alla polizia grazie anche al prezioso
aiuto del tuo benefattore (che ti aveva portata all'ospedale).
Ti aveva raccontato tutto questo mentre ti cambiava le bende, sera dopo sera,
ascoltando il tuo silenzio obbligato. Le ustioni sulla labbra erano molto gravi
e tu non riuscivi ancora a muoverle.
Mentre tu eri in ospedale la polizia aveva cominciato le ricerche del tuo
aggressore; stava facendo domande a tutti quelli con cui si presumeva fossi
entra in contatto prima dell'aggressione. La vera svolta si ebbe quando il tuo
benefattore disse alla polizia di sospettare del tuo ragazzo, con il quale
convivevi da due anni.
Dopo sei lunghi mesi di lenta agonia avevi riacquistato la capacità di parlare.
Avevi raccontato la dottore che il tuo ragazzo, una sera, ti aveva aggredita. Ti
aveva picchiata, insultata e umiliata, per poi terminare la sua terribile opera
gettandoti dell'acido muriatico sul volto. Nessuno aveva sentito nulla. Nessuno
degli occupanti degli appartamenti accanto al tuo era in casa. Dopo due ore era
rientrato un signore che trovandoti distesa nel parcheggio ti aveva portata, di
corsa, in ospedale.
La donna che eri è morta quella notte. Quella notte è morta una donna debole e
succube di un uomo che non sapeva cosa fosse l'amore. Quella notte è nata una
donna nuova; è nata una donna libera.
.
Amaranta
Ssh... E’ buio nella stanza, tutto è
completamente a soqquadro. Ci sono dei vetri rotti a terra e una finestra
aperta: entra un refolo d’aria fredda ma tu non lo senti nemmeno. Decine di
libri sono a terra, sul tappeto, sul tavolino, con le pagine stropicciate,
aperti in più punti casuali. Fogli bianchi svolazzano sull’onda di quel freddo
refolo che entra dalla finestra aperta, alcuni sono appallottolati e rimangono
sul tavolo o sul divano, altri sono stati fatti a pezzi, in decine di coriandoli
bianchi che si sparpagliano ovunque. Appoggiato a una parete c’è il divano su
cui, qualche ora fa, eri seduto. I cuscini sono messi ai lati, vicino ai
braccioli, e sono stropicciati, ancora conservano il tuo calore che effimero è
lentamente evaporato e si sperde nell’aria fredda di questo ottobre crudele. Sul
tavolino sono appoggiati un thermos di caffè vuoto e una grande tazza nel quale
lo hai bevuto. Ci sono anche un bicchiere di vetro finissimo e una bottiglia di
vino rosso, vuota. Una coperta giace inerte e accartocciata sul divano, un’altra
è caduta per terra, tra il divano e il tavolino.
Sul muro ci sono delle impronte insanguinate, quelle che hanno lasciato le tue
mani.
E’ esattamente ciò che si definisce la calma dopo la tempesta. Stavi studiando
nel seminterrato di casa tua alla luce di una lampada da studio, rannicchiato
nelle coperte, tenuto sveglio dal caffè che ti eri preparato e un bicchiere di
vino ogni tanto. Poi, dopo ore di studio, ti sei addormentato. Sarà stato
l’effetto del vino, che ha annullato quello del caffè, oppure soltanto l’ora
tarda e i libri. Hai lottato fino all’ultimo contro la pesantezza delle palpebre
e la spossatezza delle tue mani che non riescono più a scrivere numeri e
funzioni e sistemi... hai ceduto per un minuto e ti sei addormentato. Nel
momento in cui cedi, ti coglie l’oblio; la mente, i ricordi, ti portano a
rivivere quei momenti di pace sublime che una volta hai vissuto con lui. Le
vostre mani, i vostri visi, i vostri esili corpi che una volta percorrevate
palmo a palmo con le vostre mani, corpi che si sono scoperti con l’insicurezza e
la trepidazione delle prime volte. Quel viso che tante volte hai preso tra le
mani, hai accarezzato e baciato. Sei ancora sua, siete ancora lì. Ma è solo un
maledettissimo sogno, sai che non è più così.
Ti svegli di soprassalto, in lacrime, in preda al panico. Ti senti come persa,
quasi completamente svuotata, ci sono solo panico e tristezza. Ti aggrappi alle
pareti e agli scaffali pieni di libri barcollando, con il volto inondato di
lacrime. Scossa dai sighiozzi vaghi per la stanza seminando il disordine più
totale; prendi a pugni il muro chiedendoti perché ti sta succedendo tutto
questo. Rompi persino il vetro di una finestra e ti riempi le mani di tagli,
sanguini, non ti importa, continui a prendere a pugni il muro. Poi
all’improvviso ti lasci cadere pesantemente a terra a terra, ti fai male ma non
hai più forza di muovere un solo muscolo. Ignori il dolore fisico alle mani e
alle gambe; è lancinante e il sangue scorre lento pulsando inorno alle ferite
aperte, imbratta i tuoi vestiti e i muri su cui hai ripetutamente sbattuto i
pugni chiusi. Delusa da te stessa, ferita da quell’illusione onirica che ogni
notte si ripresenta, imperterrita e recidiva, a corroderti l’anima. Tu, un po’
rassegnata a questo lento supplizio cui lui ti ha condannato per chissà quanto
ancora; ti lasci andare in un pianto disperato abbracciandoti le ginocchia,
semi-nascosta, da un lato, dal divano. Nessuno può vederti, nessuno può
sentirti.
Il fatto è che sei sempre sola, sei sempre stata completamente sola. Nessuno ha
mai voluto sapere davvero cosa c’era nel fondo della tua anima. E ora vi si è
accumulato un sacco di marciume, delusione dopo delusione, tradimento dopo
tradimento. Hai creduto per troppo tempo che il solo tuo amore contasse, e che,
se ci fosse stato quello, allora tutto avrebbe potuto sistemarsi. Ma l’amore si
fa in due; un amore nato da un cuore solo che continua ad amare da solo non può
durare se non nel dolore. Perché è spossante e logorante amare qualcuno che non
ti ama, aspettare qualcuno che non torna.
Non può durare così all’infinito, soprattutto perché non è giusto, non è giusto
per te. Hai il diritto di essere felice: così felice da voltarti indietro, un
giorno, e ridere di quella sua illusione di poterti tenere sotto scacco per
sempre. E forse capirà che cosa ha perso per sempre; o forse no, ma non sarà più
un problema.
Rimani lì rannicchiato, a terra, annegata nelle tue lacrime salate d’odio e
d’amore che non si distinguono più. Labile è il confine, breve il passo; e ci si
ritrova a ferire chi ci accarezzava, e ad amare chi ci pugnalava.
Le lacrime continuano a scorrere sul tuo docile viso, tanto che sono quasi
brutali: sembrano scavare un solco sul tuo volto che difficilmente se ne andrà.
Rimani lì, così, in queste condizioni finché dal vetro rotto della finestra non
cominciano a entrare i primi raggi di luce dell’alba. La solita, che con
puntualità ogni mattina ti riporta alla realtà dei fatti.
Ma sarai felice un giorno non troppo lontano; e l’alba non sarà più una rivale
da fuggire con paura, ma un’amica mattiniera da salutare con un sorriso invece
che con un pianto.

"I mostri dell'ID", dipinto di Luigi Righi
.
Fiordalisa
Che fai qui seduta al buio, piccola silfide?
Sei qui ferma, quasi non respiri. Rimani seduta, a gambe incrociate, al centro
del freddo pavimento della cucina. Cosa guardi? I tuoi occhi sono immobili e il
tuo sguardo è innaturalmente spento e vacuo… che cos’hai? Sei seduta con una
postura eretta e rigida, quasi scomoda da sostenere. Quella postura che ti sei
così severamente imposta e che mantieni anche in casa, non solo fuori per
dimostrare di essere un’altra. Il freddo delle piastrelle del pavimento della
cucina lambisce le tue esili cosce, avvolte nella ciniglia dei pantaloni del
pigiama. I piedi sono scalzi, ben curati, con le unghie accuratamente smaltate
di nero, corte. La casacca a bottoni l’hai scaraventata a terra, poco fa, e ora
giace vicino al frigorifero, inerte. Il reggiseno nero è un po’ svuotato sul
davanti, anche se le spalline sono accorciate al massimo e dietro è allacciato
sull’ultimo fermaglio. Ultimamente sei dimagrita parecchio: prima i tuoi fianchi
erano più pieni e il tuo seno più prospero. Non hai quasi muscoli perché tua
mamma non ha mai voluto che facessi sport, “Non è roba per signorine” diceva; e
le tue forme erano morbide su quelle ossa fragili ma così piene di vita. I tuoi
occhi, un tempo di un azzurro acceso, come due zaffiri, sono ora quasi grigi e
sono diventati più opachi, come se una sottile patina di dolore si fosse
insinuata nel tuo sguardo che, anche solo qualche mese fa, era ancora lo sguardo
di una donna forte e volitiva che sapeva raggiungere i suoi obiettivi. Ora è
solo lo sguardo di una donna persa in se stessa che sta lentamente lasciandosi
affogare in quel mare che si porta dentro. Sei seduta per terra e contempli il
fondo dell’infinito con quei tuoi occhi dallo sguardo spento, a torso nudo, solo
con il reggiseno. Ti muovi impercettibilmente, ondeggi da destra a sinistra
sulle anche scheletriche. Il buio della stanza e dell’inverno ti avvolge come
una morbida coperta, ti dà sicurezza e ti fa sentire un po’ più lontana dai tuoi
problemi. Rimani lì seduta senza sapere bene il perché a lasciarti infreddolire
dall’inverno che ti raggiunge fin nelle ossa; e tu lo lasci fare come se fosse
un vecchio amico, e lui non ti ferisce più con le sue perfide e taglienti
bufere; anzi, ora la neve è come una candida e amichevole coperta che,
seppellendo tutto sotto in suo morbido manto, ti coccola per i mesi più freddi e
tu lasci che il suo ricordo ti coccoli anche nei mesi caldi. Sempre più nivea e
algida ti sta lentamente trasformando e tu la lasci fare, e anche tu a poco a
poco diventerai un morbido e flessuoso fiocco di neve. Nella mano reggi un ago
avvolto nello spago, e a terra, davanti a te, c’è una boccetta di inchiostro
nero e denso come catrame. La punta dell’ago è inzuppata di inchiostro e tu con
le tue dita di seta lo impugni come un pugnale e infilzi la pelle della mano
sinistra. Punto per punto; uno accanto all’altro. Chissà cosa disegnerai questa
volta. A parte quelli molto elaborati, la maggior parte dei tatuaggi che hai te
li sei fatta da sola, armata di ago, filo e inchiostro. Hai più inchiostro tu
sotto pelle che i tuoi libri nelle pagine, ormai è difficile scovare un angolo
del tuo corpo che non sia tatuato. Hai coperto il dolore di vivere e la
depressione con il dolore dell’ago che lentamente si insinua sotto la tua pelle,
fino a non sapere più quale sia il confine tra l’uno e l’altro.
I tuoi genitori non hanno mai saputo nulla del tuo dolore, naturalmente, sono
sempre stati due estranei in casa per te. E ora che quello schifoso alcolista di
tuo padre è morto di cirrosi epatica e con il cervello riempito di
auto-giustificazioni per tutte le porcherie che ha fatto in vita sua, tua madre
ha smesso letteralmente di vivere e si è ritirata in uno squallido appartamento
della periferia bene dove crede di poter rimanere per sempre senza mettere mai
un piede al di là della soglia di casa. Ha venduto la casa in cui abitavate, ha
venduto la macchina, ha comprato quell’appartamento in via St. George. Ha
assunto un filippino tutto fare che le pulisce la casa, le fa la spesa e le
cucina cose che lei deve solo scaldare nel microonde. La accompagna anche, una
volta a settimana, dal dottor Cox: un bravo psichiatra amico di un tuo collega
del locale, che cerca di tenere a bada il suo disturbo bipolare della
personalità, che galoppa a piede libero, e la sua insonnia cronica, da sei anni
ormai, con potenti psicofarmaci. Il filippino, Erik, è in tipo molto riservato,
ferventemente cattolico e sembra che si sia particolarmente affezionato a tua
madre, o agli stipendi che lei gli passa... Per le medicine lei è abbastanza
indipendente ma durante le sue crisi depressive è Erik a contarle le gocce per
dormire o a darle le pastiglie per regolare l’umore. Tu non la vedi più da
quando si è trasferita in isolamento e tu ti sei seppellita in un appartamento
in centro che condividi con una ragazza e due ragazzi. Di giorno, fino alle
diciotto, lavori part-time come barista in un locale buio e fumoso nel centro di
Londra che rimane semideserto per la maggior parte del tempo.
La tua coinquilina, Serafina, lavora di notte nello stesso bar in cui lavori tu,
ma lei fa il turno serale e vi date il cambio. Oltre a stare dietro il bancone
lei gestisce la seconda “attività” del locale: incontri lampo con ragazze che
“intrattengono”, per un’ora al massimo, alcuni particolari clienti. Per lo più
sono habitué, anche se raramente qualcuno di nuovo arriva. I clienti sono per la
maggior parte uomini d’affari, imprenditori, ricchi ereditieri che non sanno
come spenderei propri soldi, titolari di aziende assicurative o immobiliari.
Insomma tutti uomini apparentemente importanti, che hanno fatto carriera e hanno
contratto un buon matrimonio proprio come si contrae un buon affare,
apparentemente felicissimi con la moglie che si occupa della casa e alla quale
comprano oggetti costosi per salvare le apparenze agli occhi dei vicini curiosi;
infelici, annoiati, in cerca di un’ora di felicità con una sconosciuta o solo
qualcuno che condivida con loro un’ora di solitudine, provando poi ad affogare
l’amarezza in un bicchiere di whisky o di gin. Dopo aver consumato la loro ora
di paradiso si siedono stanchi sui divanetti del locale, con la giacca
sbottonata, la gambe divaricate, la testa leggermente reclinata all’indietro
sulla testiera del sofà e un bicchiere in mano, generalmente semi-vuoto. Oppure
si siedono al bancone sugli sgabelli alti, con le gambe ciondoloni e lo sguardo
vacuo perso nel fondo di un bicchiere vuoto che continuano a farsi riempire solo
per svuotarlo più in fretta la volta dopo. Poi verso le due del mattino se ne
vanno, uno per volta, con svogliatezza, per tornare nelle loro lussuose
residenze da ricchi, piene di oggetti preziosissimi e costosissimi a cui le
rispettive mogli sono più affezionate che a loro, ma allo stesso tempo così
vuote e desolate. La mattina successiva tutto ciò che sarà rimasto della serata
precedente sarà un forte mal di testa e un sapore dolciastro e amaro insieme in
bocca. La moglie li avrà creduti per tutta la sera al bowling, con gli amici, o
da qualunque altra parte meno che in uno squallido bar a ubriacarsi di tristezza
e di gin in compagnia di una prostituta, per giunta. E il mattino dopo li
avranno svegliati facendo le solite avance che ormai sono patetiche, scontate e
prevedibili. Con i mariti ci scopano circa una o due volte all’anno: per il loro
anniversario di nozze e per capodanno, forse. Quando erano ancora nel fiore
degli anni avevano qualche amante, giusto per scansare la noia di essere a casa
da sole tutto il giorno, ma, con il decadimento fisico dovuto all’età, che si
sono rese conto cominciare già a quarantacinque anni, hanno smesso di essere
desiderabili, per lo meno per la cerchia di uomini di cui si circondano, e si
sono lasciate andare ingrassando terribilmente per poi sentirsi dei mostri
inguardabili e ricorrere a costosissimi interventi di chirurgia plastica che
finanziano con il denaro che i mariti guadagnano. Oppure al contrario avranno
smesso di mangiare e si saranno attaccate alla bottiglia della Vodka dimagrendo
in maniera paurosa e preoccupante. I mariti allora le avranno portate da un
bravo psichiatra che avrà cercato di tenerle in piedi con forti dosi di valium e
altri farmaci ma che ben presto si sarà reso conto di ottenere moti più
risultati andando a letto con la paziente.
Serafina torna a casa, schifata dallo squallore del ceto ricco-borghese, e dorme
fino alle dieci del mattino mentre tu sei al lavoro. A tenerle compagnia durante
il tuo turno di lavoro c’è Nice.
Nice è un ragazzo di vent’anni, magro e slanciato, con dei bellissimi occhi blu
e i capelli neri tenuti corti ma non troppo, sempre un po’ spettinati. Ha
numerosi tatuaggi su braccia, gambe, collo e schiena. Lavora come magazziniere
nel deposito dei bagagli smarriti all’aeroporto; fa anche lui il turno di notte
ma solo per poter avere la giornata libera con Serafina. Loro due sono amici da
un sacco di tempo, erano a scuola insieme e sono legatissimi. Nice probabilmente
è sempre stato innamorato pazzo di Serafina, ma lei non si è mai accorta di
nulla e lui è sempre stato tropo timido per confessarglielo. Lui compra cannabis
da un tizio appena fuori dall’aeroporto quando gli avanza qualche deca dallo
stipendio. Quando la compra poi la porta a casa e la fuma in salotto con
Serafina mentre mangiano pizza e cioccolata sul divano; a volte ne compra un po’
anche per te. Quando tu torni a casa dopo il turno al bar e senti l’odore della
marijuana nell’aria ti arrabbi sempre un po’, ma non tanto, con Serafina, che in
realtà tutti chiamano Sery, perché si scorda sempre di aprire le finestre quando
fumano; se scattasse l’allarme anti-incendio si scatenerebbe il putiferio e
dovrebbero traslocare tutti.
L’appartamento non è molto grande ma quasi mai siete a casa tutti insieme,
soltanto il mattino quando c’è chi torna dal proprio turno lavorativo e c’è chi
invece si sta svegliando per cominciarlo. I luoghi comuni sono il salotto: con
un grande divano u po’ sfondato ma comodo, un tavolino basso, un tappeto e il
televisore; la cucina: che è dominio più che altro di voi ragazze in quanto Nice
e Oliver, l’altro vostro coinquilino, sanno solo usare il microonde per scaldare
cose già pronte; e infine il bagno: che è la stanza più richiesta e per la quale
si discute tutte le mattine. In ultimo ci sono le due camere da letto: la tua,
che condividi con Sery, e quella di Oliver e Nice. Le due camere da letto sono
le stanze più grandi della casa e in ognuna ci sono due letti matrimoniali posti
ai lati opposti di una grande finestra, posta tra i due letti; sotto la finestra
c’è una grande scrivania e ai piedi dei due letti ci sono due armadi a tre ante.
Al centro della stanza c’è un tappeto con dei motivi geometrici. I ragazzi hanno
sempre tutto in disordine, i letti sono sempre sfatti e ci sono calze e mutande
sulla scrivania e anche per terra insieme a magliette, pantaloni e scarpe. La
camera di voi ragazze non si può dire che sia messa meglio: se i ragazzi hanno
il caos dei vestiti voi avete il caos dei libri. O meglio, tu hai il caos dei
libri, che sono tutti accatastati sotto il letto, nei cassetti dell’armadio e
della scrivania, sulla scrivania, sotto la scrivania e in qualunque altro posto
libero. Hai perfino fatto mettere una libreria in salotto ma è già piena e pile
di libri le si stanno ergendo intorno. Sery ti rimprovera sempre perché ormai i
libri vi stanno sommergendo e ogni mese un quarto del tuo magro stipendio se ne
va a i mercatini dell’usato e delle pulci, dove tu passi praticamente tutti i
week-end. A volte anche Oliver viene con te e allora passate tutta la mattina
tra scatole di vecchi libri, poi mangiate un hamburger al volo e poi vi
reimmergete nell’oceano di carta ingiallita dal tempo e parole scritte con un
inchiostro ormai sbiadito.
Tu e Oliver non vi conoscete da molto tempo, vi siete incontrati per caso una
sera in treno, mentre tornavate a casa dall’università che poi entrambi avete
abbandonato. Tu studiavi filosofia e lui letteratura e lingue orientali: lui
infatti parla correntemente cinese mandarino, giapponese e coreano esattamente
come parla l’inglese. Avete cominciato a frequentarvi come amici; quando avete
deciso di lasciare gli studi per lavorare avete affittato quell’appartamento in
centro a Londra. Dopo qualche mese si era aggiunto Nice, migliore amico di
Oliver, e successivamente era arrivata anche Serafina. Sery era stata cacciata
da casa dai genitori perché era rimasta incinta dopo aver avuto un rapporto
occasionale con un ragazzo che conosceva appena e che non ha mai saputo della
gravidanza e che, qualche settimana dopo che lei era venuta a stare da noi, era
morto sul colpo in un incidente in moto. Non appena Sery seppe della sua morte
decise di abortire. Non era particolarmente affezionata a quel ragazzo, non
aveva avuto tempo e modo di conoscerlo meglio; quando morì lei decise di
tagliare tutti i ponti con il passato e abortì il figlio di quello sconosciuto.
Ovviamente fu un brutto colpo, anche se conosceva poco il padre del suo bambino,
fortunatamente si riprese bene sia dall’aborto sia dal lutto.
Nice invece, che aveva la stessa età di Sery, era figlio di uno di quegli
squallidi omini, così schifosamente simile all’abituale clientela serale del
bar: infelici, insoddisfatti, che prendono le decisioni per i figli al posto
loro convinti di fare la cosa giusta. A Nice questo non è mai andato giù e non
appena ha potuto camminare con le sue gambe è scappato di casa con tutti i suoi
averi e quei pochi soldi che aveva risparmiato negli anni. Con i risparmi ha
preso la patente per i mezzi da carico e scarico e nel giro di un paio di mesi è
stato assunto per il turno notturno all’aeroporto.
Oliver, invece, è il più grande del gruppo, ha lasciato gli studi quando ormai
gli mancavano solo pochi esami per laurearsi perché sua nonna è morta di cancro
e lui ha dovuto occuparsi da solo delle questioni legali che sono conseguite
alla sua morte. Suo padre, Thomas, era morto prima che lui nascesse. La madre di
Oliver, Anita, non aveva ancora fatto in tempo a comunicargli la notizia della
gravidanza che, a causa dell’improvviso licenziamento e la precaria situazione
economica, si era fatto travolgere da un treno in corsa. L’accaduto era finito
sui giornali provinciali e regionali; il suicidio di Thomas aveva profondamente
sconvolto Anita: per diverse settimane non aveva smesso di piangere, non dormiva
più non mangiava più, si era ridotta all’ombra di se stessa. Aveva dovuto
traferirsi da sua madre perché, essendo incinta, non poteva lavorare. Stava
diventando un’anoressica col pancione e non andava bene. Poi un giorno, mentre
stava camminando su e giù per il salotto, al settimo mese di gravidanza, era
svenuta e cadendo per terra aveva battuto la testa contro lo spigolo di un
tavolino procurandosi un trauma cranico. La madre di Anita, che era uscita per
una commissione, al suo ritorno l’aveva trovata lunga distesa sul pavimento e
l’aveva portata di corsa al pronto soccorso, dove dopo un paio d’ore era entrata
in coma. I medici avevano fatto nascere il bambino settimino che dovette
ricevere numerose flebo di principi nutritivi, ormoni per la crescita, vitamine
e sali minerali perché a causa dell’incipiente anoressia della madre il bambino
era denutrito. Fortunatamente riuscì a sopravvivere e gli fecero terminare la
gestazione e lo sviluppo in un’incubatrice; poi venne affidato alla nonna. Anita
purtroppo rimase in coma per dieci anni senza mai dare segni di miglioramento o
di coscienza. Fu allora che la nonna di Oliver decise di staccare la spina ad
Anita come suggerivano i medici ormai già da qualche anno. Oliver crebbe con la
nonna che gli permise di studiare e di andare all’università; ma all’età di
sessantacinque anni le venne diagnosticato un cancro terminale e nel giro di tre
mesi si spense. Oliver perse l’unica persona che aveva, che era tutta la sua
famiglia. Poi incontrò te, Fiordalisa, cominciò a lavorare e si trasferì con te,
Nice e Serafina.
Parlando molto bene diverse lingue orientali non è stato difficile per Oliver
trovare un lavoro part-time come interprete in un ufficio amministrativo e anche
un altro lavoro sempre part-time, come traduttore per una casa editrice che si
occupava di pubblicare in Europa gli elaborati di alcuni autori esordienti che
nel loro paese hanno già avuto un discreto successo. Entrambi i lavori gli
piacciono parecchio, soprattutto quello di traduttore, ed è molto soddisfatto.
Avendo due lavori ha tutta la giornata occupata ma le traduzioni le può anche
fare da casa e poi portarle in ufficio; così può gestirsele più o meno
liberamente.
Qualche volta tu e lui passate lunghe serate insieme con una buona bottiglia di
vino rosso, un film triste, una pizza e poi magari fate a gara per vedere chi
regge più shott di Vodka alla pesca. Anche se sono solo due anni che vi
conoscete e vivete insieme, è come se vi conosceste da sempre. C’è un
sottilissimo filo d’intesa che scorre tra le vostre parole e i vostri gesti, e
gli sguardi; è un legame tanto profondo quanto labile, precario; con un’amicizia
così ci si può fare molto male senza volerlo ma senza saper fare altrimenti. E’
un legame pericoloso, anche se edificante sotto molti aspetti; è difficile
mantenere in equilibrio le due parti perché siete due personalità troppo simili
tra loro. Combaciate perfettamente, tanto che potreste quasi amarvi e allora
potreste essere davvero felici, imparando a smussarvi a vicenda gli spigoli;
eppure non lo fate, perché siete entrambi talmente insicuri che avete una paura
folle di perdere quel flebile ma profondo legame che vi unisce. Così evitate di
amarvi, ma siete sempre uno nei pensieri dell’altra e se siete lontani fingete
di non mancarci, ma vi pensate e vi mancate senza avere il coraggio di
confessarvelo a vicenda come se vi amaste, ma invece non state insieme. Perché
tutte le storie finiscono prima o poi; il sesso rovina sempre tutto e una volta
che si è arrivati a quel punto non si può tornare indietro, se vi lasciaste non
potreste più essere amici, non come prima per lo meno. E allora fingete di
bastarvi perché avete una fottuta paura di amarvi. Serafina ha sempre saputo, da
quando vi conosce, che un giorno vi sareste accorti che le vostre paure erano
infondate e avreste finalmente trovato il coraggio di amarvi, perché vi siete
sempre appartenuti. Proprio lei faceva questa profezia, mentre era la prima a
non accorgersi di avere al suo fianco un uomo pronto ad amarla con tutto se
stesso e che invece si accontentava di esserle amico a costo di vederla felice
con qualcun’altro.
Poi un giorno, inaspettatamente, accadde l’impensabile. Nessuno di voi era
pronto a una cosa simile, tanto meno tu Fiordalisa, che sei stata colta di
sorpresa più di tutti e che hai subìto in maniera disastrosa le conseguenze del
terribile fatto.
Era inverno inoltrato, un uggioso pomeriggio di gennaio. Faceva un freddo
polare, aveva appena finito di nevicare e le strade erano coperte di neve
bagnata e fangosa. Tu eri a casa da sola, seduta sul divano in compagnia di un
vecchio film e un the caldo; Nice e Serafina erano andati insieme a pattinare in
una piazzetta non lontano dal vostro appartamento. Oliver era uscito al mattino
presto per andare alla casa editrice, aveva detto di non avere molto lavoro da
sbrigare e che entro le quattro del pomeriggio sarebbe rientrato con del lavoro
da fare a casa. Come uno dei tanti pomeriggi uguali a quello, ma non per questo
meno piacevole, lui sarebbe tornato a casa stanco e infreddolito con un plico
infinito di fogli da tradurre. Tu avresti messo in pausa il film che stavi
guardando e gli avresti offerto una tazza di the, che lui avrebbe bevuto con te
seduto sul divano con ancora il cappotto addosso. Poi avrebbe appeso la giacca
all'appendi-abiti all'ingresso e si sarebbe tolto le scarpe per mettere quelle
assurde calze anti-scivolo che gli hai regalato a Natale che pure gli piacciono
tanto. Lui ti avrebbe chiesto che film stavi guardando e a che punto era,
avreste finito di vederlo insieme. Infine lui si sarebbe messo al lavoro sul
tavolo in cucina mentre tu lo avresti guardato oziosa dal divano, con un sorriso
beato sulle labbra come se guardarlo fosse stato tutto ciò di cui avresti mai
potuto avere bisogno. Alla fine, prima di cena, lui avrebbe terminato il lavoro
e avreste aspettato l’arrivo dei vostri coinquilini di ritorno dalle solite
commissioni. Spesso tardavano perché si fermavano per negozi.
Ma questo particolare pomeriggio era diverso: Nice e Serafina tardavano, come al
solito, ma Oliver non si vedeva. Il film era quasi finito e lui non era ancora
arrivato. Quando vi eravate salutati quella mattina lui aveva detto che sarebbe
tornato prima, e che sarebbe tornato con meno lavoro del solito per stare un po’
con te. Ti aveva promesso che sareste andati un po' in giro a curiosare in un
mercato di Covent Garden, gli piaceva da matti vedere nei tuoi occhi quella
scintilla di stupore che si accendeva ogni volta che notavi, tra tante cose
scontate, quell'oggetto stravagante che ti colpiva particolarmente perché ti
somigliava. E lui sosteneva che in quei momenti tu fossi più bella; al di là di
come avevi acconciato i capelli prima di uscire o da quali vestiti avevi
indossato. Forse non era consapevole di cosa produceva in te quando te lo
diceva, o forse te lo diceva proprio perché lo sapeva e voleva vedere quegli
occhi imbarazzarsi per quello stupore e allo stesso tempo esserne orgogliosi.
Ma non sarebbe successo nulla di tutto questo quel pomeriggio. Alle sei di sera
tornarono Nice e Serafina, che si stupirono non poco di non trovarti con Oliver.
Tu eri seduta sul divano mentre guardavi il televisore spento. Nice guardò
Serafina preoccupato. Poi si mise in ginocchio di fronte a te. Tu ce l'avevi
davanti ma non lo vedevi. Lui ti prese dolcemente le mani senza smettere di
guardare in quelle tue pupille che erano ormai altrove. Ti fece mettere in piedi
e ti portò a sedere al tavolo della cucina per farti stare ben dritta. L'unica
cosa che eri riuscita a dire era stata "Dov'è Oliver?" con un filo di voce che
faceva trapelare soltanto una profonda angoscia. Nice e Serafina cercarono di
calmarti e di riportarti in uno stato di coscienza attivo e non vegetativo come
quello in cui ti avevano trovato. Dopo quasi mezzora tu finalmente eri uscita da
quella specie di trance e cominciavi a riacquisire il senso del tempo e di ciò
che era successo o poteva esser successo. Nice, per prima cosa, decise di
chiamare la casa editrice in cui lavorava Oliver per chiedere di lui. Tu avresti
voluto farlo ma non avevi il numero, non c’era ma i stato bisogno e di solito
Oliver ti chiamava dal suo cellulare. Gli rispose il suo collaboratore che gli
disse che quel pomeriggio Oliver era uscito quasi due ore prima del solito e che
si era portato dietro solo un paio di capitoli di un nuovo libro da tradurre.
Nessuno era solito fare domande sulla vita privata a meno che non fosse
assolutamente indispensabile qualora essa interferisse sensibilmente sul lavoro
e fosse limitante. In conseguenza, nessuno sapeva dove potesse essere andato
quel pomeriggio. Di sicuro però non poteva essere andato lontano dato che ti
aveva promesso che sarebbe tornato per stare con te quel pomeriggio. Poi Nice
passò in rassegna tutti i locali che di solito frequentavano insieme, poi tutte
le librerie, i ristoranti; alla fine prese la metropolitana e scese a tutte le
fermate della linea che passava vicino a casa loro, per vedere se magari si
fosse fermato a scrivere sulle scale di qualche fermata. A volte gli succedeva
di fermarsi in un posto a scrivere senza rendersi conto del tempo che passava.
Ma di solito non durava più di una decina di minuti, nel peggiore dei casi ci
restava mezzora, ma doveva avere davvero un momento di ispirazione incontenibile
e, di solito, succedeva abbastanza raramente. Ormai il suo ritardo era di tre
ore, non poteva più essere seduto da qualche parte a scrivere. Ogni tanto Nice
chiamava Serafina per sapere se tornava ma ogni volta era una speranza inutile
perché di Oliver non c'era traccia da nessuna parte.
Alla fine, dopo che Nice aveva quasi fatto il giro di tutta la Londra suburbana,
arriva una telefonata sul tuo cellulare. Rispondi: "Sì, chi è?" "E' la signorina
Fiordalisa Foster?" chiedono dall'altra parte. "Sì certo, sono io." rispondi tu
sempre più angosciata. "Signorina Foster sono un'infermiera St. Thomas'
Hospital. Si è appena verificato un terribile incidente: una motocicletta ha
investito un pedone nei pressi una piccola casa editrice di Covent Garden, e la
vittima è un ragazzo di nome Oliver Ashton. Addosso gli sono stati trovati i
documenti e questo numero di telefono. E' pregata di venire in ospedale
immediatamente, il ragazzo è in condizioni molto gravi.” Fiordalisa, mentre
l'infermiera parlava, aveva trattenuto il respiro e quando quella aveva finito
lei non riusciva a trovare più il modo di interrompere quello stato di apnea
involontaria. Le si riempirono gli occhi di lacrime e si portò una mano alla
bocca. Sconvolta, dopo una decina di secondi da quando l'infermiera aveva
parlato, le rispose che sarebbe arrivata subito. Poi attaccò.
Non riusciva a muoversi, non riusciva a pensare, non riusciva a piangere, non
riusciva nemmeno a respirare. Era come se in un secondo tutto il mondo si fosse
frantumato su di lei e l'avesse sotterrata dentro se stessa senza darle via di
scampo. Le uscivano lacrime dagli occhi ma non poteva battere le palpebre, non
sapeva più fare nulla. Trovò appena il modo di dire a Serafina che Oliver era al
St. Thomas' e che era in grave condizioni. Serafina chiamò immediatamente Nice,
gli disse cos'era successo e anche di farsi trovare in ospedale quanto prima.
Poi ti prese di peso sotto braccio, ti fece indossare le scarpe e il cappotto,
ti caricò in macchina e si diresse in ospedale.
Ci volle un po' prima di trovare il piano. Subito Serafina ti fece sedere su una
sedia in sala d'aspetto insieme a Nice, che nel frattempo era arrivato, e corse
a cercare un medico. Le ci volle un po' ma alla fine trovò il primario che le
spiegò che Oliver era stato portato lì in condizioni pietose e che al piano di
sotto lo stavano operando. Aveva perso molto sangue e a chiamare i soccorsi era
stata una donna di mezza età che passando di lì e lo vide in mezzo alla strada
in una pozza di sangue. Probabilmente era rimasto steso a terra per circa tre
quarti d'ora, se non un’ora, e il motociclista che lo aveva investito era
scappato. Quando arrivò all'ospedale aveva perso quasi tre litri di sangue e fu
costretto a subire un'immediata trasfusione. Poi era stato portato in
traumatologia dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico e un'emorragia
nello stomaco. L'esito dell'operazione era incerto perché avendo perso molto
sangue era debolissimo; in più aveva per sua natura la pressione molto bassa.
Mentre Serafina riferiva a Nice ciò che aveva saputo dal dottore tu ormai non
ascoltavi quasi più. Eri completamente sconvolta e cercavi astrattamente di
capire come fosse possibile che proprio Oliver dovesse ora subire tutto questo.
Sperava solo che non morisse, non doveva morire, non poteva. Lei non aveva
ancora fatto in tempo a dirgli che lo amava, non poteva morire, lei doveva
assolutamente dirglielo. Voleva baciarlo tante e tante volte, e poi voleva fare
l'amore senza più paure e insicurezze, e poi... C'erano così tante cose che
voleva fare con lui per la prima volta, e altrettante che già faceva e che
voleva continuare a fare. No, non poteva morire. Lei doveva amarlo e levargli
una volta per tutte quella sua incoerente paura di tutti, tranne che di lei. Lei
voleva che lui avesse fiducia nella vita e che ne avesse per merito suo; che ne
avesse come lei non riusciva ad averne, e magari un giorno sarebbe stato in
grado di insegnare ad avere fiducia nella vita anche lei. E lei avrebbe
imparato, avrebbe imparato per merito suo, perché lui era capace di farle
cambiare idea anche se lei era ormai rassegnata.
Dopo tre ore di operazione un medico uscì dalla stanza di fronte alla quale
loro, nel frattempo, si erano spostati e chiese chi di loro fosse Fiordalisa
Foster. A sentir pronunciare il tuo nome ti eri alzata e, senza guardare in
faccia il medico, avevi risposto. Lui disse che era molto dolente e dispiaciuto,
che purtroppo, nonostante i medici avessero fatto tutto il possibile, Oliver non
ce l'aveva fatta. Aveva una pressione sanguigna troppo bassa e avendo perso
molto sangue, nonostante la trasfusione, non erano riusciti a ossigenare il
cervello in tempo e ciò aveva causato la morte cerebrale. Il tempo che aveva
trascorso a terra senza ricevere soccorso erano stati determinanti, se colui che
lo aveva investito avesse chiamato i soccorsi, invece che scappare, forse
sarebbero riusciti a fermare in tempo l'emorragia allo stomaco e a fargli
riacquistare un flusso di sangue con una pressione costante.
In quel momento fu come se insieme ad Oliver fossi morta un po' anche tu. Non
capivi perché una persona così bella, com'era Oliver, potesse cessare d'esistere
così, da un momento all'altro, senza lasciare nemmeno un pezzetto di sé stesso
da qualche parte nel mondo, senza dire nulla, senza spiegare. Ma cosa doveva
spiegare? Non lo aveva certo voluto lui. Non sapevi nemmeno come avresti dovuto
sentirti di fronte a quella terribile consapevolezza. Non sapevi esattamente
quale sfumatura di dolore questo evento le provocasse: era un dolore
inspiegabile perché originato da un fatto che non aveva spiegazione; profondo,
perché ciò che tu provavi per Oliver forse sono capaci di provarlo solo poche
persone e solo una volta nella vita; un dolore viscerale e radicato nell'anima,
a differenza di tanti dolori molto ingombranti ma superficiali; un dolore che in
quel momento ti si imponeva come perentorio e assoluto ma che sarebbe stato
capace di diventare discreto se tu avessi imparato a gestirlo e magari, non dico
a superarlo, ma a tenerlo in conto come costante della tua vita futura, senza
concedergli troppo spazio ma esattamente quanto se ne meritava e non più di
quanto ne aveva bisogno.
Nice e Serafina le erano rimasti molto vicini nei mesi successivi alla morte di
Oliver. Non era facile per nessuno. Quasi facessero a turno capitava che
piangevano uno sulla spalla dell'altra e si consolavano a vicenda, o almeno ci
provavano, anche se non si poteva consolare davvero una tale perdita. Cercavano
di continuare le loro vite, e Nice e Serafina ci stavano quasi riuscendo. Ma tu
avevi vissuto la cosa in modo terribilmente tragico e spesso ti limitavi a
passare la maggior parte delle ore della giornata rannicchiata in un angolo del
divano con sopra una coperta spessa, con lo sguardo fisso nel vuoto con ancora
Oliver negli occhi. Era davvero dura. In casa c'erano ancora tutte le sue cose,
i suoi vestiti, i suoi libri, le sue scarpe, tutto insomma. Lui in qualche modo
era ancora lì anche se non c'era più, era più come se fosse partito per un lungo
viaggio più che come se fosse morto. Ma era morto. E non sarebbe tornato, mai
più.
.
Se volete farmi sapere che ne pensate, scrivetemi a questo indirizzo.
