![]()
Il nome
Il nome di quest'Era, Cenozoica o Terziaria, deriva dal greco "vita recente". Essa copre il lungo periodo di tempo che va da 65 ad 1,8 milioni di anni fa. In termini di Anno della Terra, esso durò più o meno dalle ore 17.28 del giorno di Santo Stefano alle 20.29 del giorno di San Silvestro. Per la grande affermazione dei Mammiferi, il Cenozoico è anche detto Era dei mammiferi, ma anche gli Uccelli poterono conquistare i cieli, non più dominati dai rettili volanti.
Il Cenozoico è diviso in due periodi, a loro volta divisi in epoche:
Paleogene o Nummolitico, diviso in due epoche:
Neogene diviso in 3 epoche:
![]()
Il Paleocene ("antico recente") è l'epoca inaugurale del Cenozoico, compreso tra il Cretacico e l'epoca Eocenica. Il termine, proposto fin dal 1878, solo in tempi recenti ha avuto una notevole diffusione a seguito di studi di micropaleontologia: compaiono infatti le prime Globigerine e i primi Nummuliti, organismi microscopici dotati di guscio calcareo, oggi estinti. Esso va da 65 a 56 milioni di anni fa; in termini di Anno della Terra, va dalle 17.28 di Santo Stefano alle 10.59 del giorno seguente.
Il Paleocene è suddiviso in tre periodi: Daniano, Selandiano e Tanetiano.
È del 2013 la scoperta che nel Paleocene esisteva nell'Oceano Indiano un minicontinente ribattezzato Mauritia. La formazione di tale continente risale a circa 61 milioni di anni fa (alle 01.15 del 27 dicembre): probabilmente si tratta di un frammento staccatosi dalle placche di Madagascar e India, quando il primo si staccò dalla seconda. Le isole di Mauritius, la Réunion e le Seychelles sarebbero frammenti di questo antico continente. La scoperta la dobbiamo ad un gruppo di ricercatori provenienti da Germania, Gran Bretagna e Norvegia, coordinato da Trond Torsvik, dell'Università di Oslo. Essi hanno scoperto che l'Oceano Indiano potrebbe essere pieno di questi frammenti continentali, appartenuti ad un continente antichissimo, staccatosi addirittura da Rodinia, come dimostrano gli zirconi trovati sulle spiagge delle isole suddette. Bernhard Steinberger, del Centro di Ricerca Norvegese per le Geoscienze, ha affermato: « Da un lato, il modello mostra la posizione delle placche rispetto ai due punti caldi al momento della rottura. D'altra parte, siamo stati in grado di dimostrare che i frammenti del continente hanno continuato a vagare quasi esattamente sopra il pennacchio della Réunion, e ciò spiega perché successivamente sono stati coperti dalla roccia vulcanica ». Da notare che questa scoperta sembra avvalorare l'antico mito Tamil che parla di una terra ubertosa sommersa per sempre durante il Pralaya, il diluvio delle tradizioni indù, e chiamata Kumari Kandam. Su di essa sarebbero sorte ben 49 nazioni e la sua capitale sarebbe stata la favolosa città di Thenmadurai. Solo una coincidenza?
Il minimo gravitazionale dell'Oceano Indiano
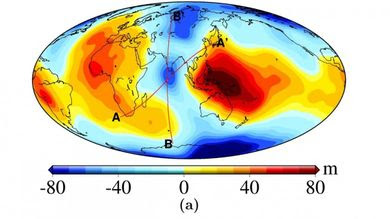 Aggiungiamo
che una vasta distesa dell'Oceano Indiano è più bassa di ben 100 metri rispetto
al livello medio globale del mare a causa di un'importante diminuzione della
gravità terrestre. Gli scienziati ne hanno ignorato a lugo la causa, ma una
ricerca nel 2023 ne ha finalmente rivelato l'origine: sembra che sia causato da
pennacchi di roccia fusa che risalgono dalle profondità
dell'Africa, ai margini dei resti di un antico fondo oceanico che sta
sprofondando. Noi sappiamo che la Terra non è una sfera perfetta, essendo
schiacciata ai poli, e che le diverse regioni del pianeta esercitano una
diversa attrazione gravitazionale a seconda della massa
della crosta terrestre, del mantello e del nucleo sotto di esse. Oggi si
possono combinare le misurazioni della gravità locale effettuate da sensori a
terra e da satelliti per mostrare come apparirebbe la superficie dell'oceano
solo a causa di questa diversa attrazione gravitazionale, escludendo altre
influenze come le maree; in questo modo si è ottenuta una visualizzazione
esagerata delle zone gravitazionali più alte e più basse del nostro pianeta. Uno
dei modelli più famosi è noto come "patata gravitazionale
di Potsdam", dal nome della sede dell'istituto di ricerca tedesco in cui
è stato sviluppato: la mappa a fianco mostra i massimi (rossi) e i minimi (blu)
gravitazionali, misurati in metri (da "How the Indian Ocean Geoid Low Was Formed",
di Debanjan Pal e altri, in "Geophysical Research Letters").
Aggiungiamo
che una vasta distesa dell'Oceano Indiano è più bassa di ben 100 metri rispetto
al livello medio globale del mare a causa di un'importante diminuzione della
gravità terrestre. Gli scienziati ne hanno ignorato a lugo la causa, ma una
ricerca nel 2023 ne ha finalmente rivelato l'origine: sembra che sia causato da
pennacchi di roccia fusa che risalgono dalle profondità
dell'Africa, ai margini dei resti di un antico fondo oceanico che sta
sprofondando. Noi sappiamo che la Terra non è una sfera perfetta, essendo
schiacciata ai poli, e che le diverse regioni del pianeta esercitano una
diversa attrazione gravitazionale a seconda della massa
della crosta terrestre, del mantello e del nucleo sotto di esse. Oggi si
possono combinare le misurazioni della gravità locale effettuate da sensori a
terra e da satelliti per mostrare come apparirebbe la superficie dell'oceano
solo a causa di questa diversa attrazione gravitazionale, escludendo altre
influenze come le maree; in questo modo si è ottenuta una visualizzazione
esagerata delle zone gravitazionali più alte e più basse del nostro pianeta. Uno
dei modelli più famosi è noto come "patata gravitazionale
di Potsdam", dal nome della sede dell'istituto di ricerca tedesco in cui
è stato sviluppato: la mappa a fianco mostra i massimi (rossi) e i minimi (blu)
gravitazionali, misurati in metri (da "How the Indian Ocean Geoid Low Was Formed",
di Debanjan Pal e altri, in "Geophysical Research Letters").
Ebbene, l'anomalia gravitazionale più importante del pianeta Terra è una pronunciata depressione del geoide sotto l'Oceano Indiano, visibile nella mappa al largo della punta meridionale dell'India, chiamata Indian Ocean Geoid Low (IOGL), che copre più di tre milioni di chilometri quadrati a circa 1200 chilometri a sud-ovest della punta meridionale dell'India; la sua enormità e il fatto che l'oceano appaia relativamente piatto in qualsiasi punto, fanno sì che l'avvallamento non sia visibile in superficie. Come risultato della bassa forza di gravità in quel punto, combinata con la maggiore forza di gravità delle aree circostanti, il livello del mare dell'Oceano Indiano sopra il minimo è di ben 106 metri più basso della media globale. L'IOGL fu scoperto nel 1948 dal geofisico olandese Felix Andries Vening Meinesz (1887-1966) durante un'indagine gravitazionale via nave, ed in seguito è stato confermato dalle misurazioni satellitari. Per spiegarne l'origine, Attreyee Ghosh, geofisico all'Indian Institute of Science (IISc) di Bangalore ha confrontato più di una dozzina di modelli computerizzati di come la regione si sia formata negli ultimi 140 milioni di anni (alle 15.28 del 20 dicembre), in seguito allo spostamento delle placche tettoniche della Terra. Ogni modello usava variabili diverse per la convezione del materiale fuso all'interno del mantello. I suoi risultati indicano che l'IOGL è stato originato da una struttura del mantello combinata con una perturbazione adiacente sotto l'Africa, chiamata "grande provincia a bassa velocità di taglio" (LLSVP, Large Low Shear Velocity Province): il materiale caldo e a bassa densità proveniente da LLSVP sotto l'Africa si trova sotto l'Oceano Indiano e crea questo minimo. Esso è probabilmente formato da resti di placche dell'Oceano Tetide in profondità nel mantello, cioè antichi resti di fondi marini dell'Oceano Tetide, che si trovava tra i supercontinenti di Laurasia e Gondwana; l'attuale India si spostò a nord nell'Oceano Tetide, creando l'Oceano Indiano, circa 120 milioni di anni fa. Come spiega la tettonica delle placche, i pennacchi di roccia fusa si formano quando le placche subdotte appartenenti all'Oceano Tetide affondano all'interno del mantello e raggiungono il confine nucleo-mantello. Secondo Ghosh, il minimo ha assunto la forma attuale probabilmente circa 20 milioni di anni fa (alle ore 9 del 30 dicembre), quando i pennacchi hanno iniziato a diffondersi nel mantello superiore, e probabilmente durerà fino a quando il materiale del mantello fluirà lungo il pennacchio, il che probabilmente continuerà per molti altri milioni di anni; quando questi flussi cesseranno, il minimo inizierà a dissiparsi.
I mammiferi che depongono le uova
Un'attività vulcanica molto intensa interessò l'epoca Paleocene cui seguì l'innalzamento delle temperature medie, e questo sembra confermare l'ipotesi vulcanica per spiegare la crisi dell'iridio.
Allorché l'era dei dinosauri fu terminata, la Terra dovette apparire vuota, poiché essi avevano occupato tutte le nicchie ecologiche. Tanto veloce era stata la loro scomparsa, comunque, tanto rapidi ad approfittarne e ad occuparne il posto furono gli esseri che nel corso del Mesozoico si erano trovati in posizione defilata, senza essere in grado di competere con i grandi dinosauri, e che ora invece, dopo la loro repentina scomparsa, erano rimasti i padroni del pianeta: i Mammiferi.
I mammiferi si distinguono dai loro antenati rettili principalmente per il fatto di incubare i piccoli dentro l'utero materno anziché dentro un uovo deposto in un nido: per un omeotermo è un grande vantaggio, ed infatti gli uccelli, omeotermi ovipari, sono costretti a covare le uova per impedire che si raffreddano. Sia la cova che l'incubazione in utero comunque favorisce le cure parentali dei genitori nei confronti della prole, e questo diminuisce le probabilità che i figli non riescano ad uscire dall'uovo. Esse a loro volta stimolano i rapporti tra individui, la gerarchia di gruppo, le convenzioni sociali e, di conseguenza, l'intelligenza. Anche se è vero, come abbiamo detto, che i dinosauri non erano gli stupidi lucertoloni descritti dal clichè, è però vero che i mammiferi e gli uccelli in generale sono meglio attrezzati dei rettili a resistere agli sconvolgimenti della Terra, e questo ha determinato il loro successo.
In effetti, mancò poco che anche i mammiferi fossero spazzati via dall'asteroide di Chicxulub, come dimostra l'esiguo numero di specie sopravvissuto dopo il cataclisma cosmico. Appena il 7 per cento dei mammiferi sopravvisse alla carneficina. Questo scenario cupo suscita una domanda: che cosa permise ad alcuni mammiferi di resistere? La risposta è diventata chiara quando si è analizzato nel dettaglio quali animali erano morti e quali sopravvissuti. I sopravvissuti erano più piccoli della maggior parte dei mammiferi del Cretacico e i loro denti indicano una dieta onnivora. Le vittime, invece, erano più grandi, con diete carnivore o erbivore più specializzate. Questi ultimi erano estremamente adattati al paesaggio della fine del Cretacico, e così, quando l’asteroide scatenò l’inferno in terra, quegli adattamenti si trasformarono in difficoltà. Gli animali più piccoli e onnivori riuscivano più facilmente a nutrirsi di qualsiasi cosa trovassero nel caos successivo all’impatto, e potevano anche rintanarsi con più facilità per aspettare che il peggio passasse. Grazie forse anche a modi più rapidi di crescere e riprodursi, riuscirono ad appropriarsi di nicchie ecologiche rimaste deserte, e iniziarono a costruire un nuovo mondo. Quello del Cenozoico.
Molti mammiferi mesozoici, come ricordato, deponevano uova dal guscio duro: erano i Prototeri ovovivipari, che assieme ai Pantoterii, ai Simmetrodonti e ai Triconodonti (oggi tutti estinti) nel Mesozoico erano stati maggioritari tra i mammiferi. Ma con l'inizio del Cenozoico si ebbe lo sviluppo di due nuove grandi famiglie di mammiferi, che rimpiazzarono quasi del tutto la precedente: sono i Pantoteri o Marsupiali, che si svilupparono e si espansero solo limitatamente all'ex continente di Gondwana (Sudamerica, Madagascar, Australia, Antartide), dove vivono tuttora, e soprattutto dei placentati o Euteri. I primi partoriscono un embrione ancora precoce che si arrampica fino ad una cavità chiamata marsupio, dove si attacca al capezzolo e completa il suo sviluppo; i secondi invece completano il proprio svil nel uppo nell'utero materno, e se i carnivori e gli onnivori partoriscono figli ciechi e inetti, al contrario gli erbivori partoriscono figli in grado di alzarsi in piedi subito dopo il parto, per l'evidente necessità di fuggire subito davanti ai predatori carnivori.
Tra i primi mammiferi di successo c'era Ectoconus ditrigonus, scoperto nel New Mexico da Edward Drinker Cope nel 1882, che quando attraversava a balzi le foreste pluviali e paludose di 65,6 milioni di anni fa (alle 16.18 del 26 dicembre), sgranocchiando foglie e legumi, era il mammifero più grande che vi avesse mai vissuto, possedendo la taglia di un montone. La sua importanza sta nel fatto che egli visse appena 380.000 anni (44 minuti e 23 secondi) dopo la catastrofe di Fine Cretacico, e sembra già perfettamente adattato ad un mondo ormai stabilizzatosi e pronto ad ospitare una nuova Era del Mondo.
 |
|
Il pantolambda, uno dei primi mammiferi erbivori (disegno dell'autore) |
Perchè i mammiferi sono diurni
Oggi molti mammiferi sono attivi di giorno, ma mancano quasi sempre dei tratti che caratterizzano gli animali diurni di altre classi. Per esempio, a differenza dei pesci, rettili e uccelli che sono predatori diurni, i mammiferi (tranne una parte dei primati) non hanno la fovea, la parte della retina che consente un' acutezza visiva molto elevata; inoltre, la varietà di fotorecettori che servono a percepire il colore in ambienti luminosi è ridotta e la retina di molti mammiferi diurni è dominata dai bastoncelli, più adatti a condizioni di scarsa luminosità, anche se il rapporto fra bastoncelli e coni varia notevolmente da una specie all'altra. Insieme ad alcune caratteristiche anatomiche rilevate nei fossili dei sinapsidi, i predecessori evolutivi dei mammiferi, questo ha suggerito che i primi mammiferi limitassero la loro attività alla notte per evitare di essere predati dai dinosauri, che erano attivi di giorno. Roi Maor dello Steinhardt Museum of Natural History dell'Università di Tel Aviv e colleghi hanno confermato questa ipotesi, riuscendo a definire il momento in cui molti mammiferi iniziarono la transizione a una vita diurna, grazie a una complessa analisi dei dati relativi a 2415 specie di mammiferi viventi e all'uso di modelli al computer per ricostruire la probabilità dei due tipi di attività dei loro antenati nel corso dell'evoluzione. risultati hanno mostrato che i mammiferi hanno iniziato a passare all'attività diurna poco dopo la scomparsa dei dinosauri, attraversando una fase intermedia di attività mista (diurna e notturna) durata alcuni milioni di anni. Questa transizione non è però iniziata contemporaneamente per tutti gli ordini e famiglie di mammiferi. Fra i primissimi ci furono gli antenati dei primati che presto rinunciarono completamente alla vita notturna. Non a caso questo gruppo di mammiferi è l'unico che ha un'acutezza visiva e una percezione cromatica paragonabile a quellaè dei rettili e degli uccelli diurni, che non hanno mai lasciato la nicchia diurna.
Ma non è tutto. Thomas Halliday, dell'University College London, ha scoperto nel 2016 che, proprio nei 10 milioni di anni (diciannove ore e mezza) successivi all'estinzione dei dinosauri, la velocità dell'evoluzione dei mammiferi è aumentata di tre volte rispetto agli 80 milioni di anni (sei giorni e mezzo) precedenti. Il paleontologo ha analizzato i fossili di 904 mammiferi e ha messo a punto una mappa delle differenze anatomiche tra le specie. Misurando il numero di modifiche nel tempo per ogni ramo dell'albero genealogico, è stato calcolato il tasso medio di evoluzione di questi animali, sia prima che dopo la scomparsa dei dinosauri,. Tra i gruppi che più hanno sperimentato questa accelerazione, vi è quello dei Laurasiaterii, le cui specie in poco tempo sono aumentate nella dimensione del corpo e nella diversità, dando vita agli antenati del gruppo che oggi comprende animali molto diversi tra loro, come pipistrelli, gatti, rinoceronti, balene, mucche, toporagni e ricci. Halliday inoltre ha scoperto che l'ultimo antenato comune a tutti i mammiferi con la placenta è vissuto nel tardo Cretacico, circa tre milioni di anni prima della fine dei dinosauri. Questa data è di 20 milioni di anni più recente rispetto a quella indicata da studi precedenti.
Tra i primi mammiferi vegetariani del Paleocene vanno ricordati i Pantodonti, il primo dei quali, il Pantolambda (vedi figura soprastante), aveva più o meno la taglia di una pecora e viveva a contatto con l'acqua; da lui si evolse il Barylambda, lungo circa due metri e mezzo: aveva arti corti e goda grossa, e dunque si può immaginare che si appoggiasse sugli arti posteriori e sulla grossa coda per raggiungere i rami inaccessibili ad altri mammiferi. Ma all'inizio dell'Eocene era già estinto. I multitubercolati, roditori simili a topi i cui denti molari erano provvisti di molte cuspidi dette appunto tubercoli, che erano riusciti a sopravvivere durante tutta l'era dei rettili, si estinsero alla fine del periodo, ma in cambio comparvero forme primordiali di primati (proscimmie), caratterizzati dal pollice opponibile, un'assoluta novità tra i viventi, anche se avevano ancora le dimensioni di un ratto.
La rapida diversificazione dei mammiferi
In effetti la diversificazione delle specie dei mammiferi probabilmente non fu lenta come ritengono i più, ma subì una drastica accelerazione nel periodo immediatamente successivo alla grande estinzione di massa di fine Mesozoico. Lo hanno suggerito Madelaine R. Atteberry e Jaelyn J. Eberle, due paleontologhe dell’Università del Colorado a Bouder, che nel 2021 hanno descritto tre nuove specie di antichissimi ungulati: Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri e Beornus honeyi. Secondo loro, quando i dinosauri si sono estinti, l'accesso a fonti di cibo e ambienti nuovi ha permesso ai mammiferi di prosperare e diversificarsi rapidamente sia per quanto riguarda l'anatomia dei denti sia per le dimensioni corporee via via più grandi. Le nuove specie descritte arrivano infatti alla taglia di un gatto, mentre i mammiferi precedenti avevano dimensioni molto più ridotte, paragonabili a quelle di un topo o un toporagno, con la sola eccezione dei suddetti multitubercolati, che riuscirono a raggiungere in alcuni casi taglie maggiori. I multitubercolati si sono peraltro estinti proprio in seguito alla comparsa di nuovi mammiferi concorrenti.
Sulla base di una minuziosa analisi delle caratteristiche dei denti e delle mascelle dei nuovi fossili, provenienti dal ricco sito fossilifero nel Great Divide Basin, lo spartiacque che divide il bacino idrografico dei fiumi che scorrono verso l'Oceano Atlantico e verso l'Oceano Pacifico negli Stati Uniti, Miniconus, Conacodon e Beornus appartengono a una variegata collezione di mammiferi placentati chiamati condilartri, progenitori di tutti gli attuali ungulati, dai cavalli ai bovini fino agli elefanti. Quello dei condilartri è spesso considerato dai paleontologi un gruppo tassonomico informale, non essendo chiare le relazioni filogenetiche fra i taxa che vi ricadono, tanto che molti (incluse le autrici di questo lavoro) preferiscono riferirsi a esso come "condilartri" tra virgolette. Le tre nuove specie appartengono in particolare alla famiglia dei periptichidi, che si distinguono dagli altri condilartri per i denti, caratterizzati da premolari rigonfi e da insolite creste verticali di smalto. Secondo Atteberry ed Eberle, è possibile che le nuove specie siano state onnivore, dato che la conformazione dei denti avrebbe permesso loro di macinare e triturare sia materiale vegetale che carne, senza tuttavia escludere la possibilità che fossero esclusivamente erbivore. Proprio al rigonfiamento particolarmente marcato deve il suo nome di genere Beornus honey, che fa riferimento al mutapelle Beorn, personaggio de "Lo Hobbit" di Tolkien. Conacodon hettingeri e Miniconus jeanninae (il più piccolo dei tre) si differenziano invece dalle altre specie del loro genere solo per alcuni particolari dei loro molari. Questi nuovi periptichidi costituiscono solo una piccola percentuale degli oltre 420 fossili di mammiferi scoperti nel sito del Great Divide Basin, e ciò significa che non abbiamo ancora colto in pieno la grande diversità dei mammiferi nel primo Paleocene: è prevedibile che presto verranno descritte molte altre nuove specie. I condilartri condividevano le nicchie ecologiche adatte agli erbivori con i giù citati pantodonti e con i teniodonti, strani esseri con enormi zampe anteriori dotate di artigli, con cui scavavano nel terreno, e possenti mandibole con canini ingrossati, che usavano per estrarre i tuberi. Tutti questi mammiferi dovevano sicuramente temere i triisodonti, il terrore del Paleocene, che sembravano lupi possenti e frantumavano le ossa delle prede con i loro molari terribili.
Il primate più antico e il superserpente
A questo proposito, il più antico primate conosciuto, vissuto circa 65 milioni di anni fa (alle 17.28 del 26 dicembre), è il Purgatorius ceratops, delle dimensioni di un topo, e con una dieta insettivora e frugivora. Il suo nome non ha niente a che vedere con la seconda cantica della "Divina Commedia", ma deriva piuttosto dalla zona di Purgatory Hill nel nordest del Montana, dove sono stati ritrovati alcuni suoi resti. Esso apparteneva all'ordine estinto degli Plesiadapiformi, strettamente imparentato con i Primati, la cui prima documentazione fossile appare poco dopo l'estinzione dei dinosauri. Secondo alcuni era comparso alla fine del Mesozoico, ma riuscì a sopravvivere alla Crisi dell'Iridio. Alcuni ricercatori avevano ipotizzato nel corso degli anni che i Plesiadapiformi primitivi fossero terrestri, e che i Primati solo successivamente si sarebbero trasferiti sulla chioma degli alberi, perché fino a tempi recenti i paleontologi avevano a disposizione solo i denti e le mascelle di quegli antichi animali da esaminare, il che aveva lasciato molti dubbi sul loro aspetto, e il loro comportamento era un mistero. Ma l'identificazione delle ossa della caviglia di Purgatorius, che si trovavano nella stessa zona in cui sono stati rinvenuti i denti, avvenuta nel 2014, ha permesso di saperne molto di più. « Le ossa della caviglia hanno caratteristiche diagnostiche per la mobilità, e quelle rinvenute sono presenti solo nelle caviglie dei primati e dei loro parenti stretti di oggi », ha spiegato Stephen Chester della Yale University, coautore dello studio. « Queste caratteristiche uniche avrebbero permesso a un animale come Purgatorius di ruotare e regolare i piedi in modo da afferrare i rami mentre si muoveva attraverso gli alberi. Al contrario, i mammiferi che vivono a terra non hanno queste caratteristiche e le loro caviglie sono più adatte alla propulsione in avanti, permettendo un più ristretto movimento laterale ». I primi appartenenti ai Primati apparsi sul nostro pianeta erano perciò arboricoli, e trascorrevano la vita passando da un ramo all'altro degli alberi e non, come si pensava, camminando per terra. La capacità di arrampicarsi sugli alberi avrebbe conferito a tale specie un vantaggio competitivo sugli altri mammiferi, per lo più terricoli, e ciò probabilmente contribuì al successo dei primi primati. A quell'epoca cominciavano a comparire le prime piante che producevano frutti, e la scoperta che quell'antico animale fosse in grado di arrampicarsi sugli alberi sembra confermare la teoria secondo cui primati e piante con fiore siano coevoluti con beneficio reciproco. Lo studio di Chester e colleghi ha così fornito le più antiche testimonianze fossili finora conosciute di come gli alberi abbiano giocato un ruolo chiave nell'evoluzione dei Primati.
Nonostante i dinosauri si fossero appena estinti, nel Paleocene visse anche un rettile spaventoso che non posso fare a meno di citare, nonostante questo mostro incuta terrore al solo parlarne. Si tratta di un serpente lungo 13 metri, quindi quanto un TIR ed il doppio di un'anaconda, che aveva una circonferenza di un metro e pesava almeno 1250 chili: sicuramente si tratta del rettile più grande mai esistito sulla Terra. Il Titanoboa cerrejonensis (il suo nome scientifico deriva da Cerrojon, il sito nel nord della Colombia dove sono venuti alla luce i suoi resti) viveva in Sudamerica 60 milioni di anni fa (alle 03.12 del 27 dicembre) e si nutriva di coccodrilli e tartarughe. I paleontologi hanno stimato la lunghezza di questo titano dalle dimensioni delle vertebre spinali, ritrovate in una miniera di carbone a cielo aperto assieme agli scheletri di altri sette serpenti e ai resti di un loro pasto: una tartaruga di due metri e un coccodrillo. « Ora abbiamo una finestra sui tempi immediatamente successivi all'estinzione dei dinosauri e possiamo conoscere gli animali che li sostituirono », ha dichiarato Jason Head, paleontologo dell'Università di Toronto, in merito a questa strabiliante scoperta. Anche in questo caso gli sceneggiatori del film "Anaconda" hanno decisamente sbagliato per difetto...
Il misterioso uccello australe
Alcuni resti fossili scoperti nel 2013 a Canterbury, in Nuova Zelanda, appartengono a uno dei più antichi uccelli marini mai scoperti, un volatile che viveva insieme ai primi pinguini tra 61,6 e 60,5 milioni di anni fa (dalla mezzanotte del 26 alle 02.13 del 27 dicembre), appena subito dopo l'estinzione dei dinosauri. A riportarli alla luce non è stato un team di ricercatori ma un dilettante appassionato di fossili, Leigh Love, che ha donato la sua scoperta al Museo di Canterbury. Qui i ricercatori Gerald Mayr e Paul Scofield hanno potuto analizzarne i resti, i frammenti di sei ossa degli arti superiori, e hanno assegnato al nuovo volatile il nome di Australornis lovei, ovvero "uccello australe di Love", dal nome del suo scopritore. Esistono pochissimi resti di uccelli dell'emisfero australe così antichi. Uno di questi è Waimanu manneringi, il primo pinguino conosciuto, vissuto nello stesso periodo e in prossimità della stessa località. Tutto quello che sappiamo con certezza del nuovo uccello però è proprio che, pur essendo un uccello acquatico, non era un pinguino. I resti trovati purtroppo non sono sufficienti a stabilire la parentela di Australornis con nessuno degli uccelli conosciuti, viventi o estinti, per cui non è possibile stabilire l'aspetto di questo misterioso animale. Si sa solo che si trattava di una specie marcatamente differente da quelle note e che assomiglia a una specie estinta i cui resti sono stati trovati in Antartide, a testimonianza dello stretto rapporto biogeografico che c'era tra l'Antartide e la Nuova Zelanda al termine del Cretacico.
Mayr e Scofield hanno dichiarato che la scoperta « rappresenta uno dei reperti di uccello più importanti del Paleocene dell'emisfero australe », e « supporta l'idea emergente che la maggior parte degli uccelli moderni erano già diversificati all'inizio del Paleogene », ovvero subito dopo l'estinzione dei dinosauri.
La grande estinzione che fece la fortuna delle rane
La grande estinzione avvenuta alla fine del Cretacico, fu anche l'occasione per l'esplosione evolutiva delle rane: i tre maggiori rami filogenetici di questi anfibi, che comprendono l'88 % delle specie di rane viventi, apparvero simultaneamente sulla Terra proprio in quel periodo. Nelle epoche successive, le rane diventarono uno dei gruppi di vertebrati più diversificati, tanto che attualmente se ne contano più di 6700 specie, ma finora la scarsità di dati genetici ha impedito ai ricercatori di ricostruirne in modo affidabile la storia evolutiva e i legami tra le varie famiglie. Le rane erano già presenti sulla Terra, ma David Blackburn, curatore della Sezione Anfibi e Rettili del Museo di Storia Naturale della Florida, ha dimostrato che finché non si estinsero i dinosauri non fu possibile la diversità di specie che osserviamo oggi. Questo risultato era inatteso: l'ipotesi più probabile per spiegare il fenomeno è che dopo la massiccia estinzione di piante a animali, le specie che sopravvissero riempirono le nuove nicchie ecologiche che si crearono.
Blackburn e colleghi sono convinti che la grande estinzione di fine Cretacico produsse una notevole alterazione degli ecosistemi, in particolare una massiccia e diffusa distruzione delle foreste. Le rane possono adattarsi a diversi micro-habitat: quando gli ecosistemi iniziarono a riformarsi, riuscirono a cogliere le nuove opportunità evolutive. Per dimostrarlo, Blackburn e colleghi hanno analizzato 95 geni di 156 specie di rane, unendo poi i dati ottenuti con quelli già disponibili relativi ad altre 145 specie, realizzando così il più dettagliato albero filogenetico di sempre di questi anfibi, che comprende tutte le 55 famiglie note. Ma il passo cruciale dello studio è stato il successivo confronto con i dati relativi ai resti fossili che ha portato a una conclusione sorprendente: le tre maggiori superfamiglie di rane (Hyloidea, Microhylidae e Natatanura) hanno avuto una divergenza filogenetica simultanea. Il risultato, per quanto inatteso, è coerente con il quadro generale dell'evoluzione animale. « Se si guarda alla filogenesi di uccelli e mammiferi, si possono rintracciare i segni della storia della Terra, cioè dei suoi più importanti eventi climatici e geologici », ha concluso Blackburn. « Ci si aspetta quindi che eventi catastrofici come un'estinzione di massa o la separazione dei continenti possano avere avuto un impatto significativo sull'evoluzione delle rane e sui processi di separazione delle diverse linee filogenetiche di questi anfibi, ed è quello che abbiamo rilevato ».
Le api hanno corso un bel rischio!
Vale la pena di aggiungere un particolare che ci farà riflettere. Secondo alcuni ricercatori dell'Università del New Hampshire, la grande estinzione di massa che segnò il passaggio dall'era Mesozoica a quella Cenozoica non spazzò via solo i dinosauri, ma rischiò di far sparire pure le api. Per molto tempo si è ipotizzato che il diffuso declino delle api carpentiere (della sottofamiglia Xylocopinae), verificatosi in concomitanza con la scomparsa dei grandi rettili al termine del Cretacico e all'inizio del Paleocene, fosse legato all'estinzione delle piante con fiori, le angiosperme, che erano fondamentali per la loro sopravvivenza. « Ma, diversamente dai dinosauri, non ci sono numerose tracce fossili di api, quindi è sempre stato molto difficile confermare questa ipotesi », ha spiegato Sandra Rehan, docente di scienze biologiche presso l'Università del New Hampshire. Per ovviare alla mancanza di resti fossili, il team di ricercatori ha utilizzato una tecnica chiamata filogenesi molecolare. Hanno cioè analizzato le sequenze di DNA di 230 specie appartenenti a quattro "tribù" di api carpentiere di tutti i continenti, per comprenderne la storia evolutiva e individuare somiglianze e differenze emerse nel corso del tempo. Incrociando i dati fossili con le analisi genetiche, i ricercatori hanno così elaborato un modello che fa luce sulla grande moria di api che si è verificata in quell'epoca remota, ed hanno riscontrato che « qualcosa di importante è accaduto a quelle popolazioni di api, proprio mentre i dinosauri si estinsero ».
Le loro analisi indicano alcuni aspetti cruciali della storia evolutiva delle Xylocopinae: la loro origine risale al Cretacico medio, circa 150-100 milioni di anni fa (dalle 20 del 20/12 alle 21.20 del 23/12), in parallelo alla rapida espansione delle eudicotiledoni, un importante gruppo di angiosperme. Poi, sostengono i ricercatori, indipendentemente dai diversi fattori che possono aver contribuito a modificare gli ecosistemi terrestri al termine del Cretacico e all'inizio del Paleocene (l'impatto di un meteorite, i cambiamenti climatici dovuti a mega-eruzioni e quelli del livello dei mari), vi sono prove evidenti che proprio 65 milioni di anni fa circa (alle 17.28 del 26/12) il rapporto insetti-piante è stato stravolto. « E data la stretta relazione tra eudicotiledoni e api, è plausibile che il declino delle piante fiorite abbia avuto un impatto sulle api, e viceversa » ha spiegato la Rehan. « Alle api è toccata la stessa sorte delle piante che impollinavano. »
Capire come questi insetti impollinatori hanno risposto agli sconvolgimenti ambientali del passato può essere determinante anche per fronteggiare i pericoli che corrono oggi. « E se si potesse raccontare tutta la storia evolutiva delle api, forse oggi ci preoccuperemmo di più di proteggerle », ha concluso la Rehan, ricordando quanto le api siano fondamentali (insieme ad altri insetti impollinatori) per l'agricoltura, e non solo. Ma da decenni ormai si assiste alla sparizione delle api, a causa soprattutto dell'uso di pesticidi, dell'infestazione di parassiti e dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico delle automobili, perché interferiscono con la capacità delle api di impollinare i fiori, alterando la loro capacità di riconoscere gli odori floreali. Comprendere cosa è successo in passato a questi insetti impollinatori può essere utile a comprendere meglio e fronteggiare i rischi che corrono oggi, e non solo per arginare gli effetti sulla biodiversità ma anche per le possibili ripercussioni sull'agricoltura, che dipende dalle api per l'impollinazione di molte coltivazioni e di piante selvatiche.
L'esplosione dei mammiferi e degli uccelli
Dato che il Cenozoico è chiamato anche "l'Era dei Mammiferi", è giusto far notare che l'evoluzione dei mammiferi terrestri presenta ancora più di un aspetto misterioso per i moderni paleontologi. Dopo essere comparsi sulla Terra nell'era Mesozoica, essi rimasero di piccole dimensioni per circa 150 milioni di anni (oltre 12 giorni dell'anno della Terra); improvvisamente, una decina di milioni di anni dopo la scomparsa dei dinosauri, essi raggiunsero proporzioni gigantesche. Ad esempio l'Indricotherium transouralicum, un erbivoro che assomigliava ai rinoceronti dei nostri giorni, anche se non possedeva le corna, arrivò al punto di raggiungere sei metri d'altezza, come una giraffa dei nostri giorni, e un peso di 17 tonnellate. Nel novembre 2010 una ricerca condotta dalla National Science Foundation ha avanzato una proposta in merito: a sviluppare forme ciclopiche furono i mammiferi conquistarono territori freddi e con estensioni immense.
Basandosi sui denti fossili, che più di ogni altra parte del corpo sono legati alle dimensioni degli animali, la ricerca ha dimostrato come esista una stretta correlazione tra ambienti ecologici ed evoluzione delle specie, indipendentemente dalla loro storia evolutiva precedente. « I mammiferi passarono da poco più di dieci chili, quando vivevano con i dinosauri, fino a 17 tonnellate dopo alcuni milioni di anni e questa crescita è avvenuta quasi contemporaneamente su tutto il pianeta interessando tutti i mammiferi, indipendentemente dalla loro dieta », ha dichiarato Felisa Smith, della University of New Mexico. Secondo lei i mammiferi iniziarono ad aumentare la loro stazza circa 55 milioni di anni fa, alla fine del Paleocene, per raggiungere dimensioni massime durante l'Oligocene, e questo avvenne soprattutto in Eurasia, e poi ancora durante il Miocene, che interessò i mammiferi dell'Eurasia e dell'Africa. « Climi freddi e grandi aree su cui poter vivere furono i fattori vincenti per i mammiferi », continua la Smith. Questa nuova scoperta confermerebbe l'ipotesi avanzata anni fa, secondo la quale, contrariamente a quanto pensato fino ad allora, non fu la fine dei dinosauri in sé e per sé a permettere ai mammiferi di accrescersi, ma gli habitat dove essi andarono a vivere. John Gittleman, della Univeristy of Georgia infatti, aveva dimostrato che dopo la scomparsa dei grandi rettili, avvenuta con la Crisi dell'Iridio, vi fu un lungo periodo di almeno una decina di milioni di anni, durante i quali i mammiferi rimasero di dimensioni simili a quelle che possedevano durante l'impero dei dinosauri. Vedremo che furono gli uccelli ad esplodere in dimensioni in quell'arco di tempo, tanto che molti persero la capacità di volare.

Il Massimo Termico di fine Paleocene
È scoperta recente il fatto che non solo il Cretacico (e con esso l'Era Mesozoica) ma anche il Paleocene, nel suo piccolo, ebbe fine in seguito a profondi cambiamenti climatici. In questo caso però si parla di un eccezionale episodio di riscaldamento globale, denominato Massimo Termico Paleocene–Eocene (PETM), il quale provocò un aumento delle temperature marine superficiali di circa 5°C. Secondo gli studi di Ian Harding e John Marshall della School of Ocean and Earth Science (SOES) dell'Università di Southampton, nel Regno Unito, il riscaldamento degli oceani portò a profondi cambiamenti ecologici, tra cui la diffusa estinzione di molti tipi di foraminiferi, minuscoli organismi unicellulari; il plancton che aveva prosperato nelle acque tropicali e subtropicali migrò verso latitudini più elevate; molte specie animali e vegetali colonizzarono anche le regioni più vicine ai poli. « Mentre sono ben documentati i cambiamenti ambientali legati al PETM alle basse e medie latitudini nell'emisfero boreale e alle alte latitudini in quello australe, poco si sapeva finora delle zone artiche », ha spiegato Harding.
Per colmare queste la cune, il gruppo di Harding ha preso in considerazione le isole Svalbard, a 78° di latitudine Nord, in cui sono presenti sedimenti spessi 2,5 chilometri di questo periodo. Grazie all'analisi del plancton e delle caratteristiche magnetiche dei sedimenti, è stato possibile identificare in modo non ambiguo la successione di 15 metri corrispondente ai 170.000 anni in cui si verificò l'evento di PETM. Alla base del carotaggio considerato sono stati trovati i resti ben conservati di dinoflagellati della serie Apectodinium augustum, già presente nelle Svalbard prima dello shift degli isotopi del carbonio che segna formalmente l'inizio della PETM, il che fa ipotizzare che il cambiamento climatico fosse già in corso. Queste analisi dimostrano che il livello del mare cominciò a sollevarsi ben prima dell'inizio del PETM, ma anche che raggiunse il suo picco circa 13.000 anni dopo. Allo stesso tempo, l'aumento del fenomeno di ruscellamento portò a uno smorzamento del rimescolamento delle acque del mare e a una stratificazione in cui gli strati superiori meno salini sovrastavano quelli inferiori più salini; la deprivazione di ossigeno nelle acque era fortemente concentrata nella parte più profonda del mare, a contatto con i sedimenti.
E tra i nostri antenati spunta Mickey Mouse!
Sette centimetri di lunghezza più tredici di coda per 30 grammi di peso: il presunto progenitore di tutti i primati assomigliava a un topolino, viveva di giorno, si nutriva di insetti ed era in grado di spiccare grandi salti fra i rami degli alberi, poiché i suoi arti inferiori erano così sviluppati e allungati che gli scopritori hanno soprannominato la nuova specie al vertice della nostra evoluzione Archicebus achilles. E se Archicebus vuol dire "antica scimmia con la coda", il nome di Achille è stato scelto per la robustezza dei suoi garretti.
Vissuto circa 56 milioni di anni fa, cioè alle 10.59 del 27 dicembre (il primate fossile più antico prima conosciuto aveva 48 milioni di anni, cioè quasi 15 ore dopo), quindi al confine tra Paleocene ed Eocene, Archicebus è stato scoperto da un contadino una decina di anni fa. Si trovava all'interno di una roccia sedimentaria formatasi sul fondo di un lago cinese, poco a sud del fiume Yangtse Kiang. Al posto del lago prosciugato oggi c'è una caverna, che si è rivelata una sorta di grotta di Alì Babà per i paleontologi, essendo ricchissima di fossili di pesci e uccelli. I ricercatori dell'Accademia delle Scienze di Pechino e del Carnegie Museum of Natural History che lo hanno studiato si sono resi conto che il suo scheletro era completo al 50 per cento (come a dire quasi completamente conservato, visto che di solito si trova solo qualche dente); e così, hanno spedito il fossile all'European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble. Qui la roccia è stata scannerizzata ai raggi X e la sua forma è emersa a tutto tondo, inclusa la parte immersa nella pietra, senza bisogno di distruggere nessun frammento.
Il piccolo animale è vissuto in una stagione molto particolare dell'Anno della Terra, con il clima caldo che faceva fiorire la vita sul pianeta (spuntavano palme in Alaska). « Archicebus era un ibrido bizzarro », ha raccontato Chris Beard del Carnegie Museum. « Il suo aspetto era molto diverso da quello degli altri primati. Aveva i piedi di una piccola scimmia, braccia, gambe e denti di un primate assai primitivo e un cranio con due occhi minuscoli ». Il fatto che la scoperta sia avvenuta in Cina, secondo Beard, « indica che questa zona tra Paleocene ed Eocene era un "punto caldo" della biodiversità. I primi passi dell'evoluzione dei primati sono stati mossi qui, non in Africa come si pensava un tempo ». E da quel piccolo Mickey Mouse (dopotutto la notizia è stata diffusa nel maggio 2013, contemporaneamente all'uscita del numero 3000 di "Topolino"!) si sarebbero evoluti i tarsi, i lemuri, le scimmie vere e proprie, gli ominidi, e infine noi uomini.
I misteriosi perissodattili sudamericani
Dopo quasi due secoli è stato risolto il mistero della collocazione tassonomica di quelli che Charles Darwin aveva definito « gli animali più strani mai scoperti », un gruppo di mammiferi sudamericani estinti che secondo alcuni scienziati erano imparentati con i perissodattili (l'ordine che comprende cavalli, rinoceronti e tapiri), mentre per altri andavano inseriti fra gli afroteri, una linea evolutiva che ha avuto origine in Africa (da cui il nome) alla quale appartengono i proboscidati, le procavie, i sirenidi (dugonghi e lamantini), i tubulidentati (oritteropo) e i macroscelidi (tenrec riccio, tenrec toporagno e talpe dorate). A dirimere la questione è stato un gruppo internazionale di ricercatori che sono riusciti a classificarli fra i perissodattili, superando le difficoltà che finora avevano bloccato paleontologi e genetisti.
« La collocazione di questi animali sudamericani nell'albero genealogico dei mammiferi è sempre stata una grande sfida per i paleontologi, perché anatomicamente erano strani mosaici, esibivano caratteristiche che si ritrovano in una grande varietà di specie del tutto indipendenti una dall'altra e che vivono in luoghi completamente diversi », ha spiegato Ross MacPhee, dell'American Museum of Natural History. Ma i fossili di questi animali, gli ultimi dei quali scomparsi solo 10.000 anni fa (alle 23.58.49 del 31 dicembre), avevano finora tenuto in scacco anche i ricercatori che, come Ian Barnes del Natural History Museum, avevano in precedenza tentato di stabilirne le parentele attraverso l'analisi del DNA. Il materiale genetico estratto da quei fossili, rimasti sepolti in terreni di regioni dal clima caldo e umido, era infatti risultato troppo degradato per dare delle risposte. La svolta è arrivata quando i ricercatori sono passati dall'analisi del DNA a quella del collagene, una proteina strutturale che si trova in tutte le ossa animali e che è in grado di resistere sostanzialmente integra anche per un milione di anni e in una vasta gamma di condizioni. « In passato si è riusciti a recuperare sequenze di collagene da campioni risalenti anche a 4 milioni di anni fa, ma in teoria per il materiale recuperato dal permafrost, si potrebbe risalire fino a 10 milioni di anni fa », hanno dichiarato gli autori.
Dato che la struttura chimica degli amminoacidi che compongono una proteina è dettata da specifiche sequenze codificanti del DNA dell'organismo, confrontando la composizione in aminoacidi di una proteina nelle diverse specie si possono ricavare informazioni utili a stabilire quanto strettamente imparentate esse siano. Per questa analisi proteomica i ricercatori hanno utilizzato 48 fossili di Toxodon platensis e di Macrauchenia patachonica, le specie scoperte da Darwin in Uruguay e Argentina. I dati ottenuti indicano che queste due specie erano ungulati perissodattili discendenti da antichi ungulati provenienti dal Nord America più di 60 milioni di anni fa (alle 03.12 del 27 dicembre), probabilmente subito dopo l'estinzione di massa dei dinosauri e di molti altri vertebrati. Tuttavia, dato che questi antichi mammiferi sudamericani formavano un gruppo molto ampio e vario, non si può ancora sapere se altre specie avessero la stessa origine o appartenessero ad altri lignaggi non ancora studiati dai ricercatori.
Il recupero dopo il grande cataclisma
Il recupero degli ecosistemi dopo la grande estinzione di massa alla fine del Cretaceo fu molto più rapido nell'emisfero meridionale che in quello settentrionale, come ha dimostrato una ricerca di paleobiologi della Pennsylvania State University, della Smithsonian Institution e del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'Argentina. Michael P. Donovan e colleghi sono giunti a questa conclusione grazie all'esame dei diversi tipi di danni rilevabili nelle foglie fossili di quell'epoca remota. In particolare, hanno analizzato 3646 di questi reperti provenienti dalla formazione di Salamanca, in Patagonia, che hanno poi confrontato con quelli osservati nelle foglie fossili rinvenute in siti del Nordamerica. Le interazioni fra piante e insetti sono infatti componenti fondamentali delle reti alimentari terrestri, e la loro sensibilità alle grandi perturbazioni ambientali è ben nota. Come hanno dimostrato numerosi studi sugli ecosistemi contemporanei e passati, la varietà dei danni provocati dagli insetti che si nutrono di foglie è strettamente correlata alla biodiversità di questi animali e, in misura solo relativamente minore, anche alla biodiversità generale della regione.
Precedenti ricerche avevano dimostrato che, successivamente all'impatto del meteorite di Chicxulub, in America settentrionale le interazioni pianta-insetto crollarono drasticamente e che per recuperare il livello precedente di biodiversità ci vollero almeno nove milioni di anni (17 ore e mezza dell'Anno della Terra). Dalle analisi di Donovan e colleghi è emerso che in Sudamerica il tracollo di quelle interazioni fu altrettanto severo, in contrasto con quanto supposto dalla cosiddetta ipotesi del rifugio, secondo cui gli eventi che portarono all'estinzione di massa avrebbero avuto un impatto minore nell'emisfero australe. Tuttavia, i ricercatori hanno anche trovato che il recupero dell'ecosistema è stato molto più veloce: la varietà delle interazioni pianta-insetto è risultata ripristinata nel giro di soli quattro milioni di anni (sette ore e mezza dell'Anno della Terra).
Dinosauri cenozoici?
Prima di passare all'Eocene, non posso fare a meno di citare uno studio secondo il quale certe ossa di dinosauro ritrovate nell'Ojo Alamo Sandstone del Bacino di San Juan, nel Nuovo Messico, risalirebbero ad un'epoca posteriore alla grande Crisi dell'Iridio, e quindi apparterrebbero al Paleocene e non al Cretacico! Questo significherebbe che alcuni dinosauri potrebbero essere sopravvissuti in un'area remota degli attuali stati del Nuovo Messico e del Colorado, in barba alla vulgata comune che vorrebbe la completa estinzione dei dinosauri alla fine dell'Era Mesozoica! Si tratta di una notizia bomba, pubblicata nel giugno 2009 sulla rivista "Palaeontologia Electronica", a firma di James E. Fassett, ricercatore dello U.S. Geological Survey di Santa Fe, e basata su dettagliate analisi chimiche dei reperti e degli strati rocciosi in cui erano inseriti.
La datazione cenozoica riguarda 34 ossa di adrosauro, e come si può immaginare è assai controversa. "La grande difficoltà di questa ipotesi, secondo cui si tratta in questo caso di resti di dinosauri sopravvissuti al drammatico evento, è escludere la possibilità che le ossa siano databili a un periodo precedente”, ha spiegato Fassett. "Dopo la morte degli animali e la deposizione delle ossa nella sabbia e nel fango, è possibile che esse siano state esumate dalle acque di un fiume e incorporate in rocce più giovani." Non si tratta di un fenomeno usuale, ma questo argomento è già stato utilizzato in passato per spiegare l'esistenza di ossa di dinosauro in strati di roccia posteriori alla grande estinzione. Ma Fassett ha accumulato un'enorme messe di dati che escluderebbe la riesumazione e rideposizione delle ossa: anzitutto le famose 34 ossa di adrosauro non rappresentano uno scheletro completo, ma appartengono senza dubbio a un unico esemplare, mentre se fossero state trasportate da un fiume sarebbero state sicuramente disperse. Inoltre analizzando la polarità magnetica delle rocce e i pollini in esse contenuti, ha concludere per vie indipendenti che la datazione corretta risale a un periodo successivo al Cretacico. Oltre a ciò, Fassett ha anche provato che le ossa di dinosauro della Ojo Alamo Sandstone hanno concentrazioni differenti degli elementi detti « terre rare » rispetto a quelle delle ossa del Cretacico ritrovate negli strati sottostanti, il che rende molto improbabile che siano state effettivamente esumate.
Certamente questa teoria stuzzica la nostra fantasia, poiché da sempre scrittori e sceneggiatori hanno rifiutato di rassegnarsi alla completa estinzione dei possenti dinosauri: da Jules Verne (1828-1905) nel "Viaggio al Centro della Terra" (1864) a sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) nel "Mondo Perduto" (1912), dal film Disney "Baby, il segreto della leggenda perduta" (1985) di Bill Norton fino agli innumerevoli episodi della saga a cartoni animati "Alla Ricerca della Valle Incantata" di Don Bluth, moltissimi nostalgici hanno immaginato la sopravvivenza di alcuni bestioni in qualche irraggiungibile recesso che li protesse dall'estinzione di fine Mesozoico. Purtroppo però nemmeno le ricerche di Fassett rappresentano la prova conclusiva che almeno una parte dei dinosauri ce la fece a sopravvivere all'estinzione: come sottolinea in una nota David Polly, uno degli editori della rivista "Palaeontologia Electronica", la maggior parte dei paleontologi rimane tuttora scettica sull'argomento. L'unica speranza è che nuove prove paleontologiche confermino senza ombra di dubbio che alcuni dinosauri ancora sopravvivevano mentre già mammiferi ed uccelli iniziavano ad occupare ogni nicchia ecologica del loro impero perduto.
![]()
Il termine Eocene significa "aurora del recente", perchè segna l'inizio della vita così come oggi la conosciamo. Va da 56 a 34 milioni di anni fa: in termini di Anno della Terra, va dalle 10.59 del 27/12 alle 05.48 del 29/12.
L'Eocene è suddiviso in quattro stratificazioni: Ypresiano, Luteziano, Bartoniano e Priaboniano.
L'orogenesi alpina
A quest'epoca risalgono i calcari e i sedimenti marini costituiti da scheletri calcarei dei Nummuliti, comparsi nel periodo precedente. Dal punto di vista della deriva continentale, l'oceano Tetide va chiudendosi e si ha così la collisione tra l'Africa e l'Europa. Insieme alla deriva verso nord dell'India, che entra a sua volta in collisione con l'Asia, questo porta all'orogenesi alpino-himalayana. Nel contesto di quest'orogenesi in Italia si sollevano le Alpi e gli Appennini, e comincia a delinearsi la forma della nostra penisola, tuttavia ancora simile ad un arcipelago montuoso. L'Asia era separata dall'Europa da un mare poco profondo di cui oggi resta un unico rimasuglio: il Mar Caspio. L'Eocene fu caratterizzato da clima caldo e prevalentemente privo di ghiacci in tutto il mondo, con foreste temperate e subtropicali a coprire gran parte del globo. Il clima era molto meno variato dell'attuale: anche alle latitudini di Londra, infatti, era di tipo semitropicale. Prosperavano palme e cicadee, come pure fichi, magnolie e la cannella. Presero a formarsi ricchi giacimenti fossiliferi, come la formazione di Green River, negli Stati Uniti occidentali, e la formazione di Messel, in Germania, con l'accumulo di sedimenti sul fondo di antichi laghi che spesso seppellivano resti di piante e animali che poi potevano fossilizzarsi.
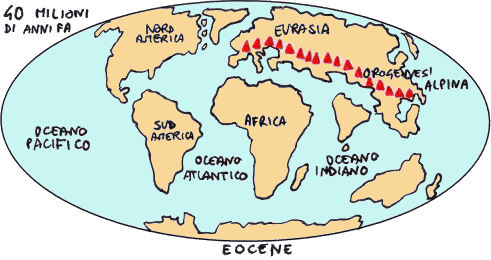
Il PETM e i rischi che si ripeta
Da decenni i climatologi sanno avvertito che sono esistiti in passato dei "tipping points" (letteralmente "punti di ribaltamento") in corrispondenza dei quali il riscaldamento globale oggi in corso potrebbe causare una cascata di effetti accelerati e irreversibili, e i geologi ne hanno identificato molti esempi nelle testimonianze fossili. Così, circa 56 milioni di anni fa (verso le ore undici del 27 dicembre), al momento della transizione tra Paleocene ed Eocene, le eruzioni vulcaniche innescarono condizioni da effetto serra che alterarono l'evoluzione e la direzione delle correnti oceaniche. Studiando i cambiamenti climatici del passato, i geologi sperano di anticipare come il cambiamento climatico attualmente in corso, causato dagli esseri umani, potrebbe alterare in modo drammatico il nostro mondo.
Il cosiddetto Massimo Termico del Paleocene-Eocene (PETM, "Paleocene-Eocene Thermal Maximum") fu in effetti un periodo eccezionalmente caldo nella storia della Terra, ma la sua causa è molto discussa. Nel 2021 Sev Kender, geologo del British Geological Survey, affermò di avere le prove che le eruzioni vulcaniche nel Nord Atlantico avrebbero fornito una componente critica a questa esplosione di calore. Gli indizi chiave di questa affermazione provengono da un sottile nucleo di sedimento estratto da un accumulo di rocce sottomarine vicino all'Islanda. Quest'area, conosciuta come provincia ignea del Nord Atlantico, si è formata dal magma che uscì dalla crosta terrestre più di 50 milioni di anni fa (alle 22.40 del 27 dicembre). I geologi avevano ipotizzato che l'attività vulcanica che ha creato queste rocce fosse coinvolta nel PETM, quindi Kender è stato immediatamente incuriosito da indizi della presenza di mercurio nel principale campione estratto. Un elevato livello di mercurio nelle carote di roccia permette di misurare l'attività vulcanica, e i livelli trovati dal gruppo indicano che le eruzioni del Nord Atlantico si sono verificate al momento giusto e con la giusta intensità per aumentare i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera. Poi, quando i vulcani si sono finalmente calmati, l'aumento delle temperature è continuato. I gas serra vulcanici avrebbero riscaldato il clima globale abbastanza da innescare il rilascio di carbonio bloccato altrove, che ha intensificato ancora di più il riscaldamento globale. Altre prove, come gli indicatori geologici di anidride carbonica atmosferica e oceanica durante questo periodo, potrebbero aiutare a testare ulteriormente questa ipotesi. Momenti nel profondo passato della Terra come il PETM forniscono preziosi punti di paragone per capire il comportamento dei sistemi climatici sotto stress, incluso il nostro clima attuale.
Antichi maremoti
Il lago Tanganica, il più antico della Rift Valley africana, è un bacino lungo e stretto diviso tra gli stati del Burundi, della Tanzania, dello Zambia e della Repubblica Democratica del Congo; si estende per circa 680 km in direzione nord-sud, con una larghezza massima di 72 km, una superficie è di 32.900 kmq ed una profondità massima di 1436 m (è il lago più profondo del Continente Nero il secondo al mondo per profondità dopo il lago Bajkal). Ma queste non sono le sue sole peculiarità. La fauna ( granchi, gamberetti, aringhe) che lo popola è infatti unica: pur essendo il Tanganica un lago d'acqua dolce, esso ha una forte somiglianza con quella marina. La prima teoria avanzata per spiegare la presenza di questi esemplari unici in quel lago parlava di una passata connessione di esso con l'oceano, ipotesi però scartata perché le recenti ricostruzioni paleogeografiche indicano che il lago non e mai stato direttamente collegato al mare. Il misterioso è rimasto fittissimo, fino ad uno studio di Tony Wilson dell'Università di Zurigo, secondo il quale la risposta è da ricercarsi in uno spaventoso maremoto avvenuto nell'Africa orientale tra Eocene ed Oligocene. Per risolvere l'enigma infatti Wilson e i suoi colleghi hanno sequenziato il DNA di un'aringa del Tanganica. La sua storia evolutiva ne fissa la comparsa nel lago fra i 50 e i 25 milioni di anni fa, nello stesso periodo in cui un immenso maremoto avrebbe inondato gran pane dell'Africa orientale per motivi tuttora sconosciuti. Questi esemplari portati dalle ondate marine si sarebbero poi diffusi nell'Africa centromeridionale, raggiungendo il Tanganica ai primi stadi di formazione. Un'ipotesi veramente suggestiva, che sembra riportare in voga l'antica "Teoria delle Catastrofi"!
Sempre all'Eocene è stata datata l'origine del Fiume Azzurro (in cinese Chang Jiang, "Fiume Lungo", detto anche Yangtze Kiang), il principale fiume cinese ed uno dei più lunghi del mondo, superato solo dal Nilo e dal Rio delle Amazzoni. Esso rivestì un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura cinese, e le cosiddette "Tre Gole", che separano il bacino di Sichuan, a ovest, dai bassopiani situati a est, hanno un significato storico e culturale tutto particolare. Senza il passaggio rappresentato dalle Tre Gole, infatti, la Cina sud-occidentale con la ricca area agricola del Sichuan sarebbe rimasta tagliata fuori dal resto del paese dalle montagne pressoché inaccessibili che circondano tale regione;: in quell'area inoltre sorge oggi una diga tra le più imponenti del mondo. I sedimenti delle Tre Gole, precedentemente datati tra due e un milione di anni fa, sarebbero in realtà molto più antichi: Alexander Densmore, ricercatore della Durham University, ha infatti stimato che il fiume cominciò a incidere l'area delle Tre Gole oltre 45 milioni di anni fa (alle 8.24 del 28 dicembre). Secondo la vulgata comunemente accettata, il Fiume Azzurro si sarebbe formato a partire da precedenti corsi d'acqua più piccoli che fluivano da ovest verso est, ma basandosi sulla datazione dei sedimenti della regione Densmore ha valutato che le Tre Gole si formarono in soli due milioni di anni, e quindi in modo estremamente rapido su scala geologica.
Perché non ci sono canguri fuori dall'Australia?
Il motivo per cui innumerevoli serpenti velenosi, lucertole spinose (Moloch horridus), topi saltellanti (Notomys alexis) o volpi volanti abbiano percorso la strada dall'Asia all'Australia, piuttosto che il contrario, è stato un mistero fino a poco tempo fa. Se andiamo a Bali non vedremo neanche un cacatua, ma ne vedremo in abbondanza andando nella vicina isola di Lombok. La situazione è la stessa per i marsupiali: L'Australia ospita innumerevoli specie di marsupiali, come il canguro e il koala, ma più si va verso ovest, più esse diventano rare. Mentre nell'isola indonesiana di Sulawesi si trovano solo due rappresentanti di questi mammiferi tipicamente australiani, nel vicino Borneo li cercheremo invano. L'Australia, d'altra parte, non ospita mammiferi tipici dell'Asia, come orsi, tigri o rinoceronti. Questo brusco cambiamento nella composizione del mondo animale attirò l'attenzione del naturalista britannico Alfred Russell Wallace (1823-1913), che viaggiò attraverso l'arcipelago indonesiano dal 1854 al 1862, per raccogliere campioni di animali e piante. Egli tracciò sulla carta geografica una linea biogeografica invisibile che correva tra Bali e Lombok e tra Borneo e Sulawesi, oggi nota come Linea Wallace, e che segna la distribuzione più occidentale della fauna australiana. I ricercatori che si occupano della biodiversità sono stati a lungo affascinati da questo brusco cambiamento delle creature lungo la Linea di Wallace, ma come si sia arrivati a questi modelli di distribuzione non era ancora stato chiarito nel dettaglio.
Per comprendere meglio questa distribuzione asimmetrica dei vertebrati lungo la Linea Wallace, i ricercatori guidati da Loic Pellissier, professore di Ecosistemi ed evoluzione del paesaggio all'ETH di Zurigo, hanno creato un modello che combina ricostruzioni del clima, spostamenti delle placche di 30 milioni di anni fa e un set di dati completo per circa 20.000 uccelli, mammiferi, rettili e anfibi registrati oggi nella regione. Quarantacinque milioni di anni fa (alle 8.24 del 28 dicembre) la placca australiana iniziò a spostarsi verso nord e scivolò sotto la potente placca eurasiatica; questo ha avvicinato due masse terrestri che prima erano molto distanti, e per le creature terrestri divenne più facile colonizzare un continente dall'altro. I ricercatori hanno dimostrato che gli adattamenti ai climi delle aree di origine sono in parte responsabili della distribuzione disomogenea dei rappresentanti della fauna asiatica e australiana su entrambi i lati della Linea di Wallace. Oltre alla tettonica delle placche, le condizioni ambientali che prevalevano milioni di anni fa sono state decisive per lo scambio tra i due continenti. Sulla base di simulazioni, gli scienziati hanno scoperto che gli animali originari dell'Asia avevano maggiori probabilità di attraversare le isole indonesiane per raggiungere la Nuova Guinea e l'Australia settentrionale. Queste isole erano caratterizzate da un clima tropicale umido, al quale gli animali si trovavano bene e al quale si erano già adattati. La fauna australiana era diversa, essendosi evoluta in un clima più fresco e sempre più secco nel corso del tempo, e quindi aveva meno successo nel prendere piede sulle isole tropicali rispetto alla fauna che migrava dall'Asia. Il clima asiatico favorì quindi le creature che raggiunsero l'Australia attraverso le isole tropicali della regione faunistica oggi nota come Wallacea, soprattutto quelle in grado di tollerare un'ampia gamma di climi, e ciò rese più facile il loro insediamento nel nuovo continente. Questi risultati ci fanno capire che possiamo comprendere gli attuali modelli di distribuzione della biodiversità solo se includiamo nelle nostre considerazioni lo sviluppo geologico e le condizioni climatiche della preistoria. Nell'attuale crisi della biodiversità, questo può aiutarci a valutare meglio le conseguenze delle invasioni indotte dall'uomo.
46 milioni di anni di punture di zanzara
Fu proprio nell'Eocene che le zanzare presero il vizio di pungere per succhiare il sangue altrui. La prova che il comportamento ematofago delle femmine di questi insetti risale a più di 46 milioni di anni fa (alle 6.27 del 28 dicembre) è venuta dall'analisi del contenuto dello stomaco di un rarissimo fossile di zanzara eseguita con una sofisticata tecnica spettrografica da ricercatori del National Museum of Natural History a Washington, del Natural History Museum a Londra e della Carnegie Institution. L'idea che l'ematofagia, un comportamento che si è evoluto indipendentemente in numerose specie, avesse un'origine che affondava nel più remoto passato geologico era sostenuta fino a poco tempo fa solo da prove indirette, come la conformazione dell'apparato buccale dei fossili di invertebrati scoperti per lo più in gocce di ambra. La conservazione nell'ambra, però, rende estremamente problematico cercare nell'intestino degli animali i resti di emoglobina o di molecole derivate, che sono l'unica prova diretta dell'ematofagia, con buona pace di "Jurassic Park".
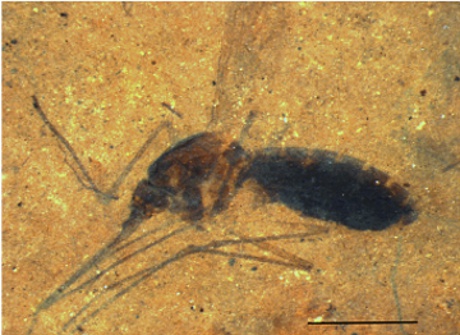 |
|
La zanzara fossile analizzata dal professor Greenwalt |
Dale E. Greenwalt e colleghi ci sono riusciti grazie al ritrovamento di alcuni fossili di zanzare, tra cui una femmina ben conservata, in una formazione marnosa nel Montana nord-occidentale risalente all'Eocene medio. La conservazione di un simile esemplare è decisamente eccezionale, visto che presuppone una serie di eventi molto improbabile: subito dopo aver consumato il suo pasto di sangue, l'insetto deve essersi spostato sulla superficie di uno specchio d'acqua per poi finire sul fondo e venire rapidamente ricoperto da sedimenti molto fini, tali da assicurare un ambiente anaerobico, e senza far subire alcun danno al suo fragile addome pieno di sangue. I ricercatori hanno usato una tecnica particolare, la spettrometria di massa di ioni secondari con analisi dei tempi di volo degli ioni (ToF-SIMS), che ha permesso di riconoscere in maniera inequivocabile prima la presenza di ferro all'interno dell'intestino dell'insetto, e poi quella di porfirine, le molecole che aggregandosi formano l'eme, la parte non proteica dell'emoglobina. Per assicurarsi la contaminazione del fossile da parte della matrice che lo conteneva, i ricercatori hanno analizzato altre parti della zanzara e l'addome di un'altra zanzara maschio rinvenuta nella stessa formazione, che sono risultati tutti privi di tracce di composti del ferro e in particolare di porfirine.
L'Era degli Uccelli
È all'Eocene che risale il primo sviluppo di famiglie di mammiferi placentati oggi diffusissimi come i Cetacei, gli Ungulati, i Roditori, i Carnivori, ed i Lemuridi. Per la maggior parte vivevano sugli alberi e conducevano vita notturna, come il Paramys, uno dei primi roditori dotati di incisivi foggiati a scalpello in continua crescita per tutta la vita, ideali perciò per sminuzzare materiale vegetale duro. I primati non poterono reggere la concorrenza e si ritirarono in habitat ristretti in Sudamerica e soprattutto in Africa, dove avvennero mutazioni decisive a loro vantaggio. Tetonius aveva già gli occhi in posizione frontale, il che gli permetteva di calcolare le distanze con grande precisione, e molto sviluppati, segno che si era adattato alla vita notturna. Molti piccoli mammiferi conquistarono il volo, e nacquero i Chirotteri: il primo, Icaronycteris, fu ritrovato sul fondo di un lago disseccato in Nordamerica, ed era perfettamente adattato al volo ad ali battenti come gli attuali pipistrelli.
Ma, siccome i mammiferi erano ancora piccoli e relativamente modesti, come detto sopra l'Eocene fu l'Era degli Uccelli. Infatti agli inizi di quest'epoca comparvero famiglie di Uccelli moderni come gli Anatidi, mentre a 50 milioni di anni fa risale la comparsa degli Psittaciformi. Si formarono inoltre le famiglie dei Fenicotteriformi, dei Galliformi, dei Pellicaniformi e dei Gruiformi. Sui laghi dell'Eocene planavano le prime fregate a noi note: andavano a pesca, o portavano via i pesci ad altri uccelli. I primi membri della linea di discendenza dei rondoni percorrevano rapidi i cieli e prendevano al volo gli insetti. Sugli alberi, primitivi antenati dei pappagalli manovravano tra i rami, cui si afferravano con piedi specializzati. Lungo le coste, alcuni de! primi ibis affondavano il becco curvo nel fango, in cerca di invertebrati. Al tempo stesso iniziò l'evoluzione degli uccelli notturni, con la comparsa dei parenti fossili dell'attuale guaciaro, ghiotto di frutti, del nictibio, che si mimetizza per tendere agguati agli insetti, e dei podargidi, predatori dal becco largo i cui discendenti moderni si nutrono di rane.
Ma gli uccelli raggiunsero anche dimensioni mostruose tipiche dei loro antenati dinosaureschi. Nell'Eocene nacque infatti una specie africana antenata dei futuri Aepyornithidae del Neozoico, conosciuti con il nome di Uccelli Elefante, e nei pascoli dell'America Settentrionale viveva un uccello ingranditosi tanto da diventare inetto al volo: era il Diatrima (Diatryma gigantea), alto tre metri, dagli arti massicci dotati di tre dita, con una testa lunga quaranta centimetri e un possente becco uncinato. Per i mammiferi di quell'epoca i diatrimidi dovevano costituire un pericolo mortale, ma non erano nemmeno i più temibili. Infatti nelle pianure del Sudamerica era possibile veder correre un mostro come quello rappresentato qui sotto, il Fororaco (Phororachos inflatus): un uccello che aveva perso le ali per diventare un formidabile cacciatore alto due metri e mezzo e tale da superare in peso un cavallo purosangue! I fororacidi sono un caso in cui la storia si è ripetuta: come i dinosauri che li avevano preceduti nel Cretacico, erano bipedi e ovipari, avevano teste enormi ed erano macchine per uccidere. Gli unici parenti viventi di questi megauccelli sono due specie di cariamidi, uccelli carnivori che oggi arrivano solo a una novantina di centimetri di altezza, ma riescono comunque a terrorizzare roditori e piccoli rettili con il becco e gli artigli aguzzi.
 |
|
Phororachos inflatus, gigantesco uccello dell'Eocene (disegno dell'autore) |
Nell'ultima fase dell'Eocene apparve l'antenato di tutti i proboscidati, il meriterio, delle dimensioni di un maiale, e con il muso allungato in un accenno di proboscide. Gli equini discendono invece dall'Iracoterio, che aveva appena le dimensioni di un fox terrier ed era dotato di quattro dita alle zampe anteriori e tre in quelle posteriori, non ancora fuse in uno zoccolo. Quanto all'Andrewsarco, era un canide che al contrario raggiungeva i quattro metri, dato che il suo cranio fossile misurava un metro da solo. Che strana epoca: cavalli nani e cani giganti... Tra gli ungulati invece il più grosso era l'Uintaterio, che aveva suppergiù le dimensioni di un rinoceronte africano. La forma del cranio era la caratteristica più sorprendente della sua specie: si schiacciava verso il muso e portava ben tre paia di corna ossee, ricoperte di pelle. Ma dalla forma dei denti si deduce che era erbivoro: le corna dovevano servirgli per difendersi dai predatori e per le lotte tra maschi. Esso si estinse senza lasciare discendenti.
La lucertola rockettara
È degna di nota in questo ipertesto l'intitolazione a Jim Morrison, leader dei Doors, di una lucertola estinta vissuta in Asia durante l'Eocene medio-superiore, tra 40 e 36 milioni di anni fa (dalle 18.00.59 del 28 alle 01.55.12 del 29 dicembre), i cui resti fossili sono stati rinvenuti in Birmania negli anni Settanta e pressoché dimenticati in una collezione del museo di paleontologia dell'Università della California. Si trattava di un animale di notevoli dimensioni: lungo 180 centimetri, il suo peso è stato stimato in oltre 27 chili, paragonabile all'attuale varano di Komodo. Tuttavia, a differenza del varano era probabilmente vegetariana. Il curioso fossile è stato battezzato Barbaturex morrisoni, proprio in onore di Jim Morrison, “poeta maledetto” del secolo scorso che era chiamato « Re lucertola » per via di un verso della sua canzone "Celebration of the Lizard": « I am the Lizard King, I can do anything! ». Il capo della squadra di ricercatori, Jason Head dell'Università di Nebraska-Lincoln, scomparso nel 1971 a soli 27 anni, era un grande fan di Morrison fin dai tempi del college. Barbaturex, invece, significa "Re barbuto", a causa di alcune impronte sotto la mascella che fanno pensare che l'animale avesse una sorta di barba... proprio come alcune star della musica Rock!
Gli uccelli topo
La maggior parte di noi non ha mai visto un uccello topo. Sono piccoli uccelli sociali che strisciano furtivi tra la vegetazione alla maniera, appunto, dei topi, talvolta appendendosi a testa in giù grazie alle abili dita prensili delle zampe. Sono ignoti a gran parte di noi perché le sei specie oggi viventi si trovano solo nell'Africa subsahariana. Si potrebbe dunque pensare che abbiano sempre avuto soltanto un ruolo secondario nella storia dell'evoluzione degli uccelli; ma non è così. La documentazione fossile mostra che nel corso dell'Eocene e del successivo Oligocene gli uccelli topo sono andati incontro a un'affascinante diversificazione, che ha dato origine a un caleidoscopio di forme di ogni tipo.
Fra le specie che prosperarono in Europa e nel Nord America durante l'" età dell'oro" degli uccelli topo vi erano i Chascacocolius cacirostris dal becco affilato, specializzati nell'aprire a forza cortecce e frutti duri, i Celerricolius acriala, dalle ali allungate, che molto probabilmente davano la caccia agli insetti, e Oligocolius psittacocephalon, dal capo simile a quello dei pappagalli, che conosciamo grazie alla scoperta di uno scheletro pieno di semi. Tutte queste forme erano però ormai svanite già 25 milioni di anni fa, torse sconfitte dallo scatenato successo dei passeracei. E oggi rappresentano soltanto un notevole esempio delle tante ramificazioni dell'evoluzione cui ha poi fatto seguito un collasso della diversità.
Di recente è stata anche trovata la prova che gli antenati delle balene vissuti nell'Eocene tornavano a terra per partorire, come oggi continuano a fare le foche, grazie a una scoperta eccezionale e finora unica al mondo: il ritrovamento di un antenato fossile dei Cetacei, una femmina di 2,6 metri di lunghezza, con un feto quasi a termine all'interno del corpo. La scoperta è avvenuta in Pakistan e la notizia è stata pubblicata sulla già citata PLoS One, che vi consiglio di visitare. Il fossile è stato battezzato Maiacetus inuus: il nome del genere significa "balena madre", e quello della specie deriva dalla dea romana della fertilità, Inuus. Maiacetus inuus era un Archeoceto, un lontanissimo parente delle balene di oggi. Viveva nell'Eocene e aveva le caratteristiche di un animale adattato a una vita semiacquatica: aveva quattro zampe con piedi trasformati in lunghe pinne per nuotare. Gli arti tuttavia non erano ancora vere e proprie pinne, e non aveva ancora la pinna caudale. Questi arti gli permettevano di risalire e di arrancare un po' in terraferma, anche se probabilmente non poteva spingersi troppo lontano dalla riva. Non lontano dallo scheletro della femmina gravida sono stati scoperti i resti di un Maiacetus inuus maschio: le dimensioni sono leggermente superiori a quelle della femmina e anche i denti sono del 20 % più grandi. Queste differenze esistono anche nei Cetacei attuali.
Giuseppe Notarbartolo di Sciara, esperto di Cetacei dell'Istituto Tethys, ha spiegato: « Conosciamo così poco sulla storia evolutiva dei Cetacei, che la scoperta di un fossile di cetaceo con il feto è straordinaria, unica. La nascita è un momento drammatico nella vita dei Cetacei attuali, perché partoriscono nell'acqua un piccolo che respira aria. È stato un giro di boa importante nella loro evoluzione. Questa scoperta è come una finestra aperta su uno stadio intermedio delle modalità di riproduzione ». Il piccolo feto fossile ha la testa rivolta verso il basso, verso il canale del parto, come i mammiferi terrestri poco prima della nascita. I Cetacei attuali invece nascono nell'acqua: il feto si presenta dunque con la coda verso il basso, pronta a uscire per prima dal corpo della madre. Le femmine ritornavano dunque a terra per partorire. Una scoperta veramente eccezionale, che apre nuovi orizzonti su un passato finora misterioso.
I primi gatti
All'Eocene risale probabilmente anche la comparsa degli antenati del gatto moderno. Circa quaranta milioni di anni fa (alle 18 del 28 dicembre) viveva un piccolo animale simile all'attuale donnola, il Miacis hargeris, uno dei più antichi e primitivi tra tutti i carnivori, descritto da Wortman nel 1901. Possedeva ancora caratteristiche arcaiche come un cranio basso e lungo, un corpo piuttosto snello, zampe corte e denti capaci di afferrare e dilaniare la carne, ma anche caratteristiche più moderne: la pelvi era simile a quella dei canidi e le vertebre erano specializzate; inoltre gli artigli erano retrattili e aveva una visione binoculare, fondamentale per la caccia e la vita arborea. Aveva inoltre un cervello più sviluppato di quello dei suoi antenati; è possibile che l'aumentata intelligenza fosse stato un fattore determinante nello sviluppo dei Miacidi, che diedero origine alle varie famiglie di carnivori attuali. Probabilmente Miacis era adatto a vivere sugli alberi, come molti altri carnivori primitivi; predava piccoli animali e forse si cibava anche di uova e frutta. Dai Miacidi derivano i caniformi (orsi, cani, procioni e donnole) ed i feliniformi (gatti, iene, zibetti e manguste). Ben presto quest'ultimo ramo si suddivise in due gruppi ben distinti. Il primo gruppo, ormai estinto da tempo, fu quello dei felidi dai denti di sciabola, che diede origine a creature di grossa mole, con lunghissimi canini. Uno degli appartenenti a questo gruppo fu Smilodon, la feroce tigre dai denti di sciabola estintasi appena 15.000 anni fa (alle 23.58.15 di San Silvestro): è probabile che questo grande predatore fosse il più spietato antagonista dell'uomo primitivo e, forse, il suo ricordo ha ispirato negli antichi Germani il culto del gatto selvatico, l'animale di Freya. Il secondo gruppo, invece, diede origine ai gatti moderni. Non si è trovata nelle caverne dell'uomo preistorico alcuna traccia fossile di questo animale, il che dimostrerebbe che gatto e uomo hanno condotto vite separate fino agli albori della civiltà, fino a quando, cioè, non nacque la necessità di cacciare le faine, i topi ed altri animali che minacciavano il surplus della produzione umana.
I primi cavalli
E che dire dell'evoluzione dei primi cavalli? Secondo alcuni paleontologi dell'Università della Florida e di quella del Nebraska, essa è la chiave per comprendere la correlazione tra le dimensioni corporee dei mammiferi e la temperatura ambientale; in particolare, sembra che l'aumento della temperatura sia correlato a una diminuzione delle dimensioni del corpo. « In origine, i cavalli erano piccoli, all'incirca delle dimensioni degli attuali cani di media taglia », ha spiegato Jonathan Bloch, curatore della sezione di Paleontologia dei Vertebrati del Florida Museum of Natural History. « Ciò che più sorprende è il fatto che dopo la loro prima apparizione subirono dapprima un'ulteriore riduzione nelle dimensioni anatomiche per poi ricrescere, in corrispondenza con un primo evento di riscaldamento globale seguito da un raffreddamento. È ben noto che in quel periodo tutti i mammiferi erano di piccole dimensioni, ma finora non era ben compreso che fu proprio la temperatura a determinare l'evoluzione delle dimensioni del corpo ».
Sifrhippus sandrae, vissuto circa 55 milioni di anni fa (alle 12.56 del 27 dicembre), è il primo antenato conosciuto dei cavalli moderni, ed è anche uno tra i più piccoli, nella famiglia degli equidi. I suoi fossili risalgono al cosiddetto massimo termico del Paleocene-Eocene, un evento climatico durato 175.000 anni (circa 20 minuti e mezzo), durante il quale l'incremento delle concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera e negli oceani determinò un incremento delle temperature globali medie di 10-20 gradi. Grazie all'analisi delle dimensioni dei fossili ritrovati nel bacino di Bihorn, nel Wyoming, i ricercatori hanno tracciato l'evoluzione del Sifrhippus da un peso stimato di circa 5,5 chilogrammi fino a meno di 4 chilogrammi nell'arco di 130.000 anni (poco più di un quarto d'ora), registrando poi un incremento avvenuto nei successivi 45.000 anni (5 minuti e 15 secondi) di circa 7 chilogrammi. « Abbiamo le registrazioni fossili di questo tipo più precise del mondo, che mostrano come cambiò il clima in quel periodo nel Wyoming », ha dichiarato Ross Secord, che ha effettuato le analisi geochimiche sui denti fossili dei cavalli e di altri mammiferi. « Quando abbiamo iniziato a ottenere i dati riguardanti l'ossigeno dallo spettrometro di massa, ci siamo subito resi conto che le variazioni nelle dimensioni dei cavalli e quelle della temperatura erano speculari le une alle altre. » I ricercatori hanno analizzato anche le possibili correlazioni con l'aridità e con i livelli di anidride carbonica, rilevando però che il fattore più influente per le variazioni delle dimensioni corporee dell'antenato del cavallo era proprio la temperatura. « Sebbene si sappia ancora molto poco su come questi animali siano arrivati nel Nord America in quel periodo, il massimo termico del Paleocene-Eocene è un evento geologico significativo per la storia dei mammiferi », ha concluso Bloch.
Tra l'altro, uno studio delle impronte e delle ossa di esemplari viventi e fossili compiuto nel 2023 da un team internazionale di esperti coordinato dall'Università di Bristol nel Regno Unito ha permesso di appurare in via definitiva che gli antenati dei cavalli moderni avevano le dita al posto degli zoccoli, ma nel corso dell'evoluzione le hanno perse. Lo studio ha ricostruito l'evoluzione delle zampe a partire da animali antichissimi come l'iracoterio (Hyracotherium leporinum), un lontano antenato del cavallo vissuto 52 milioni di anni fa (alle 18.46 del 27 dicembre). Era lungo in media 60 centimetri e alto circa 20 centimetri al garrese, più o meno come un cane e come i moderni tapiri; il suo peso doveva aggirarsi intorno ai 20 chilogrammi. Si suppone che l'iracoterio fosse un erbivoro brucatore, che si cibava principalmente di foglie, frutti e noci. Il primo fossile di questo genere fu ritrovato nei dirupi di Studd Hill, nei pressi di Herne Bay (Kent, Inghilterra), e venne descritto dal paleontologo Richard Owen (1804-1892) il 18 dicembre 1839. Esso era dotato di quattro dita nelle zampe anteriori e tre in quelle posteriori, ciascuna delle quali provvista di unghia, oltre ad un cuscinetto plantare a contatto con il suolo. « Nei fossili di cavalli successivi c'erano solo tre dita, sia nelle zampe anteriori che in quelle posteriori », ha affermato la coordinatrice dello studio, Christine Janis. « Le dita extra, note come dita laterali, erano più piccole e corte che nel tapiro, ed è probabile che non toccassero il terreno in condizioni normali, ma che servissero a dare supporto in situazioni eccezionali, come in caso di scivolate o impatti violenti. » Nei cavalli moderni, così come negli asini e nelle zebre, è rimasto solo il residuo del terzo dito nascosto nello zoccolo, con una struttura triangolare sottostante (il fettone) che agisce come un ammortizzatore.
Un curiosità: nei testi scolastici e nei libri divulgativi, l'iracoterio viene spesso descritto come « un animale della taglia di un piccolo fox terrier », fatto che evidentemente non corrisponde a verità. Questa analogia, ripetuta più volte, è stata ritenuta così sospetta che il famoso divulgatore Stephen Jay Gould (1941-2002) ha scritto un saggio intitolato "The Case of the Creeping Fox Terrier Clone" ("Il caso dell'inquietante clone di Fox Terrier"), nel quale discute il problema del plagio nei libri di testo.
I rettili artici
Alcuni ricercatori dell'Università del Colorado a Boulder hanno di recente scoperto che circa 50 milioni di anni fa (alle 22.40 del 27 dicembre) gli antenati dei nostri alligatori e delle tartarughe giganti potevano sopravvivere nell'isola di Ellesmere, la più settentrionale dell'Arcipelago Artico Canadese, sopportando ben sei mesi di oscurità all'anno. Essi hanno analizzato le abbondanze relative degli isotopi presenti nei fossili di ossa e di denti di mammiferi, pesci e tartarughe che vivevano sull'isola, allo scopo di stimare la temperatura media nel corso del primo Eocene, tra 53 e 52 milioni di anni fa (tra le 16.49 e le 18.46 del 27/12). Il risultato è stato che le temperature medie del mese più caldo sull'isola di Ellesmere erano comprese tra 19° e 20° C, mentre nel mese più freddo tra 0° e 3° C.
« I nostri dati sembrano indicare che su quest'isola non si scendeva spesso oltre il punto di solidificazione dell'acqua », ha spiegato Jaelyn Eberle, del dipartimento di scienze geologiche dell'UCB. « Si tratta del più esteso e approfondito insieme di dati paleoclimatici relativi a questa regione mai raccolti finora, e certamente spiegano perché gli alligatori e le tartarughe giganti potessero vivere sull'Isola di Ellesmere ». Insomma, durante l'Eocene l'Isola di Ellesmere era simile alle foreste di cupressacee che oggi ricoprono il Sudest degli Stati Uniti. Le prove fossili raccolte negli ultimi decenni da vari ricerche indicano che questo lussureggiante territorio ospitava testuggini giganti, tartarughe acquatiche, grandi serpenti, alligatori, lemuri volanti, tapiri e mammiferi simili a equini e rinoceronti. Questa conclusione è ritenuta assai importante per stimare il futuro dell'ambiente artico nella prospettiva di un aumento globale delle temperature.
E dall'altra parte del pianeta? Per gran parte dell'Eocene l'Antartide era priva di ghiacci e coperta di foreste, con una vegetazione rigogliosa. e una mite temperatura estiva che sulla costa oscillava tra i 20° e i 25°. A rivelare l'inedito volto del Sesto Continente è stato l'Istituto Governativo di Scienze Geologiche e Nucleari (GNS Science) della Nuova Zelanda. Un team di scienziati di tale Istituto ha studiato pollini e micro-fossili prelevati attraverso il trivellamento sotto il fondo marino, nei pressi di Wilkes Land, al largo delle coste dell'Antartide, arrivando alla scoperta della presenza di foreste pluviali tropicali e subtropicali nella regione costiera. Ciò dimostra che l'Eocene è stato il più caldo delle intere ere Cenozoica e Neozoica. Allora infatti la concentrazione di gas serra come la CO2 nell'atmosfera terrestre era più del doppio di quella attuale. « Lo studio dei periodi caldi nel passato geologico del nostro pianeta » ha spiegato Ian Raine, micro-paleontologo del GNS Science, « contribuisce a migliorare la nostra conoscenza del riscaldamento globale indotto dall'uomo, dimostrando come ecosistemi come quello antartico hanno risposto in passato ad alte concentrazioni di CO2 in atmosfera. » Tuttavia, da sola la CO2 non può spiegare l'antico clima tropicale dell'Antartide, al quale devono aver contribuito le calde correnti oceaniche che raggiungono l'Antartide trasferendo calore sul continente. Quando la corrente oceanica calda è venuta meno e la costa antartica è passata sotto l'influenza di quelle più fredde, le foreste pluviali tropicali e i lussureggianti palmeti costieri sono scomparsi, e circa 38 milioni di anni fa (alle 22 in punto del 28/12) hanno cominciato a formarsi i ghiacci antartici, che oggi rappresentano più di due terzi dell'acqua dolce della Terra; la Penisola Antartica, che si protende più a nord rispetto al resto del continente, è stata l'ultima ad esserne ricoperta. Ed è anche la parte del continente antartico che ha sperimentato il maggiore riscaldamento negli ultimi decenni: la sua temperatura media annua è aumentata fino a sei volte più velocemente delle temperature medie annuali globali. Ne riparleremo più avanti.
Antenato comune tra uomo e scimmia, o capostipite dei lemuri?
Il 19 maggio 2009 Philip Gingerich, presidente della Paleontological Society, ha presentato all'American Museum of Natural History di New York il fossile appena scoperto di un animale che potrebbe essere il progenitore comune delle scimmie e dell'uomo. Il « completo e spettacolare fossile del possibile antenato », come lo ha definito Gingerich, mostra un primate vissuto 47 milioni di anni fa, ed è stato portato alla luce a Messel Shale Pit, una cava abbandonata vicino a Francoforte. Si tratta del primo scheletro intero mai ritrovato di una nuova specie battezzata Darwinius masillae. Tale specie appartiene alla famiglia degli Adapidi, primati primitivi vissuti fra Eocene ed Oligocene in Eurasia, Africa e Nordamerica, il cui peso si aggirava sul chilogrammo, con piccole orbite oculari che fanno pensare ad animali diurni, musi allungati con una dentatura tipica di animali erbivori ed ossa postcraniali che fanno pensare ad animali arboricoli camminatori piuttosto che saltatori.
Il fossile è quello di una giovane femmina, soprannominata Ida, che somigliava probabilmente a un lemure dei giorni nostri, il mammifero dalla lunga coda che vive in Madagascar: Ida è considerato il fossile di antico primate più completo mai ritrovato. Ma il suo corpo, delle dimensioni di quello di una marmotta, aveva caratteristiche che si riscontrano persino nella specie umana, tra cui il pollice opponibile, le unghie al posto degli artigli e, nelle zampe posteriori, elementi che lasciano intravedere il passaggio dall'andatura a quattro zampe alla camminata eretta. Secondo Jorn Hurum dell'università di Oslo, che ha guidato lo studio, Ida è per i paleontologi « quello che l'arca perduta è per un archeologo », e addirittura « la stele di Rosetta dell'evoluzione » e « l'ottava meraviglia dal mondo ». Preso dall'entusiasmo, lo scienziato si è spinto ad affermare che « il fossile è così importante che sarà riprodotto sui libri di testo per i prossimi cento anni ». Molto più di un semplice fossile, intorno al quale la comunità scientifica aveva creato un clima di forte aspettativa, ma certamente il più completo fossile di primate mai trovato.
 La
località tedesca è nota per i suoi ritrovamenti di fossili ben conservati appartenenti all'Eocene,
ma questo ha destato subito sorpresa e interesse. Infatti gli antropologi si chiedono da tempo da quale dei due gruppi di proscimmie esistenti circa 50 milioni di anni fa, i
tarsidi che vivevano in Asia e gli adapidi presenti nell'America settentrionale e in Europa, allora unite,
sia partita la linea evolutiva che poi ha portato all'uomo. Ebbene, le caratteristiche del reperto tedesco farebbero pensare che proprio gli Adapidi, ritenuti anche i precursori degli attuali lemuri del Madagascar, siano gli
antenati più probabili comuni ai primati superiori e all'uomo. Uno degli aspetti a favore delle conclusioni, pubblicate sulla
già citata Public Library of
Science, è la mancanza dei denti a pettine. «
L'epoca di appartenenza, la regione del ritrovamento e la presenza di qualche carattere evolutivo diverso dalle proscimmie sembrano gli elementi di maggiore interesse »,
ha commenta Fiorenzo Facchini, antropologo dell'Università di Bologna. « È infatti possibile che questi particolari elementi si ritrovino specializzati, molto tempo dopo, in linee evolutive diverse. Bisogna comunque tener conto che passeranno milioni di anni per vedere tra le scimmie i progenitori degli ominidi come il
Proconsul o il Kenyapiteco. Infatti la separazione fra le antropomorfe e quella degli ominidi è avvenuta soltanto
sei milioni di anni fa, alla fine del Miocene. »
La
località tedesca è nota per i suoi ritrovamenti di fossili ben conservati appartenenti all'Eocene,
ma questo ha destato subito sorpresa e interesse. Infatti gli antropologi si chiedono da tempo da quale dei due gruppi di proscimmie esistenti circa 50 milioni di anni fa, i
tarsidi che vivevano in Asia e gli adapidi presenti nell'America settentrionale e in Europa, allora unite,
sia partita la linea evolutiva che poi ha portato all'uomo. Ebbene, le caratteristiche del reperto tedesco farebbero pensare che proprio gli Adapidi, ritenuti anche i precursori degli attuali lemuri del Madagascar, siano gli
antenati più probabili comuni ai primati superiori e all'uomo. Uno degli aspetti a favore delle conclusioni, pubblicate sulla
già citata Public Library of
Science, è la mancanza dei denti a pettine. «
L'epoca di appartenenza, la regione del ritrovamento e la presenza di qualche carattere evolutivo diverso dalle proscimmie sembrano gli elementi di maggiore interesse »,
ha commenta Fiorenzo Facchini, antropologo dell'Università di Bologna. « È infatti possibile che questi particolari elementi si ritrovino specializzati, molto tempo dopo, in linee evolutive diverse. Bisogna comunque tener conto che passeranno milioni di anni per vedere tra le scimmie i progenitori degli ominidi come il
Proconsul o il Kenyapiteco. Infatti la separazione fra le antropomorfe e quella degli ominidi è avvenuta soltanto
sei milioni di anni fa, alla fine del Miocene. »
Ma c'è chi non condivide tanto entusiasmo. Ad esempio, secondo un gruppo di paleontologi della Stony Brook University di New York, Ida non sarebbe affatto il tanto ricercato anello mancante tra l'uomo e gli altri primati, né tantomeno « la stele di Rosetta dell'evoluzione ». Quel fossile tanto decantato non apparterrebbe a un antenato degli ominidi, bensì dei lemuri. Gli esperti statunitensi sono giunti alle loro conclusioni dopo aver confrontato le immagini esistenti di Ida con quelle di un altro fossile, Afradapis longicristatus, scoperto in Egitto e antico di 37 milioni di anni, e dopo aver incrociato attraverso sofisticati modelli matematici i dati relativi ai due fossili con le caratteristiche di altre 117 specie di primati, sia esistenti che estinte. Il risultato dell'analisi colloca Ida in un gruppo di fossili chiamati Adapiformi, tradizionalmente considerati più vicini a piccoli mammiferi come i lemuri e i lori che ai moderni primati superiori.
Come c'era da aspettarsi, l'articolo ha subito scatenato il dibattito: infatti i paleontologi norvegesi, fra i primi sostenitori della presenza di Ida ala radice dell'albero evolutivo che condusse all'uomo, contestano l'analisi dei colleghi d'oltre Atlantico, sostenendo che essa è basata solo sul confronto digitale tra le immagini; in realtà il fossile non sarebbe cosi "schiacciato" come apparirebbe nelle fotografie, e l'analisi dei resti originali consentirebbe di ricavare molte più prove a sostegno della loro tesi. Gli scandinavi sono poi in disaccordo con gli statunitensi anche per quanto riguarda la ricostruzione dell'album di famiglia dei primati, perchè secondo loro gli Adapiformi avrebbero molte caratteristiche comuni con i nostri antenati, e non solo con quelle di lemuri e tarsi. In ogni caso, al momento attuale la collocazione di Ida nell'albero genealogico dei nostri antenati non è affatto certa, e più d'uno pensa che i dibattiti attorno ad essa sono destinati a non spegnersi tanto presto.
Alle... sogliole dell'Eocene
Facciamo un cenno agli Pleuronettiformi, i cosiddetti pesci piatti come la sogliola, che hanno entrambi gli occhi su uno stesso lato del corpo. Con le loro teste asimmetriche e un piano del corpo che è certamente il più inusuale tra tutti i vertebrati, questi pesci rappresentano a tutti gli effetti un vero enigma evolutivo. Questa loro bizzarra anatomia è stata uno degli argomenti usati dagli oppositori di Charles Darwin e della sua teoria della selezione naturale: gli scettici mettevano in dubbio che queste caratteristiche insolite avessero potuto evolversi lentamente, garantendo durante la fase di transizione un vantaggio ai fini della sopravvivenza dei pesci. Però Matt Friedman dell'Università di Oxford nel 2012 nel sito di Bolca, sui Monti Lessini in provincia di Verona, ha scoperto dei fossili che permettono di risolvere il mistero: i Monti Lessini sono conosciuti come una delle località paleontologiche più conosciute al mondo per ricchezza, diversità ed eccezionale stato di conservazione dei suoi fossili, soprattutto pesci, che documentano la presenza di un antico mare tropicale poco profondo associato a barriere coralline di circa 50 milioni di anni fa, in pieno Eocene. Proprio per la loro importanza paleontologica, i giacimenti fossiliferi di Bolca, insieme ad altre località paleontologiche della Val d'Alpone, sono stati recentemente inseriti nella lista dei siti italiani candidati a diventare patrimonio Unesco.
Si tratta di esemplari di un pesce fossile battezzato Heteronectes, trovato in rocce di origine marina risalenti a 50 milioni anni fa (alle 22.40 del 27 dicembre), nei quali l'occhio migrato non ha ancora attraversato la linea di demarcazione fra i due lati della testa. Con la sua forma già appiattita, Heteronectes mostra la perfetta fase intermedia tra i pesci con un occhio su ciascun lato della testa e gli Pleuronettiformi specializzati, in cui entrambi gli occhi sono sullo stesso lato. « Questo fossile proviene da un sito che è stato scavato letteralmente per centinaia di anni per i suoi pesci fossili, e che fornisce una panoramica straordinaria della formazione di una antica barriera corallina », ha dichiarato Friedman. « I reef sono ben noti come punti caldi della biodiversità; non è quindi così sorprendente che sia stato il sito di Bolca a fornirci la prima prova di molti gruppi di pesci moderni. La nostra conoscenza dei rapporti fra alcuni di questi gruppi è in continua evoluzione grazie al numero sempre maggiore di studi di genetica molecolare. Gli esemplari come Heteronectes rivelano il massimo livello di dettaglio che si possa ottenere dalla specie estinte. »
Non possiamo non citare qui anche la scoperta di un pesce fossile ad opera di un team italoaustriaco guidato dai paleontologi Giuseppe Marramà e Giorgio Carnevale, rispettivamente ricercatore e professore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino. Perchè è così importante? Perchè è ritenuto uno dei famosi "anelli mancanti" dell'evoluzione. Il fossile, che ha anch'esso circa 50 milioni di anni, è stato battezzato Dasyomyliobatis thomyorkei, nome con cui i ricercatori hanno voluto omaggiare niente popò di meno che il cantante britannico Thom Yorke (1968-), frontman dei "Radiohead", gruppo rock alternativo britannico formatosi nel 1985 (anche se fino al 1992 erano noti come "On a Friday"). Il fossile è stato portato alla luce nel dicembre 2020 sempre nel giacimento di Bolca nei Monti Lessini, durante gli scavi condotti dal Museo di Civico di Storia Naturale di Verona. Lo studio risolve un dibattito decennale della paleontologia: come e quando si è evoluta la durofagia e lo stile di vita pelagico nelle razze? Ricordiamo che la durofagia è l'abitudine di nutrirsi di organismi dal guscio duro o dotati di esoscheletro, come coralli, molluschi o granchi: è un termine usato principalmente per descrivere i pesci, ma viene anche usato per rifrirsi ai rettili, agli invertebrati e ai mammiferi carnivori "che triturano le ossa", come le iene. La durofagia richiede naturalmente adattamenti speciali, come denti forti e smussati e mascelle robuste. Lo studio del nuovo fossile che porta il nome del cantante dei "Radiohead" ha permesso di ricostruirne non solo l'aspetto, la dieta e il modo di vita, ma anche di appurare come questa nuova specie di razza miliobatiforme rappresenti una forma di transizione tra le specie attuali più primitive che si nutrono di prede dal corpo molle e vivono principalmente nei fondali, e quelle più evolute che si nutrono di prede dal guscio duro e vivono in mare aperto.
Perché in autunno l'America è rossa e l'Europa è gialla?
L'autunno trasforma ogni anno i boschi verdi in un magnifico caleidoscopio di tonalità calde, dall'oro al bronzo, ma si può osservare che gli alberi si comportano in maniera incredibilmente diversa a seconda del continente e della latitudine: in Europa le foglie assumono prevalentemente tinte gialle, mentre negli Stati Uniti e nell'Asia orientale si colorano di rosso. Perché queste differenze? I carotenoidi, pigmenti gialli, arancio e marroni, sono già presenti nelle foglie anche in primavera ed estate, ma diventano visibili solo quando le giornate si accorciano e la produzione di clorofilla verde (che richiede la luce e il calore del sole) rallenta fino a fermarsi. Invece i pigmenti rossi, le antocianine, non esistono nella foglia, ma sono prodotti all'arrivo dell'autunno. Ma perché gli alberi investono risorse per produrre il pigmento rosso nelle foglie, se poi sono destinate a cadere? Si pensa ad una lunga lotta evolutiva tra le piante e gli afidi, insettini che succhiano la linfa, i quali sarebbero attratti dal colore giallo e starebbero alla larga dal rosso. Ciò però spiega la colorazione rossa, ma non quella gialla.
Per spiegare le differenze cromatiche suddette il professor Simcha Lev-Yadun, del Dipartimento di Scienza e Biologia dell'università di Haifa in Israele, e Jarmo Holopainen dell'ateneo di Kuopio in Finlandia hanno pubblicato su New Phytologist una teoria che chiama in causa i cambiamenti climatici, l'orografia e le grandi migrazioni che sconvolsero la Terra 35 milioni di anni fa, quindi proprio alla fine dell'Eocene. Ampie zone della Terra erano allora coperte da una giungla sempreverde, ma nei millenni si alternarono glaciazioni e periodi asciutti, tanto che molti alberi subirono si evolsero e diventarono a foglie caduche; in seguito svilupparono il processo di produzione del pigmento rosso per respingere gli insetti. In Nordamerica così come nell'Asia orientale, le catene montuose che si sviluppano in direzione nord-sud permettevano la migrazione delle piante e degli animali dalle basse alle alte latitudini, a seconda dell'avanzamento o del ritiro dei ghiacciai; ed insieme a loro si spostavano anche gli insetti parassiti, cosicché la guerra per la sopravvivenza è continuata senza interruzioni. In Europa, invece, le montagne tra cui le Alpi si sviluppano in direzione est-ovest, come chiunque può osservare su una carta geografica, erigendo così una barriera contro le migrazioni. Molte specie di alberi non sopravvissero ai periodi di freddo glaciale, e con esse morirono anche gli insetti che dipendevano da loro. Ma quelle che riuscirono a superare le glaciazione si trovarono avvantaggiate: la lotta era finita con l'estinzione di molti insetti a loro avverse e quindi, non avevano più bisogno di difendersi spendendo una gran quantità di preziosa energia per produrre il pigmento rosso.
Uno degli indizi a favore della teoria, secondo Lev-Yadun ed Holopainen, si trova negli arbusti nani che crescono in Scandinavia, le cui foglie in autunno si tingono di colori purpurei. A differenza degli alberi, queste piccole piante sono sopravvissute alle ere glaciali sotto uno strato di neve che le ha protette dalle temperature più rigide. La neve però ha salvato dall'estinzione anche gli insetti, perciò per questi arbusti la battaglia è continuata, e la strategia della pigmentazione rossa non poteva essere abbandonata. Sicuramente una teoria affascinante e convincente.
Tra l'altro, risale proprio all'Eocene il fossile di un fiore scoperto nel 2010 nella Patagonia argentina, in un'area rocciosa lungo il fiume Pichileufù, non lontano dalla città di Bariloche in Patagonia. Esso fa pensare che girasoli, crisantemi, margherite e altri fiori della famiglia delle asteracee siano apparsi quasi 50 milioni di anni fa nei territori di quello che è oggi il Sudamerica. La scoperta è dovuta a Rodolfo Corsolini, direttore del Museo del Lago Gutiérrez ed ha già aperto la strada a diverse teorie, anche perchè sono state poche le scoperte fatte finora di fossili di tali piante, sulla cui evoluzione si sa ben poco.
Ad ogni modo, è certo che alla fine dell'Eocene il clima subì un rapido raffreddamento, e la notevole riduzione delle temperature causò la formazione di grandi ghiacciai nel continente Antartico, cui seguì un notevole abbassamento del livello dei mari e la conseguente estinzione di molte forme di vita marina. I mammiferi che vivevano sulla terraferma, invece, non risentirono di questo cambiamento climatico, e non furono coinvolti nell'estinzione.
![]()
Dal greco "poco recente", sta a significare un'evoluzione della vita un po' meno primitiva rispetto a quella precedente. Va da 34 a 23 milioni di anni fa; in termini di Anno della Terra, va dalle ore 05.48 del 29/12 alle 03.13 del 30/12. La notte di San Silvestro si avvicina.
L'Oligocene è suddiviso in due periodi: Rupeliano e Chattiano.
L'Antartide e il Nilo mutano la faccia della Terra
L'Oligocene fu un'epoca di cambiamenti. Nel corso di esso si manifestarono in tutta la loro imponenza i giganteschi fenomeni orogenetici già iniziati nell'epoca precedente, che in Italia completarono il sollevamento delle Alpi e degli Appennini ed in Asia quello della catena Himalayana. Contemporaneamente, alla fine dell'Oligocene il livello dei mari raggiunse il livello più basso della storia della Terra, a causa del formarsi della grande calotta di ghiaccio al polo Sud. Il mare poco profondo che teneva separate Europa ed Africa scomparve, ed emersero dei veri e propri "ponti continentali" come quello che congiunse Asia ed America nel luogo dell'attuale stretto di Bering. Le migrazioni di animali si fecero intense, mentre la calotta ghiacciata cambiava il clima della Terra, e di conseguenza anche la sua vegetazione. Le dense foreste delle epoche precedenti lasciarono il posto a boschi più aperti con macchie di alberi e radure. Ne approfitto per far notare che tutto questo distrugge ogni speranza degli atlantologi e degli ufologi di ritrovare civiltà perdute sotto le calotte di ghiaccio dell'Antartide: esse si formarono infatti in un'epoca in cui nessuna civiltà ancora esisteva!!
Inoltre una ricerca italiana coordinata da Claudio Faccenna, dell'Università di Roma Tre e dell'Università del Texas ad Austin, con il contributo di Alessandro Forte, dell'Università della Florida, Eduardo Garzanti, dell'Università di Milano Bicocca, e Andrea Sembroni, dell'Università di Roma Tre, ha proposto che il grande fiume Nilo scorra da almeno 30 milioni di anni (dalle 13.36 del 29 dicembre), cioè fin dall'Oligocene. La datazione basata sullo studio delle rocce ha permesso loro di arretrare l'età del fiume sei volte più di quanto era stato calcolato finora dagli esperti. I ricercatori hanno associato il corso del fiume ai movimenti delle rocce del mantello della Terra, che si spostano come le correnti di un oceano: per ricostruire questi movimenti e la data di nascita del Nilo, hanno usato modelli al computer e analisi sul campo, sia sulle rocce vulcaniche degli altopiani dell'Etiopia, che dei sedimenti della foce del Nilo. Stando alla ricerca, se alle origini il suo corso non fosse stato incanalato verso Nord dai movimenti del mantello terrestre, il fiume avrebbe deviato verso Ovest, modificando forse anche il corso della storia. Tra l'altro oggi il Nilo (in antico egizio Iteru, "il Grande Fiume") è lungo 6.852 km, ma in passato addirittura il Lago Tanganica gettava le sue acque nel bacino idrografico del Nilo, e ciò continuò fino a quando i vulcani del Virunga non ne ostruirono il corso in Ruanda. All'epoca quindi le sorgenti del Nilo si dovevano spingere fin nel nord dello Zambia!!
Le due microplacche sarde
Grazie all’analisi paleomagnetica effettuata su campioni di roccia prelevati nel Sulcis e in altre località della Sardegna, un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre ha scoperto che l’isola è nata dall’unione di due microplacche tettoniche indipendenti tra loro, avvenuta tra 30 e 21 milioni di anni fa (tra le 13.36 del 29 e le 7.00 del 30 dicembre). « È noto, grazie a dati paleomagnetici ottenuti in Sardegna e in Corsica sin dagli anni ‘70 del secolo scorso, che il blocco tettonico Sardo-Corso si è staccato 21 milioni di anni fa dal margine europeo Provenzale-Catalano, raggiungendo la sua posizione attuale con una rotazione antioraria di 50°-60° », ha spiegato Fabio Speranza, Direttore della Sezione Roma2 dell’INGV e coautore dello studio. « Con questo lavoro abbiamo scoperto che la Sardegna sud-occidentale, e precisamente il territorio del Sulcis, ha subito una rotazione maggiore, di circa 90°. Non solo: alla luce delle nuove evidenze abbiamo rivalutato dati già noti relativi a rocce molto più antiche, risalenti all’intervallo compreso tra 300 e 150 milioni di anni fa (tra le 16.00 del 7 dicembre e le 20.00 del 19 dicembre), e abbiamo scoperto che la rotazione della porzione meridionale dell’isola risulta ancora più ampia, pari a circa 120°! » Mentre la parte settentrionale della Sardegna faceva parte di un unico blocco con la Corsica e la Provenza, la placca meridionale dell’isola apparteneva alla cosiddetta placca Iberica, separatasi dall’Europa tra 120 e 150 milioni di anni fa, durante l’apertura del Golfo di Biscaglia, con una prima rotazione antioraria di 30°. Con una seconda rotazione antioraria di 30° avvenuta tra 30 e 21 milioni di anni fa, la Sardegna meridionale si è saldata al resto del blocco Sardo-Corso lungo la cosiddetta faglia di Nuoro. Dopodichè, tra 21 e 15 milioni di anni fa (tra le 7.00 e le 18.48 del 30 dicembre), l’intera placca Sardo-Corsa si è staccata definitivamente dal margine europeo con una rotazione antioraria di 60° e ha raggiunto la sua posizione attuale.
I risultati ottenuti da questo lavoro suggeriscono che prima di 30 milioni di anni fa la placca Iberica fosse in realtà molto più grande di come è oggi (si parla di "Grande Iberia") perché era unita non soltanto alla Sardegna meridionale, ma anche alle Isole Baleari, al blocco Calabro-Peloritano, ai blocchi Kabili (Algeria settentrionale) e al blocco Alboran (che comprende Marocco e Andalusia). In seguito, a partire da 30 milioni di anni fa, la "Grande Iberia" è stata frammentata e le microplacche prodotte da questa frammentazione si sono disperse fino a raggiungere la loro posizione attuale. Questo lavoro ci ricorda che anche in un Paese come il nostro, in cui negli ultimi 50 anni sono stati effettuati moltissimi studi geofisici e paleomagnetici, ancora vi sono molti aspetti da comprendere sul processo di frammentazione e deriva delle microplacche che ha portato all’attuale assetto tettonico italiano. Tra i prossimi obiettivi del team c’è sicuramente quello di provare a determinare con maggiore precisione l’età della più antica rotazione antioraria di 30° della Sardegna meridionale, ad oggi compresa in un intervallo di tempo lunghissimo, tra 250 e 40 milioni di anni fa (tra le 17.20 dell'11 dicembre e le 18.01 del 28 dicembre): riuscire a datare meglio questo evento ci consentirebbe di approfondire ulteriormente le conoscenze sulla tettonica del nostro Paese.
Esplodono i mammiferi
Se l'Eocene era stata il regno degli uccelli, come già anticipato sopra nell'Oligocene si ebbe l'esplosione dei mammiferi, che soppiantarono i grandi predatori pennuti dei periodi precedenti. Ben presto essi manifestarono i consueti fenomeni di gigantismo: le praterie dell'Oligocene formicolavano di suini giganteschi, lunghi otto metri e alti cinque, di camelidi simili a giraffe (Calicoterii), di cervidi con parecchie corna, e addirittura di erbivori grossi il triplo di un elefante africano (Baluchiterii o "belve del Belucistan"): con i loro 8 metri di lunghezza e 5 di altezza, questi ultimi rappresentano certamente i più grandi mammiferi terrestri conosciuti. Esistevano anche cavalli con tre dita e delle dimensioni di un gatto (Eoippi) o di un vitello (Mesoippi), più evoluti degli Iracoterii. Dai goffi Barylambda discesero i primi Rinocerontidi, mentre il Brontops, lungo 6 metri ed alto due e mezzo al garrese, fu il primo rinoceronte vero e proprio. Un vero carrarmato vivente!
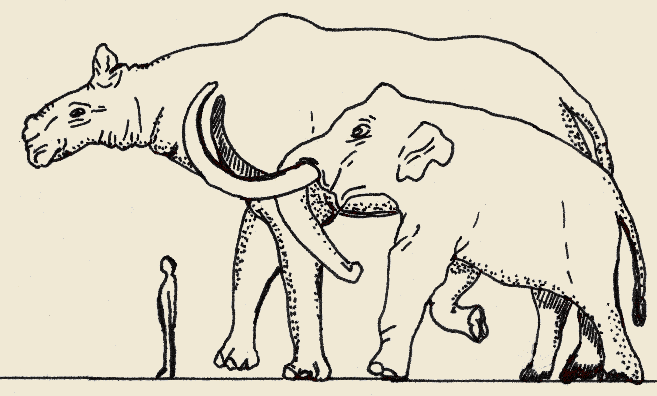 |
|
Il Baluchiterium, il più grande mammifero mai esistito, disegno dell'autore. Qui è confrontato con un Mastodonte suo contemporaneo e con un uomo attuale |
A questo proposito, occorre dire che negli anni novanta del XX ssecolo diverse spedizioni a caccia di fossili nel Cile settentrionale hanno portato alla scoperta di diversi siti che conservano centinaia di resti di mammiferi, oggi noti con il nome di Fauna di Chucal, tra cui almeno 18 specie di armadilli giganteschi, roditori e parenti di opossum, nonché un'ampia gamma di ungulati estinti. L'ultima grande scoperta in questi siti è avvenuta nel 2004, quando un gruppo di studiosi statunitensi e cileni ha ritrovato sulle Ande, a un'altitudine di circa 4000 metri, i resti lo scheletro parziale di una nuova specie di gliptodonte, un mammifero estinto dotato di una corazza rigida che poteva arrivare a pesare due tonnellate, e che potrebbe essere un antenato dell'attuale armadillo. Secondo quanto riferiscono sulla rivista "Journal of Vertebrate Paleontology", gli autori guidati da John Flynn, dell'American Museum of Natural History di New York, e Darin Croft, della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, l'animale, che è stato battezzato con l'interminabile nome di Parapropalaehoplophorus septentrionalis, pesava intorno agli 80 chilogrammi ed era probabilmente ricoperto da un massiccio scudo a placche fisse, a differenza di ciò che si riscontra nell'armadillo, in cui le placche hanno una certa mobilità. Le basse temperature, l'aria rarefatta e la mancanza di umidità hanno rappresentato condizioni difficili per il recupero, ma secondo i ricercatori non sono le stesse in cui viveva il gliptodonte. « I nostri studi in altri punti dell'altipiano suggeriscono che la regione si trovava a una altitudine inferiore all'epoca di questi animali », ha spiegato Flynn. « Oltre a fornirci uno sguardo sulla paleoecologia della regione, questi risultati ci danno nuove indicazioni sui tempi di sollevamento delle Ande. » Insieme con i fossili vegetali recuperati nella stessa area, ciò suggerisce che il Cile settentrionale presentasse un'ampia savana a circa 1000 metri di altitudine sul livello del mare, caratterizzata da un numero limitato di alberi e dominato da animali che brucavano l'erba.
Nell'Oligocene comparvero anche i Mastodonti ("con i denti a capezzolo"), antenati dell'elefante, come il Gonfoterio (Gomphotherium angustidens) qui sotto disegnato. Il suo nome significa "a forma di cuneo"; per capire il perchè, si osservi la foggia delle quattro zanne. Per forma e dimensioni questo mammifero alto anche tre metri non era troppo diverso dagli attuali elefanti ma, oltre alle zanne superiori, ne aveva altre due infisse nella mandibola, che probabilmente serviva per dragare i fiumi e i laghi alla ricerca di piante acquatiche di cui si nutriva. Le zanne mandibolari subirono poi un'ulteriore evoluzione nella linea che condusse ai mastodonti "dalle zanne a pala", come Amebelodon e Platybelodon, in grado di "raspare" i fondali in modo ancora più efficiente. Anche il cranio del gonfoterio differiva da quello degli elefanti moderni, essendo più lungo e basso. Il gonfoterio fu un animali dal grande successo evolutivo, visto che prosperarono in molte parti del mondo per svariati milioni di anni.
 |
| Gomphotherium angustidens, disegno dell'autore |
Intanto gli artiodattili prendevano il posto dei perissodattili come vegetariani più importanti. Nei continenti meridionali facevano il loro debutto gli sdentati, con gli armadilli corazzati, e gli opossum, mentre i bradipi raggiungevano dimensioni colossali con il Megaterio, alto fino a sei metri. Il vantaggio di questi giganti consisteva nel poter raggiungere i rami alti degli alberi, e quindi nel non competere per il cibo con la maggioranza degli animali, mentre la grande mole scoraggiava anche i carnivori più tenaci ed affamati. Decisamente ormai i mammiferi erano esplosi fino ad occupare ogni angolo del globo. Comparvero infine le prime vere scimmie, le Platirrine e le Catarrine.
Gli antenati dei Cetacei
Alcuni mammiferi, come il Basilosauro (Basilosaurus cetoides) lungo 25 metri, riscoprirono l'elemento liquido e diedero il via alla famiglia dei Cetacei. Da notare che il nome di quest'animale in greco significa "rettile re", perchè al momento della scoperta (effettuata da Albert Koch nel 1845) fu scambiato per un dinosauro. Esso aveva ben 44 denti: nella parte anteriore le mascelle erano dotate di denti simili ad arpioni che servivano per infilzare le prede, mentre nella parte posteriore si trovavano denti dal bordo seghettato, adatti a frantumare le ossa delle vittime. Il basilosauro aveva anche due arti posteriori molto piccoli e quasi atrofizzati, retaggio della sua origine sulla terraferma (si discute ancora quale famiglia di mammiferi terrestri diede poi vita ai Cetacei; certamente il Maiacetus inuus di cui si è detto sopra era tra i loro antenati). Da notare che, secondo alcuni criptozoologi, il lago Okanagan (Canada) ospiterebbe un "mostro" simile al basilosauro, detto Ogopogo dalle popolazioni del luogo.
C'è da dire che le balene contano in totale 84 specie viventi e più di 400 specie estinte, tra cui alcune che passavano parte della loro vita sulla terraferma. Per spiegare una simile variabilità evolutiva, i biologi dell'Università della California a Los Angeles hanno utilizzato tecniche molecolari per ricostruire 35 milioni di anni di storia evolutiva delle balene, a partire dalla loro comparsa sulla Terra. « Le balene rappresentano la più spettacolare invasione degli oceani per opera di una linea evolutiva di mammiferi », ha spiegato Michael Alfaro, professore di ecologia e biologia evolutiva dell'UCLA. « Esse sono spesso in cima alla catena alimentare e sono fondamentali in tutti gli ecosistemi in cui compaiono. Sono gli animali più grossi che siano mai esistiti. Inoltre i cetacei, che includono oltre alle balene i delfini e le focene, sono i mammiferi che possono raggiungere le massime profondità oceaniche. I biologi hanno dibattuto a lungo sulla possibilità che qualche caratteristica evolutiva cruciale nella storia evolutiva delle balene abbia permesso una rapida espansione delle balene quanto a numero e morfologia: sono stati candidati a questo ruolo il sonar, il cervello di grandi dimensioni e i fanoni, utilizzati per filtrare i piccoli organismi che entrano nella dieta del cetaceo. Oggi sappiamo che l'evoluzione delle prime balene fu eccezionalmente rapida. » Infatti le specie di dimensioni grandi, medie e piccole apparvero tutte già nella fase iniziale dell'evoluzione delle balene, al massimo 25 milioni di anni fa (alle 23.20 del 29 dicembre), e per molti milioni di anni non sono cambiate.
Aggiungiamo che le dimensioni della balenottera azzurra e degli altri misticeti (i cetacei dotati di fanoni e non di denti) sono un prodotto recente dell'evoluzione, che risale a non più di due milioni e mezzo di anni fa (alle 19.01 del 31 dicembre). A dimostrarlo nel 2017 sono stati alcuni ricercatori dell'Università di Chicago, della Stanford University e dello Smithsonian National Museum of Natural History di Washington, D.C. Nicholas Pyenson e colleghi hanno misurato tutti i reperti di misticeti, viventi ed estinti, conservati allo Smithsonian, che possiede una delle più grandi collezioni di crani di balena, integrando quei dati con quelli relativi a esemplari conservati altrove. Sono così riusciti a stimare la lunghezza di 63 specie di balene estinte, alcune delle quali vissute più di 30 milioni di anni fa (alle 13.36 del 29 dicembre). I dati raccolti hanno mostrato chiaramente che le grandi balene di oggi non sono esistite per la maggior parte della storia e che il gigantismo di quei animali si è sviluppato in un periodo relativamente breve, iniziato circa 4,5 milioni di anni fa (alle 15.14 del 31 dicembre), quando nella documentazione fossile hanno iniziato a comparire balene lunghe più di 10 metri, mentre cominciavano a scomparire quelle di dimensioni più piccole. Il fatto che l'incremento delle dimensioni abbia interessato contemporaneamente più rami evolutivi dell'albero filogenetico di questi animali suggerisce che in quel periodo una dimensione massiccia fosse in qualche modo diventata vantaggiosa, probabilmente in seguito a un cambiamento ambientale: a quel tempo il pianeta stava infatti entrando in un periodo glaciale.
 |
| Basilosaurus cetoides, disegno dell'autore |
A questo proposito, nel 2010 Mario Urbina, vera e propria leggenda vivente della paleontologia peruviana, ha ritrovato nel Deserto di Ica in Perù i resti di un animale, oggi conservati al Museo di Storia Naturale di Lima, che nel 2023 è stato studiato nei dettagli da un gruppo internazionale di scienziati guidati dal professor Giovanni Bianucci e collaboratori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, e comprendente paleontologi delle università di Milano-Bicocca e di Camerino, ricercatori peruviani e altri di diverse nazionalità europee. Battezzato Perucetus colossus, si tratterebbe dell'animale più pesante di tutti i tempi: vissuto 40 milioni di anni fa (alle 18.01 del 28 dicembre) e lungo 20 metri, poteva probabilmente raggiungere le 340 tonnellate, quasi il doppio della più grande balenottera azzurra e oltre quattro volte l’Argentinosauro, uno dei più grandi dinosauri mai rinvenuti. Si tratta di 13 vertebre, 4 costole e parte del bacino, il quale indica ci dice che il Perucetus era ancora provvisto di piccole zampe posteriori, una condizione riscontrata anche negli altri Basilosauridi, il gruppo di cetacei arcaici a cui è stato riferito questo nuovo "mostro marino". Sebbene lo scheletro non sia completo, stime rigorose basate sulla misurazione delle ossa conservate e sulla comparazione con un ampio database di organismi attuali e fossili indicano che la massa scheletrica di Perucetus era di circa 5-8 tonnellate, un valore almeno doppio rispetto alla massa scheletrica del più grande animale vivente, la balenottera azzurra. L’enorme massa corporea indica che i cetacei sono stati protagonisti di fenomeni di gigantismo in almeno due fasi: in tempi relativamente recenti, con l’evoluzione delle grandi balene e balenottere che popolano gli oceani moderni, e circa 40 milioni di anni fa, con la nascita dei Basilosauridi di cui Perucetus è il rappresentante più straordinario. Le sue vertebre sono talmente pesanti che per ogni spostamento erano necessarie diverse persone: la più leggera pesa 100 chili! Oltre a rendere più difficili le fasi di scavo e preparazione, ciò ha complicato fortemente l’analisi osteoanatomica dei reperti, e quindi è stato necessario ricorrere alle più innovative metodologie della paleontologia virtuale e in particolare alla scansione a luce strutturata, per acquisire ed elaborare modelli tridimensionali nei dettagli di tutte le ossa raccolte. Si è così appurato che tutte le ossa di Perucetus sono costituite da un osso estremamente denso e compatto, simile a quello che si rinviene nei sirenidi attuali. Questi mammiferi abitano in acque costiere poco profonde, dove uno scheletro particolarmente pesante funziona da "zavorra", facilitando così l’alimentazione sul fondale (forse privilegiando la ricerca di carogne di altri vertebrati marini come fanno oggi alcuni grandi squali) ed aumentando l’inerzia all’azione delle onde, ma l’enorme massa ricostruita per l’intero scheletro riflette anche l’alto peso specifico della tipologia di tessuto osseo di cui esso si compone. L’ispessimento e appesantimento dello scheletro, chiamato con termine tecnico pachiosteosclerosi, che accomuna Perucetus ai sirenidi, non si ritrova in nessun cetaceo attualmente vivente. È probabile dunque che fornisse a Perucetus la stabilità necessaria per abitare acque agitate prossime alla linea di costa.
Le prime Catarrine
Le scimmie del Vecchio Mondo, o Catarrine, e tra queste le scimmie antropomorfe, sono una componente fondamentale dei moderni ecosistemi dell'Africa e dell'Asia, ma le prime fasi della loro storia evolutiva sono ancora scarsamente documentate. Nel maggio 2013 tuttavia Nancy J. Stevens, dell'Università dell'Ohio ad Athens, ha descritto due reperti fossili ritrovati in Africa Orientale e risalenti a 25,2 milioni di anni fa, che rappresentano una testimonianza della diversità delle catarrine durante un periodo di profondi cambiamenti dell'ecosistema terrestre africano.
Le Catarrine si sono separate dalle scimmie del Nuovo Mondo circa 40 milioni di anni fa (alle 18.01 del 28/12), e hanno colonizzato molte zone dell'Africa e dell'Asia. Si suddividono in due superfamiglie: i Cercopitecoidi, tra cui i babbuini e i macachi, e gli Ominoidi, o scimmie antropomorfe, che hanno caratteristiche fisiche e intellettive più simili a quelle umane, e di cui fanno parte gorilla, orangutan, scimpanzè e bonobo, nonché noi stessi. L'assenza di fossili di catarrine più antichi di 20 milioni di anni (di 39 ore dell'Anno della Terra) era però in stridente contrasto con le stime basate sugli studi molecolari e genetici, secondo i quali la separazione tra le due superfamiglie è avvenuta tra 30 e 25 milioni di anni fa (tra le 13.36 e le 23.20 del 29/12): in pratica, due lunghi rami filogenetici erano rimasti finora senza prove fossili. I due reperti fondamentali per chiarire questo passaggio cruciale della nostra origine sono stati ritrovati nel 2011 a Nsungwe, in Tanzania, all'interno del Rukwa Rift, un tratto del rift dell'Africa orientale, e datati a 25,2 milioni di anni fa (le 22.56.38 del 29 dicembre). Il bacino del Rukwa Rift mostra una delle più antiche accumulazioni sedimentarie dell'intero sistema del rift dell'Africa orientale. Gli scavi dell'ultimo decennio hanno documentato una lunga e complessa storia paleontologica della porzione occidentale del rift, che contiene i resti di fauna continentale risalente sia al Cretacico che all'Oligocene.
Il primo reperto, battezzato Nsungwepithecus gunnelli in onore del paleontologo Gregg F. Gunnell, è il più antico fossile conosciuto di scimmia antropomorfa: si tratta di una mandibola parziale che conserva le caratteristiche dentali che collocano la specie tra gli Ominoidi noti come nyanzaptecine. Il secondo è un terzo molare inferiore appartenente alla più antica specie nota del gruppo delle scimmie del Vecchio Mondo, battezzata Rukwapithecus fleaglei, in onore di John G. Fleagle. Considerata la scarsità di dati paleontologici relativi alla regione africana risalenti all'intervallo tra 30 e 22 milioni di anni fa (tra le 13.36.00 del 29/12 e le 05.10.24 del 30/12), i fossili della Rukwa Rift forniscono una rara e preziosa testimonianza della diversità delle catarrine durante un periodo di profondi cambiamenti dell'ecosistema terrestre africano. La precisa stratigrafia del sito suggerisce che l'evoluzione dei primi Ominoidi e Cercopitecoidi nell'Africa orientale sia avvenuta sullo sfondo di un sollevamento tettonico nella porzione occidentale della rift orientale, in coincidenza con l'evento di riscaldamento globale del Tardo Oligocene.
Come avvenne che abbiamo perso la coda
Tutti i mammiferi tranne le scimmie antropomorfe e gli esseri umani hanno una coda, che è andata perduta circa 25 milioni di anni fa (alle ore 23.20 del 29 dicembre) nell'evoluzione degli ominidi ancestrali da cui tutte queste specie discendono. Primatologi e studiosi dell'evoluzione hanno considerato questa "riprogrammazione anatomica" strettamente correlata a uno stile caratteristico di locomozione che ha contribuito al bipedismo umano, caratteristica che ha favorito la discesa dagli alberi dei nostri antenati per spostarsi e correre più facilmente nelle praterie. A lungo però è rimasta sconosciuta la mutazione genetica che ha determinato questo cambiamento epocale, le cui tracce sono evidenti nel breve residuo nella parte finale della nostra colonna vertebrale chiamata coccige. Nel 2021 uno studio guidato da Bo Xia e colleghi del NYU Langone Health di New York ha dimostrato che dietro questo epocale cambiamento potrebbe esserci un piccolo tratto di DNA che è "saltato" in un nuovo sito di un cromosoma, alterando la produzione di una proteina chiave.
Xia e colleghi sono partiti dallo studio della formazione della coda in diverse specie animali, analizzando in particolare una trentina di geni che, nella fase embrionale, si attivano nelle cellule staminali; questa attivazione porta alla formazione dei tessuti ossei e muscolari nella parte terminale della colonna vertebrale. Dal confronto tra cinque specie di scimmie antropomorfe senza coda (scimpanzé, bonobo, gorilla, orangutan, gibboni) e sei specie di scimmie con la coda (macaco, macaco cinomolgo, macaco nemestino, babbuino verde, mandrillo, rinopiteco bruno) i primatologi hanno scoperto una mutazione genetica presente solo nel primo gruppo e negli esseri umani. Questa mutazione si trova su un gene chiamato TBXT, che curiosamente è uno dei primi geni scoperti più di un secolo fa. A provocare la mutazione è un singolo trasposone, cioè uno di quegli elementi che si pensa costituiscano fino al 10 % dell’intero genoma e che sono in grado di spostarsi da un punto all’altro di esso; questo spostamento di trasposoni spesso rende inattivi o cambia i livello di attivazione dei geni in cui si inseriscono. Per verificare la loro scoperta, i ricercatori hanno prodotto la stessa mutazione sul gene TBXT in topi di laboratorio, ed hanno potuto osservare che gli embrioni di topo ingegnerizzati crescevano con una coda molto corta e tozza, o addirittura assente.
Un particolare importante emerso dai risultati è che la mutazione espone le specie che ne sono portatrici a un maggior tasso di malformazioni della colonna vertebrale durante lo sviluppo embrionale, che attualmente negli esseri umani colpisce circa un neonato su mille. L’idea dei ricercatori è quindi che questo sia stato il prezzo pagato durante l’evoluzione degli ominidi per il vantaggio adattativo acquisito con la perdita della coda.
Il supersqualo
Tra Eocene ed Oligocene visse anche il Megalodonte (Carcharodon megalodon), sicuramente il maggior squalo mai esistito. Fu considerato un parente stretto del più noto e tuttora vivente Squalo Bianco (Carcharodon carcharias), soprattutto per la grande somiglianza nella forma e nella struttura dei denti, ma alcuni hanno proposto di classificare il Megalodonte nel nuovo genere Carcharocles, sostenendo che solo per convergenza evolutiva lo squalo bianco e il supersqualo estinto hanno una dentatura tanto simile. I suoi fossili sono per lo più denti lunghi fino a 17 cm, i quali fanno pensare ad un animale la cui lunghezza avrebbe potuto superare i 17 metri e il cui peso avrebbe potuto raggiungere le 45 tonnellate! Se gli si attribuisce un metabolismo simile a quello dello squalo bianco, ne consegue che il Megalodonte avrebbe dovuto divorare ogni giorno 8 tonnellate di carne, cioè un quinto del suo peso. Possedeva un'apertura della mascella superiore ai due metri, e il ritrovamento di alcune vertebre fossili di balena danneggiate da denti terribili fa pensare che esso avrebbe potuto sbafarsi anche le più grandi balene.
Il Megalodonte era diffuso in tutti gli oceani, ma probabilmente prediligeva i mari caldi e temperati. Si pensa che preferisse le zone costiere, in cui era facile incontrare i grossi mammiferi marini di cui certamente si nutriva. L'Oligocene e il Miocene furono i periodi di massima diversificazione dei cetacei di grossa taglia (20 generi di balene contro i 6 attuali), ed i loro mari pullulavano anche di molte altre possibili prede (dugonghi, tartarughe marine, pinnipedi di grossa taglia, pinguini come quelli di cui parleremo tra poco, altri squali predatori, squali balena, tonni), dunque la diffusione del Megalodonte non può certo stupirci. I paleontologi ritengono che esso si sia estinto alla fine del Cenozoico, cioè circa due milioni di anni fa (ore 20.00.24 del 31/12), ma alcuni criptozoologi hanno avanzato l'ipotesi che il supersqualo sia sopravvissuto fino a tempi molto più recenti, o addirittura che ne esistano tuttora degli esemplari vivi e vegeti. Come prova essi portano dei denti la cui datazione è controversa e gli avvistamenti moderni di gigantesche creature simili a squali: nel 1918 un pescatore di Port Sthephens (Nuovo Galles del Sud, Australia) narrò di aver incontrato un titanico squalo bianco lungo non meno di 30 metri, ed anche lo scrittore americano Zane Grey (1872-1939) giurò di aver avvistato nel 1928 presso l'isola di Rangiroa, nell'arcipelago di Tuamotu (Pacifico del Sud), un gigantesco squalo dalle grandi pinne pettorali e di color verde-giallastro, lungo fino a 12 metri. Nonostante questi incontri, tuttavia, non si ha notizia che sia mai stato pescato un esemplare di quelle dimensioni, ed è improbabile che il Megalodonte viva tuttora in mare aperto, dato che, come si è detto, probabilmente esso viveva lungo le coste. I presunti avvistamenti di Megalodonte sopravvissuti sono normalmente considerati abbagli dovuti all'avvistamento di squali elefante, squali balena o altri grandi animali. Questo naturalmente non ha impedito alla fantascienza, al cinema e ai videogiochi di impossessarsi di questi animali, tanto che una casa produttrice americana di attrezzature per immersioni si chiama proprio Megalodon!
Ali gigantesche
Potrebbe essere il più grande uccello che abbia mai volato sulla Terra quello descritto da Daniel T. Ksepka dell'Università della South Carolina. Si tratta di un esemplare fossile della specie Pelagornis sandersi scoperto nel 1983, nei pressi di Charleston. Secondo le stime, infatti, le sue dimensioni sono doppie di quelle dell'albatros urlatore, il più grande uccello moderno, e superano quelle stimate per la specie estinta Argentavis magnificens, che finora deteneva questo record di dimensioni. Nel lungo passato della Terra alcune famiglie di uccelli estinti hanno superato notevolmente questi limiti: si tratta in particolare della specie Argentavis magnificens e e degli uccelli oceanici noti come pelagornitidi, apparsi nel Paleocene, che hanno colonizzato tutto il globo, per poi estinguersi nel Pliocene. Membro di questa famiglia è Pelagornis sandersi, vissuto tra 28 e 25 milioni di anni fa (tra le 17.29 e le 23.20 del 29 dicembre), di cui sono disponibili ossa delle ali e delle zampe e il cranio pressoché completo.
Ksepka e colleghi hanno utilizzato i dati ricavati dall'analisi dello scheletro per prevedere, grazie a un programma al computer, le prestazioni di volo, in funzione delle diverse stime di massa, apertura alare e forma dell'ala. Dalla simulazione, è emerso che P. sandersi aveva un'apertura alare compresa tra 6 e 8 metri, quindi troppo ampia per prendere il volo semplicemente battendo le ali o lanciandosi nell'aria da un punto fisso. Come Argentavis, il cui volo era stato descritto da una simulazione al computer del 2007, il Pelagornis probabilmente prendeva il volo correndo lungo una discesa con il vento di fronte o sfruttando le raffiche, come fa un deltaplano. Una volta in aria, mostrano le simulazioni, le lunghe e sottili ali dell'uccello avrebbero prodotto un planaggio molto efficiente. Librandosi contro le correnti ascensionali che si originano dalla superficie oceanica, Pelagornis era in grado di procedere in volo planato per chilometri sull'oceano aperto senza battere le ali, dirigendosi di tanto in picchiata verso il mare per nutrirsi del pesce che riusciva a catturare.
L'alba dei passeriformi
La radiazione dei passeriformi, cioè la loro diversificazione in numerose specie differenti, ebbe inizio circa 33 milioni di anni fa (alle 07.45 del 29 dicembre) in Australia, ma fu solo dieci milioni di anni dopo (quasi venti ore dopo) che cominciarono a disperdersi e a colonizzare tutto il mondo, con la sola eccezione dell'Antartide. Lo ha dimostrato un gruppo di ricercatori dell'Università del Kansas e della Louisiana State University, che hanno condotto un'analisi comparativa di dati paleontologici, paleogeografici e genetici, fra cui la più ampia analisi genetica mai effettuata sui passeriformi. Con 5000 specie circa, i passeriformi rappresentano quasi metà delle specie della classe degli uccelli. Precedenti analisi genetiche avevano già appurato la loro origine australiana, ma non si conoscevano né l'epoca in cui avvenne la diversificazione né i percorsi lungo cui si diffusero nel resto del pianeta.
L'incertezza aveva fatto ipotizzare che tanto la radiazione quanto la dispersione risalissero almeno a 60 milioni di anni fa (alle 03.12 del 27 dicembre), quando l'Australia era relativamente vicina all'Africa. L'ipotesi prevedeva comunque migrazioni su distanze molto lunghe. Ma 33 milioni di anni fa il continente australiano si era allontanato molto dall'Africa e il percorso che oggi apparirebbe naturale (il passaggio attraverso la Nuova Guinea e l'arcipelago indonesiano) non esisteva ancora. Per una decina di milioni di anni i passeriformi continuarono quindi a diversificarsi in Australia. Circa 23 milioni di anni fa (alle 03.13 del 30 dicembre), tuttavia, i sommovimenti tettonici portarono alla formazione dei primi abbozzi della Nuova Guinea e della regione che comprende l'arcipelago indonesiano, creando un lungo ponte di isole fra il continente australe e l'Asia. Proprio in quel periodo, inoltre, il clima dell'Australia stava progressivamente inaridendosi, privando gli uccelli dell'ambiente a foresta in cui vivevano. Il ponte di isole offrì quindi la possibilità di allontanarsi dal loro luogo d'origine per migrare verso la più ospitale Nuova Guinea prima, e nel resto del mondo poi.
Il pinguino colossale
Che l'Oligocene non cessi di riservare sorprese ai paleontologi lo dimostrano i resti fossili di uno dei più grandi pinguini mai esistiti, ritrovati in Nuova Zelanda dopo anni di ricerche. L'uccello, un gigante di un metro e mezzo di altezza e 60 kg di peso, è vissuto 27 milioni di anni fa (alle 19.26 del 19 dicembre), quando la Nuova Zelanda era per lo più sommersa e consisteva di scogli sporgenti e isolati, che offrivano cibo abbondante e riparo dai predatori. Le prime tracce del pinguino, soprannominato Kairuku (in lingua Maori « tuffatore che torna con il cibo ») furono scoperte nel 1977, in una scogliera preso Waimate, nell'Isola del Sud, dal professor Ewen Fordyce dell'Università di Otago. Negli anni successivi il paleontologo neozelandese e il suo collega Dan Ksepka dell'Università della North Carolina hanno ricostruito insieme il pennuto preistorico, scoprendo che era molto più grande del più alto dei pinguini moderni, il pinguino Imperatore, che cresce fino a un metro e pesa fino a 30 kg. « Il Kairuku era un uccello elegante per gli standard dei pinguini », hanno dichiarato i due studiosi, « con un corpo snello e lunghe pinne, ma con zampe corte e spesse ». Le sue grandi dimensioni erano probabilmente un adattamento che gli consentiva di nuotare per lunghe distanza e tuffarsi più a fondo delle sue controparti moderne. Le ragioni della sua estinzione? Presumibilmente il cambiamento climatico e il numero crescente di predatori.
![]()
(da 23 a 5,3 milioni di anni fa)
Il termine Miocene deriva dal greco "meno recente" (dell'epoca che seguirà, lapalissiano). Durò da 23 a 5,3 milioni di anni fa, e cioè, in termini di Anno della Terra, dalle 3.13 del 30/12 alle 13.41 del 31/12.
L'Eocene è suddiviso in sei periodi: Aquitaniano, Burdigaliano, Langhiano, Serravalliano, Tortoniano e Messiniano (finalmente delle epoche derivate da toponimi italiani!)
La Crisi di Salinità del Messiniano
L'evento geologico più importante del periodo fu lo spostamento verso Nord del continente africano, che andò ad urtare contro l'Europa e l'Asia, mentre la Tetide si chiuse definitivamente. L'Africa non era più isolata dal resto dei continenti, e così molti mammiferi eurasiatici si spostarono a sud, mentre proboscidati e primati compivano il percorso contrario. Alla fine dell'epoca, a causa dell'ostruzione dello stretto di Gibilterra, per alcune centinaia di migliaia di anni il Mediterraneo non fu più alimentato dalle acque dell'Oceano Atlantico, e quindi non fu in grado di compensare l'evaporazione con le precipitazioni e con l'apporto dei fiumi, il che lo portò quasi in secco. A quei tempi insomma il Mediterraneo sarebbe apparso come un'immensa distesa arida, zeppa di depositi di sale, la cui base in alcuni punti raggiungeva i 4 km al di sotto del livello degli oceani. Altro che Atlantide!
Questo evento è oggi noto come Crisi di Salinità del Messiniano, dal nome del periodo geologico in cui ebbe luogo. Il fenomeno fu scoperto nel 1970, quando alcuni oceanografi recuperarono dai sondaggi condotti sul fondale delle carote contenenti ghiaie di origine fluviale, oltre che gessi, salgemma e varie altre rocce derivate dalla precipitazione di sali da acque marine soprasature. In alcuni campioni erano presenti minerali di cloruro di potassio, un sale estremamente solubile che precipita solamente con l'evaporazione delle ultime acque prima del disseccamento. Altre prove del disseccamento del Mediterraneo sono la presenza di antichi canyon, ora colmati da sedimenti, scavati ai margini della depressione dall'erosione dei fiumi, che allora scorrevano fino alle pianure abissali asciutte. Gli studi condotti in Egitto per la costruzione della diga di Assuan hanno permesso di stabilire che il Nilo è arrivato in corrispondenza di Assuan a scavare il proprio letto alcune centinaia di metri sotto il livello del mare attuale. I rilievi sismici nella regione dell'attuale delta, eseguiti per la ricerca di giacimenti petroliferi, hanno individuato il letto messiniano dell'antico Nilo, che si trovava circa 2400 metri sotto il livello del mare attuale!
Si pensa che il Mare Nostrum sia rimasto completamente isolato dall'Oceano Atlantico da 5,59 a 5,33 milioni di anni fa, cioè dalle 13.00 alle 13.37 del 31 dicembre. All'inizio prevalsero fenomeni erosivi di grande estensione, che crearono grandi sistemi di canyon ai margini del Mediterraneo, mentre le fasi più recenti sono caratterizzate dalla deposizione di cloruro di potassio entro bacini ampi e poco profondi, un po' come se al centro del Tirreno, dell'Adriatico, dell'Egeo fossero sopravvissuti dei laghi salmastri simili all'attuale lago Ciad. Alcuni di questi depositi messiniani sono stati poi sollevati da spinte tettoniche, ed affiorano oggi in Sicilia e nella parte nord-orientale della Libia. Dunque l'area mediterranea, oggi nota per i panorami mozzafiato di Amalfi e delle isole greche, fu sottoposta a fasi cicliche di disseccamento ed inondazione per circa 700.000 anni, fino alla cosiddetta Alluvione Zancleana, di cui riparleremo all'inizio del Pliocene.
Un tempo si pensava che la crisi di salinità fosse dovuta alla tettonica delle placche africana, arabica ed euroasiatica, il cui movimento avrebbe portato all'isolamento del Mediterraneo. Oggi invece si pensa che la chiusura della comunicazione tra Mediterraneo e Atlantico fosse l'esito dell'abbassamento del livello del mare conseguente all'aumento della coltre glaciale antartica. Fabio Florindo, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha presentato a fine 2015 la prima prova geologica diretta della correlazione tra espansione dei ghiacci antartici ed evento messiniano, grazie all'analisi di 60 carotaggi di sedimenti ricavati da varie campagne di trivellazione in Antartide. « I dati empirici dimostrano che il ghiaccio del continente antartico si è espanso poco prima del Messiniano, ma la precisa cronologia degli eventi chiave non combaciava », ha spiegato Christian Ohneiser, ricercatore dell'Università di Otago, in Nuova Zelanda. Per chiarire le discrepanze, gli autori sono ricorsi a un modello computerizzato, sviluppato da Paolo Stocchi, ricercatore del Royal Netherlands Institute for Sea Research e coautore dello studio, in grado di simulare la crescita della coltre glaciale antartica, per vedere quale impatto geofisico potesse avere quella crescita, oltre a un complessivo abbassamento del livello marino. Dalla simulazione è emerso che la coltre ghiacciata antartica ha avuto un effetto non uniforme sul livello globale del mare, a causa di una complessa interazione tra gli effetti gravitazionali e rotazionali, e le deformazioni della crosta terrestre dovute all'avanzamento e alla ritirata del ghiaccio nelle varie zone. L'analisi ha mostrato anche che, con l'evaporazione del Mediterraneo, la crosta terrestre intorno allo Stretto di Gibilterra iniziò ad alzarsi, per la mancanza del peso sovrastante dell'acqua. « Questo processo tenne il Mediterraneo isolato dall'Oceano Atlantico finché la crosta iniziò a rilassarsi e a sprofondare. Contemporaneamente, l'Antartide iniziò a fondere, sollevando ancora i livelli del mare », ha aggiunto Ohneiser.
Ma la Crisi di Salinità ebbe anche effetti globali. La quantità d'acqua evaporata dal Mediterraneo dovette essere redistribuita per opera delle precipitazioni negli oceani di tutto il mondo, provocando un innalzamento del livello del mare pari a circa 10 metri. D'altro canto, lo stesso Mediterraneo imprigionò ne i propri fondali una percentuale significativa (almeno il 5 %) del sale prima disciolto nelle acque oceaniche: questo portò ad una diminuzione della salinità media delle acque marine, innalzandone la temperatura di congelamento. Le acque oceaniche quindi passarono più facilmente allo stato di ghiaccio in presenza di basse temperature, abbassando la temperatura media della Terra e costituendo forse una delle cause concomitanti del successivo innesco delle grandi Glaciazioni Quaternarie, di cui parleremo a proposito del Pleistocene. Inoltre, il disseccamento del Mediterraneo provocò sicuramente drammatiche variazioni climatiche in tutta l'area e nelle regioni adiacenti, condizionando la distribuzione delle specie viventi e la loro migrazione.

La fine del superlago eurasiatico
Il Mediterraneo però non fu l'unico mare a subire una crisi di salinità in questo periodo. Pochi lo conoscono, ma Paratetide fu il più grande lago conosciuto nella storia geologica della Terra, e scomparve completamente a causa di quattro cicli catastrofici legati ai cambiamenti climatici. Paratetide, nato come ramo dell'oceano Tetide circa 155 milioni di anni fa (alle 10.16 del 19 dicembre), si estendeva dalle attuali Alpi fino al lago d'Aral. Eppure circa 6,8 milioni di anni or sono (alle 10.46 del 31/12) è quasi scomparso a causa di mutazioni climatiche, portando all'estinzione un gran numero significativo di specie che vivevano in esso e forzando una grande migrazione di megafauna, i progenitori delle giraffe e degli elefanti di oggi, verso l’Africa. Lo ha scoperto il paleogeografo Dan Palcu dell’Università di São Paulo, che tramite lo studio di reperti fossili, di depositi sedimentari e della geologia dell'area intorno al Mar Nero ha ricostruito le vicissitudini di questa importante scomparsa, individuando i movimenti tettonici che ne hanno contribuito alla formazione e i quattro principali cali nel livello dell'acqua di Paratetide. Il più grave è stato l'ultimo, accaduto tra 7,9 e 7,65 milioni di anni fa (tra le 8,37 e le 9.00 di San Silvestro), durante un periodo siccitoso noto come Great Kherson Drying. Durante questo episodio, i livelli dell'acqua del lago di Paratetide sono crollati di ben 250 metri, separando il megalago in minilaghi probabilmente tossici per la maggior parte della vita acquatica, data l’elevata concentrazione sale e altri sedimenti nocivi in alte concentrazioni per le specie viventi. Al suo posto è sorto improvvisamente un vasto deserto, nato in poche migliaia d’anni durante i quali Paratetide potrebbe aver perso fino al 70 % della sua superficie e fino a un terzo del suo volume.
« Deve essere stato un mondo preistorico post-apocalittico, una versione acquatica delle terre desolate di Mad Max », ha affermato il geologo Wout Krijgsman della Utrecht University che ha preso parte allo studio Il corpo d’acqua nel suo momento di massima espansione avrebbe coperto un'area di circa 2,8 milioni di chilometri quadrati, trattenendo più di 10 volte la quantità di acqua dolce che si trova oggi nei laghi del Pianeta. Un altro studio mostra come l'abbassamento dei livelli dell'acqua intorno al Mare di Paratetide abbia trasformato le aree prima sommerse in praterie, fornendo terreno fertile anche per l'evoluzione di molti mammiferi terrestri. Secondo la biologa evoluzionista Madelaine Böhme dell'Università di Tubinga, quando i livelli dell'acqua sono scesi, a causa di cambiamenti climatici, queste praterie sono diventate punti caldi per l'evoluzione. Le migrazioni delle nuove specie poi, spinte da ulteriori periodi di siccità a cui gradualmente si sarebbero abituate, avrebbero costituito la base della biodiversità della savana africana. Come si vede, la paleogeografia può dirci molto degli scenari di scarsità idrica e trasformazione terrestre causati dalla più rapida mutazione climatica (causata dall’uomo, stavolta) mai registrata dagli scienziati negli ultimi 800.000 anni, che rischia seriamente di metterci nei guai.
L'era delle praterie
Durante l'epoca miocenica si verificò un ulteriore, generale abbassamento della temperatura con il conseguente accrescimento di volume dei ghiacci dell'Antartide. Ciò accelerò ulteriormente il raffreddamento della Terra, poiché il ghiaccio rifletteva nello spazio la luce del sole. Nell'Oligocene la temperatura media terrestre era stata di circa 18° C, ma nel Miocene precipitò a 14° C ed oggi addirittura è di soli 9° C. Il clima più fresco e secco ebbe un profondo effetto sulla vita vegetale, e le graminacee erbose si sparsero dove prima prosperavano boschi e foreste. Cominciava cioè il trionfo delle praterie. Nelle due Americhe, in Europa e in Asia vaste regioni si ricoprirono di distese erbacee: nascevano le pampas che oggi tutti conosciamo. Anche in Africa le foreste arretrarono ed avanzò la savana, regno dei grandi felini e degli ancor più grandi erbivori.
Le praterie costituirono l'ambiente ideale per lo sviluppo dei mammiferi, potendo offrire cibo a molti più animali che non le foreste. Naturalmente, grazie all'abbondanza di cibo, in quest'epoca i mammiferi si diversificarono in numerosissime forme, dirette antenate di quelle attuali, mentre i più antichi mammiferi colossali si estinguevano, e gli uccelli assumevano praticamente l'aspetto attuale. Mammiferi di mole diversa si nutrono diversamente a seconda dei diversi livelli di vegetazione, cosicché nelle praterie le piante vengono utilizzate al massimo dagli erbivori, con il minor livello di competizione. Oggi, ad esempio, nelle savane africane le zebre si nutrono della sommità delle graminacee, gli gnu delle loro foglie, e le gazzelle dei getti al livello del suolo; è molto probabile che i mammiferi del Miocene si fossero specializzati in modo analogo. La vita negli spazi aperti tuttavia pone anche nuovi problemi agli animali. Le graminacee dalla consistenza più dura sono difficoltose da digerire rispetto alle proteine delle foglie, per cui la dentatura e il sistema digerente devono adeguarsi. Inoltre, negli spazi aperti tanto i predatori che le prede risultano più visibili; per questo, la maggior parte degli erbivori divennero veloci corridori, mentre i predatori diventavano a loro volta rapidi nella corsa, oppure svilupparono metodi di caccia in branco, o ancora evolsero colori mimetici (es. le striature della tigre) per accostarsi di soppiatto ai branchi di erbivori senza essere visti.
Nei nuovi spazi aperti creatisi dal diradamento delle foreste ebbero ampia diffusione gli Equidi, i Mastodonti e gli antenati del rinoceronte; tra questi, l'Indricoterio qui sotto disegnato fu uno degli ultimi mammiferi di grossissima taglia (era alto come una giraffa adulta e lungo fino ad otto metri!). Il suo corpo pesante era sostenuto, come già il baluchiterio dell'epoca precedente, da arti colonnari, così come quelli dei mastodonti. Tra questi ricordiamo il tetralofodonte ("quattro denti aguzzi"), dotato appunto di quattro zanne, due infisse nella mascella inferiore e due in quella superiore; e lo stranissimo platibelodonte ("denti piatti come zanne"), con due incisivi a spatola infissi nella lunghissima mascella inferiore, con i quali probabilmente frugava il terreno paludoso alla ricerca di cibo. Ancor più strano era il deoinoterio ("belva spaventosa"), alto 4 metri con zanne superiori inesistenti, ed un paio di zanne inferiori al contrario fortemente sviluppate e rivolte ad angolo retto rispetto alla mandibola; la loro funzione non è chiara. Probabilmente si tratta di un gruppo isolato dal punto di vista evolutivo.
Tra gli equidi si sviluppò il mesoippo ("cavallo di mezzo", ma... Tolkien non c'entra!), grande circa come un coyote e con piedi tridattili, e poi il merichippo che aveva già zoccoli simili a quelli del cavallo moderno, perchè le altre due dita del Mesoippo si erano atrofizzate; aveva già le dimensioni di un somaro. Il teleocerato era un insolito tipo di rinoceronte con zampe cortissime ed un unico, robusto corno sul naso, mentre tra i cervidi si svilupparono il gigantesco Megaceros irlandese, con palchi spettacolari larghi oltre tre metri, e il sintetocerato, dotato di uno strano corno biforcuto sul muso. Al contrario, si svilupparono carnivori felidi parenti degli attuali leone e tigre; ma, mentre in questi ultimi i denti superiori si ridussero, continuarono invece ad ingrossarsi in animali come lo smilodonte ("denti a coltello") del Nordamerica, detto anche "tigre dai denti a sciabola", e nel tilacosmilo ("cortello inguainato"), un marsupiale carnivoro dell'America meridionale, entrambi dotati di enormi zanne a forma di pugnale che si allungavano fuori dalla bocca. Dovevano rappresentare il terrore del Miocene. Sempre al Miocene risale il più grosso cranio di uccello mai scoperto, che misura ben 70 centimetri di lunghezza, appartenente al titanico Kelenken guillermoi e vissuto in Sudamerica.
Le scimmie globe-trotter
La più antica testimonianza di un interscambio di specie di mammiferi fra il Sudamerica e il Nordamerica risale a circa 20,9 milioni di anni fa (alle 7.19 del 30 dicembre), ed è costituita da sette denti di alcuni cebidi, che appartengono a gruppo delle scimmie platirrine o scimmie del Nuovo Mondo, scoperti nel 2016 da un gruppo di ricercatori dell'Università della Florida in collaborazione con lo Smithsonian Tropical Research Institute a Balboa (Panama). Prima di questo ritrovamento, avvenuto nella formazione di Las Cascadas durante gli scavi per l'ampliamento del canale di Panama, il fossile più antico che dimostrava la diffusione di mammiferi fra i due subcontinenti risaliva ad appena 9 milioni di anni fa (alle 06.28 di San Silvestro).
Oggi le platirrine sono diffusissime negli ecosistemi tropicali del Nord e Sud America, ma la loro storia evolutiva ai tropici è in gran parte sconosciuta. Infatti i climi tropicali umidi rendono molto difficile la conservazione dei resti di animali, e in assenza di fossili di primati in America Centrale, le stime sul loro arrivo in quella regione si fondavano sulle divergenze genetiche a livello molecolare. L'ipotesi prevalente formulata su questa base era che fossero arrivate nelle regioni tropicali centroamericane dal Sudamerica nel corso di diverse ondate di dispersione successive alla formazione dell'istmo di Panama, tra 4 e 3 milioni di anni fa (tra le 16.12.48 e le 18.00.36 del 31/12). I nuovi fossili indicano invece che la diversificazione e la diffusione di questi animali deve essere iniziata molto prima, e che deve essersi realizzata non per via terra, ma via acqua. I tratti di mare rappresentano un notevole ostacolo alla diffusione delle specie, ma non sono una barriera del tutto invalicabile, come dimostrano le numerose specie vegetali e animali che sono riuscite in varie epoche a superarle, magari a bordo di zattere naturali galleggianti. La distanza fra le due masse continentali del Nord e Sud America era infatti piccola anche prima della formazione dell'istmo. Secondo i ricercatori è plausibile che la diffusione di queste scimmie abbia interessato tutta l'area del Mar dei Caraibi.
I primi erbivori
A quanto pare, i primi erbivori furono gli antenati di zebre e cavalli. Ad appurarlo è stato uno studio condotto da ricercatori dell'Università dello Utah, che hanno studiato i cambiamenti di dieta di numerosi gruppi animali fra 10 e 3 milioni di anni fa (tra le 4.32 e le 18.00 del 31 dicembre). Ci sono riusciti analizzando i rapporti isotopici del Carbonio in 452 denti fossili di nove famiglie animali provenienti da tre siti paleontologici del Kenya, in cui vivevano anche gli antenati dell'uomo.
Il passaggio da una dieta a prevalenza di foglie di alberi ed arbusti a una a prevalenza di erba fu legata a cambiamenti nell'ambiente in cui gli animali vivevano, ma la ricerca dimostra che iniziò a svilupparsi prima che l'ecosistema a savana iniziasse a diffondersi. L'ecosistema di primo tipo dominò infatti l'Africa Orientale per tutto il periodo compreso fra 16 e 5 milioni di anni fa (tra le 16.51 del 30/12 e le 14.16 del 31/12), con l'eccezione di alcune aree erbose, distribuite a macchie di leopardo.
I primi animali a passare a una dieta composta prevalentemente da erba abbandonando quella a base di foglie di alberi e arbusti furono appunto le zebre, circa 9,9 milioni di anni fa (alle 04.43.40 di San Silvestro). Successivamente, 9,6 milioni di anni fa (alle 05.18.43), si adattarono gazzelle, gnu, bufali e in generale i bovidi, anche se alcune specie di essi conservarono la predilezione per foglie e arbusti, esattamente come avvenne più o meno nello stesso periodo per i rinoceronti.
Gli elefanti iniziarono invece a nutrirsi di erbe circa 7,4 milioni di anni fa (alle 09.35.40), per poi adottarle come alimento pressoché esclusivo per diversi milioni di anni, salvo tornare a una dieta prevalentemente a base di foglie e arbusti circa un milione di anni fa (alle 22 in punto). Per gli antenati dei suini il passaggio fu graduale, fra i 6,5 e i 4,2 milioni di anni fa (fra le 11.20.48 e le 15.49.26). Gli antenati delle giraffe, complice probabilmente il loro collo, rimasero invece sempre esclusivi consumatori di foglie.
 |
| L'Indricoterio, colossale mammifero del Miocene (disegno dell'autore) |
Il gelo dalla polvere cosmica?
A giudicare da quanto pubblicato dalla rivista Nature il 19/1/2006, sembra che nel corso del Miocene lontani eventi spaziali abbiano potuto influire sul clima della Terra, provocando una lunga ondata di gelo. Le prove dell'evento sono custodite nei fondali oceanici, tra i sedimenti degli Oceani Atlantico e Indiano, sotto forma di particelle microscopiche databili con i moderni metodi radioattivi. Tutto avrebbe avuto inizio quando un grande asteroide del diametro di circa 150 km, in orbita tra Marte e Giove insieme a parecchi suoi simili, sarebbe entrato in collisione con un altro corpo di più piccole dimensioni, chiamato Veritas. Quest'ultimo si sarebbe diviso in tanti grandi frammenti, ancora oggi rintracciabili perché in base al principio di conservazione della quantità di moto seguono tuttora l'orbita del corpo celeste progenitore. il loro studio da Terra ha permesso di ricostruirne le complicate vicende orbitali, e così si è dedotto che la collisione avrebbe prodotto una valanga di minute particelle, lentamente attratte dal Sole; incontrando la Terra, esse sarebbero penetrate nell'atmosfera, causando una vera e propria pioggia di polveri e detriti in grado di attenuare la radiazione solare, e scatenare un lungo periodo di freddo. Una glaciazione, insomma. Tutto ciò sarebbe accaduto 8 milioni e duecentomila anni fa (alle 8 in punto del 31 dicembre).
« Le prove che le particelle da noi raccolte nei sedimenti oceanici sono i resti di quella antica collisione sono fornite, oltre che dalle datazioni, dalla presenza di elio- 3, un isotopo raro sulla Terra, ma abbondante nello spazio, dove viene continuamente rifornito dal vento solare e assorbito dai frammenti cosmici », ha spiegato il geochimico Ken Farley del Caltech di Pasadena. La correlazione fra la pioggia di polveri cosmiche e i segni del raffreddamento climatico del nostro lontano passato, registrati attraverso lo studio dei fossili e di altri indicatori geochimici, sembra inoppugnabile. Tutto questo può aiutarci a decifrare l'incostante clima della Terra, per distinguere tra le oscillazioni climatiche provocate dai vari fattori naturali e quelle ora indotte dalle attività umana.
I genitori della patata
Nonostante la coltivazione delle patate sia vecchia di 8000 anni, quando comunità di cacciatori-raccoglitori iniziarono a selezionare le piante selvatiche che crescevano intorno al lago Titicaca, al confine tra Perù e Bolivia, l’origine di questo vegetale è rimasta a lungo ambigua e controversa. Nel 2025 però i ricercatori dell’Accademia Cinese di Scienze Agrarie hanno trovato la soluzione a questo enigma. Per molto tempo si è dibattuto sull’ipotesi secondo cui la patata comune (Solanum tuberosum L.), la quarta coltura di base più importante al mondo, insieme a grano, riso e mais, si sarebbe evoluta a seguito di una lunga serie di selezioni e mutazioni, come la maggior parte delle specie, a partire da una patata ancestrale. Al contrario, gli scienziati cinesi hanno scoperto che la patata sarebbe sorta rapidamente e improvvisamente, nove milioni di anni fa (alle 08.25.36 del 31 dicembre), a seguito di un incrocio tra due specie preesistenti: un antenato degli attuali pomodori e una piccola solanacea selvatica, originaria del Cile, chiamata Etuberosum. Il risultato arriva dall’analisi di 450 genomi provenienti da patate coltivate e da specie selvatiche: i ricercatori hanno trovato che tutte le specie contengono un mix di materiale genetico proveniente dall'Etuberosum e dal pomodoro, suggerendo appunto la presenza di un evento di ibridazione. Questa antica ibridazione ha generato una particolare combinazione di geni che ha determinato lo sviluppo dei tuberi, strutture non presenti prima di quel momento nelle specie genitrici.
I ricercatori sono andati a valutare, tramite analisi funzionale, se i geni individuati fossero in grado di dar vita a un tubero, così da verificare che fosse stato proprio l’incrocio tra le specie genitrici a determinare lo sviluppo di questa caratteristica prima inesistente. Le patate, sia quelle coltivate che le varianti selvatiche, condividono, infatti, il tratto distintivo dei tuberi sotterranei, che mancano sia nei pomodori che nell’Etuberosum, dove è solamente presente la formazione di stoloni, rami sotterranei che non si “gonfiano”. I ricercatori hanno così scoperto che i geni chiave della patata per la formazione dei tuberi derivano da una combinazione di materiale genetico appartenente a ciascun genitore. Nello specifico, si tratta del gene SP6A, derivante dal pomodoro, che agisce come un interruttore e invia un segnale alla pianta che avvia il processo di sviluppo di queste strutture, e del gene IT1, proveniente dall’Etuberosum, che aiuta, invece, a controllare la crescita degli steli sotterranei che formano i tuberi. Senza uno dei due pezzi, la progenie ibrida non sarebbe stata in grado di produrre queste strutture che hanno portato al successo del nuovo ibrido vegetale. Le ibridazioni avvengono continuamente nel mondo della biologia, in quanto tutte le specie che non sono perfettamente isolate dal punto di vista riproduttivo, possono dar luogo a incroci con specie imparentate. Nonostante il pomodoro e l’Etuberosum siano piante distinte, presentano un antenato comune da cui si sono differenziate circa 15 milioni di anni fa (alle 18.48 del 30 dicembre). Qualche milione di anni dopo erano, pertanto, ancora specie piuttosto vicine, e la loro biologia ha consentito che il polline di una finisse sul pistillo dell’altra, dando origine al capostipite della patata. Spesso però questi incroci sono poco fertili o hanno una fisiologia poco funzionale. In questo caso, invece, l’emergere, probabilmente fortuito, del tubero, ha dato un vantaggio competitivo alla nuova specie. Il tubero è, infatti, in grado di immagazzinare nutrienti, favorendo la sopravvivenza della pianta in condizioni di stress, come periodi di siccità, e le consente di riprodursi anche senza semi o impollinazione, quindi anche quando la parte esterna muore. A decretare il successo di questa nuova specie e a metterne subito alla prova la sopravvivenza, è stata la concomitanza del suo sviluppo con la rapida formazione della catena delle Ande, avvenuta proprio nello stesso periodo, tra dieci e sei milioni di anni fa (tra le 04.32 e le 12.19 del 31/12). Questo evento ha creato nuovi ambienti ecologici, con gradienti di temperatura e piovosità molto diversi. La patata, capace di sopravvivere anche in condizioni difficili, ha avuto quindi la possibilità di colonizzare questi nuovi ecosistemi grazie a caratteristiche, come appunto quella del tubero, che l’hanno resa più resistente rispetto alle specie genitrici. Le caratteristiche vantaggiose di questo ibrido hanno poi favorito una grande diversificazione della patata, permettendo a questa pianta di espandersi rapidamente e di occupare diversi ambienti, dalle praterie agli altipiani dell'America centrale e meridionale, arrivando fino ai giorni nostri e diventando una delle colture più diffuse al mondo. Infatti gli Inca credevano che la patata avesse persino una divinità ad esa votata, Axomama; e quando una malattia delle patate causata da un oomicete, la peronospora della patata e del pomodoro, colpì l'Irlanda nell'autunno del 1845, distruggendo un terzo circa del raccolto della stagione e l'intero raccolto del 1846, ne derivò una carestia (ricordata dagli irlandesi come "An Gorta Mór") che causò la morte di almeno un milione di irlandesi, e l'emigrazione all'estero di un altro milione!
L'enigmatico ungulato di Darwin
Nel 2017, grazie all'analisi del DNA mitocondriale, è stato possibile trovare una collocazione sicura nell'albero evolutivo a Macrauchenia patachonica, una delle specie più sconcertanti vissute tra 7 milioni di anni fa e 20.000 anni fa (tra le 10.22.24 e le 23.57.39 del 31 dicembre). Un gruppo di paleontologi dell'Università di Potsdam, in Germania, e dell'American Museum of Natural History a New York, hanno dimostrato il rapporto di parentela tra Macrauchenia e vari ungulati moderni, come i cavalli, i rinoceronti e i tapiri. I primi fossili di questi animali furono scoperti da Charles Darwin nel 1834 durante il suo viaggio in Sudamerica. Tornato in Inghilterra, Darwin li passò al famoso paleontologo Richard Owen perché li studiasse e descrivesse. Owen rimase però concertato a causa della singolare commistione di tratti dell'animale. Dapprima, a causa del lungo collo, pensò che fosse legato agli odierni lama e cammelli, ma in seguito al ritrovamento di altri resti si ricredette. Nella maggior parte dei mammiferi l'apertura nasale è situata nella parte anteriore del cranio, appena sopra i denti anteriori, mentre in Macrauchenia è posta più in alto, vicino alle cavità oculari, un tratto che lo avvicinava maggiormente agli elefanti. Alla fine Owen concluse che forse si trattava di una forma di transizione fra i camelidi e altri artiodattili ruminanti.
Ora, grazie alle più avanzate e sofisticate tecniche di analisi del DNA antico, Michael Hofreiter e colleghi sono riusciti a recuperare circa l'80 % del DNA mitocondriale di diversi fossili di questi animali, riuscendone a ricostruire la storia evolutiva. L'analisi di questi dati ha permesso di concludere che Macrauchenia era un membro del gruppo di ungulati che ha dato origine agli attuali perissodattili, delle cui prime specie si hanno testimonianze fossili risalenti a 55 milioni di anni fa (alle 12.56 del 27/12). I ricercatori hanno anche stabilito che la linea evolutiva di Macrauchenia si separò da quella dei perissodattili moderni circa 66 milioni di anni fa (alle 15.31 del 26/12), cioè nello stesso periodo in cui si verificò una delle più grandi estinzioni di massa. Ora i ricercatori sperano di riuscire a condurre un'analoga analisi sui resti di un altro enigmatico ungulato nativo del Sudamerica, il "rinoceronte" Toxodon, che Darwin considerava « l'animale più strano mai scoperto ». Da notare che nel film "La minaccia fantasma", il primo della saga di Star Wars, sul pianeta Tatooine una bestia molto simile al macrauchenia viene utilizzata come animale da tiro per portare gli Sgusci sulla linea di partenza della gara!
|
|
| Puijila darwini, possibile anello di ricongiunzione fra mammiferi terrestri e pinnipedi (disegno di Mark Klingler) |
L'antenato delle foche
All'inizio del Miocene risale anche lo scheletro fossilizzato di un mammifero semiacquatico trovato nel 2007 tra i ghiacci del Canada, che da vivo misurava poco più di un metro, disponeva di una lunga coda, aveva una struttura a metà tra quella di una foca e di quella di una lontra, era privo di pinne ma aveva tutte e quattro le zampe palmate. L'ipotesi dirompente è che esso rappresenti l'anello di congiunzione tra i mammiferi terrestri e i pinnipedi moderni (foche, otarie, trichechi e leoni marini) adattati a vivere in un habitat prevalentemente marino. Il fossile è stato ritrovato nell'isola di Devon, che fa parte dell'arcipelago artico canadese e con i suoi 55.247 Km2 non è solo la ventisettesima isola più vasta del mondo, ma anche la più vasta isola disabitata del pianeta Terra. Siccome l'isola fa parte di Nunavut, il territorio autonomo Inuit creato nel 1999, la nuova specie è stata battezzata Puijila darwini: infatti "puijila" in lingua Inuktitut significa « giovane mammifero di mare ». Invece darwini è un omaggio a Charles Darwin il quale fu il primo a teorizzare l'esistenza di anelli di ricongiunzione tra le diverse forme animali nel suo "L'origine delle specie", ed a postulare il possibile ritorno alla vita acquatica da parte di animali adattati alla terraferma. « Un animale strettamente terrestre, cacciando occasionalmente nelle acque poco profonde, poi nei fiumi e nei laghi, potrebbe essere convertito in un animale così perfettamente acquatico da affrontare l'oceano aperto », scrisse infatti l'autore della teoria della selezione naturale
Lo scheletro ritrovato era completo al 65 per cento, e ciò ha permesso una ricostruzione abbastanza dettagliata delle sembianze dell'animale; inoltre stato ritrovato sul fondo di un cratere insieme ai resti di pesci risalenti allo stesso periodo, e questo certamente conferma la natura acquatica dell'animale. Le ossa delle zampe con le loro falangi piatte lasciano supporre la presenza di estremità palmate, adatte al nuoto, mentre la struttura robusta degli arti indica che il mammifero riusciva a camminare agevolmente fuori dall'acqua. I lunghi canini fanno supporre che fosse un formidabile cacciatore, mentre la larga cavità infraorbitale nel cranio sembra indicare che disponesse di un olfatto particolarmente sviluppato, e forse di vibrisse come le attuali foche. Naturalmente a quell'epoca l'isola di Devon doveva godere di un clima assai più mite dell'attuale: i fossili fanno pensare che l'habitat di Puijila fosse ricco di foreste decidue e di conifere. Secondo il capo della ricerca Natalia Rybczynski, del Canadian Museum of Nature di Ottawa, « questa scoperta indica che i pinnipedi sono passati attraverso una fase di acqua dolce nella loro evoluzione ». « Puijila è la prova evolutiva che aspettavamo da tanto tempo », ha confermato Mary Dawson, biologa americana coinvolta nella ricerca.
L'antenato dei grandi felini
Alcuni fossili scoperti tre anni fa sull'altopiano tibetano sono risultati essere i più antichi mai rinvenuti tra quelli dei grandi felini, e appartenenti a membri di una specie che era finora sconosciuta battezzata Panthera blytheae, che viveva tra 5,95 e 4,10 milioni di anni fa (tra le 12.25.02 e le 16.00.07 del 31 dicembre), ed assomigliava al leopardo delle nevi. Tra i fossili dei felini del genere Panthera il più vecchio prima di questa scoperta risaliva a "soli" 3,6 milioni di anni fa (intorno alle ore 17), ed era stato trovato negli anni settanta in Tanzania. Panthera blytheae è il frutto di una spedizione compiuta nel 2010 in una zona remota e rocciosa nella contea di Zanda, nel Tibet sudoccidentale, una terra un tempo popolata dalla megafauna del Pleistocene, dove gli scienziati si aspettavano di trovare piuttosto resti di antilopi e rinoceronti preistorici. E invece, sorpresa: ossa e frammenti di cranio di un misterioso grande felino, almeno tre esemplari, e un teschio quasi intatto.
I grandi felini dunque verrebbero dall'Asia: lo studio di Panthera blytheae sembra colmare le precedenti discrepanze tra il fatto che, se la filogenetica molecolare sembrava puntare all'Asia quale terra d'origine dei felini, i pochi e frammentari resti più antichi delle specie appartenenti a Panthera erano state rinvenute in Africa. Adesso, grazie alla scoperta di questo antico felino di 20-25 chili che viveva nei climi rigidissimi delle montagne tibetane a un'altitudine media di 4.500 metri sul livello del mare, l'ipotesi dell'origine asiatica dei grandi felini ha una base molto più solida. « Questi fossili sono i più antichi, ma non sono assolutamente i più primitivi », ha dichiarato l'autore della scoperta, Jack Tseng del Museo Americano di Storia Naturale di New York: « c'è ancora qualche gattone che non è ancora stato descritto ». Alcuni colleghi hanno contestato l'affermazione dell'équipe guidata da Tseng, secondo cui Panthera blytheae sarebbe quasi identica a Panthera uncia, cioè al leopardo delle nevi che vive attualmente nelle catene montuose dell'Asia centrale. Se così fosse, ciò suggerirebbe una grande stabilità nell'adattamento delle specie nel corso di milioni di anni. In ogni caso, la storia dei grandi felini è importante per capire l'evoluzione di tutti i felidi, incluso il gatto domestico, la cui origine, secondo Tseng e colleghi, risalirebbe a 16 milioni di anni fa (alle 16.51.12 del 30 dicembre), cinque prima (otto ore e tre quarti prima) di quanto si pensasse in precedenza. Prove genetiche suggeriscono che la separazione tra Panthera e Felinae (i piccoli felini come le linci e il gatto domestico) sarebbe avvenuta circa 6,37 milioni di anni fa (alle 11.36 del 31/12).
Ma ho una sorpresa in serbo per voi. Una certa quantità di enigmatici fossili portati alla luce tra il 1978 e il 1980 in un sito nel Kenya occidentale chiamato Meswa Bridge è rimasta conservata e non studiata per decenni in un cassetto del Nairobi National Museum, in Kenya, ma nel 2019, grazie alle analisi di questi antichi resti, è emerso che appartenevano a un enorme mammifero carnivoro, di dimensioni maggiori rispetto a quelle di un orso polare: una nuova specie cui è stato attribuito il nome di Simbakubwa kutokaafrika. Questo possente predatore viveva sulla Terra circa 22 milioni di anni fa (alle 05.10.24 del 30 dicembre). In Swahili Simbakubwa si traduce con "grande leone", ma in realtà questo enorme animale non era un felino. Piuttosto, rappresenta il più antico membro noto di un gruppo di mammiferi estinti noti come ienodonti, così chiamati per via della somiglianza dei loro denti con quelli delle iene, anche se i due sono gruppi distinti. Prima ancora che i predecessori dei carnivori moderni come i leoni, le iene e i lupi si evolvessero, le scena globale dei predatori era sostanzialmente dominata dagli ienodonti. La scoperta contribuisce a chiarire alcuni aspetti dell'evoluzione di questo gruppo di enormi carnivori, che si situavano all'apice della catena alimentare negli stessi ecosistemi africani nei quali si stavano evolvendo le scimmie antropomorfe. Lo studio del fossile potrebbe inoltre aiutare gli scienziati a comprendere in modo più approfondito le ragioni per le quali questi predatori finirono per scomparire.
Le antenate delle balene
E non è tutto. Meredith Rivin, paleontologa presso la California State University di Fullerton, ha identificato nei fossili ritrovati durante i lavori di costruzione di una nuova strada attraverso Laguna Canyon (Los Angeles) nel 2000 da una squadra di operai, ben 11 specie di progenitori delle attuali balene, tra cui quattro del tutto nuove. Le moderne megattere e balenottere azzurre sono dotate di fanoni, strutture simili a lame sfilacciate appese alla superficie superiore della bocca, che usano per filtrare l'acqua di mare e cibarsi di plancton; invece le nuove specie scoperte, risalenti ad un'epoca compresa fra i 19 e i 17 milioni di anni fa (tra le 11.00.48 e le 14.54.24 del 30 dicembre), erano dotate di denti, e non sono antenate dirette delle odierne balene, ma piuttosto rappresentano un forma di passaggio vicina alle specie che avrebbero dato origine ai cetacei che conosciamo oggi. Il loro nome scientifico esatto è misticeti dentati.
Finora, ha dichiarato la Rivin, « si credeva che all'epoca di quei fossili i misticeti dentati si fossero estinti da circa cinque milioni di anni, e invece ne abbiamo trovato un'enorme varietà. Non solo non si erano estinti, ma anzi, il gruppo era molto variegato. Prima del ritrovamento di questi reperti non c'erano molti fossili di misticeti dentati risalenti al Miocene Inferiore. » I paleontologi che hanno lavorato accanto agli operai stradali, in molti anni di scavi hanno scoperto centinaia di ossa di balena e più di 30 crani. Tre delle nuove specie sono relativamente piccole, come dei moderni delfini; una delle specie più grandi, invece, una balena di 9 metri del genere Morawanocetus, è simile ad un'altra specie di balene antiche, Llanocetus denticrenatus, che si pensava estinta 35 milioni di anni fa (ore 03.52 del 29/12). Un altro cetaceo deve ancora essere estratto completamente dalla roccia, ma Meredith Ravin ha dichiarato che comunque questa balena è ben diversa da qualsiasi fossile abbia mai visto prima: i suoi denti hanno radici molto lunghe che si spingono fino all'osso. Lo studio sulle "nonne" balene prosegue.
Il panda spagnolo
Una novità diffusa dai giornali nel maggio 2012 che non può certo mancare in questo mio ipertesto: in Spagna vivevano ursidi imparentati geneticamente con gli attuali panda giganti della Cina. Infatti alcuni ricercatori del Museo Spagnolo di Scienze Naturali e dell'Università di Valencia hanno riportato alla luce a Nombrevilla, nella provincia di Saragozza, i resti fossili dell'Agriarctos beatrix, un antenato dei panda vissuto 11 milioni di anni fa (ore 02.35.12 del 31/12). Si trattava di un plantigrado onnivoro che non pesava più di 60 chili, meno del più piccolo degli orsi attuali (l'Helarctos malayanus della Malesia, che pesa 65 kg). Secondo Juan Abella, principale autore della ricerca, l'orsetto iberico viveva nelle foreste ed era più incline a salire sugli alberi di quanto facciano oggi l'orso polare e l'orso bruno, forse per sfuggire ai predatori. La sua dieta era composta da frutta, vegetali, insetti, miele e forse da carogne. La sua estinzione può essere stata causata dalla scomparsa dell'habitat forestale a scapito degli spazi aperti, che caratterizzò tutto il Miocene. In ogni caso, la scoperta dell'Agriarctos beatrix sposta indietro di due milioni di anni l'origine del gruppo di cui fa parte il panda gigante, in un'area che può essere identificata nel bacino a nord-est della penisola iberica.
|
|
|
Ricostruzione dell'Agriarctos beatrix (dal SINC) |
L'antenato dei capodogli
I racconti di mostri marini, dai tempi di Ulisse fino a quelli di Moby Dick, hanno turbato continuamente i sonni dell'umanità. Per la Bibbia, ad esempio, il mare è considerati simbolo del male, del disordine, del caos che si oppone all'azione creatrice di Dio. Ma, soprattutto nel passato geologico della Terra, questa non è stata sempre solo una metafora. Lo sanno bene Olivier Lambert del Museum National d'Histoire Naturelle di Parigi e l'italiano Giovanni Bianucci dell'Università di Pisa, i quali hanno riportato alla luce denti, teschio e mandibola di un mammifero marino fossile, probabilmente un antenato dell'odierno capodoglio, che però, a differenza di quest'ultimo, a giudicare dalla dentatura doveva essere un feroce predatore. Il fossile è stato rinvenuto in Perù, ha circa 13 milioni di anni ed è stato chiamato Leviathan melvillei: il Leviatano era infatti un mostro marino facente parte della mitologia ebraica, e così viene descritto nel libro di Giobbe 41, 10-24:
« Il suo starnuto irradia luce e i suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Dalla sua bocca partono vampate, sprizzano scintille di fuoco. Dalle sue narici esce fumo come da caldaia, che bolle sul fuoco. Il suo fiato incendia carboni, e dalla bocca gli escono fiamme. Nel suo collo risiede la forza, e innanzi a lui corre la paura. Le giogaie della sua carne sono ben compatte, sono ben salde su di lui, non si muovono. Il suo cuore è duro come pietra, duro come la pietra inferiore della macina. Quando si alza, si spaventano i forti, e per il terrore restano smarriti. La spada che lo raggiunge non vi si infigge, né lancia, né freccia né giavellotto; stima il ferro come paglia, il bronzo come legno tarlato. Non lo mette in fuga la freccia, in pula si cambiano per lui le pietre della fionda. Come stoppia stima una mazza, e si fa beffe del vibrare dell'asta. Al disotto ha cocci acuti, e striscia come erpice sul molle terreno. Fa ribollire come pentola il gorgo, fa del mare come un vaso da unguenti. Dietro a sé produce una bianca scia, e l'abisso appare canuto.. »
Questa spaventevole descrizione non appare inadatta al fossile appena scoperto, visto che la sua lunghezza poteva andare da 13 a 18 metri ed era dotato di denti giganteschi, lunghi 36 centimetri e con un diametro di 12 centimetri. Il Leviathan melvillei doveva essere il terrore dei mari; ed è stato probabilmente sotto la suggestione di questa dentatura da incubo che gli autori hanno battezzato la specie con il nome dello scrittore Herman Melville (1819-1891), autore di "Moby Dick", una delle creature più malvagie che la natura abbia mai partorito. Eppure anche questa sorta di "Balena Bianca" del Miocene si è estinta, non certo per mano del capitano Achab, ma probabilmente a causa di cambiamenti delle temperature oceaniche che divennero troppo basse per la sua sopravvivenza. Il suo discendente capodoglio (Physeter macrocephalus) è il più grande animale oggi vivente munito di denti, misura fino a 18 metri di lunghezza e riesce a spingersi fin nelle profondità abissali, dove ingaggia tremendi duelli con la sua preda preferita, i calamari giganti, Non è escluso che il "Moby Dick del Perù" con i suoi denti giganti arrivasse a predare altri grandi abitanti del mare, probabilmente le balene. Davvero davanti ad un mostro simile i nostri antenati avrebbero pensato che solo l'Onnipossente potesse contrastarlo, e che la sua morte fosse uno dei segnali della fine del mondo, come descrive Isaia 27, 1:
« In quel giorno il Signore punirà con la spada dura, grande e forte, il Leviatàn serpente guizzante, il Leviatàn serpente tortuoso, e ucciderà il drago che sta nel mare. »
Gli antenati dei colibrì
Anche i colibrì hanno una storia evolutiva che affonda le sue radici nel Miocene. Lo ha dimostrato un gruppo di scienziati guidati da Jim McGuire dell'Università della California a Berkeley, che in dieci anni di lavoro ha ricostruito lo studio dell'albero evolutivo dei colibrì, esaminando 284 delle 338 specie conosciute degli uccelli più piccoli del mondo. Si è trattato di un'analisi molto sofisticata di filogenetica molecolare, che ha portato a far risalire la prima diversificazione dei colibrì a 22 milioni di anni fa (ore 05.10.24 del 30 dicembre), quando invasero il Sudamerica e iniziarono una rapida evoluzione in nove gruppi principali. Il loro successo è dovuto in gran parte alla straordinaria relazione con i fiori dai quali succhiano il nettare: in pratica questi uccelli si sono evoluti insieme ai fiori.
McGuire e colleghi hanno scoperto che gli antenati dei colibrì si divisero dai rondoni già 42 milioni di anni fa (ore 14.14.24 del 28 dicembre), probabilmente in Eurasia, e solo 20 milioni di anni dopo arrivarono in Sudamerica, dove trovarono le condizioni ideali per la loro straordinaria storia evolutiva. La loro nicchia ideale sono state le Ande: proprio tra le vallate andine si è svolta la gran parte della diversificazione nel corso degli ultimi 10 milioni di anni, e nelle stesse zone ora vivono circa 140 specie di colibrì. La colonizzazione del Nord America e dei Caraibi avvenne a partire da 5 milioni di anni fa (ore 14.15.59 del 31 dicembre). « Lo studio mostra come queste specie siano molto vulnerabili se le loro nicchie ecologiche vengono alterate », ha concluso lo studioso californiano: un monito per tutti noi a non porre fine a tanto preziosa biodiversità.
Il superpappagallo
Il pappagallo più grande della preistoria e vissuto in Nuova Zelanda: i suoi resti fossili sono stati trovati nel 2008 nei pressi di Saint Bathans, in un giacimento fossile risalente a circa 19 milioni di anni fa (alle 11.00.48 del 30 dicembre), in Central Otago nell'Isola del Sud. All'inizio si pensava si trattasse di un'aquila di enormi dimensioni, ma i paleontologi della Flinders University di Adelaide guidati dal professor Trevor Worthy si sono dovuti ricredere. Il pappagallo conservato nel Canterbury Museum di Christchurch pesava sette chilogrammi ed appare grande il doppio del neozelandese kakapo; proprio per questo, oltre che per la sorprendente scoperta, è stato chiamato Heracles inexpectatus. Una volta stabilito che si trattava di un animale sconosciuto, la sfida era capire da quale famiglia provenisse. Poiché non erano stati scoperti pappagalli giganti in passato, ci è voluto del tempo per differenziarlo da tutti gli altri uccelli e stabilire che, dato l'insieme unico di caratteristiche, si trattava definitivamente di un pappagallo.
Sebbene la regione sia ora di clima freddo, l'ambiente dell'epoca era tale che l'Heracles avrebbe vissuto vicino a un grande lago in una fitta foresta subtropicale. La sua dieta è sconosciuta; la maggior parte dei pappagalli oggi sono vegetariani, ma quando gli animali sono più grandi, sono predatori. Era così grande che avrebbe richiesto una notevole quantità di calorie al giorno. Si pensa che, grazie al suo becco grande e affilato, Heracles si cibasse di noci e bacche, senza però disdegnare piccole prede. Ancora oggi esistono esempi di pappagalli neozelandesi onnivori che si nutrono uccelli marini. Il kiwi della Nuova Zelanda e il dodo di Mauritius sono esempi di come gli ecosistemi nelle isole abbiano prodotto uccelli grandi e incapaci di volare prima dell'introduzione o dell'evoluzione di predatori terrestri. Le due isole della Nuova Zelanda hanno ospitato un numero particolarmente elevato di tali specie grazie alle loro grandi dimensioni, all'ecosistema complesso e all'assenza di predatori.
Le antiche giraffe che si prendevano a testate
Nel 1996 il paleontologo cinese Jin Meng, curatore responsabile della sezione mammiferi fossili presso il Museo di storia naturale di New York, ha scoperto uno strano cranio nella vasta e arida distesa del bacino di Junggar, nella Cina settentrionale: un cranio robusto e massiccio, con una placca ossea di quasi un centimetro di spessore intorno all'area in cui si sarebbe trovata la fronte dell'animale. Anche alcune vertebre del collo scoperte nelle vicinanze erano vistosamente ispessite, e quindi erano adatte a resistere a un enorme sforzo. Egli chiamò la sua scoperta "guài shòu", cioè "strana bestia", ma nel 2021 le diede un nome ufficiale: Discokeryx xiezhi. Esso visse circa 16,9 milioni di anni fa (circa alle ore 15 del 30 dicembre) ed era un antico parente delle giraffe odierne. A differenza delle giraffe viventi, il cui collo presumibilmente si è evoluto principalmente per nutrirsi delle foglie in cima agli alberi, il cranio e le vertebre spesse di Discokeryx erano quasi certamente il risultato di una competizione sessuale: i maschi insomma si scontravano per le femmine a suon di testate con una forza forse mai vista prima nel regno animale, come facevano alcuni dinosauri. Questa specie fornisce un buon esempio di adattamento estremo, dimostrando che gli animali, anche quelli filogeneticamente imparentati, possono evolvere in direzioni completamente diverse tra loro.
Nel Miocene medio, l'attuale habitat desertico della Cina settentrionale era caldo, umido e adatto alla vita di una serie di specie diverse. Meng e i suoi colleghi hanno analizzato lo smalto di un dente ed eseguito scansioni di tomografia computerizzata di due crani per rivelarne la struttura interna, confrontando i resti dell'animale con i fossili di oltre 50 altre specie trovati nella stessa area, la maggior parte delle quali erano ungulati come Discokeryx. Le prove indicano che Discokeryx condivideva alcune caratteristiche morfologiche con le giraffe moderne e probabilmente si nutriva forse di un mix di fogliame ed erba. Aveva le dimensioni di una grossa pecora, ma la testa e il collo di questa specie erano forse tra i più robusti mai posseduti da un mammifero, e forse anche da qualsiasi creatura precedente, visto che i ricercatori cinesi hanno individuato in Discokeryx la più complessa articolazione testa-collo tra i mammiferi noti finora. Pachycephalosaurus è un dinosauro famoso per i duelli a testate, il suo nome significa infatti "lucertola dal cranio spesso". Eppure gli esperti di dinosauri con cui Meng e i suoi colleghi si sono consultati hanno confermato che la struttura unica della testa e del collo di Discokeryx probabilmente gli consentiva di sopportare colpi ancora più forti!
Anche tra i maschi delle giraffe moderne si svolgono feroci battaglie per la conquista delle femmine; però, anche se Discokeryx xiezhi condivide l'albero filogenetico con esse, le giraffe moderne usano il collo per combattere, non la testa. L'evoluzione di questi colli allungati anzi potrebbe essere avvenuta proprio per combattere, e non solo per raggiungere il fogliame. Insomma, il comportamento può aver fortemente influenzato l'evoluzione morfologica: si tratterebbe di un comportamento estremo che porta a un'evoluzione morfologica estrema nei giraffoidi. Naturalmente l'evoluzione del collo lungo delle giraffe moderne è tutt'altro che una questione risolta, perché anche le giraffe femmine hanno un collo lungo e sia i maschi sia le femmine hanno arti molto lunghi; in realtà, è possibile che a guidare l'evoluzione del collo e degli arti delle giraffe moderne sia stata una combinazione, in quel ramo filogenetico, di selezione naturale per una particolare preferenza alimentare e di selezione sessuale. Per quanto riguarda Discokeryx, invece, la sua struttura cranica si è quasi certamente evoluta come risultato della selezione sessuale e del combattimento tra maschi. Quando si dice: botte da orbi...
Il Megapiranha dal morso assassino
Sempre parlando di creature mioceniche acquatiche, non si può non far cenno al Megapiranha paranensis, vissuto circa 10 milioni di anni fa (ore 04.31.59 del 31/12) in Sudamerica. Infatti, come ha scoperto Stephanie Crofts, dell'Università di Washington, questo pesce in rapporto alle sue dimensioni aveva il morso più potente mai apparso sulla Terra. Sviluppava una potenza superiore addirittura superiore a quella dei re dei morsi: il Dunkleosteus terrelli del Devoniano, il Tirannosaurus rex del Cretacico e il supersqualo Carcharodon megalodon dell'Oligocene.
La potenza del morso del megapiranha era tale da permettergli di spaccare conchiglie dallo spesso guscio e le ossa dei pesci. Il confronto è stato fatto con il morso del più forte dei piranha attuali, il piranha nero (Serrasalmus rhombeus), un pesce di circa 1,1 kg che sviluppa un morso con una forza di 320 Newton, pari a oltre 32 kg, corrispondente a oltre 30 volte il suo peso, e a tre volte più del morso dell'alligatore. Considerando che il megapiranha pesava circa 10 chili, secondo le estrapolazioni dei fossili ritrovati, probabilmente sviluppava un morso stimabile tra 1.240 e 4.750 Newton, ossia tra 127 e 485 kg, e forse anche di più: una forza spaventosa, in rapporto alle dimensioni del pesce preistorico. Gli scienziati hanno stimato che il Tirannosaurus rex era in grado di sviluppare nel suo morso una forza di 13.400 Newton (oltre 1.360 kg), pari a meno di trenta volte il suo peso. Conclusione: alla larga dai piranha, soprattutto nel Miocene!
La fine della tundra antartica
Come ha concluso uno studio condotto da ricercatori della Rice University e della Louisiana State University, risalirebbero a 12 milioni di anni fa (alle 00.38.24 del 31 dicembre) le ultime tracce di vegetazione a tundra nel continente antartico. Questo importante risultato è stato ottenuto esaminando accuratamente migliaia di singoli granelli di polline fossili, che si sono conservati nei sedimenti fangosi sotto il fondale marino al largo della costa della Penisola Antartica, sotto quasi 100 metri di roccia sedimentaria. I ricercatori sono stati così in grado di accertare con precisione le specie di piante che esistevano nella Penisola negli ultimi 36 milioni di anni (cioè nelle ultime 70 ore dell'Anno della Terra). « Abbiamo potuto ricostruire un quadro dettagliato del rapido declino delle foreste durante il tardo Eocene e l'avanzata dei ghiacci nel medio Miocene, circa 12 milioni di anni fa », ha dichiarato John Anderson, principale autore dello studio in cui è tracciato il quadro più dettagliato finora ottenuto di come fino la Penisola Antartica ha progressivamente ceduto all'espansione dei ghiacci durante un prolungato periodo di raffreddamento globale. « Il modo migliore per prevedere i futuri cambiamenti nel comportamento dei ghiacci antartici e la loro influenza sul clima è quello di capirne il passato ».
« Vi è un dibattito di vecchia data su quanto rapidamente sia progredita la glaciazione in Antartide », ha aggiunto Sophie Warny, che ha curato la ricostruzione palinologica suddetta. « Il responso dei reperti fossili è univoco: l'espansione glaciale nella Penisola Antartica è stato un processo lungo e graduale, influenzato da cambiamenti atmosferici, tettonici e oceanografiche. » Inutile aggiungere che queste ricerche hanno suscitato interrogativi sul modo in cui quella coltre glaciale reagirà all'aumento globale delle temperature previste per i prossimi decenni.
Il fossile vivente del Laos
Un'altra notizia che ha dell'incredibile è arrivata dal lontano Laos nel marzo 2006. Mary Dawson, studiosa del Museo di storia naturale Carnegie, ha scoperto nelle foreste della nazione asiatica uno strano roditore metà topo e metà scoiattolo, già noto da tempo agli abitanti del luogo che lo chiamano « kha-nyou » ("topo delle rocce"). Non sarebbe una gran notizia, se non fosse per il fatto che la famiglia di mammiferi cui esso appartiene, i Diatomidi (Diatomydae), era fino ad allora considerata estinta da non meno di 11 milioni di anni (quindi dalle 2.35 del mattino del 31 dicembre dell'Anno della Terra), e precisamente tra la fine del Serravaliano e l'inizio del Tortoniano (vedi sopra). La famiglia prende il nome dal Diatomys, un roditore i cui resti fossili erano stati ritrovati in Cina e poi in varie parti dell'Asia nel 2005; il nuovo mammifero è stato battezzato Laonastes aenigmamus, e, a detta degli scopritori, rappresenta una rara opportunità per verificare se le informazioni che si erano tratte dall'analisi dei fossili circa le caratteristiche dell'organismo vivente erano corrette. Insomma, un fossile vivente che ci aiuta a capire come vanno ricostruiti i fossili del passato.
|
|
| Laonastes aenigmamus, il fossile vivente del Laos (dis. dell'autore) |
Il mostro con il becco dell'Argentina
Sul numero di ottobre 2006 della rivista Nature è stata pubblicata la notizia della scoperta del più grande uccello predatore di tutti i tempi, vissuto proprio nel Miocene e scoperto da Luis Chiappe e Sara Bertelli, due scienziati del Museo di storia naturale di Los Angeles. Esso appartiene alla famiglia dei Phorusrhacidi, è vissuto 15 milioni di anni fa (alle 18.48 del 30 dicembre dell'Anno della Terra) ed è stato ritrovato a Comallo, in Argentina. La sua stazza era paragonabile a quella dei suoi antenati dinosauri, essendo alto circa 3 metri. A causa della sua incredibile stazza era incapace di volare, ed occupava la nicchia ecologica dei carnivori; infatti aveva artigli enormi e un pericoloso becco, con il quale era in grado di inghiottire un mammifero grande quanto un agnello. Il teschio di questo mostro misura oltre 70 centimetri, circa il 10% più grande delle specie di Phorusrhacidi finora rinvenute: l'Argentina si conferma terra di giganti, come già detto a proposito dei dinosauri.
« I Phorusrhacidi divennero i più grandi predatori conosciuti quando il Sudamerica era isolato dalle altre masse continentali », dice Luis Chiappe. Probabilmente la scoperta cambierà molte teorie legate agli spostamenti e alle migrazioni degli uccelli avvenute nel Cenozoico. Fino ad ora infatti i paleontologi sostenevano che questi uccelli, essendo giganteschi, avessero grandi difficoltà a muoversi velocemente; ma i fossili ritrovati dimostrano che l'uccello aveva piedi agili e lunghi che gli permettevano di muoversi velocemente come gli emù e gli struzzi. « Quest'uccello probabilmente cacciava inseguendo gli altri animali, soprattutto i mammiferi, e usava il suo becco per colpirli e abbatterli », ha affermato Chiappe. « Molto probabilmente in futuro scopriremo che durante quel periodo, tra 60 e 2 milioni di anni fa, sono esistite numerose e affascinanti specie molto simili a questa ». E molto pericolose, aggiungo io.
L'uccello Roc delle pampas
Evidentemente l'Argentina è terra di fossili incredibili, perché è qui che sono stati dissepolti, oltre ai resti del più grande uccello non volatore, anche quelli del più grande uccello volatore mai esistito, l'Argentavis magnificens. Questo pazzesco animale, del quale sono note alcune parti del cranio, un omero incompleto e altre ossa delle ali, aveva un'apertura alare di sette metri, e quindi era in grado di rivaleggiare, in quanto a dimensioni, con i più grandi pterosauri: per fare un confronto, quella del grifone può raggiungere i 2,80 metri, e l'esemplare di uccello vivente con la maggiore apertura alare mai documentata, un albatros urlatore, arrivava ai 3,63 metri. Le caratteristiche del volo dell'Argentavis sono state descritte dai ricercatori della Texas Tech University sulle pagine dei "Proceedings of the National Academy of Science". Dai ritrovamenti effettuati nella Formazione di Andalhuala, vicino a Catamarca, alle pendici delle Ande, nella Formazione di Epecuen nei pressi di Carhue, e nelle Salinas Grandes de Hidalgo, nella pampa argentina, risulta che molto probabilmente l'uccello non possedeva la muscolatura in grado di sollevare la sua massa, stimata intorno ai 70 chilogrammi, né per mantenere un battito d'ali costante durante il volo. Eppure era sicuramente capace di volare: impronte visibili di inserzioni di penne remiganti sulle ossa delle sue ali lasciano pochi dubbi in proposito. Questo fatto confuta la teoria secondo la quale il massimo limite per gli uccelli volatori era rappresentato da forme odierne come cigni, albatros, condor e otarde. Con un vento considerevole, l'uccello poteva librarsi in volo semplicemente spiegando le sue ali, proprio come gli albatros odierni. Infatti il Sudamerica, durante il Miocene, era esposto a forti correnti occidentali, dal momento che le Ande avevano appena iniziato a formarsi e non erano molto alte.
L'Argentavis era dunque un esperto del volo planato, ottenuto sfruttando al meglio le correnti ascensionali e spiccando il volo da punti molto elevati, così come fanno molti uccelli odierni. « Ma una volta che si trovava su una corrente ascensionale, poteva probabilmente guadagnare uno o due chilometri di quota senza neanche un battito d'ali, ma semplicemente mantenendo una rotta circolare. Una volta guadagnata quota, poteva passare a un'altra corrente ascensionale e percorrere in questo modo fino a 300 chilometri al giorno », ha dichiarato Sankar Chatterjee, curatore della sezione di paleontologia del Museo del Texas Tech University e coordinatore della ricerca.
E l'Argentavis, vissuto nella pampa argentina nel Miocene superiore, era in buona compagnia. Esso infatti fa parte della famiglia dei Teratorniti, uccelli da preda vissuti in Nordamerica e Sudamerica dal Miocene al Pleistocene., che include i più grandi uccelli volatori mai esistiti. Le parentele dei teratorniti con gli altri uccelli da preda non sono chiare: la maggior parte dei paleontologi ritiene che fossero imparentati con gli attuali condor. Per questo tradizionalmente i teratorniti sono stati descritti come divoratori di carogne, molto simili a enormi condor, ma i lunghi becchi ricurvi sono molto più simili a quelli delle aquile e di altri uccelli predatori attivi, che a quelli degli avvoltoi. Molto probabilmente questi enormi uccelli erano anche saprofagi, ma sembra che il loro nutrimento si basasse nella maggior parte dei casi sulla predazione attiva, se è vero che Argentavis avrebbe potuto tranquillamente inghiottire una lepre tutta intera. Non c'è da stupirsi se foto delle ricostruzioni di questi mostri dell'aria vengono spesso inserite nelle raccolte di animali strani e misteriosi che circolano in Internet, come mostra l'immagine sottostante, in cui si vede il dottor Kenneth E. Campbell, uno degli scopritori, accanto a una ricostruzione di questo vero e proprio Boeing vivente nel Museo di Storia Naturale di Los Angeles.
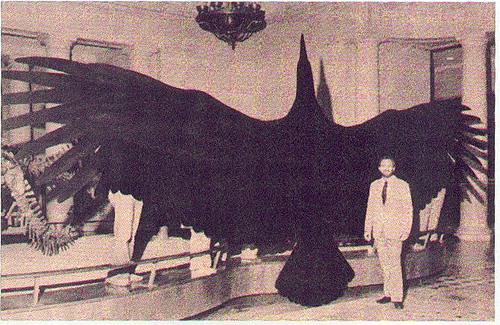
Un altro uccello di dimensioni eccezionali era Pelagornis chilensis, un uccello marino la cui apertura alare poteva raggiungere i 5,20 metri, scoperto nel Cile del Nord da Gerald Mayr del Museo di Storia Naturale Senckenberg a Francoforte, in Germania, e David Rubilar del Museo Nazionale di Storia Naturale di Santiago del Cile. Esso appartiene alla famiglia dei pelagornitidi, chiamati anche uccelli dentati, perché il bordo del loro lungo becco era ornato di proiezioni spinose che ricordano i denti, la cui funzione era quella di trattenere le prede catturate in mare aperto. Fossili di uccelli con il becco orlato di pseudo-denti sono stati trovati in tutti i continenti, ma si trattava per lo più di campioni incompleti e frammentari, in quanto le fragili ossa di questi animali difficilmente resistono ai processi di fossilizzazione. Il nuovo fossile è invece integro e completo al 70 %, cosa che ha fornito importanti informazioni sulle dimensioni e sull'anatomia di questo strano uccello. « Per quanto questi animali possano in qualche modo ricordare per l'aspetto le creature di Jurassic Park, si tratta in realtà di veri uccelli, i cui ultimi rappresentanti possono anche essere coesistiti con i primi esseri umani in Africa settentrionale », ha dichiarato Mayr. Ma vi è una differenza fondamentale fra l'Argentavis, il Pelagornis e il mitologico uccello Roc dei racconti di Simbad il Marinaio, in grado di ghermire e sollevare anche un elefante: quest'ultimo appartiene al mito, mentre l'Argentavis e il Pelagornis sfrecciarono davvero sulle pampas sudamericane cinque milioni di anni fa, terrorizzando ogni creatura di piccola taglia vivente al suolo. E nessun mito può essere più terrificante di un predatore in carne e ossa!
Ubriaconi preistorici
L'alcool fa parte dell'esistenza umana da millenni. Le bevande alcoliche sono parte integrante della nostra cultura, e hanno usi cerimoniali e religiosi. Fino al XIX secolo birra, brandy, rum o grog (una miscela di acqua e rum) erano le bevande dei marinai, preferite all'acqua che ristagnava durante i lunghi viaggi. L'alcool è un lubrificante sociale, un anestetico e un antisettico. È una delle droghe più usate del mondo, e si è iniziato a produrlo fin dall'avvento dell'agricoltura, quasi 9000 anni fa (ore 23.58.57). Ma come mai questo inebriante veleno è entrato a far parte dell'esistenza umana? Nel 2015 uno studio ha dimostrato che la capacità di digerire l'alcool fu acquisita circa 10 milioni di anni fa (alle 04.32 del 31/12), da un antenato comune di esseri umani, scimpanzè e gorilla, quindi senz'altro ben prima che imparassimo a produrlo. Ciò indica che questa sostanza entrò nella dieta umana molto prima di quanto si pensasse, e con modalità che ebbero implicazioni significative per la sopravvivenza della nostra specie.
Gli esseri umani portano con sé le firme genetiche delle loro abitudini alimentari ancestrali. Le varianti genetiche che rendono disponibili nuove fonti di cibo possono offrire grandi opportunità a chi ne è portatore. La capacità di consumare latte, per esempio, è dovuta alla variante, nota come persistenza della lattasi, di un gene che è emerso circa 7500 anni fa (ore 23.59.07) tra primi europei. Per chi non ha la mutazione, il lattosio del latte è un leggero veleno, che provoca sintomi simili a quelli della dissenteria. Allo stesso modo, la capacità di digerire l'alcool può essere una firma genetica di modelli alimentari diffusi tra gli antenati degli esseri umani: la tolleranza all'alcool può aver consentito di mangiare la frutta troppo matura che, caduta a terra, aveva iniziato a fermentare naturalmente. Poiché pochi animali sono in grado di tollerare l'alcool, questo avrebbe fornito i nostri antenati una fonte di cibo abbondante e per cui c'erano pochi concorrenti. E potrebbe aver contribuito al passaggio ad abitudini di vita terricole invece che arboricole.
La lisi dell'alcool dopo l'ingestione è un processo complicato, che coinvolge un certo numero di enzimi. La maggior parte dell'alcool viene scisso nell'intestino e nel fegato. Matthew Carrigan e colleghi del Santa Fe College hanno analizzato l'enzima ADH4, abbondante nell'intestino, che svolge un ruolo importante nell'impedire che l'alcool ingerito abbia accesso al flusso sanguigno. In particolare, gli autori hanno testato la capacità di digestione dell'alcool dell'ADH4 di nostri parenti lontanissimi come gli scandenti, piccoli animali simili al toporagno. Si è così scoperto che la forma di ADH4 che si trova negli esseri umani, gorilla e scimpanzè è 40 volte più efficiente nella scissione dell'alcool di quella trovata nelle specie più primitive. L'ADH4 consente di digerire anche le sostanze chimiche che le piante producono per non farsi mangiare dagli animali, ma con l'aumento della capacità di digerire l'alcool è emersa una capacità ridotta di digerire molte di queste altre sostanze chimiche. Ciò indica che gli alimenti contenenti alcool erano più importanti. Ma anche se l'ADH4 è tra i più importanti enzimi per la digestione dell'alcool, non è l'unico. C'è un altro enzima simile, l'ADH3, che contribuisce alla lisi dell'alcool. Le donne di solito hanno livelli di attività più bassi di questo enzima, il che le porta ad avere tassi alcolemici più elevati rispetto agli uomini dopo l'assunzione di una dose elevata della sostanza. Inoltre, l'ADH4 non è l'unico enzima che può aver aiutato gli esseri umani ad adattarsi al consumo di alcool: una variante di un enzima epatico, l'ADH1B, ad elevata attività nella lisi dell'alcool, è comparso nelle popolazioni dell'Asia orientale con l'avvento della coltivazione del riso, forse come forma di adattamento alla fermentazione di questo cereale. È interessante notare che gli altri animali hanno adottato proprie strategie: utilizzando un enzima diverso, una specie della famiglia del toporagno è in grado di consumare il nettare dei fiori di palma fermentato, l'equivalente di 10-12 bicchieri di vino al giorno, senza evidenti segni di intossicazione.
Gli esseri umani fanno affidamento sull'ADH4 come enzima principale per digerire l'alcool, e per questo motivo sono anche sensibili ai postumi di una sbornia. L'ADH4 e altri enzimi simili digeriscono l'alcool convertendolo in un'altra sostanza chimica, l'acetaldeide, che provoca l'arrossamento della pelle, mal di testa e altri sintomi. Il moderno consumo di alcool è stato anche definito una “sbornia evolutiva”: l'adattamento a livelli modesti di alcool nel cibo ha lasciato gli esseri umani a rischio di abuso di alcool, una volta appreso come produrne forme altamente concentrate. E, in effetti, varianti genetiche dell'ADH4 sono state collegate ad alcool e alla tossicodipendenza, anche se ci sono molti altri geni che possono influenzare la suscettibilità alla dipendenza da alcool. Indipendentemente dal ruolo che ADH4 gioca nella dipendenza da alcool, è comunque chiaro che il nostro complesso rapporto con l'alcool risale a milioni di anni fa, ancora prima che esistesse la specie umana.
La famiglia degli ominoidei si spezza in due
L'arboricolo Proconsul africanus potrebbe essere stato il capostipite della superfamiglia degli ominoidei, che comprende la nostra specie, le grandi scimmie (oranghi, gorilla, scimpanzé e bonobo) e gli ilobatidi (gibboni e siamanghi). All'interno della famiglia degli ominoidei si distinsero due grandi rami evolutivi: quello che avrebbe portato alle grandi scimmie antropomorfe africane, e quello che avrebbe portato nel Neozoico al genere Homo, cioè a noi. Purtroppo, i fossili a nostra disposizione a cavallo di questo cruciale periodo di transizione sono scarsissimi, e dunque risulta veramente difficile spiegare il motivo della grande separazione interna alla superfamiglia degli ominoidei, tra quanti portarono al gorilla, quanti al gibbone, quanti all'orango, quanti allo scimpanzè e quanti all'uomo. Secondo la teoria ormai classica, proposta nel 1983 dal francese Yves Coppens (1934-vivente), questa differenziazione tra la linea evolutiva dell'uomo e quella delle odierne scimmie antropomorfe va ricollegata ai giganteschi sommovimenti geologici che ebbero luogo in Africa orientale circa 10 milioni di anni fa (alle 04.32 del 31 dicembre), che apersero una spaccatura nella crosta terrestre oggi nota come Rift Valley. La formazione di questa lunga vallata, che va dalla depressione del mar Morto e del Giordano fino ai grandi laghi dell'Africa sudorientale attraverso il mar Rosso ed il triangolo di Afar in Etiopia, fece sì che ad ovest della Rift Valley gli antenati degli attuali scimpanzè e gorilla continuassero a vivere nel clima umido e ricco di vegetazione arborea tipico della foresta tropicale. Invece ad est le condizioni ambientali mutarono profondamente: il suolo si inaridì, le foreste scomparvero, al loro posto si diffusero le savane, ed i primati si ritrovarono tra gli animali più vulnerabili perchè, essendo quadrumani, non erano veloci nella fuga e non avevano mezzi efficaci per difendersi. Se sopravvissero, è perché svilupparono un cervello più grosso di quello di ogni altro mammifero, in proporzione al corpo, ed una postura eretta: un vantaggio non da poco, visto che consentiva loro di dominare la savana al di sopra delle alte erbe, avvertendo il pericolo con anticipo.
Anche questa ipotesi però, per quanto assai convincente, deve oggi essere rivista, dopo la scoperta, avvenuta nel 1995 in Ciad (ossia 2000 Km a ovest della Rift Valley), di un australopiteco (vedi più sotto) vecchio di 3 milioni di anni, l'Australopithecus bajrelghazali. Comunque sia, le scimmie antropomorfe rimaste nella foresta appartenevano al genere Dryopithecus, antenate (come conferma l'analisi dei loro denti) dei moderni scimpanzè e gorilla, mentre Pliopithecus, scoperto nel 1837 dal francese Edouard Lartet (1801-1871), fu il primo gibbone, ed infatti possedeva già le lunghissime braccia caratteristiche di questo genere. Il primo primate con caratteri simili a quelli umani fu considerato a lungo invece il Ramapithecus ("scimmia di Rama", per ricordare l'eroe protagonista del poema epico indiano Ramayana), ritrovato nel 1934 in India da George Edward Lewis, dell'Università di Yale: probabilmente viveva ai margini della foresta ed era carnivoro, a differenza della maggior parte degli altri primati. Da allora e fino all'inizio degli anni ottanta Ramapithecus fu considerato il primo primate ominoide antenato dell'uomo. Oggi invece si tende a considerarlo meno "umano" di quanto sembrasse all'inizio, e molti tendono a ritenerlo piuttosto l'antenato dell'orango (Pongo pygmaeus, dal malese "orang-utan", cioè "uomo dei boschi"); e c'è chi addirittura ritiene che i fossili di Ramapithecus altro non siano che i resti delle femmine di un'altra specie ominoide, il Sivapithecus, caratterizzata da forte dimorfismo sessuale.
E c'è anche chi è in completo disaccordo con la teoria tradizionale. Infatti, secondo una ricerca condotta da paleoantropologi della Baylor University a Waco, in Texas, dell'Università del Minnesota e della City University of New York, proprio la densa foresta tropicale avrebbe giocato un ruolo di primo piano nell'evoluzione dell'essere umano, perché sarebbe in quell'ambiente che si sarebbero evoluti gli ominoidei. Com'è noto, è raro trovare un sito che contenga contemporaneamente fossili di ominoidei ben conservati e una quantità di indicatori paleoambientali tale da consentire di stabilire dei collegamenti fra singole specie e habitat specifici. Nel loro studio Lauren Michel e colleghi hanno analizzato gli indicatori ambientali relativi al Miocene inferiore di uno di questi rari siti, quello di Rusinga Island in Kenya, nel quale sono stati trovati i resti di un esemplare di Proconsul insieme a diversi fossili di animali e vegetali. Fra questi ultimi spiccano ceppi di alberi fittamente addensati e foglie ben conservate di specie prevalentemente sempreverdi, mentre i dati paleoclimatici suggeriscono che la temperatura variasse fra i 22,6° e i 34,5° C, e che il livello delle precipitazioni fosse relativamente elevato. Insieme ai molti fossili di altre scimmie e vertebrati rinvenuti, questo prova la presenza di una densa foresta a baldacchino a più strati, un tipo di foresta che però è esistita in un intervallo temporale ristretto all'interno di una storia paleoambientale del Miocene inferiore molto più lunga. Precedenti studi sulla struttura anatomica di Proconsul avevano indicato che, pur preferendo gli spostamenti sugli alberi, questo antico primate era già adattato anche per muoversi a terra, una capacità che si era quindi evoluta prima che nella regione si diffondessero gli ambienti aperti. Anche questo Nodo di Gordio appare perciò assai difficile da sciogliere.
Il Pierolapithecus e il Nakalipithecus
A complicare il quadro del suddetto "divorzio" interno alla superfamiglia degli ominoidei è venuta una scoperta compiuta nel novembre 2004, e pubblicizzata dalla rivista Science, riguardante i resti fossili di una piccola scimmia antropomorfa vissuta circa 13 milioni di anni fa (alle 22.41 del 30 dicembre), non in Africa ma, sorprendentemente, in Europa, e più precisamente in Spagna, nel comune di Pierola. La specie è stata perciò battezzata Pierolapithecus catalaunicus I resti, trovati consistono in un cranio, alcune costole, vertebre, articolazioni delle mani ed altri piccole ossa. Il piccolo esemplare a cui appartenevano i resti fossili è stata chiamata Pau, che in catalano significa "pace", perché la scoperta è stata fatta durante alcune grandi manifestazioni contro la guerra in Iraq. Il paleontologo Salvador Moyà-Solà, dell'Istituto di Paleontologia di Sabadell (Barcellona), considera questa specie addirittura un antenato comune fra i grandi primati e la razza umana!! La scoperta fa il paio con il recente ritrovamento nel continente americano, avvenuto nel luglio 2005, di quella che pare un'orma umana: essa sembra spostare la presenza umana in esso molto più indietro di quanto fino ad ora ritenuto (dal 13.000 al 40.000 a.C.), ponendo grossi problemi riguardo alle teorie della lenta migrazione della specie umana. Queste scoperte hanno messo fortemente in discussione per qualche tempo la teoria che le diverse specie umane abbiano avuto origine in Africa: secondo alcuni, sulla base di questi ritrovamenti bisognava ammettere che le scimmie catarrine si fossero estinte in Africa verso la metà del Miocene, circa 14 milioni di anni fa (alle 20.45 del 30 dicembre), sopravvivendo invece in Europa e in Asia, per poi tornarvi all'inizio del Pliocene e dare origine ai generi Australopithecus e Homo. Ma l'ipotesi è rimasta in voga solo per pochi anni.
Oggi infatti gli antropologi ritengono, unicamente in base a studi sul DNA e non su resti fossili, scarsissimi durante tutto questo periodo di transizione, che l'esatta linea di separazione tra uomo e gorilla sia da collocarsi tra 9 e 8 milioni di anni fa (dalle 06.28 alle 8.25 del 31 dicembre), mentre quella tra uomo e scimpanzè tra 7 e 5 milioni di anni fa (dalle 10.22 alle 14.15 del 31 dicembre). A gettare luce su questo autentico "buco nero" di fossili è venuta la scoperta di un grande ominoide, Nakalipithecus nakayamai, ad opera di un gruppo di ricercatori giapponesi e kenyoti. I suoi resti fossili, cioè parte di un arco mandibolare con alcuni denti, sono stati rinvenuti in rocce datate circa 9,8 milioni di anni fa (alle 04.55 del 31 dicembre) presso Nakali, nella Rift Valley del Kenya. Secondo Scientific American che ne ha dato notizia al mondo, la mandibola dovrebbe appartenere ad un individuo delle dimensioni di un gorilla femmina. L'usura dei denti dimostrerebbe che la dieta di questo ominoide era per lo più vegetariana. Questo Nakalipithecus è senz'altro il fossile conosciuto più vicino all'ultimo antenato comune fra l'uomo e le grandi scimmie antropomorfe africano; la sua scoperta confuta definitivamente l'ipotesi dell'estinzione delle catarrine africane avanzata da più parti dopo la scoperta di Pierolapithecus, del quale si è detto subito sopra: ipotesi che del resto era già stata messa in discussione dalla scoperta di altri due ominoidei poco più antichi di Nakalipithecus, cioè Samburupithecus e Chororapithecus, rispettivamente in Kenya e in Etiopia. Anche in questo caso, solo la scoperta di nuovi importanti fossili potrà gettare nuova luce su uno dei periodi più misteriosi della nostra storia evolutiva.
 Il
cucciolo di Nyanzapithecus
Il
cucciolo di Nyanzapithecus
Un cranio fossile eccezionalmente completo scoperto nel 2017 e risalente a 13 milioni di anni fa (alle 22.41 del 30 dicembre) potrebbe far luce sul lontano antenato comune agli esseri umani e alle grandi scimmie: oranghi, gorilla, scimpanzé e bonobo, che insieme a noi costituiscono la famiglia degli ominidi. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori coordinati da Isaiah Nengo, della Stony Brook University, e Fred Spoor del Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie a Lipsia. L'analisi del reperto sembra segnare un punto significativo a favore della tesi che gli antenati delle grandi scimmie si siano evoluti in Africa, e non, come sostenuto da altri paleoantropologi, in Eurasia per migrare successivamente in Africa. Si sa ben poco sull'evoluzione degli antenati comuni con le altre grandi scimmie, vissuti fra i 17 e i 7 milioni di anni fa (tra le 14.54 del 30/12 e le 10.22 del 31/12), per i quali disponiamo di ben pochi fossili, costituiti principalmente da denti isolati e da ossa parziali. In particolare, appariva grave la lacuna fra i 14 e i 10 milioni di anni fa (tra le 22.41 del 30/12 e le 04.32 del 31/12), un lasso di tempo per il quale finora non c'era alcun cranio fossile, neppure parziale. Il cranio ritrovato nel sito di Napudet, nella parte meridionale del bacino del Turkana, in Kenya, colma finalmente questa lacuna. Come riferiscono i ricercatori, apparteneva a un giovanissimo esemplare di una nuova specie, Nyanzapithecus alesi, i cui tratti ricordano in parte quelli degli attuali gibboni. In realtà Nyanzapithecus alesi sarebbe un parente molto stretto dell'antenato comune a tutte le grandi scimmie (il nome della specie, alesi, deriva dalla parola "ales", che nella lingua delle popolazioni locali significa "antenato").
Molte delle parti più informative del cranio sono conservate all'interno del fossile e per renderle visibili i ricercatori sono ricorsi a una forma di radiografia in 3D realizzabile grazie alla luce di sincrotrone. In questo modo sono stati in grado di rivelare la cavità del cervello, l'orecchio interno e i denti adulti in via di formazione. La qualità delle immagini è stata così buona da poter stabilire dai denti che il piccolo aveva circa un anno e quattro mesi quando è morto. Confrontando i denti del piccolo e quelli di nianzapiteco adulto i ricercatori hanno accertato che la sua capacità cranica da adulto avrebbe raggiunto i 101 millilitri, stabilendo così una sua parentela più stretta con gli ominidi che con gli antenati delle altre scimmie del Vecchio mondo (cercopitechi e colobi), la cui capacità cranica all'epoca non doveva superare i 35 millilitri circa. L'analisi del canale semicircolare dell'orecchio interno fa invece supporre che i tratti di Nyanzapithecus alesi che ricordano il gibbone in realtà si siano evoluti in modo indipendente. (gibboni e siamanghi formano una famiglia affine ma distinta da quella delle grandi scimmie, insieme alle quali costituiscono la superfamiglia delle scimmie antropomorfe). Dalle caratteristiche dell'orecchio interno, inoltre, Nengo e colleghi ipotizzano che Nyanzapithecus alesi doveva avere movimenti arboricoli più lenti e meno agili rispetto a quelli acrobatici dei gibboni moderni.
C'è anche Sandrone
Prima di proseguire con il Pliocene, parliamo di un'altra scimmia antropomorfa estinta, che ci riguarda se non altro perchè è stata scoperta in territorio italiano. Alto un metro e dieci, era bipede, ma le zampe corte e l'alluce molto distaccato dal resto del piede rendevano la sua andatura molto incerta, aveva una testa piccola con due grandi occhi e con le mani si procurava il cibo, soprattutto bacche e foglie. I suoi denti, analizzati recentemente con l'apparecchiatura per la luce di sincrotrone di Grenoble, avevano un aspetto che li rende adatti a una dieta a base di vegetali. Questo è l'identikit di « Sandrone », un parente stretto del gibbone che popolava l'Europa 8 milioni di anni fa (alle 8.25 del 31 dicembre), e i cui ultimi esemplari sono stati scoperti cinquant'anni fa vicino a Grosseto e in Sardegna, presso la centrale di Fiume Santo (Sassari). A battezzarlo così è stato un operaio al lavoro nella miniera di lignite presso Baccinello, in Toscana, che ne riportò alla luce uno scheletro quasi completo il 2 agosto del 1958; scientificamente parlando, è un oreopiteco (Oreopithecus bambolii). Buona parte dei resti di Oreopithecus è oggi conservata nel Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze.
La cosa veramente singolare consiste nel fatto
che quest'ominoide al suo tempo era l'unico sopravvissuto dell'Europa
tropicale, cioè di quella fase della storia del nostro continente in cui
il clima era caldo-umido, tale da giustificare in esso la diffusione di animali
come elefanti, ippopotami ed antilopi. All'epoca l'oreopiteco abitava una grande isola boscosa composta dalle attuali Toscana meridionale e Sardegna. Ma da dove vi è arrivato?
Esso discende probabilmente dal Nyanzapithecus, suo stretto parente del Kenya, ma antico di 15 milioni di
anni: è possibile che questa scimmia abbia raggiunto il territorio europeo attraverso la Sardegna per poi proseguire per la
Toscana, grazie ad un ponte continentale tra quello che allora era « l'aricipelago italiano
» e l'Africa. «Era un animale davvero unico e la sua parentela con i primati è ancora oggetto di
 discussione»,
ha spiegato Lorenzo Rook, del dipartimento di Scienze della Terra dell'università di
Firenze, che ha dedicato anni allo studio e alla ricostruzione di questo primate.
« Nonostante sia stato scoperto 50 anni fa, finora dell'oreopiteco si sapeva davvero molto poco.
Solo ora è chiaro che non è imparentato con i nostri più diretti antenati, ma è uno degli ultimi rappresentanti di un ampio gruppo di scimmie antropomorfe che nel Miocene superiore erano diffuse in Europa e
Asia ». Tuttavia la somiglianza con il diretto antenato dell'uomo, l'Australopiteco,
« ne fa una specie chiave per comprendere le fasi più antiche della nostra
evoluzione »: evoluzione che alla fine ha decretato la sconfitta degli oreopiteci, relegando la loro esperienza a una sorta di prova generale in vista della comparsa dei primi
ominidi veri e propri.
discussione»,
ha spiegato Lorenzo Rook, del dipartimento di Scienze della Terra dell'università di
Firenze, che ha dedicato anni allo studio e alla ricostruzione di questo primate.
« Nonostante sia stato scoperto 50 anni fa, finora dell'oreopiteco si sapeva davvero molto poco.
Solo ora è chiaro che non è imparentato con i nostri più diretti antenati, ma è uno degli ultimi rappresentanti di un ampio gruppo di scimmie antropomorfe che nel Miocene superiore erano diffuse in Europa e
Asia ». Tuttavia la somiglianza con il diretto antenato dell'uomo, l'Australopiteco,
« ne fa una specie chiave per comprendere le fasi più antiche della nostra
evoluzione »: evoluzione che alla fine ha decretato la sconfitta degli oreopiteci, relegando la loro esperienza a una sorta di prova generale in vista della comparsa dei primi
ominidi veri e propri.
Buchi neri e supernovae cenozoiche
Circa 6 milioni di anni fa (alle 12.19 del 31/12), quando gli ominoidei muovevano i loro primi passi sulla Terra, il buco nero nel nucleo della Via Lattea era in una fase di intensa attività, e proiettava verso l'esterno enormi quantità di gas. Lo ha scoperto Fabrizio Nicastro, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) e colleghi di una collaborazione internazionale, grazie ad una serie di calcoli che riguardano la massa mancante nella nostra galassia. Le misurazioni mostrano infatti che la Via Lattea ha una massa complessiva che va da 1000 a 2000 miliardi di masse solari ed è costituita per l'83 % dalla misteriosa materia oscura e per il restante 17 %, pari a 170-340 miliardi di masse solari, dalla materia ordinaria. Tuttavia, se si tiene conto di tutte le stelle, della polvere e del gas presenti nella galassia, il calcolo arriva a circa 65 miliardi di masse solari. Il resto della materia ordinaria, costituita da neutroni, protoni ed elettroni, non si trova. Ma dove si può nascondere?
« È stato come giocare a un gigantesco nascondino cosmico », ha commentato Nicastro. « Analizzando i database delle osservazioni in raggi X del telescopio spaziale XMM-Newton dell'ESA, abbiamo concluso che la massa mancante è costituita da una nebbia gassosa di alcuni milioni di gradi di temperatura che permea la nostra galassia: è questa nebbia ad assorbire i raggi X che provengono dalle sorgenti più lontane sullo sfondo. » Le misurazioni e alcuni modelli al computer hanno poi permesso di calcolare la distribuzione di questa massa ordinaria, risultata ben poco uniforme: essa forma infatti una sorta di guscio sferico centrato nel nucleo della galassia. Ciò implica che nella parte più interna il gas stesso fu spazzato via da un evento di energia enorme. A produrla fu il buco nero, che mentre inghiottiva parte del gas, ne proiettò la parte restante verso l'esterno alla velocità di circa 1000 chilometri all'ora.
In sei milioni di anni, l'onda d'urto creata da questa fase di attività ha percorso una distanza di 20.000 anni luce. Nel frattempo, il buco nero ha esaurito il gas circostante ed è entrato in una sorta di "ibernazione". Questa ricostruzione è corroborata dalla presenza di stelle di 6 milioni di anni di età nelle vicinanze del centro galattico, che si formarono da una parte dello stesso materiale che un tempo fu inghiottito dal buco nero. « Queste differenti linee di evidenza sono legate tra loro in modo molto stretto », ha dichiarato Martin Elvis, coautore dello studio. « Questa fase attiva durò da 4 a 8 milioni di anni, un tempo ragionevole per un questo tipo di oggetti. » Le osservazioni e i modelli al computer a essi associati mostrano anche che il gas ammonta a 130 miliardi di masse solari di materiale, il che potrebbe spiegare dove si nascondeva la materia mancante della galassia: semplicemente, era troppo calda per essere vista.
Prima di passare all'ultimo periodo del Cenozoico, aggiungiamo una scoperta che ha davvero dell'incredibile. Che l'atmosfera abbia cambiato più volte composizione nella storia della Terra è ormai un fatto accettato da tutti, ma il professor Brian Thomas della Washburn University a Topeka (Kansas) ha proposto che queste trasformazioni siano state provocate tra l'altro da vicine esplosioni stellari. Si pensa infatti che due supernovae di tipo II (quelle a collasso nucleare) siano esplose a meno di 300 anni luce dalla Terra nell'arco degli ultimi milioni di anni, come dimostra la presenza nei raggi cosmici di ferro-60, un isotopo del ferro con emivita di 2,6 milioni di anni, che sarebbe un residuo di quelle esplosioni. La prima esplosione avrebbe avuto luogo otto milioni di anni fa (alle 08.25 di San Silvestro), la seconda due milioni e mezzo di anni fa (alle 19.01 dello stesso giorno). A causa della vicinanza delle supernovae, raggi cosmici ad alta energia sarebbero riusciti a penetrare l'atmosfera fino ai suoi strati più bassi; il flusso di muoni sarebbe addirittura aumentato di 20 volte, causando eventi atmosferici catastrofici per via dell'elevata ionizzazione dell'aria a bassa quota. E non solo: flussi così elevati di particelle avrebbero prodotto un aumento significativo del tasso di mutazioni genetiche, accelerando i processi evolutivi. La nascita dei generi Australopithecus ed Homo insomma potrebbe essere una conseguenza di quei catastrofici eventi cosmici. Sarà andata proprio così? Comunque sia, è un'ipotesi davvero affascinante!
![]()
Il nome Pliocene ("più recente") indica che essa è l'epoca più vicino alle condizioni geoclimatiche attuali. Infatti essa occupa il lasso di tempo compreso tra l'epoca Miocenica e l'epoca Pleistocenica, va da 5 milioni e 300 mila ad 1 milione ed 800 mila anni fa ed è la più breve delle epoche del Cenozoico. In termini di Anno della Terra, va dalle 13.40.58 alle 20.29.46 dell'Ultimo dell'Anno.
Nel Pliocene si distinguono tre stratificazioni: Zancleano, Piacenziano e Gelasiano.
All'inizio del Pliocene si verificò un notevole ed esteso innalzamento dei mari. Di conseguenza lo stretto di Gibilterra si riaprì e si originò la più vasta e più tremenda cascata mai esistita al mondo, larga 16 Km, alta 500 m e centinaia di volte più potente delle Niagara Falls, la quale inondò gran parte delle regioni mediterranee, disseccatesi nel periodo precedente durante la Crisi di Salinità del Messiniano. Una recente indagine pubblicata sulla rivista scientifica Nature ha permesso ai ricercatori spagnoli del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Consiglio Superiore di Investigazione Scientifica, CSIC) di stabilire che tale processo di riempimento non fu affatto lento, come molti geologi ritenevano fino a poco tempo fa: l'inondazione sarebbe avvenuta nell'arco di alcuni anni al massimo, e non nel corso di alcuni secoli, dando vita ad un'alluvione catastrofica, la più terrificante che abbia conosciuto il nostro pianeta nella sua storia geologica recente, detta Alluvione Zancleana dal nome del periodo in cui è avvenuta. Il livello del mare si è alzato rapidamente, con picchi massimi di 10 metri al giorno, e in breve tempo il Mare Nostrum ha raccolto il 90 per cento delle sue acque che lo riempiono tuttora, tornando ad essere un mare. Prima di questo evento il bacino aveva un clima nettamente tropicale, mentre da qui in poi nacque il famoso "clima mediterraneo", temperato ed adatto al sorgere delle prime civiltà umane.
Ben presto si passò da un eccesso all'altro, perché il Mediterraneo e gli altri mari lasciarono affiorare quasi esclusivamente le catene montuose. A quei tempi la pianura Padana era del tutto sommersa, e dell'Italia era possibile vedere soltanto gli Appennini. Le isole del Mediterraneo rimasero del tutto isolate e svilupparono una fauna a sé, con particolari forme nane a causa della scarsità di spazio a disposizione. A Malta, ad esempio, si sviluppò il Loxodonta falconeri, un elefantino non più grosso di un pony!
Alla fine dell'epoca, invece, i mari tornarono a riabbassarsi, permettendo la riemersione di vaste regioni.
Quando ai poli faceva caldo
I ricercatori della U.S. Geological Survey hanno dimostrato, sulla base di chiare prove paleoclimatiche, che nel corso del medio Pliocene, circa tre milioni e mezzo di anni fa (alle 17.11.12 del 31 dicembre) la Terra fu investita da un periodo così caldo che l'Oceano Artico e il Mare del Nord persero completamente la calotta di ghiacci nella stagione estiva. Questo periodo fu caratterizzato da temperature eccezionalmente alte: durante il medio Pliocene le temperature della superficie del mare Artico erano tra 10° e 18 °C , mentre le temperature attuali sono vicine a 0 °C. E l'evento non fu limitato all'emisfero boreale: circa 3,3 milioni di anni fa (alle 17.34.34) i ghiacci che ricoprivano l'Antartide si ritirarono, lasciando il posto per almeno 200.000 anni (per 25 minuti) a un clima più temperato; lo scioglimento dei ghiacciai provocò il sollevamento del livello medio dei mari di 10 metri. Sono questi i sorprendenti risultati del progetto internazionale ANDRILL (ANtarctic geological DRILLing), che il 16 dicembre 2006 ha raggiunto il record di mille metri di profondità sotto il fondale del Mare di Ross occidentale, e che con le sue trivellazioni ha ricostruito gli ultimi 17 milioni di anni (33 ore) di storia dell'Antartide, tracciando una mappa della storia climatica del Sesto Continente molto diversa rispetto a quella ipotizzata finora. « Abbiamo scoperto che circa 16 milioni di anni fa (alle 16.50 del 13 dicembre) l'Antartide aveva un clima simile a quello attuale dell'isola del sud della Nuova Zelanda o della Patagonia meridionale, con abbondante vegetazione, fiumi e un clima piovoso », ha spiegato David Harwood, ricercatore della Nebraska University di Lincoln che ha partecipato ad ANDRILL. Le trivellazioni riprenderanno ne1 2012, in cerca di nuove conferme a questa teoria decisamente controcorrente rispetto alla climatologia "ufficiale".
E non basta: il geologo Paul Bierman dell'Università del Vermont ha riportato alla luce nel 2013 una tundra sotterranea risalente a 2,7 milioni di anni fa (le 18.44.38 del 31/12), sepolta sotto la calotta glaciale della Groenlandia, spessa ben due chilometri. La scoperta costituisce una prova del fatto che la calotta glaciale della Groenlandia sia durata molto più a lungo di quanto sinora ipotizzato, e che abbia attraversato diversi periodi di riscaldamento globale del passato. Persino nelle fasi più calde dalla formazione della calotta di ghiaccio, quindi, il centro della Groenlandia è rimasto stabile. « È probabile che non si sia mai sciolta del tutto », ha precisato Bierman: « questo ha permesso alla tundra di essere sigillata senza subire modifiche sotto il ghiaccio attraverso milioni di anni di riscaldamento e raffreddamento globale. La visione tradizionale dei ghiacciai li descrive come potenti agenti di erosione, ma noi abbiamo dimostrato che la calotta della Groenlandia non si sta comportando come tale: al suo centro l'erosione è stata incredibilmente bassa sin dal suo emergere, quasi tre milioni di anni fa ». Lo strato di ghiaccio ha conservato la terra come un frigorifero, preservando questo antico paesaggio che dovrebbe essere stato esposto in superficie tra duecentomila e un milione di anni prima di essere ricoperto. La tundra doveva essere in parte boschiva, simile alla verde tundra dell'Alaska.
Le glaciazioni
Al contrario, tuttavia, l'evento più importante del Pliocene avvenne tre milioni di anni fa, cioè alle 18.09.36 di San Silvestro in termini di Anno della Terra. L'abbassamento del livello degli oceani determinò infatti il completamento del collegamento dell'America Settentrionale con quella Meridionale, interrompendo definitivamente il passaggio delle correnti calde provenienti dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, e reindirizzandole verso il Polo Nord.
A quei tempi, nonostante le temperature a quella latitudine fossero molto basse, l'aria secca impediva ogni precipitazione nevosa, per cui non esisteva ancora la calotta polare artica. L'arrivo delle correnti calde dalle zone equatoriali portò anche l'aumento dell'umidità, cui seguirono le prime precipitazioni che, congelando per le basse temperature, iniziarono a costruire un gigantesco continente di ghiaccio. Da allora, alternando massime estensioni della calotta artica, dette glaciazioni, con massime contrazioni, dette epoche interglaciali, i ghiacci sono stati sempre presenti nella regione.
A causa di tutto ciò le temperature medie si abbassarono, determinando cambiamenti dell'ambiente e delle risorse alimentari, il che si ripercosse sull'evoluzione degli esseri viventi, poi proseguita nel Neozoico. Altro evento degni di nota è la formazione del Mar Rosso con l'apertura di una Rift Valley che un giorno spaccherà in due il continente africano.
Il canto del cigno dei mammiferi
Nei mari del Pliocene i molluschi assunsero forme praticamente uguali a quelle attuali, mentre si estinsero i foraminiferi, ed i coralli si limitarono a Sud del 35º parallelo di latitudine Nord. Squali giganti popolavano i mari. Invece la fauna delle terre emerse per l'80% era simile ai Mammiferi attuali. L'età dei mammiferi, coincisa con l'Oligocene ed il Miocene, cominciò a subire un declino graduale: l'esplosione di vita animale seguita all'estendersi delle praterie era terminata e, con il raffreddarsi del clima, i mammiferi mostrarono una sempre minore varietà di forme. Notevole sviluppo ebbero tuttavia i proboscidati, con l'affermazione definitiva dei mastodonti, le cui zanne giunsero ai quattro metri di lunghezza, e con la comparsa di Elefantidi del genere Stegodon. In America fecero la comparsa il plioippo, il primo cavallo con un vero zoccolo, ed il Camelus che successivamente emigrò in Eurasia, dove avevano avuto origine i bovidi, ben rappresentati dal gigantesco Uro (Bos primigenius), che si estinse in Polonia nel 1920.
Nel corso del Pliocene, inoltre, l'unione del continente Nordamericano con quello Sudamericano, che fu il motivo scatenante di tutta la storia geologica che prosegue tuttora, favorì l'interdiffusione tra le faune nordamericane e quelle sudamericane, mettendo fine all'isolamento che per tutto il Cenozoico aveva favorito l'evoluzione in Sud America di specie esclusive di Mammiferi. Tra gli Sdentati, Megatherium e Gliptodonti risalirono a Nord, dove sarebbero rimasti anche durante l'epoca Pleistocenica. La migrazione verso Sud fu invece più intensa e significativa, tanto da causare in breve tempo l'estinzione dei mammiferi indigeni più primitivi. Si espansero ulteriormente le tigri dai denti a sciabola.
|
|
|
Smilodonte o Tigre dai Denti a Sciabola (disegno dell'autore) |
Il Supertopo
Nel gennaio 2008, sulla rivista scientifica Proceedings of the Royal Society B, che si occupa di scienze biologiche, i paleontologi Andrés Rinderknecht e Ernesto Blanco hanno annunciato la scoperta, avvenuta in una zona rocciosa nei pressi del fiume Rio de la Plata, in Uruguay, i fossili del Josephoartigasia monesi, un topo gigantesco vissuto quattro milioni di anni fa (alle 16.12.48 del 31 dicembre). Questo straordinario roditore era grande come un toro: lungo quasi tre metri ed alto circa un metro e cinquanta, pesava almeno una tonnellata. L'enorme cranio dell'animale era lungo 53 centimetri. Proprio per la sua enorme stazza i due scopritori lo hanno soprannominato "il Supertopo". In realtà, più che ad un ratto domestico si pensa che assomigliasse al capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), il più grande roditore vivente, sempre del Sudamerica, che arriva a pesare fino a 60 kg, ma che ha ovviamente dimensioni molto minori. Il mega-ratto preistorico, a causa della sua mole imponente, probabilmente viveva semisommerso in acqua, come gli ippopotami moderni. Ma molti dubbi rimangono sui cibi che esso consumava.
Senza dubbio la sua arma più pericolosa erano i denti, affilatissimi per lottare e difendersi: i suoi incisivi erano lunghi circa 30 cm e quasi la metà di questi sbucava fuori dalla bocca, rendendo ancora più minaccioso il suo grugno. Secondo Blanco, questo animale usava i suoi formidabili denti o per abbattere gli alberi, come fanno i castori moderni, o per combattere contro i predatori, non potendo essere molto agile e veloce a causa del suo peso. Il professor Ernesto Blanco, che lavora all'Istituto di Fisica di Montevideo, suggerisce che questo esemplare sviluppò una mole così colossale e dei denti così affilati unicamente per proteggersi dai predatori, analogamente ai fenomeni di gigantismo che produssero dinosauri colossali nel Sudamerica del periodo Giurassico. La storia, in genere, tende a ripetersi.
Il Superstruzzo
I resti trovati nelle grotte di Taurida in Crimea nel 2018 durante la costruzione di una strada potrebbero appartenere all'uccello più grande che abbia mai calcato le terre dell'emisfero boreale della Terra. Accadeva attorno ai due milioni di anni fa (verso le ore 19 del 31 dicembre), quando gli antenati dell'uomo si affacciavano fuori dalle pianure africane e forse hanno incontrato (e magari anche cacciato) questi esemplari di Pachystruthio dmanisensis. Accanto a questi fossili sono emersi quelli di mammut e predatori come ghepardi e iene giganti, e anche lui non faceva eccezione. Misurando l'osso femorale, gli antropologi hanno calcolato che doveva essere alto tre metri e mezzo e pesare quasi mezza tonnellata, quanto un orso polare, tre volte lo struzzo e come dieci emù, gli animali ancora viventi che gli somigliano di più. Tuttavia la parentela non è certa: Secondo Nikita Zelenkov, dell'Accademia delle Scienze Russa, è la prima volta che nell'emisfero nord viene rinvenuto un esemplare di uccello gigante di queste dimensioni. La specie, infatti, era già nota, ma non la sua taglia, che ha lasciato di stucco i paleontologi. E questo racconta parecchio anche della "legge della giungla" nelle steppe di quella che è oggi l'Europa orientale. Le lunghe zampe dovevano permettergli, infatti, di correre veloce per sfuggire ai carnivori, le ossa dei quali sono state rinvenute non distante dalle sue.
Il record del più grande uccello mai esistito va al Vorombe Titan, un uccello elefante del Madagascar che poteva arrivare anche a 800 chili di peso. Quello europeo gareggia invece con i moa neozelandesi (anche loro estinti). Erano tutti alti più di tre metri, ma il Pachystruthio doveva pesare circa il doppio. Un gigantismo che, spiegano gli autori dello studio, potrebbe derivare da una risposta all'ambiente, sempre più arido. Un corpo più grande ha un metabolismo più lento ed è avvantaggiato nelle steppe con cibo meno nutriente a disposizione. Inoltre siamo nel periodo in cui i primi ominidi devono aver calcato queste terre dopo essere usciti dall'Africa, ed è possibile che il grosso uccello sia stato una delle prede dei cacciatori per la carne, le piume e le uova. In Georgia, non molto più a est, sono stati trovati i resti più antichi di ominidi in Europa risalenti tra un milione e mezzo e due milioni di anni fa. Le loro strade, dunque, potrebbero essersi incrociate proprio sulle sponde del Mar Nero.
Il Supercoccodrillo
Dopo il supertopo, è il turno del supercoccodrillo, che avrebbe potuto ingoiare un essere umano in un colpo solo. Stiamo parlando del Crocodylus thorbjarnarsoni: lungo fino a otto metri e mezzo, viveva tra i quattro e i due milioni di anni fa nei laghi profondi della zona dell'attuale Lago Turkana, in Kenya. I suoi resti fossili, trovati negli anni sessanta, erano conservati presso i National Museums of Kenya di Nairobi; solo nel 2011, riesaminandoli, un gruppo di paleontologi ha scoperto che appartenevano a una specie finora sconosciuta.
Nell'ordine dei Crocodilia, che comprende anche alligatori e caimani, sono esistiti anche mostri più grandi, come il Deinosuchus hatcheri, vissuto nel Giurassico, lungo fino a 15 metri e in grado di attaccare i dinosauri. Crocodylus thorbjarnarsoni è però il più grande dei coccodrilli in senso stretto, sostiene Christopher Brochu della University of Iowa, capo dello staff di ricerca, dato che esso somigliava a un odierno coccodrillo del Nilo, solo più grosso e pesante (per inciso, il coccodrillo più grande mai catturato vivo è con tutta probabilità Lolong, un coccodrillo d'acqua dolce pescato nelle Filippine il 3 settembre 2011, lungo 6,17 m e pesante 1075 Kg).
Con ogni probabilità le dimensioni abnormi di questo rettile si devono alla sua capacità di cacciare prede molto grosse, tra cui gli ominidi. Secondo Brochu, il coccodrillo tendeva loro agguati quando andavano a raccogliere acqua dal lago: « era una brutta situazione per i nostri antenati: senz'acqua morivano, ma correvano gravi rischi anche se si recavano al lago per bere ». A tutt'oggi non sono mai stati trovati segni del morso di un rettile sul fossile di un ominide, ma questo potrebbe trovare spiegazione ammettendo, appunto, che Crocodylus thorbjarnarsoni fosse in grado di ingoiare un ominide intero. I coccodrilli hanno stomaci di ferro, ed ingoiano pietre che li aiutano a frantumare le ossa delle vittime. Questo ci lascia molto da pensare, dato che noi oggi siamo abituati a vedere noi stessi come predatori al vertice della catena alimentare, ma evidentemente fino a pochi milioni di anni fa non era affatto così. Brochu aggiunge poi che il ritrovamento della nuova specie « contribuisce a smentire il mito secondo cui i coccodrilli sarebbero fossili viventi. L'evoluzione dei coccodrilli e dei loro parenti stretti è stata complessa e variegata quanto quella di qualsiasi altro gruppo di animali: dobbiamo smetterla di vederli come relitti del passato, che evolvono poco e con estrema lentezza ».
Il cimitero dei cetacei pliocenici
Nel 2011, accanto alla Panamericana che attraversa il deserto di Atacama nel Cile settentrionale, durante gli scavi per allargare l'autostrada è stata fatta una scoperta straordinaria: un cimitero di cetacei risalente a 5 milioni di anni fa (ore 14.16 del 31/12). Da allora il sito è stato ribattezzato Cerro Ballena (Collina delle balene). In tutto sono stati rivenuti una quarantina di scheletri appartenenti alla famiglia delle balenottere e altre specie estinte come il delfino a faccia di tricheco (Odobenocetops). Gli scienziati cileni e statunitensi hanno dovuto scavare con rapidità: la compagnia che aveva ricevuto in appalto i lavori aveva concesso loro solo due settimane prima di riprendere l'opera di allargamento della strada. A tempo di record, i paleontologi non solo hanno portato alla luce i resti, ma hanno allestito tutte le attrezzature per operare una scannerizzazione tridimensionale dei fossili, in modo da poterli studiare con più calma in seguito. Tutti gli scheletri erano quasi completi, e molti erano disposti nella stessa direzione e con il ventre in su; tali modalità di rinvenimento hanno subito fatto pensare a un evento rapido e che ha interessato diversi esemplari nello stesso tempo.
Tale scoperta costituì fin da subito un enigma per i paleontologi, i quali non riuscivano a spiegarsi come un simile numero di reperti del primo Pliocene potesse trovarsi concentrato in un solo luogo. Solo nel 2014 i paleontologi dello Smithsonian Institution, sono arrivati a una possibile soluzione: vi sarebbero forti evidenze che i cetacei siano rimasti avvelenati da alghe tossiche. Le carcasse e gli animali morenti sarebbero poi stati trasportati dalle onde e dalle correnti alle foci di un fiume, dove sono stati spiaggiati e quindi ricoperti dalla sabbia. Il fatto che non fossero disposti nello stesso livello, ma su più livelli sovrapposti, ha indicato che questa moria di massa si è ripetuta almeno quattro volte nell'arco di migliaia di anni; un tempo che a noi può apparire assai lungo ma, ragionando su scala paleontologica, i quattro eventi si sono succeduti con grande frequenza, addirittura sospetta. In ogni caso, l'ingestione di alghe tossiche è ancora oggi tra le principali cause degli spiaggiamenti di massa dei cetacei.
L'incredibile narvalo tropicale
Può sembrare incredibile, ma da milioni di anni nelle campagne intorno a Grosseto riposavano i resti di uno straordinario signore dei mari artici. Si tratta di qualcosa di impensabile perfino per gli scienziati dell'Università di Pisa che l'hanno scoperto: resti fossili di un animale, simile a un narvalo o un beluga, che si credeva impossibile nuotasse un tempo nel Mediterraneo o lungo le coste italiane. La scoperta è stata fatta dal team di Giovanni Bianucci e Alberto Collareta, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che nel 2019, con l'aiuto dei ricercatori Fabio Pesci e Chiara Tinelli, stavano scavando in una cava di sabbia ad Arcille, nel grossetano, quando si sono imbattuti in un grande cranio fossile risalente a 5 milioni di anni fa. Dalle analisi è risultato appartenere a un animale della famiglia dei monodontidi, come il beluga e il narvalo, cetacei che vivono solo nelle gelide acque artiche. Oggi è impossibile vederli nelle calde acque del Mediterraneo e ancora più assurdo - almeno così si pensava - che potessero essere vissuti in questo mare all'inizio del Pliocene, quando il nostro clima era tropicale. Invece è successo.
L'animale ritrovato è stato battezzato Casatia thermophila, un omaggio a Simone Casati, scopritore di molti importanti fossili della Toscana e in particolare della cava di Arcille, mentre thermophila significa amante del caldo, per sottolineare che questo cetaceo viveva in acque tropicali. I resti dell'animale, grazie all'aiuto della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, sono stati esposti nella Galleria dei Cetacei del Museo di Storia Naturale di Pisa. Per Bianucci si tratta di una scoperta straordinaria, perché è il primo monodontide scoperto nell'area Mediterranea, che ci ha permesso di descrivere la quarta specie fossile al mondo di questa famiglia, e soprattutto perché questo fossile è stato trovato "fuori posto". I ritrovamenti fossili di questo tipo, estremamente scarsi, potranno ora aiutare i ricercatori a conoscere di più sull'evoluzione di questi cetacei che un tempo, si crede, nuotavano con altre creature oggi scomparse dalle nostre acque. Che durante il Pliocene inferiore il Mediterraneo fosse un mare caldo si sapeva da tempo, ma altri fossili straordinari trovati nella cava di Arcille supportano il fatto che Casatia thermophila nuotasse insieme ad animali marini di acque tropicali, come ad esempio il temibile squalo zambesi, il vorace squalo tigre e l'enorme marlin, tutte forme oggi assenti dal Mediterraneo. Durante gli scavi sono stati ritrovati anche alcuni scheletri di un antenato del dugongo e altri reperti fossili che confermano la presenza di un "paleoambiente tropicale". È la conferma definitiva che il narvalo e il beluga derivano da forme di mare caldo tropicale: è probabile che le due specie attuali di monodontidi abbiano evoluto i loro straordinari adattamenti alle acque fredde in tempi geologicamente molto recenti, durante il Quaternario, quando l'emisfero settentrionale fu interessato da ripetute glaciazioni e da un trend di progressivo irrigidimento climatico. Durante il Pliocene buona parte del territorio toscano era sommerso da un mare popolato da una grande varietà di organismi: i profondi mutamenti geologici e climatici intercorsi da allora hanno rimodellato il territorio, rendendolo oggi una vera miniera a cielo aperto.
Il rinoceronte marsupiale
Il Pliocene vide anche il prosperare della cosiddetta megafauna australiana. Il continente australe infatti rimase a lungo isolato dalle altre terre emerse, ed in esso si sviluppò una fauna autoctona costituita in particolare da marsupiali, che talora raggiunsero forme e dimensioni impressionanti. Uno degli epicentri dei ritrovamenti dei fossili di questa megafauna è costituita dalle grotte di Naracoorte, poste nell'Australia meridionale a quattro ore di auto dalla capitale Adelaide. Qui il suolo è traforato da buche chiamate "pitfall traps", buchi profondi che aprono la via ad un grande sistema di caverne. Nel 1969 il paleontologo Rod Wells esplorò la grotta nota come Victoria Cave, e scoprì che il suo pavimento di terra rossa era letteralmente lastricato di migliaia di ossa, evidentemente appartenute alle vittime delle pitfall traps. La Victoria Cave custodiva le ossa di circa 45 mila animali, molte delle più antiche delle quali appartenevano proprio all'antica megafauna australiana. Tra questi c'era il Thylacoleo carnifex, pesante 158 chili e alto al garrese 75 centimetri, quindi il maggior mammifero carnivoro del continente. Acquattato nel sottobosco australiano, balzava fuori all'improvviso riuscendo ad abbattere prede molto più massicce di lui, afferrandole con gli artigli affilati come pugnali. Il dromornitide (Dromornis stirtoni) fu uno dei massimi uccelli conosciuti: alto tre metri, pesava 450 kg e visse all'incirca otto milioni di anni fa, quando l'Australia si stava inaridendo. Il wonambi (Wonambi naracoortensis) era invece un mostruoso gigantesco serpente che superava i 6 metri di lunghezza, il cui nome deriva dalla parola aborigena che significa "serpente arcobaleno”, una figura ricorrente nell'arte e nella mitologia aborigena. Vi era poi il procoptodonte (Procoptodon goliah), il maggior canguro conosciuto (in Australia il più grosso animale terrestre indigeno oggi sopravvissuto è il canguro rosso) che era alto due metri e, a differenza dei canguri viventi, poteva allungare le zampe anteriori sopra la testa per strappare il fogliame dagli alberi. Il procoptodonte fu uno degli ultimi animali della megafauna a estinguersi, e ha coabitato con l'uomo per migliaia di anni, ispirando i racconti aborigeni su un battagliero canguro dai lunghi arti. Sicuramente però il campione di questa megafauna da brividi fu il diprotodonte (Diprotodon australis), il più grande mammifero marsupiale mai esistito. Questo carro armato vivente raggiungeva i quattro metri di lunghezza, e può essere paragonato, come forma e dimensioni, agli odierni rinoceronti, anche se le sue abitudini di vita erano probabilmente più simili a quelle degli ippopotami. Il corpo era decisamente voluminoso, sorretto da zampe massicce e fornite di zoccoli; il cranio era privo di corna e la dentatura richiamava da vicino quella dei roditori. Nel giacimento di Callabonna, un lago fossile, ne sono stati rinvenuti numerosi resti. Per vederne una ricostruzione fantastica animata tratta dal sito Youtube, cliccate qui sotto.
La megafauna australiana dominò a lungo l'isola-continente, ma di punto in bianco scomparve circa 40.000 anni fa (alle 23.55.19 del 31 dicembre), a causa di un'estinzione di massa che ha fatto piazza pulita di quasi tutti gli animali di peso superiore ai 45 chilogrammi. Di quello stupefacente complesso di grandi vertebrati restarono solo pochi superstiti, tra cui i canguri. La causa di questa misteriosa estinzione può essere una sola: l'arrivo dell'uomo, che raggiunse l'Australia attraverso il Mare della Sonda e, trovandosi di fronte una fauna non abituata a predatori tanto attivi, finì per sterminarla con una caccia eccessiva. Richard Roberts dell'Università di Wollongong e Barry Brook dell'Università di Adelaide, utilizzando i nuovi metodi di datazione, hanno dimostrato come i resti fossili della megafauna australiana e i primi strumenti degli aborigeni risalgano allo stesso periodo, e quindi gli esseri umani siano coesistiti per un periodo di tempo relativamente breve con i mammiferi giganti dell'isola-continente. Ciò fa pensare che sia la caccia la causa più diretta della scomparsa di molte specie di grandi dimensioni. « L'Australia è stata colonizzata durante un periodo in cui il clima era relativamente favorevole », ha spiegato Brook, « il che corrobora l'ipotesi che sia stato l'uomo, e non il cambiamento climatico a causare l'estinzione. » È perciò possibile che all'origine del mito del bunyip ("diavolo"), spirito maligno abitante i laghi e gli stagni secondo la mitologia aborigena australiana, così come del gazeka della Nuova Guinea, altro animale fantastico che alcuni asseriscono di aver avvistato, ci siano proprio i ricordi degli uomini che per primi si trovarono di fronte a queste straordinarie creature: le tradizioni orali potrebbero aver tramandato gli incontri avvenuti migliaia di anni fa tra gli ultimi diprotodonti e i primi abitanti dell'Australia e della Nuova Guinea.
Il progenitore degli ominidi: Orrorin tugenensis
Verso la fine del Pliocene nella famiglia degli ominoidei iniziò l'evoluzione degli ominidi, scimmie antropomorfe dirette antenate dell'uomo. Con l'affermarsi di una sola specie, in grado di controllare tutte le altre forme viventi, cambiò il meccanismo stesso dell'evoluzione animale. Nelle ere precedenti l'evoluzione aveva infatti prodotto un gran numero di mammiferi altamente specializzati; ora predominavano forme meno numerose, ma assai più adattabili a qualsivoglia ambiente. L'età dei mammiferi stava per finire, ed era in procinto di iniziare l'età dell'uomo. Su un unico continente i mammiferi continuarono a vivere indisturbati: l'Australia, almeno fino all'arrivo di James Cook...
 Le scoperte dell'ultimo decennio hanno
completamente rivoluzionato la famiglia degli ominidi. Sicuramente uno dei
ritrovamenti più importanti è quello avvenuto casualmente in Kenya, nella regione delle
Tugen Hills,
nel
marzo 2000: si tratta di porzioni ossee di 5 individui risalenti a 6 milioni di
anni fa (ore 12.19.12), cui è stato dato prima
il nome provvisorio di “Millenium Man”, e poi quello scientifico di Orrorin tugenensis.
Doveva essere alto tra 100 e 120 cm, e pesare tra i 35 e i 50 Kg. Alcuni antropologi
identificarono subito in esso il più antico ominide, antenato dei successivi,
mentre per altri
si trattava solo di uno dei tanti tentativi evolutivi che hanno
portato a un ramo morto, mentre Ardipiteci ed Australopiteci avrebbero avuto
più successo. Più recentemente, tuttavia, le ricerche pubblicate su
Science da
Brian G. Richmond, della George Washington
University, e da
William L. Jungers, della Stony Brook
University,
affermano che le prime avvisaglie della rivoluzione anatomica del bipedismo
sarebbero comparse nell'albero genealogico dell'evoluzione umana proprio con Orrorin tugenensis.
I due paleoantropologi, attraverso un' analisi quantitativa delle combinazioni di caratteri che definiscono la morfologia degli arti inferiori, hanno verificato che
esso, pur così antico, possedeva già tutti gli adattamenti necessari per l'andatura
bipede, ed in particolare una postura simile a quella degli australopiteci e dei parantropi, i due generi che
dominarono la famiglia degli ominidi fino a due milioni di anni fa. Orrorin, che in lingua locale significa non a caso
« uomo originale », camminava come gli Australopiteci, oscillando sulle anche, ma diversamente dal bipedismo occasionale delle grandi scimmie attuali. Eppure, le mani e gli arti superiori sono ancora quelli di chi si arrampica sui rami per nutrirsi e per ripararsi dai predatori. La discesa dagli alberi non è stata quindi una marcia trionfale di conquista, ma una ben più circospetta esplorazione di nuove nicchie ecologiche, attraverso differenti combinazioni di comportamenti misti, un po' arborei e un po' da spazi aperti. Come
ha detto un noto evoluzionista commentando l'andatura di questi ominidi
primigeni, « se volete trovare qualcosa che cammini come lui, cercate nella scena del bar intergalattico di Guerre Stellari
». Spostare l'intero peso corporeo sugli arti inferiori non è certo un adattamento ottimale, come sanno coloro che soffrono di lombalgia;
quindi deve essere stato selezionato per un vantaggio diretto, tanto conveniente per i suoi possessori da
compensare ampiamente le scomodità collaterali: il mal di schiena è il fastidioso effetto collaterale di un' invenzione evolutiva senza la quale
noi oggi non saremmo qui.
Le scoperte dell'ultimo decennio hanno
completamente rivoluzionato la famiglia degli ominidi. Sicuramente uno dei
ritrovamenti più importanti è quello avvenuto casualmente in Kenya, nella regione delle
Tugen Hills,
nel
marzo 2000: si tratta di porzioni ossee di 5 individui risalenti a 6 milioni di
anni fa (ore 12.19.12), cui è stato dato prima
il nome provvisorio di “Millenium Man”, e poi quello scientifico di Orrorin tugenensis.
Doveva essere alto tra 100 e 120 cm, e pesare tra i 35 e i 50 Kg. Alcuni antropologi
identificarono subito in esso il più antico ominide, antenato dei successivi,
mentre per altri
si trattava solo di uno dei tanti tentativi evolutivi che hanno
portato a un ramo morto, mentre Ardipiteci ed Australopiteci avrebbero avuto
più successo. Più recentemente, tuttavia, le ricerche pubblicate su
Science da
Brian G. Richmond, della George Washington
University, e da
William L. Jungers, della Stony Brook
University,
affermano che le prime avvisaglie della rivoluzione anatomica del bipedismo
sarebbero comparse nell'albero genealogico dell'evoluzione umana proprio con Orrorin tugenensis.
I due paleoantropologi, attraverso un' analisi quantitativa delle combinazioni di caratteri che definiscono la morfologia degli arti inferiori, hanno verificato che
esso, pur così antico, possedeva già tutti gli adattamenti necessari per l'andatura
bipede, ed in particolare una postura simile a quella degli australopiteci e dei parantropi, i due generi che
dominarono la famiglia degli ominidi fino a due milioni di anni fa. Orrorin, che in lingua locale significa non a caso
« uomo originale », camminava come gli Australopiteci, oscillando sulle anche, ma diversamente dal bipedismo occasionale delle grandi scimmie attuali. Eppure, le mani e gli arti superiori sono ancora quelli di chi si arrampica sui rami per nutrirsi e per ripararsi dai predatori. La discesa dagli alberi non è stata quindi una marcia trionfale di conquista, ma una ben più circospetta esplorazione di nuove nicchie ecologiche, attraverso differenti combinazioni di comportamenti misti, un po' arborei e un po' da spazi aperti. Come
ha detto un noto evoluzionista commentando l'andatura di questi ominidi
primigeni, « se volete trovare qualcosa che cammini come lui, cercate nella scena del bar intergalattico di Guerre Stellari
». Spostare l'intero peso corporeo sugli arti inferiori non è certo un adattamento ottimale, come sanno coloro che soffrono di lombalgia;
quindi deve essere stato selezionato per un vantaggio diretto, tanto conveniente per i suoi possessori da
compensare ampiamente le scomodità collaterali: il mal di schiena è il fastidioso effetto collaterale di un' invenzione evolutiva senza la quale
noi oggi non saremmo qui.
Nel 2013 Sergio Almécija del Dipartimento di Scienze Anatomiche della Facoltà di Medicina della Stony Brook University, nello Stato di New York, ha promosso uno studio su Orrorin tugenensis insieme ad alcuni colleghi spagnoli e italiani, tra cui David M. Alba, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino. Essi hanno studiato a fondo i caratteri anatomici dei reperti ritrovati nelle Tugen Hills, e mediante analisi statistiche multivariate hanno mostrato la vicinanza delle caratteristiche del reperto indicato dalla sigla BAR 1002'00, la porzione prossimale di un femore, ad alcuni schemi anatomici tipici proprio dei futuri australopiteci. Altre caratteristiche anatomiche, in particolare dei trocanteri, le protuberanze nella parte superiore del femore, sembrano invece riportare indietro le lancette dell'evoluzione, perché sono del tutto simili a quelle già presenti nelle scimmie del Miocene. I risultati indicano che i femori degli ominidi e quelli delle grandi scimmie si sono evoluti in differenti direzioni da una morfologia più primitiva, e che Orrorin si situa così in un punto intermedio tra le scimmie del Miocene e gli australopiteci del Pliocene. Tutto ciò porta a delineare uno scenario evolutivo dei primi ominidi un po' diverso da quello comunemente accettato, scenario i primi ominidi bipedi, tra cui Orrorin, si sarebbero evoluti dalle precedenti grandi scimmie del Miocene, ancora prevalentemente arboricole, ma che possedevano già in larga parte la stazione eretta. Ciò confermerebbe che nelle grandi scimmie attuali l'anatomia del femore ha seguito un adattamento successivo e legato alla sospensione ai rami degli alberi.
Il mistero dell'anello mancante
I genetisti hanno suggerito che gli antenati degli odierni uomini e scimpanzè si separarono tra loro tra i 4 e i 6 milioni di anni fa (tra le 12.19.12 e le 16.12.48), mentre gli antenati dei gorilla si staccarono tra i 7 e i 9 milioni di anni fa (tra le 06.28.48 e le 10.22.24), tuttavia non ci sono praticamente fossili di scimpanzè e gorilla, e quindi queste date sono state calcolate contando il numero di differenze di sequenze del DNA tra le tre specie e dividendo tale cifra per un presunto "tasso di mutazione" per i primati. Il problema è che spesso gli scienziati calcolano il tasso di mutazione usando le datazioni dei fossili di altre specie di primati, e poi lo applicano anche alle scimmie antropomorfe africane e agli esseri umani. Questo approccio tuttavia è soggetto a errori, poiché si basa sulla precisione dell'età dei fossili, e presuppone che i tassi di mutazione siano simili tra le specie di scimmie antropomorfe.
Ma l'antropologo molecolare Linda Vigilant dell'Istituto di Aantropologia Evolutiva Max Planck di Lipsia ha suggerito un modo migliore: utilizzare i dati dei recenti sequenziamenti del genoma degli esseri umani, che stima più precisamente il numero medio delle mutazioni avvenute nel tempo. Queste nuove stime possono poi essere utilizzate dagli scienziati per calcolare da quanto tempo si sono divise le linee evolutive. Fino a poco tempo fa, però, i ricercatori non disponevano di abbastanza campioni di DNA di scimpanzé e di altri primati per poter calcolare con precisione questi tempi di generazione.
Ora, dopo un decennio di analisi dei modelli di riproduzione negli scimpanzè e nei gorilla in Africa, Vigilant e Kevin Langergraber, primatologo all'Università di Boston, hanno trovato i dati di cui avevano bisogno. Per ottenere i tassi di mutazione, il team ha diviso il numero di mutazioni tra genitori e prole (per questo è stato analizzato il DNA dei coproliti raccolti) con i tempi di generazione appena calcolati. Ebbene, i tassi sono più lenti di quanto precedentemente stimato utilizzando i fossili.
Il risultato è che gli esseri umani e gli scimpanzè si sono divisi prima del previsto: almeno dai 7 agli 8 milioni di anni fa, ma forse già 13 milioni di anni fa (alle 22.41.36 del 30 dicembre). La scissione tra i gorilla e il lignaggio che portò a esseri umani e scimpanzè avvenne invece tra gli 8 e i 19 milioni di anni fa (tra le 11.00.48 del 30 e le 08.25.36 del 31). Queste datazioni sono soggette a un margine di errore così alto perché, come ha spiegato Vigilant, presuppongono che i tassi di mutazione oggi calcolati siano rimasti costanti nel tempo in tutte e tre le specie. Resta perciò da verificare se i tassi di mutazione siano stati più veloci nel passato che nel presente.
Sahelanthropus tchadensis
Un ulteriore curioso ritrovamento è avvenuto nel 2001 nel Ciad, quindi lontano da quell'Etiopia che finora era stata indicata come terra d'origine dei primi ominidi, dove è stato disseppellito un teschio che promette di essere il più antico progenitore dell'uomo. Qualche dente, pochi frammenti di mandibola e soprattutto un cranio ben conservato che si è subito guadagnato la copertina di Nature con il titolo « Il più antico ominide conosciuto »; questi fossili sono affiorati a Toros-Menalla nel deserto del Djurab, vicino alle antiche sponde del lago Ciad, grazie al lavoro della missione archeologica franco-ciadiana diretta da Michel Brunet, dell’Università di Poitiers. L’esemplare a cui appartenevano questi resti è stato soprannominato Toumaï, che nella lingua locale significa "speranza di vita". Ovviamente l'analisi del ritrovamento è ancora in corso, ma è già chiaro che Sahelanthropus tchadensis, come è stato battezzato il reperto, mostra una apparentemente enigmatica combinazione di caratteristiche antiche e moderne. Il cervello appare di dimensioni analoghe a quello di uno scimpanzè (360-390 cm3), ma la faccia è più piatta e i denti ricordano quelli degli ominidi più recenti; cosa ancora più importante, esso somiglia agli altri membri del ramo umano anche per l’anatomia del foro che si trova alla base del cranio, dove si inserisce la colonna vertebrale. La sua posizione è più anteriore rispetto a quanto accade negli animali quadrupedi, e il suo orientamento più verso il basso suggerisce che la testa di Toumaï fosse posizionata sopra un collo eretto. Henry Gee, editore della rivista scientifica Nature, affermò che il fossile ci ha chiarito quanto confuso sia stato il processo di evoluzione: "Ci mostra che l'evoluzione dagli antichi ominidi a ciò che siamo oggi non è stata una progressione continua e regolare", e aggiunge: "è il più importante reperto a memoria d'uomo dai tempi degli australopiteci degli anni venti. È sorprendente trovare un meraviglioso cranio così antico". Del resto il teschio è così vecchio da appartenere ad un'epoca in cui le creature che sarebbero diventate gli uomini moderni non si erano differenziate molto dalla linea che avrebbe originato le scimmie.
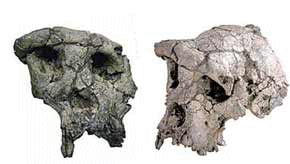 Il problema di colmare la lacuna temporale
di oltre 6 milioni di anni tra Ramapithecus ed Australopithecus anamensis
resta però intatto in tutta la sua drammaticità, e non ci aiuta il fatto
che questi ominidi dovevano essere sicuramente molto rari sulla Terra, visto
il loro livello di specializzazione, non solo a paragone della popolazione
mondiale odierna, ma anche di altre specie a loro
contemporanee; Quindi le testimonianze di ciò che accadde tra i dieci e i cinque
milioni di anni fa sono molto scarse, e diventa difficilissimo ricostruire
un albero genealogico della specie umana districandosi in mezzo a tutte le false
partenze, gli esperimenti falliti e i vincitori effettivi prodotti dall'evoluzione, come vedremo parlando del Neozoico. Ilpotrebbe essere sia un antenato dell'uomo, sia un membro di un ramo collaterale del nostro albero
genealogico. I ricercatori credono si tratti di un maschio, ma anche questo
fatto non è chiaro al 100%.
Il problema di colmare la lacuna temporale
di oltre 6 milioni di anni tra Ramapithecus ed Australopithecus anamensis
resta però intatto in tutta la sua drammaticità, e non ci aiuta il fatto
che questi ominidi dovevano essere sicuramente molto rari sulla Terra, visto
il loro livello di specializzazione, non solo a paragone della popolazione
mondiale odierna, ma anche di altre specie a loro
contemporanee; Quindi le testimonianze di ciò che accadde tra i dieci e i cinque
milioni di anni fa sono molto scarse, e diventa difficilissimo ricostruire
un albero genealogico della specie umana districandosi in mezzo a tutte le false
partenze, gli esperimenti falliti e i vincitori effettivi prodotti dall'evoluzione, come vedremo parlando del Neozoico. Ilpotrebbe essere sia un antenato dell'uomo, sia un membro di un ramo collaterale del nostro albero
genealogico. I ricercatori credono si tratti di un maschio, ma anche questo
fatto non è chiaro al 100%.
Finalmente, nel 2022 (quindi dopo oltre vent'anni di studio matto e disperatissimo), paleontologi dell’Università di Poitiers, del Consiglio Nazionale delle Ricerche Francese, dell’Università di N’Djamena e del Centro Nazionale di Ricerca del Ciad hanno pubblicato i dati delle loro ricerche su questo fossile; sulla base della morfologia esterna e della struttura interna dei fossili, Guillaume Daver, Franck Guy e colleghi hanno concluso che Sahelanthropus tchadensis doveva passare la maggior parte del suo tempo in piedi, probabilmente non solo quando era a terra ma anche sugli alberi. Per arrampicarsi poteva contare su avambracci ricurvi come quelli degli scimpanzè e mani dalla presa ferma. Naturalmente la controversia non è chiusa in modo definitivo: infatti, mentre le ulne sono chiaramente scimmiesche, il femore è incompleto, perché conserva la parte allungata (diafisi) ma è privo delle giunture. Seppure la pistola fumante non ci sia ancora, comunque, una forma di bipedismo con adattamenti per arrampicarsi è l’ipotesi più ragionevole considerando l’insieme delle evidenze fossili e l’habitat forestale e lacustre. Resta però un altro problema irrisolto: nonostante sia un milione di anni più vecchia di qualsiasi altro ominide noto, la nuova specie non è saltata fuori dall’Africa orientale, ma da un sito distante 2500 chilometri dai fossili più vicini di questo gruppo: non si può dunque escludere che le somiglianze con il ramo umano si siano evolute indipendentemente, senza un legame diretto di parentela. La caccia all'antenato comune di tutti i primati superiori odierni continua.
La mutevolezza del clima influenzò l'evoluzione degli ominidi
Le sponde del lago Turkana, in Kenya, oggi sono aride e inospitali, e sono dominate dalle praterie. Ma non è sempre stato così: negli ultimi quattro milioni di anni, il bacino di Omo-Turkana ha visto l'avvicendarsi di diversi climi ed ecosostemi che hanno fatto da cornice a importanti passi dell'evoluzione umana. Una delle teorie paleoantropologiche più accreditate prevede che un inaridimento a lungo termine del clima nell'area abbia contribuito all'espansione delle praterie e alla diffusione dei grandi erbivori, trasformazioni che a loro volta ebbero un'influenza determinante nello sviluppo umano durante il Pliocene e il Pleistocene. Sulla base di questa teoria molti studi hanno analizzato la locomozione, le proporzioni del corpo, la termoregolazione, la ricerca del cibo, l'uso di utensili e l'organizzazione sociale degli antichi ominidi in funzione di un progressivo inaridimento.
Scott Blumenthal dell'Università di Oxford e colleghi di una collaborazione internazionale hanno scelto di studiare il bacino di Omo-Turkana, i cui sedimenti preservano abbondanti prove fossili delle prime fasi di sviluppo degli ominidi e degli ambienti correlati per tutto il periodo del Pliocene e del Pleistocene. La storia ambientale della zona non è necessariamente rappresentativa di tutta l'Africa orientale, ma offre comunque un modello per studiare la correlazione tra l'antico clima e l'ecologia. Questi studi però avevano ottenuto risultati scarsi e discutibili a causa della difficoltà di ricostruire milioni di anni di dati climatici con una risoluzione spazio-temporale soddisfacente.
Gli autori hanno usato una tecnica che prevede l'analisi degli isotopi dell'ossigeno presenti nei denti degli erbivori. Hanno valutato in particolare la presenza dell'ossigeno-18, che dipende dalle precipitazioni e dal grado di umidità dell'ambiente in cui vivevano gli animali: l'evaporazione infatti arricchisce di ossigeno-18 l'acqua piovana. I ricercatori sono così riusciti a ricostruire il livello di aridità della regione e il tipo di piante che vi cresceva, in rapporto alla dieta degli erbivori stessi. Inaspettatamente, non è emersa alcuna associazione tra i trend di inaridimento a lungo termine e l'espansione della vegetazione bassa e la diffusione degli erbivori. Il confronto con la stratigrafia dei resti di ominidi e dei relativi reperti archeologici dimostra invece che i nostri antichi antenati vissero per milioni di anni in un ambiente caratterizzato da una notevole variabilità del clima e dell'abbondanza delle precipitazioni. L'evoluzione umana non subì quindi la pressione selettiva di un processo di inaridimento ambientale progressivo, ma fu influenzata da interazioni ecologiche tra animali e vegetazione molto più varia e complessa di quanto finora immaginato.
Debutta il bipedismo
Robert Echkardt, docente di sviluppo genetico e di morfologia evoluzionistica della Penn State University, ha studiato a lungo uno dei momenti cruciali della nostra evoluzione, creando con la tomografia immagini tridimensionali di uno dei tre fossili femorali appartenenti alla specie Orrorin tugenensis, e in particolare del collo del femore, quella parte di osso che connette la gamba al bacino tramite la testa femorale. Ebbene, dalla sua struttura ha dedotto che questa creatura effettivamente è il più antico ominide per il quale abbiamo prove evidenti di stazionamento eretto e di bipedismo. Secondo Echkardt, Orrorin era abituato a camminare e correre, perchè il suo osso femorale presenta differenze strutturali così profonde da far presupporre non solo che la specie camminasse sei milioni di anni fa, ma che lo facesse già dai diecimila ai centomila anni prima. Insomma, l'evoluzione stava lavorando da tempo per adattare la creatura a un nuovo modello comportamentale». Negli scimpanzè e nei gorilla, la parte superiore e quella inferiore del collo del femore hanno pressappoco lo stesso spessore, mentre nell' uomo il rapporto è di 1 a 4; nel fossile di Orrorin il rapporto è di 1 a 3, e questo suggerisce inequivocabilmente una transizione biomeccanica alla posizione eretta. Infatti il tipo di postura determina il modo in cui si distribuisce il peso, e la struttura dell'osso si adatta alle diverse condizioni. In altre parole, anche se il fossile si presenta delle stesse dimensioni di quello di uno scimpanzè, la sua composizione interna ha rivelato una storia molto diversa. Non solo: anche la muscolatura di Orrorin, si ipotizza, sarebbe stata molto simile alla nostra, con un grande gluteo più complesso che negli scimpanzè. « Il prossimo passo », ha affermato il professor Echkardt, « sarà quello di realizzare simulazioni tridimensionali delle forze di tensione e compressione attorno all'osso femorale, per produrre un modello completo della muscolatura. Inoltre, siamo alla ricerca di altri fossili di Orrorin, per ripetere l'analisi tomografica, applicando software più avanzati, e riconfermare i risultati ottenuti: c'è ancora chi, fra gli studiosi, continua ad essere scettico, forse per le implicazioni delle nostre conclusioni, che metterebbero Orrorin proprio alla base dell' albero evolutivo dell' uomo ».
Ma come si è passati all' andatura su due gambe? Ci sono varie teorie sul bipedismo, e quindi sull' adattamento di Orrorin al terreno. Certamente ha avuto un ruolo importante il cambiamento climatico sopravvenuto alla fine del Miocene, al quale abbiamo già accennato: la siccità ha fatto sparire le rigogliose foreste che allora coprivano l'Africa, e al loro posto è subentrato un habitat da savana. In questa situazione, il bipedismo garantisce due vantaggi molto semplici, che a noi oggi sembrano scontatissimi: un repertorio di locomozione flessibile (poter correre, saltare, nuotare e arrampicarsi in caso di necessità) e una minore esposizione della superficie corporea ai raggi solari. Orrorin viveva in una parte del continente africano, a oriente della Rift Valley, che stava inaridendosi sempre più: l'habitat di foresta andava frammentandosi e si formavano radure sempre più estese, che poi diventarono praterie e savane. Se per sopravvivere è necessario attraversare ampi spazi aperti sotto un sole tropicale, magari portando in braccio un cucciolo o del cibo, e cercando di avvistare i predatori in agguato nell'erba alta, il bipedismo è una soluzione efficace, ancor più se lo si è già sviluppato occasionalmente durante veloci scarpinate sul suolo per variare la propria dieta. Insomma, che cosa ci ha reso, in principio, « umani »: una questione di testa o, piuttosto, di piedi buoni? La risposta a questa domanda non è più così scontata, dopo aver scoperto che nella storia della famiglia ominide la postura eretta è comparsa molto prima dei nostri grossi cervelli e delle superbe facoltà della nostra mente!
Aggiungiamo che gli antropologi stanno ancora studiando lo scheletro quasi completo di un ominide di sesso femminile vissuto circa 3,67 milioni di anni fa (alle 16.51.20 di San Silvestro) che potrebbe essere stato il primo ad avere un'andatura bipede simile alla nostra. Soprannominato "Little Foot" per le piccole dimensioni delle ossa del piede, che sono state tra le prime parti dello scheletro a essere scoperte, è stato classificato come Australopithecus prometheus, un'attribuzione ancora discussa. Il fossile ha richiesto ben vent'anni per essere estratto dalla roccia in cui era contenuto, è completo al 90 % (per un confronto, la famosissima Lucy è completa solo al 40 %!) ed in vita era alto ben 130 cm, molto più di altri ominidi conosciuti. Le gambe di "Little Foot" sono più lunghe delle sue braccia, in modo simile a quanto avviene negli esseri umani moderni, rendendola il più antico ominide in cui è presente con certezza quella caratteristica: questo significa che "Little Foot" era più adatta a camminare eretta sul suolo rispetto a molti altri australopiteci, alcuni dei quali sembrano aver trascorso più tempo a muoversi tra gli alberi. Le ossa e i denti del cranio di "Little Foot" sono così insoliti da giustificare la sua classificazione come specie distinta, e secondo alcuni potrebbe essere l'antenato di un genere di ominidi chiamato Paranthropus, coesistito con le prime specie Homo per circa un milione di anni. Il lavoro intorno a questo insolito primate bipede è però appena agli inizi.
L'ipotesi della scimmia acquatica
Un'altra delle caratteristiche che ci distingue nettamente dai nostri parenti primati è il fatto di avere la pelle quasi del tutto spoglia di peli. È vero, abbiamo peli in abbondanza sul capo, sul viso, intorno al pube e spesso sul torace, ma in confronto alle altre scimmie antropomorfe noi siamo praticamente nudi. Come abbiamo fatto a perdere la pelliccia che caratterizza praticamente tutti i mammiferi? La domanda ce la poniamo da secoli, ma trovare una risposta convincente è assai difficile, anche perchè della deambulazione eretta è rimasta traccia fossile negli scheletri dissepolti, ma nessuno dei reperti rinvenuti presenta lembi di pelle. Solo di recente la genetica ha cominciato a fornire risposte convincenti, e ne riparleremo a proposito del Neozoico, ma vale la pena di citare qui un'ipotesi che era molto in voga fino a poco tempo fa, quella della scimmia acquatica.
Come si sa, i cetacei sono del tutto nudi in modo da ridurre l'attrito dell'acqua sulla superficie della pelle. Sulla base di questa considerazione, lo zoologo inglese sir Alister Hardy (1896-1985) nel 1960 propose che la nostra specie potrebbe aver avuto una fase acquatica lungo il corso della propria evoluzione. In pratica, tra i 5 e i 7 milioni di anni fa (tra le 10.22 e le 14.16 di San Silvestro) i sollevamenti tettonici nella Rift Valley dell'Africa orientale avrebbero isolato gli antenati dell'uomo dal loro ambiente preferito, quello delle foreste tropicali, ed essi si sarebbero adattati a una vita semiacquatica nelle paludi, lungo le coste e nelle pianure alluvionali, dove avrebbero vissuto per circa un milione di anni, vivendo costantemente immersi in acqua e lasciando emergere solo la testa. Questi ominidi si sarebbero accoppiati in posizione ventrale, avrebbero avuto un solo piccolo alla volta e le mammelle delle femmine sarebbero state estremamente prosperose, per permettere l'allattamento sopra il livello dell'acqua. Le prove di questa fase acquatica sarebbero la forma del corpo, che ricorderebbe quella dei mammiferi semiacquatici, i capelli concentrati solo sulla sommità del capo e lo strato di grasso posto direttamente sotto pelle. Certamente si tratta di un'ipotesi affascinante, ma è sbagliata almeno per tre ragioni.
In primo luogo, i mammiferi acquatici non sono tutti assolutamente nudi: ad esempio la lontra presenta una pelliccia densa e impermeabile, che intrappola l'aria facilitando il galleggiamento. In secondo luogo, i dati fossili mostrano come gli ambienti acquatici del tempo pullulassero di coccodrilli affamati e ippopotami aggressivi, di fronte ai quali i nostri piccoli e indifesi antenati non avrebbero avuto scampo. In terzo luogo, la teoria della scimmia acquatica sostiene che i nostri predecessori avrebbero modificato lo stile di vita da terrestre a semiacquatico, per poi tornare a tempo pieno sulla terraferma. Oggi dovremmo assistere ad alcune tribù africane che vivono ancora a quel modo, cosa che invece non avviene di certo. L'ipotesi più semplice è che gli uomini abbiano sempre vissuto sulla terraferma, e che l'evoluzione della pelle nuda sia dovuta ai cambiamenti climatici che favorirono le praterie della savana rispetto alle foreste, e la storia della scienza ci insegna che la spiegazione più semplice è spesso quella giusta.
La dorsiflessione degli ominidi
Ad agitare gli ambienti accademici è venuto poi uno studio condotto da Jeremy DeSilva dell'Università del Michigan, il quale è partito da una considerazione stupefacente tanto è semplice: per poter vivere appollaiati sugli alberi, spostandosi con agilità di ramo in ramo, occorre il fisico giusto, e gli ominidi non ce l'avevano. È una questione di dorsiflessione: basta misurare l'angolo dell'articolazione dell'anca per capire che gli ominidi vissuti nell'arco temporale che va da 4,1 ad 1,5 milioni di anni fa (dalle 16 alle 21 del 31 dicembre) non avrebbero potuto vivere spostandosi da un albero all'altro. L'evidente differenza con gli scimpanzè moderni, che hanno un angolo di dorsiflessione più che doppio, suggerisce che la loro vita sugli arbusti non rappresentasse la quota più significativa della loro esistenza, o che comunque l'attività di arrampicata fosse molto differente dal modo con cui si arrampicano gli scimpanzè. Osservando gli scimpanzè del Kibale National Park in Uganda, Jeremy DeSilva e la sua équipe hanno paragonato la conformazione di questi primati a dodici fossili di tibie appartenuti a ominidi, rilevando l'impossibilità che questi ultimi abbiano vissuto prevalentemente sugli alberi prima di assumere una postazione eretta. Come vivessero non è ancora chiaro, ma secondo DeSilva una cosa è certa: i nostri progenitori non erano dei grandi arrampicatori.
Merita una segnalazione anche l'annuncio, fatto a La Paz nel maggio 2008 dal paleontologo boliviano Manuel de la Torre, della scoperta dell'impronta pietrificata del piede di un uomo che camminò eretto fra 15 e 5 milioni di anni fa lungo quello che oggi è l'altipiano andino in Bolivia, quindi di gran lunga più vecchia di quella scoperta nell'agosto del 2007 da archeologi egiziani su una roccia nell'oasi di Siwa e risalente a circa due milioni di anni fa. Secondo il suddetto antropologo l'orma misurerebbe 29,5 centimetri (taglia 39), corrispondente ad un uomo alto circa 1,70 metri e pesante 70 chili, e sarebbe stata rinvenuta nelle vicinanze del lago Titicaca, a circa 70 chilometri ad ovest di La Paz, fra i villaggi di Tiwanaku e Guaqui, abitati da indigeni Aymara. In realtà i contadini della zona la conoscevano già e la veneravano come « l'orma dell'Inca », attribuendola ad antichi quanto mitologici antenati precolombiani. De la Torre ha anche affermato che l'uomo la lasciò camminava probabilmente sulla spiaggia di quello che all'epoca doveva essere un lago, che si seccò progressivamente, pietrificandosi e conservando tracce di quell'orma lasciata nella notte dei tempi. È inutile dire che, se lo straordinario rinvenimento fosse confermato da ulteriori indagini, esso sconvolgerebbe tutte le teorie finora accettate sull'evoluzione della specie umana, esposte qui sopra. La scoperta è stata però accolta con un certo scetticismo degli addetti ai lavori: alcuni ritengono che l'orma sia un escamotage per sostenere la superiorità delle culture del Nuovo Mondo su quelle del Vecchio Mondo, in un generale clima di anticolonialismo e di antioccidentalismo che oggi sembra pervadere tutti i paesi in via di sviluppo. Solo il futuro potrà dirci se a lasciare quell'enigmatica impronta fu davvero un primitivo essere umano tre volte più vecchio dei più antichi ominidi africani conosciuti.
 Ardipithecus ramidus
Ardipithecus ramidus
Non basta. Nel 1994, nella Rift Valley etiopica, fu trovato il fossile di Ardipithecus ramidus, ominide risalente a 4,4 milioni di anni fa (15.26.05 del 31/12). Nel 1997 è stato trovato molto vicino un altro fossile abbastanza simile, battezzato come Ardipithecus ramidus kadabba perché certamente più antico (circa 5,6 milioni di anni: ore 13.00.55) e probabilmente prossimo alla biforcazione fra gli ominidi e le scimmie antropomorfe come scimpanzè e gorilla). Il 2 ottobre 2009 la rivista "Science" ha poi annunciato la scoperta di uno scheletro femminile scoperto in Etiopia e battezzato Ardi. L'analisi di cranio, denti, pelvi, mani, piedi, e altre ossa rivela un mix di tratti primitivi che Ardi condivide con i suoi progenitori, i primati del Miocene, ma rivela anche caratteristiche presenti solo in ominidi di epoche posteriori. Ardi, che probabilmente pesava circa 110 chili, aveva un cervello vicino alla dimensione degli scimpanzè di oggi, un quinto della nostra, e una faccia relativamente piccola. Maschi e femmine avevano circa le stesse dimensioni. L'analisi dello smalto dei denti dimostra che Ardi era onnivora, una dieta diversa da quella delle attuali scimmie africane come gli scimpanzè, che si nutrono principalmente di frutta, e i gorilla, che si nutrono per lo più di foglie, fusti e corteccia. Il team di ricerca ha suggerito che Ardi impiegasse molto del suo tempo sul terreno, alla ricerca di piante commestibili, funghi, invertebrati e, forse, piccoli vertebrati.
« Con l'Ardipiteco abbiamo una forma non specializzata che non è evoluta molto rapidamente verso l'Australopiteco. Così, se analizziamo il corpo dalla testa ai piedi troviamo un mosaico, che non corrisponde né a uno scimpanzè né a un uomo » ha sottolineato Tim White della University of California di Berkeley, uno dei principali autori della ricerca. « Questi studi sono stati effettuati grazie a uno sforzo di ricerca internazionale, e aprono una nuova finestra su un periodo dell'evoluzione umana su cui ancora sappiamo molto poco, in cui i primi ominidi stavano stabilendosi in Africa dopo essersi differenziati dai propri progenitori, che avevano in comune con le scimmie africane » ha aggiunto Brooks Hanson, vice direttore di Science. La mancata somiglianza di Ardi di con uno scimpanzè o con un uomo moderno indica che l'ultimo antenato comune tra le grandi scimmie antropomorfe e l'uomo è vissuto almeno 6 milioni di anni fa.
Il nuovo fossile ha dimostrato incontestabilmente che la specie era in grado di assumere già la posizione eretta. Tuttavia, tra le molte sorprese associate a questo ominide, vi è la conclusione che questa specie fece i suoi primi passi verso la deambulazione eretta non nella savana, come ritenuto finora da generazioni di scienziati, ma su un territorio di foresta rada, cioè erano ancora per lo più arboricoli. Stanley Ambrose e colleghi dell'Università dell'Illinois sono giunti a questa conclusione analizzando i denti di alcune decine di specie di mammiferi trovati nello stesso strato di suolo dell'Ardipithecus, per ricostruire il suo ambiente naturale. Ambrose e colleghi hanno analizzato le abbondanze relative degli isotopi di carbonio nelle ossa di 36 esemplari e nei denti di 5 altri di Ardipithecus confrontandoli con altri 172 denti di alcune decine di mammiferi di diverse specie trovati nello stesso suolo. Secondo i risultati delle loro analisi, a quel tempo il territorio variava da un terreno boschivo nella parte occidentale della zona studiata fino a una prateria intervallata da alberi.
"La dieta di Ardipithecus è caratteristica della foresta rada e dei margini della foresta", hanno dichiarato i ricercatori. "Nella sua dieta c'è molto più del carbonio dell'ecositsema della foresta rada che nello scimpanzè ma molto meno dei loro discendenti, gli australopithecus che correvano nella savana." Queste prove, insieme con gli studi anatomici che indicano che Ardipithecus era in grado di camminare eretto ma anche di afferrare i rami degli alberi con i piedi, suggeriscono che questo ominide ancestrale fece i suoi primi passi su due gambe nella foresta molto prima che si avventurasse nella prateria aperta.
Ultimamente però alcuni antropologi hanno proposto che Ardipithecus sia piuttosto un antenato delle grandi scimmie antropomorfe africane, proprio perchè il suo arto superiore presenta un mosaico di caratteristiche ominidi e scimmiesche, facendo permanere i dubbi su questo nostro antichissimo parente. Tra questi ci sono Bernard Wood, direttore del Center for the Advanced Study of Hominid Paleobiology della George Washington University, e Terry Harrison, direttore del Center for the Study of Human Origins della New York University, i quali hanno studiato a lungo le relazioni evolutive tra i fossili di Orrorin, Sahelanthropus e Ardipithecus, arrivando alla conclusione che le somiglianze tra di esse potrebbero semplicemente essere dovute ad omoplasie, cioè a caratteristiche comuni a specie non imparentate, frutto di convergenze evolutive. Wood e Harrison sottolineano come i piccoli canini di Ardipithecus e di Sahelanthropus siano le prove più convincenti a supporto dell'ipotesi che si tratti dei primi antenati dell'uomo. Tuttavia, la riduzione dei canini non è esclusiva della nostra linea evolutiva, ma è un processo che si è verificato in modo indipendente in molte linee di scimmie fossili (Oreopithecus, Ouranopithecus e Gigantopithecus), presumibilmente per effetto di un simile cambiamento nell'alimentazione.
Australopithecus afarensis
La famiglia più importante di ominidi pliocenici è però certamente quella degli Australopiteci ("scimmie australi"), il cui primo rappresentante è l'Australopithecus anamensis (il suo nome in dialetto kenyota significa "lago"), che visse tra i 4,2 ed i 3,9 milioni di anni fa (tra le 15.49.26 e le 16.24.29) e che trascorreva l'esistenza lungo corsi fluviali fiancheggiati dalla savana; la maggior parte dei suoi resti sono stati trovati nei siti di Kanapoi e Allia Bay. Molto meglio conosciuto per la quantità e qualità dei fossili ritrovati è tuttavia l'Australopithecus afarensis, vissuto nel triangolo di Afar in Etiopia (da cui il nome) tra i 3,9 e i 3 milioni di anni fa (tra le 16.24.29 e le 18.00.36). I suoi fossili (la celeberrima Lucy, così nominata dal titolo di una canzone dei Beatles, "Lucy in the sky with diamonds") furono ritrovati nel 1974 da Donald Johanson (1943-vivente) dell'Università dell'Arizona, e rivoluzionarono la paleontologia umana. Di Lucy sappiamo che era una giovane donna, era alta un metro, sapeva camminare in posizione eretta e aveva probabilmente perso l'abilità necessaria a saltare tra un ramo e l'altro. Gli afarensis erano ancora molto simili alle scimmie antropomorfe: faccia larga con una fronte bassa, naso piatto, mascella superiore sporgente e una mandibola voluminosa con grandi denti posteriori, oltre ad un volume del cervello pari a soli 480 cm3.
Un certo numero di caratteristiche anatomiche del bacino, delle gambe e della colonna vertebrale indica che questi individui camminavano abitualmente su due arti quando erano al suolo, ma le dita delle mani e dei piedi incurvate e altri indizi forniscono una prova sicura del fatto che Lucy e gli altri membri della sua specie trascorrevano buona parte del loro tempo arrampicati sugli alberi. Se prendiamo come confronto gli scimpanzè di oggi, possiamo calcolare che Lucy fosse capace di arrivare a varie decine di metri di altezza e che per dormire al sicuro dai predatori si preparasse "un letto" fra i 7 e i 20 metri. Da lì forse, un giorno o una notte di 3,18 milioni di anni fa (ore 17.48.35), Lucy perse l'equilibrio, finendo a terra e rompendosi spalle, collo, torace e bacino. « Quelle fratture sono compatibili con un evento di decelerazione verticale », ha scritto su " Nature" nell'agosto 2016 John Kappelman dell'Università del Texas a Austin, cioè con una caduta rovinosa. Kappelman e il suo team hanno osservato i resti delle ossa di Lucy con una tomografia computerizzata a raggi X ad alta risoluzione, poi hanno poi consultato dieci ortopedici, e hanno smentito l'ipotesi precedente, secondo cui le fratture sarebbero frutto del normale processo di fossilizzazione. « Lucy è caduta dall'alto e ha tentato consciamente di proteggersi portando avanti le braccia ». Per quanto precisa sia stata l'analisi di Kappelman, però, la sua conclusione non è stata accolta senza scetticismo. Lo scopritore di Lucy, Donald Johanson, è uno dei più critici nei confronti del lavoro dei suoi colleghi, sottolineando che anche antilopi, gazzelle, rinoceronti e giraffe mostrano spesso fratture simili, ma non sono certamente caduti da un albero. Secondo lui Lucy è morta sbranata da un grande felino, che ha rotto le ossa e persino il cranio della malcapitata ominide con le potenti mandibole, e anche secondo me questa resta l'ipotesi più probabile per risolvere questo "Cold Case" del Cenozoico.
La camminata di Laetoli
Nonostante questo, all'Australopithecus afarensis è generalmente attribuita la celeberrima "camminata di Laetoli", scoperta nel 1978, in prossimità del lago Eyasi, al confine tra Kenya e Tanzania, da un'equipe di paleoantropologi guidata da Mary Leakey (1913-1996). Vicino a Laetoli sorge il Sadiman, un vulcano oggi spento, ma certamente attivo attorno ai 4 milioni di anni fa. Nel corso di un'eruzione esso emise una nube di cenere composta di carbonatite, che si depositò sul territorio circostante formando uno strato di circa 1,5 cm. A quello sbuffo di cenere seguì uno scroscio di pioggia della stagione umida, che impregnò le ceneri. Alcuni ominidi camminarono sulle ceneri inumidite dalle prime piogge. Il clima semiarido dell'area favorì l'immediata essiccazione di questo strato, che ben presto fu ricoperto da nuove ceneri prodotte dal vulcano e trasportate dal vento. Oggi, tali ceneri hanno dato vita ad uno strato di tufo vulcanico di circa 20 cm. e conservano una sequenze di 50 orme, che si estendono per più di 23 metri. Inizialmente si pensava che si trattasse delle impronte di due individui che camminavano verso nord, non contemporaneamente tra loro; più probabilmente appartengono a tre ominidi, due adulti e un bambino, uno dei quali, durante la marcia, ha posato i piedi all'interno delle impronte dell'individuo che lo precedeva. Nel sito di Laetoli si sono conservate numerose tracce di animali, tra cui antilopi, giraffe, rinoceronti, elefanti, equidi estinti del genere Hipparion, iene, uccelli ed altre scimmie. Le orme sono datate a 3,7 milioni di anni fa (alle 16.47.50) e dalle loro dimensioni, rispettivamente 18,5 x 8,8 cm e 21,5 x 10 cm, si suppone che questi antichi ominidi fossero alti tra i 120 e 140 cm. Tim White, presente al rivenimento, dichiarò: « Se ce ne fosse una su una qualsiasi spiaggia, oggi, e si chiedesse a un bambino di quattro anni di cosa si tratti, quel bimbo direbbe subito che si tratta di orme lasciate da qualcuno che camminava. Non le troverebbe differenti da altre centinaia di orme. La morfologia esterna è la stessa: tallone moderno ben formato, arcata ben sostenuta, polpastrelli delle dita. L'alluce sta bene allineato, non sporge di lato, come l'alluce di una scimmia antropomorfa, o come l'alluce in tanti disegni di australopiteci che si possono vedere riprodotti nei libri. »
Non tutti però hanno condiviso lo stesso entusiasmo, e molti scienziati hanno continuato a dibattere se le orme di Laetoli indicassero un bipedismo analogo a quello dell'uomo moderno o piuttosto uno meno efficiente, simile a quello degli scimpanzé, in cui ginocchia e fianchi sono piegati durante la deambulazione. Solo in tempi recenti David Raichlen e colleghi dell'Università dell'Arizona ha condotto inequivocabili esperimenti biomeccanici appositamente progettati per risolvere la questione, filmando, registrando con strumenti di cattura del movimento e approntando modelli tridimensionali delle impronte lasciate da un gruppo di soggetti che camminavano su un letto di sabbia, sia nella nostra maniera, sia nel modo accucciato degli scimpanzè. I ricercatori hanno poi esaminato la profondità relativa delle impronte all'altezza del tallone e delle dita, riscontrando che essa è quasi identica a quella prodotta da una persona che cammini in posizione eretta: una camminata alla moda dello scimpanzé provoca invece impronte molto più profonde all'altezza delle dita. « Questa forma di camminata è energeticamente molto efficiente, e suggerisce che i ridotti costi energetici siano stati molto importanti per l'evoluzione del bipedismo prima della comparsa del nostro genere », ha spiegato Raichlen. « La parte più affascinante di questo studio consiste nel fatto di suggerire che, al tempo in cui i nostri antenati avevano ancora un'anatomia adattata a passare molto tempo sugli alberi, avevano già sviluppato una forma di bipedismo molto efficiente, simile a quella dell'uomo moderno ».
Questi risultati sono stati poi confermati da un'ulteriore analisi condotta da ricercatori dell'Università di Liverpool, di quella di Manchester e della Bournemouth University, i quali hanno utilizzato una nuova tecnica statistica, mutuata da quelle utilizzate per lo studio dell'imaging funzionale del cervello, così da ottenere una impronta tridimensionale media delle 11 impronte intatte del percorso Laetoli. « Abbiamo trovato che le impronte di Laetoli rappresentano un tipo di camminata bipede in posizione eretta, con la spinta esercitata dalla parte anteriore del piede, in particolare dall'alluce, proprio come gli esseri umani odierni, e molto diversa dalla camminata bipede di scimpanzè e altre scimmie », ha dichiarato Robin Crompton, che ha partecipato alla ricerca. Quando camminano in posizione bipede, le grandi scimmie di oggi spingono infatti il terreno verso l'esterno con la parte centrale del piede. Questi studi confermerebbero l'opinione secondo cui l'andatura bipede è stata acquisita dagli antenati dell'uomo molto prima di quanto generalmente ritenuto, circa 3,7 milioni di anni fa (alle 16.47.50 di San Silvestro).
 Oggi la specie introdotta da Johanson
è stata rimessa in discussione: secondo alcuni gli esemplari ad essa
riconducibili apparterebbero invece a due specie distinte, l'una già
completamente bipede o quasi, l'altra ancora legata alla vita arboricola: le
impronte di Laetoli apparterrebbero allora alla prima di queste due neospecie,
che sarebbe l'effettiva antenata dell'uomo, mentre Lucy apparterrebbe alla
seconda. Comunque sia, le
spettacolari impronte fossili conservatesi nei tufi di Laetoli costituiscono
certamente la più antica testimonianza della locomozione
bipede umana; ma purtroppo esse sono state ripetutamente utilizzate da
gruppi di integralisti religiosi per sostenere la falsità dell'evoluzionismo,
attribuendole ad un uomo identico
a quello moderno che non ha mai subito trasformazioni morfologiche di sorta, o
addirittura da ufologi e ciarlatani vari per convincere i soliti creduloni che
si tratterebbe addirittura di orme lasciate da antichi extraterrestri in visita
di piacere sul nostro pianeta. Aveva ragione Gilbert K. Chesterton: « Quando
gli uomini non credono più a nulla, è allora che cominciano a credere a tutto!
»
Oggi la specie introdotta da Johanson
è stata rimessa in discussione: secondo alcuni gli esemplari ad essa
riconducibili apparterebbero invece a due specie distinte, l'una già
completamente bipede o quasi, l'altra ancora legata alla vita arboricola: le
impronte di Laetoli apparterrebbero allora alla prima di queste due neospecie,
che sarebbe l'effettiva antenata dell'uomo, mentre Lucy apparterrebbe alla
seconda. Comunque sia, le
spettacolari impronte fossili conservatesi nei tufi di Laetoli costituiscono
certamente la più antica testimonianza della locomozione
bipede umana; ma purtroppo esse sono state ripetutamente utilizzate da
gruppi di integralisti religiosi per sostenere la falsità dell'evoluzionismo,
attribuendole ad un uomo identico
a quello moderno che non ha mai subito trasformazioni morfologiche di sorta, o
addirittura da ufologi e ciarlatani vari per convincere i soliti creduloni che
si tratterebbe addirittura di orme lasciate da antichi extraterrestri in visita
di piacere sul nostro pianeta. Aveva ragione Gilbert K. Chesterton: « Quando
gli uomini non credono più a nulla, è allora che cominciano a credere a tutto!
»
Ma non è tutto. Dato che le orme (vedi foto a sinistra) appartengono a due adulti che camminavano molto vicini, gli artisti chiamati a rendere visivamente la scena per giornali e musei li avevano rappresentati come una coppia formata da un maschio e una femmina, abbracciati per farsi coraggio, con un piccolo al seguito. Ma nel 2016 un gruppo di ricerca italo-tanzaniano ha rinvenuto altre impronte a distanza di un centinaio di metri, che sembrano cambiare completamente il senso del quadro. Fra tanti segni lasciati dagli animali, si riconoscono le orme di due ominidi. Uno ha dimensioni notevoli, tanto che gli studiosi lo hanno ribattezzato Chewie, come lo scimmione peloso di Guerre stellari. « Abbiamo stimato 1,65 metri d'altezza per quasi 45 chili, e questo ne fa il più grosso esemplare di Australopithecus afarensis conosciuto », ha dichiarato Giorgio Manzi dell'Università La Sapienza di Roma, che ha studiato i reperti insieme a colleghi dell'Università di Perugia, Pisa, Firenze e Dar es Salaam. Questa taglia over size suggerisce che i maschi e le femmine della specie di Lucy avessero una struttura fisica molto diversa. Il fenomeno è chiamato dimorfismo sessuale, e consente di ipotizzare una strategia riproduttiva poligamica, che spazzerebbe via la rappresentazione tradizionale. I maschi dominanti, insomma, dovevano avere molte compagne, un po' come accade tra i moderni gorilla. « Considerando insieme tutte le impronte, vecchie e nuove, ci troviamo di fronte a un'unità composta da un maschio, due o tre femmine e uno o due piccoli », ha calcolato Manzi, sempre che lo scenario non si complichi proseguendo gli scavi. Le impronte potrebbero insomma sollevare il velo sull'organizzazione sociale di una specie estinta da milioni di anni. Non c'è da stupirsi che qualcuno abbia paragonato le tracce di Laetoli a quelle di Neil Armstrong sul suolo lunare. Le une rappresentano i primi passi dell'umanità nel cosmo, le altre il viaggio evolutivo dell'uomo dalla notte dei tempi.
Nel marzo 2006 è stato dato l'annuncio della scoperta di un possibile anello di ricongiunzione fra gli ardipiteci e gli australopiteci: un team internazionale di paleoantropologi diretto da Tim White dell'università di Berkeley ha rinvenuto nel deserto dell'Afar, la regione nord-orientale dell'Etiopia dove è stata ritrovata anche Lucy, alcuni fossili risalenti a 4,1 milioni di anni fa (16.00.07 del 31/12), che sembrano rappresentare una forma primitiva di Australopithecus anamensis, ma esibiscono in modo molto netto la discendenza dal genere Ardipithecus. Lo stesso Tim White afferma: « Il fatto che i fossili di Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis ed Australopithecus afarensis siano stati rinvenuti in strati sedimentari successivi nella stessa area lungo il medio corso dell'Awash, il fiume che segna il confine meridionale dell'Afar, suggeriscono una precisa successione evolutiva ». L'affermazione non è certamente priva di fascino.
La "bambina di Lucy"
Nel 2018 poi un gruppo di ricercatori del Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire, dell'Università di Chicago e dell'Università di Boston ha annunciato la scoperta del fatto che gli adulti di Australopithecus afarensis avevano un'andatura perfettamente bipede, ma i loro piccoli trascorrevano ancora molto tempo sugli alberi, proprio come le specie evolutivamente precedenti. La scoperta è arrivata dall'esame del piede di un australopiteco di sesso femminile e di due o tre anni di età, i cui resti fossili erano venuti alla luce nel 2002 nella località di Dikika, nella regione dell'Afar, in Etiopia. Dato che il reperto era stato ritrovato non lontano da dove nel 1974 era stata trovata Lucy, e che apparteneva alla stessa specie, la stampa ha soprannominato il fossile "la bambina di Lucy", malgrado risalga a 3,32 milioni di anni fa (alle 17.32.13 del 31/12), vale a dire circa 300.000 anni prima della più famosa Lucy (circa 35 minuti prima). Lo scheletro di Dikika, ben conservato e quasi completo, è stato subito attribuito ad Australopithecus afarensis, ma poiché era parzialmente immerso in una matrice rocciosa, il suo studio ha richiesto un lunghissimo e certosino lavoro di rimozione. Ebbene, l'analisi della struttura del piede della bambina di Dikika ha mostrato che l'arto non ha alcune caratteristiche proprie del piede delle grandi scimmie e assenti negli esseri uomini moderni, ma la base dell'alluce e il calcagno hanno una forma che suggerisce che i piccoli afarensis, pur essendo in grado di camminare con la stazione eretta, trascorrevano parecchio tempo sugli alberi. « Se vivessimo nell'Africa di tre milioni di anni fa, senza fuoco, senza abitazioni e senza alcun mezzo di difesa, faremmo meglio a salire su un albero quando tramonta il Sole », ha osservato Jeremy DeSilva, del Dartmouth College, primo autore dello studio. « Camminare male in un paesaggio pieno di predatori è una buona ricetta per l'estinzione ». Nel corso dello sviluppo, però, la curvatura dell'alluce si rettificava e si rinforzava il calcagno, e il piede assumeva una forma perfettamente adatta all'andatura bipede. La scoperta potrà contribuire a una migliore comprensione dei processi di adattamento ecologico e alimentare in atto negli afarensis, che hanno infine portato all'evoluzione del genere Homo.
Aggiungiamo il fato che, come ha scoperto un gruppo internazionale di ricercatori diretti da Emma Mbua della Mount Kenya University e da Masato Nakatsukasa dell'Università di Kyoto, la regione in cui viveva Australopithecus afarensis era ben più vasta e varia di quanto finora ritenuto. Fino al 2016 tutti i fossili di questo ominide erano stati ritrovati nella zona centrale della Rift Valley; invece i nuovi fossili identificati, costituiti da denti e ossa dell'avambraccio di un soggetto adulto e di due neonati e datati fra 3,5 e 3,3 milioni di anni fa (tra le 17.11.12 e le 17.34.34 del 31/12), provengono da una regione più a est di questa grande fossa tettonica, situata sugli altopiani del Kenya. Più precisamente il ritrovamento è avvenuto nel sito di Kantis, in prossimità delle colline Ngong, vicino a Ongata Rongai, un sobborgo di Nairobi. Il sito di Kantis ha iniziato a essere scavato negli anni novanta quando un contadino della zona riferì a un gruppo di geologi, che si trovava nella zona per condurre alcuni rilievi, che negli anni settanta si era imbattuto in alcune ossa fossilizzate, della cui importanza scientifica non si era tuttavia reso conto. « In precedenza erano stati scoperti resti di Australopithecus bahrelghazali in Ciad, confermando che la distribuzione dei nostri antenati ominidi si estendeva nell'Africa centrale, ma questa è la prima volta che un fossile di australopiteco è stato trovato a est della Great Rift Valley », ha spiegato Nakatsukasa. Le analisi sui resti di vegetali e animali della stessa epoca hanno inoltre mostrato che la regione di Kantis era umida, ma l'ambiente era più semplice e caratterizzato da un minor numero di alberi rispetto agli altri siti in cui erano stati trovati fossili di questa specie. « A quanto pare Australopithecus afaransis era bravo ad adattarsi ad ambienti diversi », osserva Nakatsukasa. Si tratta forse della prima grande migrazione di massa nella storia degli ominidi?
Australopithecus deyiremeda
I fossili di una nuova specie di Australopiteco sono stati rinvenuti il 4 e il 5 marzo 2011 nella regione etiope di Afar, dove gli archeologi avevano già trovato i resti di Lucy, da una squadra di ricercatori del Museo di Storia Naturale di Cleveland. Gli ominidi a cui quelle ossa di mandibola e quei denti appartennero sono stati assegnati a una nuova specie, Australopithecus deyiremeda, che nella lingua delle genti di Afar significa « parente stretto ». Grazie alla radiodatazione, alle analisi paleomagnetiche e geologiche, si è potuto stabilire che quei fossili risalgono tra i 3.5 e i 3.3 milioni di anni fa (tra le 17.11.12 e le 17.34.34 del 31/12). Ciò significa che la nuova specie si sovrappose cronologicamente all'Australopithecus afarensis.
Che cosa avevano in comune questi Australopiteci, e cosa di diverso? Sicuramente condividevano la regione geografica in cui vivevano, oltre che numerosi tratti morfologici. Il « parente stretto » di Lucy aveva però anche tratti assai diversi. La mandibola era più robusta, mentre i denti, dallo smalto spesso, erano di forma e dimensione diversi; in particolare i canini erano molto più piccoli che nei resti di qualsiasi altro ominide. Il fatto che i denti anteriori siano piuttosto piccoli indicherebbe che, nonostante le due specie di Australopiteco abitassero fianco a fianco, le loro diete erano probabilmente differenti. Si pensa che i resti ritrovati appartengano a quattro individui, che avevano tratti misti tra scimmia ed essere umano (tra l'altro nell'aprile 2015 è stato scoperto che, a quarant'anni di distanza dal suo ritrovamento, tra le ossa di Lucy vi sono mischiate quelle di una scimmia).
La nuova specie è un'ulteriore dimostrazione del fatto che la stirpe di Lucy non era la sola specie di ominide ad abitare la regione di Afar nel Medio Pliocene. « Le attuale prove fossili mostrano con forza che c'erano due, se non tre, specie umani che vivevano nella stessa epoca e in prossimità geografica », ha dichiarato Yohannes Haile-Selassie, capo del progetto paleontologico Woranso-Mille nella regione di Afar. Una questione, quella della convivenza di diverse specie di ominidi, dibattuta da decenni. La morfologia della mandibola e l'anatomia dentale di Australopithecus deyiremeda mostra anche come nei reperti fossili appaiano prima di quanto si pensasse in precedenza alcune caratteristiche tradizionalmente associate al genere di mammiferi ominidi Paranthropus (tra 2,7 e 1 milione di anni fa, tra le 18.44.38 e le 22.00.12) e al genere Homo, la cui origine sarebbe spostata indietro a 2.8 milioni di anni fa. Il nostro albero genealogico si arricchisce e si complica ogni anno di più.
Australopithecus bahrelghazali
La dieta degli antenati dell'uomo si è discostata da quella tipica delle grandi scimmie molto prima di quanto si pensasse, come ha dimostrato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Oxford, dell'Université de N'Djamena in Ciad e del Collège de France. Per arrivare a questa conclusione, Julia Lee-Thorp e colleghi hanno analizzato i rapporti isotopici del carbonio (13C/12C) depositato nei denti di Australopithecus bahrelghazali, un ominide vissuto circa 3,5 milioni di anni fa (ore 17.11.12), i cui resti fossili sono stati ritrovati nel 1993 a Bahr el Ghazal, nella regione di Toro Koro, in Ciad: si tratta delll'unica specie di australopiteco scoperta fuori dall'Africa orientale. Il carbonio presente nei denti deriva da quello assorbito per via alimentare, il quale presenta rapporti isotopici differenti e caratteristici a seconda che provenga da foglie e frutti di arbusti e piante ad alto fusto (piante C3) oppure da vegetali di tipo erbaceo (piante C4). Ora, nei denti del bahrelghazali i ricercatori hanno identificato la firma isotopica propria di una dieta ricca di alimenti derivati da piante C4, un tipo di alimenti che non fa parte della dieta standard delle grandi scimmie e che rappresenta in qualche misura una sfida, dato che per un loro adeguato sfruttamento sono necessari adattamenti a livello sia dentale sia digestivo, poiché sono ricchi sia di fitoliti (depositi di granuli silicei delle cellule vegetali) sia di amidi complessi.
In effetti, fino a non molti anni fa si riteneva che negli antenati dell'uomo moderno questo cambiamento nella dieta fosse avvenuto molto più di recente, tanto che la scoperta avvenuta nel 2012 che Paranthropus boisei (di cui riparleremo a proposito del Neozoico) avesse un regime alimentare al 77 % a base di piante erbacee, era considerata da alcuni una sorta di "aberrazione" isolata. Il fatto che l'Australopithecus bahrelghazali abbia adottato così precocemente una dieta di questo tipo è spiegato con la necessità di sopravvivere in un ambiente molto più aperto di quello abitato da altri ominidi contemporanei, come Australopithecus afarensis in Africa orientale. I dati paleoambientali raccolti indicano infatti che il paesaggio del bacino del Ciad all'epoca era caratterizzato da una vasta savana, con pochi alberi collocati per lo più ai bordi di un grande lago e dei corsi d'acqua a esso connessi. La sopravvivenza in un habitat simile, evidentemente, era condizionata dalla capacità di ampliare lo spettro degli alimenti utilizzati, includendovi le nuove risorse di tipo C4.
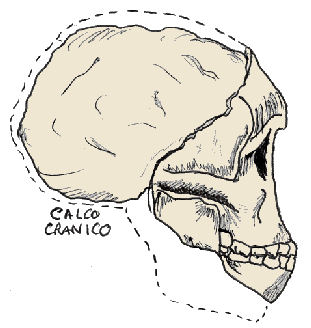 Australopithecus
africanus
Australopithecus
africanus
Circa tre milioni di anni fa (verso le 18), dall'Australopithecus afarensis discese l'Australopithecus africanus, il cui primo ritrovamento si deve al paleontologo sudafricano Raymond Dart (1893-1989), il quale a Taung, circa 120 Km a nord di Kimberley nel Botswana, nel 1924 portò alla luce il teschio di un cucciolo di Australopithecus africanus, da lui battezzato con il celebre nome di "Bambino di Taung" (vedi figura) e vecchio di 2,3 milioni di anni (ore 19.31.22). Il cranio non si è conservato, ma ci resta il calco pietrificato del suo cervello, del volume di circa 380 centimetri cubi. Il Bambino di Taung ha i lobi frontali squadrati e la forma dei poli temporali che suggeriscono un alto grado di encefalizzazione, il che ha portato a concludere che nell'Australopithecus africanus si sia verificata una riorganizzazione neurologica rispetto ai cervelli di altri ominidi più antichi, anche se non è ancora chiaro se questa riorganizzazione sia avvenuta o meno in corrispondenza di un ampliamento del cervello, dato che non sono disponibili resti fossili dei diretti ascendenti di Australopithecus africanus. Tra l'altro, la famosa rivista antropologica « The American Journal of Physical Anthropology » ha dato notizia nel gennaio 2006 di uno studio condotto dal professor Lee Berger, uno dei più famosi specialisti di paleontologia al mondo e ordinario della Wits University di Johannesburg, il quale ha permesso di appurare che questo cucciolo di soli tre anni e mezzo fu inequivocabilmente ucciso da un'aquila, perchè sul suo teschio sono ancora evidenti i segni del becco dell'uccello, che uccise il piccolo e poi ne estrasse gli occhi per divorarli (per saperne di più, cliccare qui). « Ciò dimostra », commenta il prof. Berger, « che i nostri progenitori non si dovevano preoccupare solo dei grandi animali che vivevano sulla terraferma, come i felini o gli sciacalli, ma anche di questi predatori che vivevano nei cieli. Oggi invece la situazione si è capovolta: sono i volatili predatori a doversi preoccupare della rapacità degli esseri umani. » Parole sante.
Tornando all'Australopithecus africanus, con circa 160 cm di altezza e 40 Kg di peso, l'adulto aveva le dimensioni di un giovane gorilla ed un volume cranico pari a 500 cm3: ancora vicino a quello scimmiesco, quindi. È però nella forma del cranio che afarensis ed africanus differivano notevolmente: in Africanus troviamo infatti denti più simili a quelli umani che a quelli delle scimmie, con canini più piccoli di quelli di afarensis, ed una mascella completamente umana. La dentizione dimostra che si trattava di un onnivoro, ma si nutriva prevalentemente di carne. Quasi certamente abitava nelle steppe ed era cacciatore, dunque il suo stile di vita era molto diverso da quello dei parantropi suoi contemporanei, dei quali parleremo tra breve a proposito del Pleistocene. Esso era in grado di adoperare semplici bastoni e pietre per cacciare, e possedeva più di ogni altra specie del tardo Pliocene le caratteristiche dell'uomo moderno; ma è del tutto aperto il dibattito intorno alla sua parentela con noi. In altre parole, nessuno oggi può precisare se è stato l'Australopithecus africanus a dare inizio alla linea evolutiva culminata nell'Homo sapiens sapiens, o se si tratti solo di un "esperimento fallito", cugino del genere Homo e nulla più.
Nel 2004 il geologo Naomi Levin della Johns Hopkins University di Baltimora ha scoperto un sito di 1,95 milioni di anni fa (alle 20.12 del 31 dicembre), nel nord del Kenya, e ha trascorso quattro anni di scavo che hanno prodotto migliaia di strumenti litici e ossa fossili. Levin ha così scoperto che i primi ominidi che vivevano in quello che è oggi il nord del Kenya mangiavano una più ampia varietà di cibi di quanto si è creduto fino ad oggi: la loro guida comprendeva pesci e animali acquatici come tartarughe e coccodrilli. Ricchi di proteine e sostanze nutritive, secondo la Levin tali alimenti possono avere svolto un ruolo chiave nello sviluppo del cervello nei nostri antenati. « Considerando che la crescita di un cervello più grande richiede molte sostanze nutrienti e calorie, gli antropologi hanno postulato che la carne aggiunta alla loro dieta sia stata la chiave per lo sviluppo di un cervello più grande », ha dichiarato la Levin. « Prima d'ora non avevamo a disposizione una ricchezza di dati tale da dimostrare la grande varietà di risorse animali che i primi umani avevano a disposizione. » Levin e i suoi collaboratori sono stati in grado di concludere che gli ominidi macellavano almeno 10 tipi di animali, tra cui tartarughe, pesci, coccodrilli e antilopi: segni di tagli trovati sulle ossa indicano che gli ominidi utilizzavano utensili di pietra a spigoli vivi per macellare le loro prede. « Non è chiaro per noi come i primi uomini trattassero la carne macellata, ma è probabile che la mangiassero cruda », ha proposto Levin. Il suo gruppo ipotizza che l'ambiente umido e paludoso abbia offerto a quegli ominidi l'occasione per aumentare le proteine nella loro dieta e far crescere così i loro cervelli, mentre probabilmente evitavano il contatto con i carnivori più grandi, come le iene e leoni.
Lo studio del Bambino di Taung compiuto negli Anni Duemila da un gruppo internazionale di paleoantropologi della School for Advanced Research di Santa Fe, nel New Mexico, del Dipartimento di Antropologia della Florida State University a Tallahassee e dell'Istituto e Museo antropologico di Zurigo, in Svizzera, ha appurato che l'evoluzione cerebrale degli ominidi potrebbe essere stata fortemente influenzata dalle limitazioni nel rapporto tra le dimensioni della pelvi materna e quelle del cranio del feto. I suddetti ricercatori infatti hanno descritto per la prima volta la sutura frontale del Bambino di Taung. Nell'essere umano, tale la sutura inizia a chiudersi a partire dai due anni e si salda entro i sei anni; una saldatura incompleta (sutura metopica) non è rara, al contrario di quanto avviene nelle grandi scimmie. Considerando gli ominidi adulti vissuti tra 3 e 1,5 milioni di anni fa (più o meno tra le 18 e le 21), la sutura metopica è relativamente frequente, il che porta a ipotizzare che durante la prima evoluzione degli ominidi una fusione tardiva simile a quella degli umani moderni abbia rappresentato un meccanismo adattativo. In particolare, tre aspetti potrebbero aver favorito un ritardo della chiusura della sutura frontale: la difficoltà di partorire neonati con un cranio di grandi dimensioni attraverso un apparato sessuale riconfigurato per l'andatura bipede (il cosiddetto "dilemma dell'ostetrica"); alti tassi di crescita del cervello subito dopo la nascita; e infine la riorganizzazione e l'espansione della neocorteccia frontale. Complessivamente, i dati raccolti suggeriscono che l'evoluzione del cervello dell'ominide avvenne nell'ambito di un insieme di costrizioni feto-pelviche, che avrebbero richiesto la modificazione degli schemi di ossificazione neurocranica frontale.
Le mani dell'australopiteco
Secondo Matthew Skinner dell'Università del Kent a Canterbury, gli antenati dell'uomo potrebbero aver cominciato a maneggiare utensili già oltre tre milioni di anni fa (alle 18 in punto del 31/12), ovvero circa 500.000 anni (poco meno di un'ora) prima di quanto pensato prima di lui. Il paleontologo inglese si è basato sulla comparazione delle ossa delle mani di esseri umani moderni, scimpanzè, altre grandi scimmie, Neanderthal e specie ancora più antiche di ominidi. La scoperta più significativa riguarda le mani di Australopithecus africanus: mentre le ossa spugnose delle mani delle scimmie antropomorfe non sono adatte a gesti propri dell'uomo, quelle di Australopithecus presentano una struttura interna « compatibile con l'opposizione forzata del pollice con le altre dita, adottata tipicamente per maneggiare utensili », mentre sembrano aver perso le caratteristiche che in altri animali le rendono ideali per camminare sulle nocche o arrampicarsi sugli alberi.
Fino a tempi recenti, gli strumenti in pietra più antichi di cui si avesse notizia erano quelli ritrovati accanto ai resti di un ominide vissuto tra 2,4 e 1,5 milioni di anni fa (tra le 19.19.40 e le 21 in punto), che fu per questo battezzato Homo habilis. Nel 2000, però, sono stati rinvenuti in Etiopia alcuni utensili risalenti a 2,6 milioni di anni fa (ore 18.56.19). Basandosi poi sui segni presenti su ossa animali ritrovate sempre in Etiopia, e datate a 3,4 milioni di anni fa (ore 17.22.53), alcuni studiosi hanno ritenuto che fossero stati usati utensili per tagliare la carne di quegli animali. La nuova indagine su Australopithecus sembra confermare la teoria di un uso degli utensili molto più antico di quanto si pensasse.
Il punto è capire quando gli ominidi abbiano sviluppato la capacità di impugnare con precisione tra il pollice e le altre dita un frammento appuntito di selce, in modo da usarlo per staccare la carne dalle ossa delle prede. Skinner e colleghi ritengono che, per stabilire il periodo in cui è avvenuto questo cruciale passaggio evolutivo, analizzare la struttura interna delle ossa delle mani sia più adatto di altri approcci più tradizionali che si limitavano a valutare la forma esterna di quelle ossa. Con questo metodo, inoltre, è possibile dedurre che un ominide manovrava utensili, anche se questi utensili non sono stati materialmente rinvenuti; naturalmente, il ritrovamento di un vero strumento in pietra di tre milioni di anni fa metterà a tacere qualsiasi dubbio.
Il superudito degli australopiteci
I primi ominidi vissuti circa due milioni di anni fa (ore 20.00.24) avevano un udito più sensibile alle alte frequenze sia rispetto al nostro, sia rispetto a quello degli scimpanzè. A scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori dell'Universidad Complutense di Madrid, dell'Universidad de Alcalá e della State University of New York a Binghamton, i quali ipotizzano anche che proprio questa particolare sensibilità potrebbe essere la radice del successivo sviluppo del linguaggio. Grazie alla tomografia computerizzata, Rolf Quam e colleghi hanno ricostruito le strutture scheletriche dell'orecchio di molti dei primi fossili umani scoperti nei siti sudafricani di Sterkfontein e Swartkrans, per poi applicare modelli informatici che permettono di correlare la struttura dell'orecchio alla sensibilità per differenti frequenze. In precedenza lo stesso gruppo di ricerca aveva sfruttato la stessa procedura per stabilire le capacità uditive dei presunti antenati dell'uomo di Neanderthal, vissuti circa 430.000 anni fa (ore 23.00.47) a Sima de los Huesos, in Spagna, scoprendo che gli abitanti di Sima avevano un udito pressoché identico a quello dell'uomo moderno.
Rispetto agli altri primati, gli esseri umani si caratterizzano per avere una maggiore sensibilità in una più ampia gamma di frequenze. Tra 1,0 e 5,0 kHz, i valori di trasmissione di potenza del suono nell'essere l'umano sono significativamente più elevati rispetto a quelli nello scimpanzè. Dalla ricerca è emerso che Australopithecus africanus, pur avendo un udito complessivamente simile a quello degli scimpanzè, aveva una più elevata sensibilità alle frequenze comprese fra 1,5 e 3,0 kHz, per le quali la loro finezza di udito era addirittura superiore a quella umana. Quam e colleghi osservano che il modello di sensibilità uditiva di questi antichi ominidi poteva facilitare l'uso di una complessa comunicazione vocale a corto raggio in ambienti aperti, come la savana, in cui le l'intensità delle onde sonore si smorza prima di quanto avvenga sotto l'ombrello di una foresta pluviale.
I ricercatori fanno notare che all'interno di questa gamma di frequenze ricadono molti dei suoni emessi nella lingua parlata, in particolare quelli delle consonanti ad alta frequenza (come i fonemi t, k, f, e s), e che l'uso di consonanti è una delle principali differenze tra il linguaggio umano e la maggior parte delle forme di vocalizzazione proprie della comunicazione animale. « Non stiamo sostenendo che questi ominidi avessero pienamente sviluppato il linguaggio umano, che implica un contenuto simbolico », ha spiegato Quam, ricordando che le piccole dimensioni del loro cervello e l'anatomia del loro tratto vocale fa ritenere improbabile che avessero la capacità di linguaggio. Tuttavia, lo studio permette di « chiarire quando è emerso il particolare modello della percezione uditiva umana e, per estensione, quando possiamo avere iniziato a sviluppare il linguaggio ».
I manufatti algerini e kenyoti
Ma a che epoca risalgono i più antichi manufatti umani mai scoperti? Secondo un gruppo di ricercatori diretto da Mohamed Sahnouni del Centre National de Recherches Préhistoriques ad Algeri, a circa 2,4 milioni di anni fa (alle 19.19.40). Essi sono fatti di pietra e ossa di animali macellati e sono stati scoperti nel sito archeologico di Ain Boucherit, nel bacino del Beni Fouda, sull'altopiano dell'Algeria nordorientale. La scoperta, annunciata nel dicembre 2018, retrodata di oltre mezzo milione di anni i più antichi strumenti litici mai trovati in Nord Africa. La loro fabbricazione risalirebbe approssimativamente allo stesso periodo di quelli in assoluto più antichi, scoperti in Africa orientale in diverse regioni della Rift Valley, dalla gola di Olduvai, in Kenya, fino al bacino dell'Hadar, in Etiopia. Ciò implica che la tecnica di produzione di manufatti litici si diffuse dall'Africa orientale in altre regioni del continente in modo eccezionalmente rapido, oppure che ebbe origine quasi simultaneamente in regioni differenti. Altri manufatti e ossa con segni di macellazione sono stati portati alla luce anche in uno strato di roccia più recente, databile a 1,9 milioni di anni fa (ore 20.18.05), e dunque coevi o di poco precedenti a quelli finora considerati i più antichi dell'Africa settentrionale.
La tecnica di scheggiatura della pietra usata per ottenere gli strumenti di Ain Boucherit, che comprendono utensili da taglio a spigolo vivo per la lavorazione di carcasse animali, sembra la stessa di quella usata per i manufatti di Olduvai, pur mostrando sottili variazioni, forse imputabili al tipo di pietra calcarea e selce disponibili localmente. Tuttavia sono state scoperte anche pietre lavorate di una forma che non trova riscontri nei reperti provenienti dall'Africa orientale, e la cui funzione non è stata ancora chiarita. Le ossa fossilizzate che conservano traccia dell'uso degli utensili in pietra sono composte principalmente da resti di bovini ed equidi di piccole e medie dimensioni. I segni rilevati suggeriscono che venissero scuoiati, eviscerati e scarnificati, e che diverse ossa venissero frantumate per accedere al midollo. Non è però chiaro se questi antichi ominidi si dedicassero alla caccia o si limitassero ad approfittare di animali morti, caduti preda di grandi carnivori.
Finora non sono stati trovati resti di ominidi in associazione diretta con i primi strumenti di pietra conosciuti, né in Nord Africa, né in Africa orientale, per cui non si sa a quale o quali specie vada attribuita la paternità di quei manufatti e neppure se gli autori appartenessero al genere Australopithecus o a una delle prime forme di Homo, che secondo una recente scoperta forse era già presente in Etiopia 2,8 milioni di anni fa. I fossili provenienti dall'Algeria cambierebbero il punto di vista secondo cui l'Africa orientale sarebbe stata la culla dell'umanità: di fatto, sarebbe stata l'intera Africa ad essere la culla dell'umanità!
Ma c'è chi sostiene che i nostri antenati usassero in modo sistematico utensili in pietra già prima di 2,58 milioni di anni fa (alle 18.58.39). Il problema per gli scienziati del settore è dover comporre un quadro coerente dei diversi ritrovamenti fossili e litici, ognuno con la propria datazione. I paleoantropologi hanno posto un primo punto fermo nel 2013, quando hanno scoperto il più antico fossile attribuito al genere Homo. Gli scavi effettuati nel 2011 nel sito di Lomekwi, in Kenya, avevano però riportato alla luce percussori risalenti a 3,3 milioni di anni fa (alle 17.34.34), che rappresentano i più antichi strumenti in pietra mai scoperti. Questi strumenti sono quindi indizio di una più antica origine del genere Homo, oppure del fatto che la produzione di utensili non è esclusiva del genere umano, ma è anche attribuibile ad antenati più antichi di altri generi, come si può argomentare sulla base della constatazione che anche scimpanzè e altri primati fanno un uso rudimentale di attrezzi. Queste scoperte recenti sono poi da mettere in relazione con le acquisizioni ormai storiche del complesso industriale Olduvaiano, un insieme di utensili risalenti a circa 2,5 milioni di anni fa (alle 19.00.59) che prende il nome dalla gola di Olduvai, nel nord della Tanzania, dove sono stati scoperti. Ora arrivano i dati di Bokol Dora.
Christopher Campisano e colleghi dell'Arizona State University hanno effettuato la datazione dei reperti, basata in parte sull'analisi delle ceneri vulcaniche presenti nei sedimenti e in parte sulla "firma" magnetica dei sedimenti stessi, che conservano una registrazione dell'inversione della polarità del campo magnetico terrestre, avvenuta 2,58 milioni di anni fa. Gli autori hanno scoperto che i sedimenti del sito di Bokol Dora hanno una polarità "normale", tipica del periodo precedente l'inversione, differente dalla polarità dei reperti di altri siti vicini, tipica del periodo successivo all'inversione. Le caratteristiche delle schegge, inoltre, sono molto lontane da quelle di Lomekwi e di quelle dei primati non umani. La conclusione degli autori è dunque che gli utensili di Bokol Dora siano in continuità con l'industria olduvaiana, mentre mancano indizi che possano indicare una connessione con quelle precedenti dell'industria lomekwiana. L'ipotesi è che l'uso di utensili sia un tratto generalizzato di molti primati, compresi gli antenati degli esseri umani, ed è emerso diverse volte nel nostro lontano passato. Tuttavia, gli strumenti dell'industria olduvaiana segnano una svolta epocale, avvenuta probabilmente in risposta a una trasformazione dell'ambiente di grandi proporzioni. Dato che varie specie di primati di tutto il mondo usano abitualmente utensili di pietra per cercare nuove risorse, sembra altamente probabile che in tutta l'Africa differenti antenati abbiano trovato nuovi modi di usare strumenti litici per estrarre risorse dal proprio ambiente: per averne una conferma, naturalmente, abbiamo bisogno di trovare altri siti e altri utensili”.
Australopithecus sediba
Ma lo scoop del secolo potrebbe essere la
scoperta, annunciata l'8 aprile 2010, del possibile "anello mancante" tra
Australopithecus, a tutti gli effetti ancora una scimmia, e Homo, il genere a
cui noi apparteniamo. Si tratta dei resti fossili di due scheletri risalenti a
circa due milioni di anni
fa (verso le ore venti),
i quali così si collocano evolutivamente e temporalmente tra l'Australopitecus e il primo
rappresentante conosciuto del genere Homo.
I resti appartengono a un giovane maschio di 10-13 anni e a una femmina adulta, trovati a poca distanza l'uno dall'altro; il contesto geologico indica che
probabilmente la morte dei due ominidi è avvenuta in tempi ravvicinati,
entrambi morti precipitando in una grotta e presto ricoperti dai sedimenti che li hanno conservati.
Certamente si tratta degli australopiteci più recenti mai rinvenuti dai
paleontologi. Autore del
clamoroso ritrovamento è stato il già citato paleontologo sudafricano Lee Berger
della Witwatersrand University
di Johannesburg nella caverna di Malacapa, nel sito sudafricano di Malapa, in Sud Africa, a 40 chilometri da Johannesburg e a 15 dal più noto sito di Sterkfontein
(dove nel 1994 è già stato trovato un fossile quasi completo di
Australopitecus risalente a 3,3 milioni di anni fa):
non a caso quel sistema di grotte era già noto come la "Culla
dell'umanità" e classificato come
"Patrimonio dell'Umanità" dall'Unesco. Grazie a una tomografia
compiuta nell'estate 2012, all'interno di un blocco di roccia sono stati scoperti
ulteriori fossili tra cui parti della mascella e elementi critici del corpo, compresi quelli che sembrano essere un femore completo, costole, vertebre e altri elementi importanti degli arti, alcuni mai visti prima con altrettanta completezza nella documentazione fossile
dell'evoluzione umana. Berger ha catalogato i due
scheletri come appartenenti alla nuova specie Australopithecus sediba
(in lingua Sotho "sediba" significa "sorgente"), e a
proposito di essi ha dichiarato: « Possiamo stimare che l'altezza di entrambi fosse di circa 1,27 metri, anche se il giovane con tutta probabilità sarebbe divenuto più alto. La femmina doveva pesare sui 33 chilogrammi al momento della morte e il ragazzo sui
27. Appare certa la loro deambulazione eretta. La dimensione del cranio del giovane era fra i 420 e i 450 centimetri cubi, che è poco se confrontato con i 1200-1600 di quello umano, ma la forma sembra più avanzata di quello
degli australopiteci. ». La caratteristica che più di ogni altra rende particolarmente interessanti questi resti sono alcuni aspetti della struttura del bacino e le piccole dimensioni dei denti, che condividono con le prime specie di
Homo: il loro studio potrà
gettare luce sul periodo in cui i nostri antenati cominciarono a camminare in posizione
eretta, mentre
le ossa delle mani ci potrebbero dire quanto il nuovo ominide era in grado di
maneggiare manufatti. Il professor Phillip Tobias, antropologo che è stato fra i primi a identificare
l'Homo habilis come una specie umana nel 1964, ha
dichiarato la scoperta "entusiasmante": «
Scoprire un  intero scheletro, invece di un paio di denti o un osso di un braccio, è una rarità.
Un conto è trovare una mascella con un paio di denti, un altro trovare una mascella attaccata a un teschio, e tutti e due attaccati a una colonna vertebrale, un bacino e delle ossa
pelviche. »
I caratteri condivisi con gli Homo ad esso contemporanei potrebbero dunque candidare il sediba ad antenato comune di tutto il nostro
genere, ma alcuni antropologi hanno invitato alla prudenza, potendo quei
caratteri essere
dovuti a convergenza evolutiva (cioè potrebbero essere comparsi indipendentemente a seguito di analoghi adattamenti ambientali e di
dieta).
intero scheletro, invece di un paio di denti o un osso di un braccio, è una rarità.
Un conto è trovare una mascella con un paio di denti, un altro trovare una mascella attaccata a un teschio, e tutti e due attaccati a una colonna vertebrale, un bacino e delle ossa
pelviche. »
I caratteri condivisi con gli Homo ad esso contemporanei potrebbero dunque candidare il sediba ad antenato comune di tutto il nostro
genere, ma alcuni antropologi hanno invitato alla prudenza, potendo quei
caratteri essere
dovuti a convergenza evolutiva (cioè potrebbero essere comparsi indipendentemente a seguito di analoghi adattamenti ambientali e di
dieta).
Gli studi compiuti negli Anni Duemiladieci sui resti dell'Australopithecus sediba (a fianco sulla copertina di Science nell'aprile 2010) sembrano tuttavia andare in direzione contraria: i dettagli del cranio, del bacino, delle mani e dei piedi resi noti dai ricercatori di un'ampia collaborazione internazionale dimostrerebbero proprio che si tratta di un mosaico di caratteristiche arcaiche e moderne, che ne fanno il miglior candidato a rappresentare il più antico antenato diretto del genere Homo. Tali conclusioni sollevano dubbi su alcune teorie finora accettate che riguardano l'evoluzione dell'anatomia umana, compresa l'ipotesi che il bacino delle prime specie umane si evolse in risposta all'aumento delle dimensioni del cervello. Inoltre, alcuni particolari emersi dall'analisi dei reperti indicherebbero Australopithecus sediba anche come costruttore e utilizzatore di utensili. Queste scoperte sono state rese possibili sia dall'eccezionale stato di conservazione dei resti, sia dalla possibilità di effettuare una scansione a raggi X ad alta risoluzione del cranio del giovane maschio presso lo European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble, in Francia. Poiché i fossili sono troppo antichi per essere datati direttamente, i ricercatori hanno analizzato i sedimenti calcificati che hanno mantenuto i fossili così ben preservati. Robyn Pickering dell'Università di Melbourne in Australia e i suoi colleghi hanno utilizzato tecniche avanzate di datazione paleomagnetica, in grado di misurare quante volte il campo magnetico si è invertito, inducendo un cambiamento nella magnetizzazione delle rocce. Si è così appurato che i fossili di Australopithecus sediba risalgono a 1,977 milioni di anni fa (ore 20.00.05), e perciò predatano l'emergere dei primi tratti specifici del genere Homo, finora attribuiti a Homo habilis e Homo rudolfensis, dei quali parleremo a proposito del Pleistocene. Secondo le conclusioni dello studio, il cervello del giovane individuo era di tipo umano, ma ancora troppo piccolo rispetto ai cervelli tipici delle specie del genere Homo. La regione orbitale frontale del cervello, direttamente dietro le orbite oculari, mostra alcuni segni di riorganizzazione neurale, un processo che forse prelude alla formazione di un lobo frontale di tipo umano. I risultati di Pickering pongono dunque in dubbio la teoria di un graduale ampliamento del cervello durante la transizione da Australopithecus a Homo. Per contro, viene portata acqua al mulino dell'ipotesi alternativa, secondo cui la riorganizzazione dei neuroni nella regione orbitofrontale avrebbe permesso all'Australopithecus sediba di evolvere notevolmente pur mantenendo un cranio più piccolo.
La singolarità di Australopithecus sediba emerge anche dall'esame dei denti, che mostrano una differenza morfologica da quelli di Australopithecus afarensis e una maggiore vicinanza a quelli di Australopothecus africanus e degli Homo. L'analisi della mandibola, pur evidenziando una certa affinità con quella di altri australopiteci, per forma e dimensione ricorda molto di più quella dei più antichi reperti di Homo disponibili. Al contrario, gli arti superiori degli ominidi di Malapa hanno una morfologia in gran parte primitiva, apparendo ancora ben adattati all'arrampicata sugli alberi. È senz'altro possibile che queste caratteristiche siano solo il retaggio di un antenato realmente arboricolo, « ma è curioso », ha osservato Steven E. Churchill della Witwatersrand University, « che siano rimaste immutate per diversi milioni di anni, per poi scomparire improvvisamente con la comparsa del genere Homo ». Anche in questo caso c'è però un elemento di novità, che riguarda la mano, in cui si notano diversi elementi che potrebbero segnalare una maggiore capacità di manipolazione rispetto agli australopiteci precedenti.
Il mosaico emerge invece nettamente dall'esame della struttura toracica: la parte superiore del torace ha una forma conica caratteristica degli australopiteci, simile a quella delle grandi scimmie e poco consona all'oscillazione delle braccia che accompagna l'andatura bipede dell'uomo, la cui gabbia toracica è infatti sostanzialmente cilindrica. Nella parte inferiore si nota invece un certo restringimento mediolaterale tipico dell'uomo. Grazie al fatto che il fossile di Malapa è il primo scheletro di ominide primitivo che conserva intatti quasi tutti gli elementi della colonna vertebrale, i paleontologi hanno potuto trarre molte informazioni sulla la mobilità della parte inferiore della schiena. Australopithecus Sediba, che aveva lo stesso numero di vertebre lombari dell'uomo moderno, possedeva però una schiena funzionalmente più lunga e più flessibile nella sua parte inferiore. Inoltre, la forte curvatura lombare è simile a quella osservabile nello scheletro di Homo erectus di Nariokotome.
Nel 2015 in Sudafrica, durante gli scavi nella "Culla dell'Umanità", sono emerse anche alcune vertebre lombari fossili di due milioni di anni fa, scoperte da una collaborazione internazionale di paleoantropologi guidati da Scott Williams, della New York University, e dal già citato Lee Berger. Sono poche, ma sono bastate per stabilire che l’ominide a cui appartenevano, una femmina di Australopithecus sediba soprannominata Issa, sapeva camminare su due zampe in posizione eretta, come gli esseri umani, ma anche arrampicarsi ancora sugli alberi, come una scimmia. Insieme ad altre vertebre scoperte in passato, questi fossili hanno permesso di ricostruire uno dei modelli più completi di colonna vertebrale dei primi ominini. « La regione lombare è fondamentale per comprendere il bipedismo nei nostri primi antenati e capire quanto bene si fossero adattati a camminare su due zampe », ha commentato Williams. « Le serie di più vertebre lombari associate sono straordinariamente rare nella documentazione fossile degli ominidi: quelle relative a specie ancestrali africane sono solo tre ». Ricerche precedenti sulla colonna vertebrale inferiore incompleta di Australopithecus sediba avevano ipotizzato che questo australopiteco avesse una colonna vertebrale relativamente dritta, cioè senza lordosi, la curvatura lombare in avanti tipica degli umani moderni, ritenuta il segno dell’adattamento all’andatura bipede; si pensava quindi che la spina dorsale di Issa fosse più simile a quella di specie primitive di ominidi antichi, vissuti oltre due milioni di anni fa. L’analisi di Williams e colleghi sembra ribaltare questa visione, perché questi reperti mostrano che in realtà la lordosi di Issa era più accentuata che in qualsiasi altro australopiteco finora scoperto, superata solo da quella osservata in un esemplare di Homo erectus (il ragazzo di Turkana, scoperto in Kenya e risalente a 1,6 milioni di anni fa, cioè alle 20.53.07), e dagli esseri umani moderni. Significative sono anche le dimensioni e la forma dei processi trasversi delle vertebre, che suggeriscono una potente muscolatura del tronco, utile forse per comportamenti arboricoli. Gli studiosi hanno così concluso che Australopithecus sediba rappresenta una forma transitoria di antico antenato umano, dotato di una colonna vertebrale intermedia tra quella di umani moderni e neanderthaliani e quella delle grandi scimmie, e adattato sia a camminare a terra sia a vivere sugli alberi. In che modo queste combinazioni di tratti potessero coesistere nei nostri antichi antenati, compresi i potenziali adattamenti sia per camminare a terra su due zampe sia per arrampicarsi efficacemente sugli alberi, rimane una della maggiori questioni in sospeso sull’origine degli esseri umani.
Infine, dall'esame dell'anatomia degli arti inferiori di Australopithecus sediba, Jeremy M. DeSilva ha potuto avanzare una specifica ipotesi biomeccanica sul modo di camminare di questa specie, che camminava con una gamba completamente estesa e con un piede invertito durante la fase di oscillazione della camminata bipede; il contatto iniziale della parte laterale del piede provocava una marcata iperpronazione del piede, ossia una sua eccessiva rotazione, un po' come quella che si osserva nei podisti, che poi si ripercuoteva sulla postura della gamba. Questi meccanismi sono diversi da quelle spesso ricostruiti per altri australopiteci, e suggeriscono che ci può essere stato diverse forme di bipedismo durante il Pliocene e il Pleistocene. In conclusione, hanno osservato gli studiosi che hanno esaminato il nuovo australopiteco, « in qualunque punto di questi scheletri noi guardiamo, dalle mandibole ai piedi, possiamo vedere la prova del passaggio dall'australopiteco a Homo; ovunque vediamo la prova dell'evoluzione. » Se questa teoria riceverà ulteriori conferme dagli studi futuri, contribuendo a colmare le principali lacune dell'intricato cespuglio darwiniano dell'evoluzione umana, l'intera storia del genere Homo potrebbe davvero essere rivista in modo significativo.
La funzione del foro occipitale
Già cento anni fa era stata formulata l'ipotesi, assai controversa tra i paleontologi, che la posizione del foro alla base della scatola cranica che mette in comunicazione la cavità che ospita il cervello con il canale vertebrale, noto come foro occipitale o foramen magnum, sia correlata all'evoluzione del bipedismo. Nel 2017 però ad essa sono state portate nuove prove grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori della Stony Brook University e dell'Università del Texas ad Austin. Rispetto agli altri primati, il foro occipitale dell'essere umano è spostato in avanti, e questo spostamento sarebbe legato alla necessità di equilibrare il peso della testa che, con il bipedismo, si trova direttamente in cima alla colonna vertebrale. L'ipotesi fu formulata per la prima volta dal paleoantropologo Raymond Dart dopo l'analisi dei resti del cosiddetto "bambino di Taung". Secondo altri ricercatori lo spostamento sarebbe invece legato al progressivo aumento delle dimensioni relative del cervello della nostra specie, ma non al bipedismo.
Nel nuovo studio Gabrielle A. Russo ed E. Christopher Kirk hanno confrontato la posizione e l'orientamento del foro occipitale in 77 specie di mammiferi, tra cui marsupiali, roditori e primati. Dall'analisi dei dati raccolti i ricercatori hanno concluso che le dimensioni della scatola cranica non sono correlate né con la grandezza né con l'orientamento del foro occipitale, mentre si osserva una correlazione fra questi due parametri e il livello di bipedismo delle diverse specie. Per esempio, esseri umani, canguri, lepri saltatrici (roditori del genere Pedetes) e topi delle piramidi hanno un foro occipitale spostato più in avanti rispetto a quello dei loro parenti quadrupedi più stretti. Secondo la Russo, questa è una prova convincente che si tratta di un fenomeno reale. Il dibattito comunque prosegue.
Ominidi e batteri si sono evoluti insieme!
Prima di passare all'ultima era geologica, un'altra scoperta fondamentale. Come hanno dimostrato Howard Ochman dell'Università del Texas a Austin e colleghi, alcuni dei batteri che costituiscono il microbiota umano, l'insieme dei microrganismi che vivono nel nostro apparato digerente e sono importanti per la digestione, si sono coevoluti con la nostra specie nell'arco di milioni di anni. Gli autori dello studio hanno infatti prelevato e studiato i campioni fecali di 16 cittadini del Connecticut, negli Stati Uniti, e di grandi scimmie africane: 47 scimpanzè del Gombe National Park, in Tanzania, 24 bonobo selvatici che vivono nella Repubblica Democratica del Congo e 24 gorilla del Camerun. Grazie al sequenziamento genetico, Ochman e colleghi hanno analizzato le differenti versioni di uno specifico gene batterico presente in ciascun campione fecale. Da questa analisi, gli scienziati hanno ricostruito l'albero evolutivo di tre gruppi di batteri che rendono conto del venti per cento del microbioma dell'intestino umano. Per due di questi gruppi, Bacteriodaceae e Bifidobacteriaceae, l'albero filogenetico somiglia molto nella forma a quello degli esseri umani e dei suoi antenati, ovvero gli ominidi, il che è un chiaro segno dell'avvenuta coevoluzione. Solo il terzo albero filogenetico batterico, quello dei Lachnospiraceae, è più complicato: in almeno quattro casi, questi batteri sono passati da una specie ospite di primate a un'altra.
Complessivamente, il dato che emerge con evidenza è che i batteri si sono separati in ceppi distinti più o meno nello stesso periodo in cui i rispettivi ospiti si sono evoluti in rami filogenetici diversi. Una di queste separazioni batteriche è avvenuta circa 15,6 milioni di anni fa (alle 17.37.55 del 30/12), quando il ramo filogenetico del gorilla si è separato da quello degli altri ominidi. In un altro caso, la separazione è avvenuta circa 5,3 milioni di anni fa (alle 13.40.58 del 31/12), quando gli esseri umani si sono separati da scimpanzè e bonobo. L'aspetto più interessante è la possibilità che questa codiversificazione tra batteri e ospiti possa estendersi molto più indietro nel tempo: è possibile che i nostri microbi intestinali possano risalire ai nostri comuni antenati con tutti i mammiferi, tutti i rettili, tutti gli anfibi e forse anche a tutti gli invertebrati. Se fosse vero, sarebbe incredibile!
Una cosa comunque è certa: la diffusione dell'uomo praticamente in ogni regione della Terra ha portato la vita al più alto grado di evoluzione che sia mai avvenuta... almeno dal nostro punto di vista!
Ed ora facciamo l'ultimo passo verso il Neozoico. Invece cliccate qui se preferite accedere alla Tavola sinottica riassuntiva.