
L'eredità degli Unni
di Lord Wilmore
Ungheria – Bulgaria – Polonia – Russia – Boemia – Lituania – Valacchia – Moldavia – Serbia – Turchia – Crimea – Turkestan – Mongolia
.
L’origine etnica degli Unni è uno dei temi più dibattuti della storiografia antica, perché le fonti sono poche e spesso indirette. Esiste un consenso di massima su alcuni punti: la maggior parte degli storici ritiene che gli Unni abbiano avuto origine nelle steppe dell’Asia centrale, probabilmente tra l’attuale Mongolia, il Kazakhstan e il nord della Cina. Alcuni storici collegano gli Unni ai Xiongnu, una confederazione nomade che combatté contro la Cina imperiale tra il III sec. a.C. e il I sec. d.C., sulla base di somiglianze culturali e militari, continuità geografica e dinamiche tipiche delle confederazioni nomadi delle steppe. Gli Unni non erano un gruppo etnicamente omogeneo, ma piuttosto una confederazione multietnica, che includeva popolazioni di origine turca, gruppi iranici, elementi mongolici e, col tempo, anche popolazioni europee sottomesse (germaniche, sarmatiche, ecc.) Del resto, per i popoli delle steppe l’identità era più politica e militare che etnica. Si legga in proposito questo interessante articolo. Quanto all'aspetto fisico, le fonti romane descrivono alcuni Unni con tratti asiatici, ma queste descrizioni sono spesso esagerate o cariche di pregiudizi. La lingua unna è quasi del tutto sconosciuta, ma quel poco che ne resta suggerisce una possibile base turca, anche se ciò non è dimostrabile con certezza (in turco, Attila potrebbe significare "Piccolo padre"). Normalmente si crede che gli Unni siano scomparsi dalla storia senza lasciare dietro di sè alcuna eredità. Ma è proprio vero?
.
Premessa: dagli Xiongnu ai Cazari
Sovrani mitologici
1) Oghuz Qaghan, leggendario
figlio di Kara Khan e di Ay Khanbikeh, visse in un'epoca imprecisata ed è
considerato l'antenato leggendario di tutti i popoli Turchi e di tutte le
nazioni dell'Asia centrale

Bandiera degli Xiongnu
Chanyu degli Xiongnu
2) Touman (220–209 a.C.), lontano discendente
dell'ultimo sovrano della dinastia cinese Xia, fu contemporaneo di Qin Shi
Huangdi, il primo unificatore della Cina, e a sua volta riunificò le trbù
turco-mongole fondando il Qaghanato Xiongnu
3) Modu Chanyu (209–174 a.C.), assunse per
primo il titolo di Chanyu, equivakente a "Khan"
4) Laoshang Chanyu (174–161 a.C.)
5) Junchen Chanyu (161–126 a.C.)
6) Yizhixie Chanyu (126–114 a.C.)
7) Wuwei Chanyu (114–105 a.C.)
8) Er Chanyu (105–102 a.C.)
9) Xulihu Chanyu (102–100 a.C.)
10) Qiedihou (101/100–96 a.C.)
11) Hulugu Chanyu (96–85 a.C.)
12) Huyandi Chanyu (85–68 a.C.)
13) Xulüquanqu Chanyu (68–60 a.C.)
14) Woyanqudi Chanyu (60–58 a.C.)
15) Huhanye Chanyu (58–31 a.C. )
16) Fuzhulei Ruodi Chanyu (31–20 a.C.)
17) Souxie Chanyu (20-12 a.C.)
18) Juya Chanyu (12-8 a.C.)
19) Wuzhuliu Chanyu (8 a.C.-13 d.C.)
20) Wulei Chanyu (13–18 d.C.)
21) Huduershidaogao Chanyu (18–46 d.C.)
22) Wudadihou Chanyu (46 d.C.)
Chanyu degli Xiongnu
Meridionali
23) Sutuhu (46–55)
24) Qiufu Youti (55-57)
25) Yifa Yulüti (57–59)
26) Xitong Shizhu Houti (59–63)
27) Qiuchu Julinti (63)
28) Huxie Shizhu Houti (63–85)
29) Yitu Yulüti (85–88)
30) Tuntuhe (88–93)
31) Anguo (93–94)
32) Shizi (94–98)
33) Wanshishizhudi (98-124)
34) Wujihoushizhudi (124–128)
35) Xiuli (128–144)
36) Cheniu (144)
37) Hulan Ruoshi Zhujiu (144–147)
38) Jucheer (147–158)
39) Tute Ruoshi Zhujiu (158–178)
40) Huzheng (178–179)
41) Qiangqu (179–188)
42) Chizhi (188–189)
43) Yufuluo (189–195)
44) Huchuquan (195–216)
Xianbei
45) Kebineng (216-235), sconfisse l'ultimo dei
Chanyu degli Xiongnu e fondò il Qaghanato degli Xianbei
46) Tufa Shujineng (235-279)
47) Murong Tuyuhun (269-317)
48) Murong Hui (317-333)
49) Murong Huang (333-348)
50) Murong Ke (348-352)

Bandiera degli Unni di Attila
Qaghan degli
Unni
51) Kama Tarkhan o Grumbat (352-358),
re dei Chioniti o Unni rossi (i Kian-yun dei cinesi), di lui parla lo storico
Ammiano Marcellino. Lasciate le steppe del Kazakistan, migrò con il suo popolo
nelle regioni del Mar Caspio
52) Balamber o Valamiro (358-370),
luogotenente di Grumbat, sottomise i Sarmati e gli Alani
53) Alypbi (370-386), altro luogotenente di
Grumbat, di lui si sa poco o nulla
54) Uldino (386-412), Khan degli Unni Occidentali,
si alleò con l'imperatore romano d'oriente Arcadio, ma poi tentò invano di
attaccare Costantinopoli
55) Donato (386-411), Khan degli Unni Orientali, fu
il primo Qaghan degli Unni a convertirsi al cristianesimo, nella versione
ariana. Fu ucciso a tradimento dagli ambasciatori bizantini, come narra lo
storico Olimpiodoro di Tebe
56) Charaton (411-412), luogotenente di Donato,
tentò di raccoglierne l'eredità, ma fu sconfitto da Rua
57) Octar o Uptar (412-430),
"coraggioso", figlio di Uldino, in diarchia con il fratello Rua fino al 430, fu
ucciso in battaglia dai Burgundi
58) Rua o Rugila (412-435),
in diarchia con il fratello Octar fino al 430, si spostò verso occidente e prese
come ostaggio il generale romano Flavio Ezio, di cui poi divenne amico. Secondo
la tradizione, morì colpito da un fulmine
59) Bleda (435-445), figlio di Mundjuk, fratello di
Octar e Rua, in diarchia con il fratello Attila fino al 445. Secondo lo storico
bizantino Prisco di Panion fu ucciso dal fratello con l'aiuto di Arderico, Re
dei Gepidi e suo tributario
60) Attila o Idil (435-453),
figlio di Mundjuk, in diarchia con il fratello Bleda fino al 445, fu
soprannominato "il Flagello di Dio" per la sua ferocia. Con lui l'impero unno
giunse al suo apogeo: il suo dominio si estendeva dall'Europa centrale al Mar
Caspio, e dal Danubio al Mar Baltico, unificando Germani orientali, Slavi ed
Ugro-finni. Incassò dal generale Flavio Ezio la sconfitta dei Campi Catalaunici,
ultima grande vittoria dell'impero romano d'occidente, ma dopo l'assassinio di
Ezio puntò su Roma per saccheggaiarla. Temendo di restare intrappolato in
Italia, accettò un ingente riscatto da parte del carismatico Papa Leone I Magno
e si ritirò. Morì durante una notte d'amore in circostanze mai chiarite
61) Ellac (453-454), figlio di Attila e di Kreka,
fu ucciso nella battaglia del fiume Nedao dal re dei Gepidi Arderico, e l'impero
unno cominciò a sgretolarsi
62) Tuldila (454 457), figlio di Attila, fu
eliminato dai fratelli
63) Dengizic (457-469), figlio di Attila, morì in
battaglia contro i bizantini
64) Ernac (469-482), figlio di Attila, fu alleato
dell'impero bizantino. Alleato con i bizantini attaccò il Re dei Goti Teodorico
il Grande, ma fu sconfitto e ucciso
65) Tingiz (482-498), figlio di Attila, governò sui
territori dell'attuale Ucraina
66) Belkermac (498-509), figlio di Attila, morì in
battaglia contro gli Alani
67) Djurash (509-517), figlio di Ernac, di lui si
sa poco o nulla
68) Tatra (517-536), luogotenente di Djurash, diede
il nome ai monti tra i quali fu sepolto
69) Boyan Chelbir (536-547), usurpatore, fu
l'ultimo Qaghan del popolo Unno unito
70) Sandilch (547-551), Qaghan degli Utriguri, orde
del Don orientale, da lui discendono gli Ungari
71) Zabergan (547-552), Qaghan dei Kutriguri, orde
del Don occidentale, da lui discendono i Cumani
Qaghan
dei Göktürk
72) Bumin (552), figlio Asjina Tuwu,
sconfisse gli Unni e fondò il Qaghanato dei
Göktürk ("Turchi azzurri")
73) Yabghu (552–575), fratello minore di
Bumin, sconfisse gli Eftaliti, fondò a sua volta il Qaghanato Göktürk
occidentale
74) Tardu (575–602), figlio di Yabghu, sconfisse lo
Shah Sasanide Bahram VI. Cercò di riunificare tutti i Goktürk sotto il suo comando, ma
fu sconfitto e ucciso
75) Heshana (604–611), figlio di Niri, pronipote di
Bumin, visse in un periodo di guerre civili e finì giustiziato
76) Sheguy (610–617), figlio di Tulu, figlio di
Tardu, anch'egli morì in battaglia
Qaghan degli Onoguri
77) Organa (617-632),
sovrano delle tribù degli Onoguri (dal turco Onoq, "le Dieci Frecce"),
si rese indipendente dai Göktürk
78)
Kubrat (632-665), nipote di Organa, comandante degli Unni e dei Proto-bulgari nella regione a nord
del Mar Nero, fondò la Grande Bulgaria nei territori dell'attuale Ucraina
79)
Batbajan (665-668), primogenito del Khan Kubrat, fu
sconfitto e ucciso dai Cazari
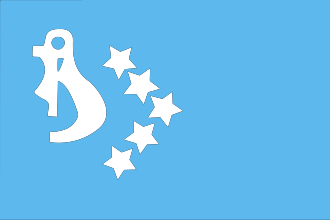
Bandiera del Qaghanato dei Cazari
Qaghan dei Cazari
80) Busir Glavan (690-715), sconfisse e sottomise gli Onoguri; una parte di loro
migrò verso i Balcani, dando vita alla nazione bulgara europea (vedi sotto);
un'altra migrò verso nord e diede vita al Khaganato dei Bulgari del Volga. I
restanti rimasero nell'attuale Ucraina e furono gli antenati degli Ungari
81) Barjik (715-732) figlio di Busir Glavan, sconfisse il Califfato Omayyade di
Damasco
82) Bihar (732-736), figlio di Barjik e padre di Tzitzak, consorte
dell'imperatore bizantino Leone III Isaurico
83) Prisbit (736-737), sorella di Bihar
84) Bulan (737-763), fratello di Bihar e Prisbit, "alce" in lingua turca, decise
la conversone dei Cazari all'Ebrraismo per evitare di essere assorbiti dagli
Arabi o dai Bizantini
85) Baghatur (763-786), figlio di Bulan, in turco "figlio di Dio"
86) Obadia (786-809), figlio di Baghatur, scambiò ambasciatori con il Califfo
Hārūn al-Rashīd, protagonista delle "Mille e una Notte"
Interregno (809-825)
87) Khan-Tuvan Dyggvi (825-840), salì al trono dopo un periodo turbolento a
causa dell'opposizione di alcuni nobili Cazari alla conversione al Giudaismo
88) Tarkhan (840-845), eliminò Khan-Tuvan Dyggvi e gli succedette
89) Hezekiah ben Obadiah (845-860)
90) Manasseh I (860-865)
91) Chanukkah (865-870)
92) Isaac ben Chanukkah (870-875)
93) Zebulun ben Isaac (875-880)
94) Menahem ben Aaron (875-900)
95) Manasseh II (880-890)
96) Benjamin (880-920)
97) Nisi ben Menasseh (890-900)
98) Aaron I ben Nisi (900-920)
99) Aaron II ben Benjamin (920-940)
100) Joseph ben Aaron (940-965), ultimo sovrano
cazaro documentato
Nel 965 il variago Svjatoslav, Principe di Novgorod e Kyiv, distrusse la capitale Itil, provocando il disfacimento del Qaghanato Cazaro, ma a quel punto l'ereditò degli Unni stava già passando ad altri popoli, euopei ed asiatici.
Ecco dunque tutti i sovrani delle nazioni che possono vantarsi ancor oggi di rappresentare l'eredità degli Unni. Le varie ucronie qui sotto presentate sono quasi tutte distinte e incompatibili l'una con l'altra.
.
I – Sovrani d'Ungheria
Sovrani degli Ungari, dinastia
degli Árpád
89) Levedi (845-851), unificò per primo le sette tribù magiare ed incaricò il suo
vassallo Álmos di trovare una nuova patria per il suo popolo, non volendosi
convertire all'ebraismo
90) Álmos (851-896), luogotenente di Levedi, lasciò la Cazaria e guidò gli Ungari in Transilvania,
iniziando la penetrazione nel bacino pannonico, ma morì assassinato
91) Árpád (896-907), figlio di Álmos e capo delle sette tribù magiare, fondò il
primo stato ungherese tra il Danubio ed i Carpazi, e iniziò una serie di
scorrerie contro i territori del Sacro Romano Impero
92) Zoltán (907-948), figlio di Árpád
93) Fajsz (948-955), nipote di Zoltán
94) Taksony (955-972), figlio di Zoltán
95) Géza (972-997), figlio di Taksony
96) Stefano (997-1038), figlio di Géza e di Sarolta, nell'anno 1000 ottenne da Papa
Silvestro II il titolo di Re Apostolico d'Ungheria, ma morì senza eredi
Re d'Ungheria non
dinastici
97) Pietro Orseolo (1038-1041, 1° regno), figlio del doge Ottone Orseolo e della
sorella di Stefano I, salì al trono ma fu deposto dalla nobiltà ungherese
98) Samuele (1041-1044), cognato di Stefano I
97) Pietro Orseolo (1044-1046, 2° regno), rimesso sul trono dall'imperatore Enrico III, fu
deposto a seguito di una rivolta pagana
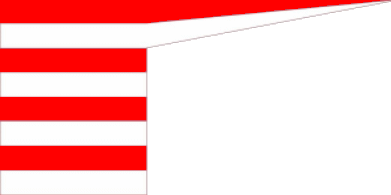
Bandiera della dinastia degli Árpád
Re d'Ungheria della dinastia
degli Árpád
99) Andrea I il Cattolico (1046-1061), nipote di Stefano I, fu esiliato dal fratello
Béla
100) Béla I (1060-1063), fratello di Andrea I
101) Salomone (1063-1074), figlio di Andrea I
e di Anastasia di Kyiv, regnò in conflitto con i cugini Géza e Ladislao
102) Géza I (1074-1077), figlio di Béla I e di Richeza di Polonia
103) Ladislao I il Santo (1077-1095), figlio di Béla I, alla morte del fratello Géza
I fu eletto re dai nobili ungheresi al posto del cugino Salomone
104) Colomanno (1095-1116), figlio di Géza I e di Sinadene di Bisanzio
105) Stefano II (1116-1131), figlio di Colomanno e di Felicia d'Altavilla, morì senza
eredi
106) Béla II il Cieco (1131-1141), nipote di Colomanno e cugino di Stefano II
107) Géza II (1141-1162), figlio di Béla II e di Elena di Rascia
108) Stefano III (1162-1163, 1° regno), figlio di Géza II e di Eufrosina di Kyiv,
regnò in contrasto con gli zii Ladislao e Stefano
109) Ladislao II (1162-1163), figlio di Béla II e zio di Stefano III, spodestò il
nipote con l'appoggio dell'imperatore bizantino Manuele I Comneno
110) Stefano IV (1163-1165), figlio di Béla II e zio di Stefano III
108) Stefano III (1163-1172, 2° regno), fu rimesso sul trono dall'imperatore Federico
Barbarossa, ma morì senza eredi
111) Béla III (1172-1196), figlio di Géza II e fratello di Stefano III
112) Emerico (1196-1204), figlio di Béla III e di Agnese d'Antiochia, regnò in
contrasto con il fratello Andrea
113) Ladislao III (1204-1205), figlio minorenne di Emerico e di Costanza d'Aragona,
la reggenza del regno venne affidata allo zio Andrea
114) Andrea II il Gerosolimitano (1205-1235), figlio di Béla III, zio di Ladislao
III.
115) Béla IV (1235-1270), figlio di Andrea II e di Gertrude di Merania, ricostruì il
regno dopo l'invasione mongola del 1241
116) Stefano V (1270-1272), figlio di Béla IV e di Maria Laskarina
117) Ladislao IV il Cumano (1272-1290), figlio di Stefano V e di Elisabetta di
Cumania
118) Andrea III il Veneziano (1290-1301), nipote di Andrea II, alla sua morte senza
figli si estinse la dinastia degli
Árpád
Re d'Ungheria
Non dinastici
119) Venceslao (1301-1305), Re di Ungheria, di Boemia e di Polonia, fu costretto ad
abdicare
120) Béla V (1305-1307), giovane figlio di Enrico XIII di Witelsbach e di Elisabetta,
figlia di Béla IV, fu spodestato ed esiliato
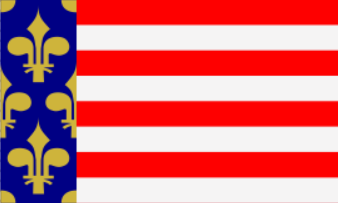
Bandiera della dinastia degli Angiò
Re d'Ungheria della dinastia
d'Angiò
121) Carlo I (1308-1342), figlio di Carlo Martello d'Angiò, a sua volta figlio di Carlo II di
Napoli e nipote di Stefano V
122) Luigi I il Grande
(1342-1382), figlio di Carlo I e di Elisabetta di Polonia, fu anche Re di
Polonia
123) Maria (1382-1385, 1° regno), figlia di Luigi I e di Elisabetta di Bosnia
124) Carlo II il Breve (1385-1386), figlio di Luigi di Durazzo e di Margherita
Sanseverino, ultimo erede maschio del remo ungherese della dinastia angioina, fu
anche Re di Napoli e salì al trono dopo aver spodestato Maria, ma morì
avvelenato dopo due mesi
123) Maria (1386-1395, 2° regno), fu rimessa sul trono, ma il governo fu affidato di
fatto al marito Sigismondo di Lussemburgo
Re d'Ungheria elettivi
124) Sigismondo I di
Lussemburgo (1387-1437), consorte di Maria e discendente
di Béla IV tramite sua madre Elisabetta di Pomerania e suo padre Carlo IV di
Lussemburgo, fu anche Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Boemia
125) Alberto d'Asburgo (1437-1439), genero di Sigismondo I, fu anche Duca d'Austria, Re
di Germania e Re di Boemia
126) Ladislao V Jagellone (1440-1444), re di Polonia, fu proclamato re dalla nobiltà
ungherese.
127) Ladislao VI d'Asburgo il Postumo (1445-1457), figlio di Alberto e di Elisabetta
di Lussemburgo, fu anche Duca d'Austria e Re di Boemia, ma morì senza eredi
128) Mattia I Hunyadi il Giusto (1458-1490), eetto re d'Ungheria, morì lasciando solo
un figlio illegittimo, Giovanni, a cui non fu permesso di succedergli sul trono
129) Ladislao VII Jagellone
(1490-1516), nipote di Ladislao VI, Re di Boemia, fu eletto
re d'Ungheria
130) Luigi II Jagellone (1516 1526), figlio di Ladislao VI e di Anna di
Foix-Candale, fu anche Re di Boemia. A soli vent'anni sconfisse gli Otomani
nella Battaglia di Mohács, impedendo loro di conquistare il paese, ma cadde
durante la stessa battaglia e non lasciò eredi diretti
Re d'Ungheria della dinastia
Zápolya
131) Giovanni I
Zápolya (1526-1540), figlio di Stefano Zápolya e di Edvige
di Cieszyn, alla morte di Luigi II fu eletto Re d'Ungheria e sconfisse
Ferdinando I d'Asburgo, Imperatore del Sacro Romano Impero e cognato di Luigi
II, che aspirava al trono ungherese
132) Giovanni II Zápolya (1540-1570), figlio di Giovanni I e di Isabella Jagellona,
lottò duramente contro gli Ottomani ma morì senza figli
Re d'Ungheria della dinastia
Báthory
133) Stefano VI Báthory (1570-1586),
Stefano Báthory e di Caterina Telegdi, eletto dalla Dieta
ungherese, fu anche Re di Polonia. Sua cugina era la famosa serial killer
Erzsébet Báthory, che egli fece imprigionare dopo aver scoperto le sue malefatte
134) Sigismondo II Báthory (1586-1613), figlio di
Kristóf (fratello di Stefano VI) e di Elisabetta Bocskai
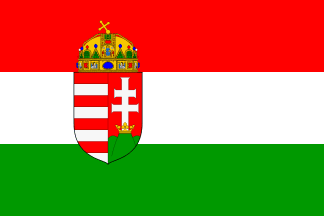
Bandiera dell'Ungheria oggi in uso
Re d'Ungheria della dinastia
Rákóczi
135) Giorgio I Rákóczi (1613-1648), figlio di Sigismondo
Rákóczi e di Anna Gerendi, partecipò alla Guerra dei Trent'Anni dalla parte dei
cattolici
136) Giorgio II Rákóczi (1648-1660). figlio di Giorgio I Rákóczi e di Susanna
Lorántffy
137) Francesco I Rákóczi (1660-1676), figlio di Giorgio II Rákóczi e di Sofia Báthory,
strinse alleanza con il Re Sole
138) Francesco II Rákóczi (1676-1735), figlio di Francesco I Rákóczi e di Ilona
Zrínyi, assediò Vienna nella speranza di conquistare il titolo di Sacro Romano
Imperatore, ma fu sconfitto dal re di Polonia Giovanni III Sobieski. Concentrò
allora tutte le forze contro l'ormai declinante impero ottomano e conquistò
Belgrado e Sarajevo. In Ungheria oggi è considerato un eroe nazionale
139) Giorgio III Rákóczi (1735–1756), figlio di Francesco II Rákóczi e di Carlotta
Amalia d'Assia-Wanfried, partecipò alla Guerra di Successione Austiaca ma perse
quasi tutti i territori conquistati dal padre. Non avendo figli, adottò come erede Miklós
József Esterházy, che avviò una nuova dinastia
Re d'Ungheria della dinastia
Esterházy
140) Miklós I
Esterházy il Magnifico (1756-1790), figlio di József Simon Esterházy e di
Maria Octavia von Gilleis, fu il principale mecenate di Haydn
141) Anton Esterházy
(1790-1794), figlio di Miklós I e di Maria Antonia di Wittelsbach, si
rappacificò con gli austriaci e combattè a fianco della Prima Coalizione contro
i rivoluzionari francesi
142) Miklós II Esterházy
(1794-1806, 1° regno), figlio di Anton e di Maria Cristina d'Asburgo-Lorena
(figlia di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano di Lorena), è ricordato
per le ingenti spese del suo regno, che mandarono lo stato sul lastrico.
Sconfitto da Napoleone nella Battaglia di Austerlitz, fu costretto ad andare in
esilio a San Pietroburgo
143) Giuseppe Bonaparte
(1806-1813), fratello maggiore di Napoleone I, fu designato dal fratello al
trono di Budapest, ma fu estremamente impopolare perchè straniero e perchè fece
abbattere molte chiese e conventi. Contro di lui si sollevò una guerriglia che
costituì una spina nel fianco per l'Empereur. Dopo la sconfitta del fratello
nella Campagna di Russia e l'invasione dell'Ungheria da parte degli alleati, fu
costretto alla fuga
142) Miklós II Esterházy
(1813-1833, 2° regno), restaurato sul trono dal Congresso di Vienna, portò
avanti una politica più cauta del suo primo regno e aderì alla Santa Alleanza
144) Paolo I Esterházy
(1833-1866), figlio di Miklós II e di Maria Ludovica d'Austria-Este,
inizialmente governò come un monarca assoluto, ma nel 1848 rischiò di essere
travolto dalla rivoluzione capeggiata da Lajos Kossuth. Per evitare di perdere
il trono fu costretto a concedere una Costituzione e a regnare senza governare;
Kossuth divenne il primo Cancelliere della nuova Ungheria. Sotto di lui
l'Ungheria partecipò alla Guerra di Crimea accanto a Regno Unito, Francia e
Sardegna
145) Miklós
III Esterházy
(1866-1894), figlio di Paolo I e di Maria Augusta di Sassonia, il suo regno vide
l'industrializzazione del paese e la costruzione di ferrovie ed infrastrutture.
Attraverso il porto di Fiume il regno intraprese anche una politica coloniale in
Africa ed Asia
146) Miklós IV Esterházy
(1894-1920), figlio di Miklós III e di Elena d'Orléans, con lui l'Ungheria aderì
alla Quadruplice Intesa con Francia, Regno Unito e Russia. Dopo l'assassinio di
Alessio, figlio dello Zar Nicola II, e lo scoppio della Grande Guerra,
l'Ungheria fu invase dalle truppe austriache e tedesche, e Miklós IV fu
costretto all'esilio in Grecia, per poi far ritorno in patria in seguito alla
sconfitta austriaca
147) Paolo II Esterházy
(1920-1940, 1° regno), figlio di Miklós IV e di Beatrice di Borbone-Spagna, salì
al trono 19 anni e subito dovette affrontare la rivoluzione comunista di Béla
Kun e la secessione in armi della Croazia (appoggiata dall'Italia). Nel 1940 il
paese venne invaso dai nazisti e Paolo II fu rinchiuso nel Palazzo Reale di
Gödöllő, essendosi rifiutato sia di abdicare che di lasciare il paese
Interregno (1940-1945), durante
il quale l'Ungheria fu governata dalle Croci Frecciate di Ferenc Szálasi, un
filonazista fantoccio di Hitler che mandò miglia di ebrei allo sterminio. Molti
di loro si salvarono grazie all'eroismo dell'italiano Giorgio Perlasca, che si
spacciò per console spagnolo e tenne nascoste centinaia di Ebrei nel palazzo
dell'ambasciata
147) Paolo II Esterházy
(1945-1989, 2° regno), tornò sul trono alla sconfitta dei nazisti. L'Ungheria fu
liberata dai sovietici, ma nella spartizione dell'Europa decisa a Yalta fu
assegnata alla sfera d'influenza americana, anche se dovette cedere vari
territori orientali alla Romania comunista. Grazie al Piano Marshall il paese
conobbe una rapida crescita economica e aderì alla NATO. Un tentativo di
rivoluzione comunista di János Kádár nel 1956 portò all'assassinio del
Cancelliere socialista Imre Nagy, ma fu stroncato dalle truppe dell'Alleanza
Atlantica. Nel 1973 l'Ungheria aderì alla CEE. Paolo II morì il 25 maggio 1989,
poco prima della caduta del Muro di Berlino
148) Paolo III Esterházy
(1989-2025), figlio di Paolo II e di Mafalda di Savoia (morta nel campo di
concentramento di Buchenwald), con lui l'Ungheria conobbe la rivoluzione di
Internet e fece il suo ingresso nel Terzo Millennio. Morì il 22 settembre 2025
all'età di 88 anni
149) Paolo IV Esterházy
(2025-in carica), figlio di Paolo III e della campionessa di nuoto ungherese
Andrea Gyarmati, nato il 18 febbraio 1986, siede oggi sul trono di Santo Stefano
150) Miklós (V) Esterházy
(erede al trono), figlio di Paolo IV e della famosa attrice ungherese Alexandra Borbély, nato il 5
maggio 2023

Personificazione dell'Ungheria, immagine creata con BING
.
II – Sovrani di Bulgaria
Khan dei Bulgari della dinastia
Dulo
80) Asparuc (668-701), figlio
di Kubrat, guidò la migrazione dei Bulgari dalla Grande Bulgaria verso
occidente (vedi sopra), e si stanziò in Mesia con il suo popolo. Dopo la vittoria
nella battaglia di Ongal contro l'Impero bizantino, fondò il Primo Impero
Bulgaro. Morì in battaglia contro i Cazari
81) Tervel (700-721), figlio
di Asparuc, ricevette il titolo bizantino di Cesare per aver aiutato il Basileus
Giustiniano II a riconquistare il trono. Aiutò i bizantini anche durante
il secondo assedio arabo di Costantinopoli, contribuendo a salvare la città
82) Kormesij (721-738), figlio
di Tervel
83) Sevar (738-753), figlio di
Kormesij, morì assassinato.
84) Kormisoš (753-756),
usurpatore, diede inizio a un periodo di instabilità
85) Vineh (756-761),
usirpatore, morì assassinato
86) Telec (761-764), morì
assassinato
87) Sabin (764-766), fu deposto
e morì in esilio nell'Impero Bizantino
88) Umor (766), fu deposto e
morì in esilio
89) Toktu (766 767), morì
assassinato
90) Pagan (767-768), figlio di
Vineh, morì assassinato
91) Telerig (768 777), figlio
di Tervel, fu deposto e morì in esilio
92) Kardam (777-803), figlio di
Telerig, diede inizio a un periodo di stabilizzazione e di consolidamento della
Bulgaria
Khan dei Bulgari della dinastia
di Krum
93) Krum (803-814), introdusse
le prime leggi scritte. Nella battaglia di Pliska (26 luglio 811) sconfisse e
uccise il Basileus bizantino Niceforo I, e con il suo teschio si fece
costruire una coppa in cui brindare alla vittoria. Morì di ictus
94) Omurtag (814-831), figlio
di Krum, è ricordato per la politica edilizia, la riforma amministrativa e la
persecuzione dei cristiani
95) Malamir (831-836), figlio
di Omurtag, morì giovane per cause naturali
96) Presian I (836-852), nipote
di Malamir, conquistò quasi tutta la Macedonia
97) Boris I il Santo (852-889),
figlio di Presian I, accolse alla sua corte i Santi fratelli Cirillo e
Metodio, fu battezzato con il nome di Mihail e convertì il suo
popolo al Cristianesimo. Adottò il bulgaro antico come lingua ufficiale dello
Stato e della Chiesa. Abdicò e si fece monaco
98) Vladimir I Rassate
(889-893), figlio di Boris I, fu d depositato e fatto accecare dal padre
99) Simeone I il Grande
(893-927), figlio di Boris I, nel 913 si proclamò Zar (imperatore) dei Bulgari.
Portò la Bulgaria all’apice politico e culturale. e alla massima estensione
territoriale, conquistando gran parte della valle del Danubio: il suo regno
coincide con l'Età d'oro della cultura bulgara. Morì d'infarto
100) Pietro il Santo (927-969),
figlio di Simeone I, con una durata di 42 anni il suo regno fu il più lungo
nella storia bulgara. Abdicò e morì in un monastero
101) Boris II (969-971), figlio
di Pietro I, venne imprigionato dai bizantini e morì uiso accidentalmente dalle
guardie di frontiera bulgare mentre rientrava nel Paese
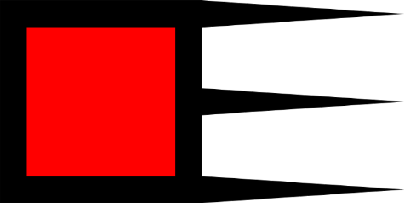
Bandiera della dinastia di Krum
Zar dei Bulgari della
dinastia dei Cometopuli
102-105) Davide I, Mosè, Aronne
e Samuele I (971-977), noti
come i Cometopuli, figli del barone Nicola, regnarono congiuntamente
106) Romano I (977-997), figlio
di Pietro I, catturato in battaglia dai Bizantini nel 991, morì in prigionia a
Costantinopoli
105) Samuele I (997-1014, 2°
regno), uno dei Cometopuli, abile generale, resse l'impero di Bulgaria durante
la prigionia di Romano I (976-997) e fu proclamato imperatore alla sua morte.
Dovette subire gli attacchi dell'imperatore Basilio II che occupò quasi tutta la
Bulgaria. Morì di infarto alla vista del massacro dei suoi soldati nella
battaglia di Kleidion da parte del Basileus, che per questo ottenne
l'appellativo di Bulgaroctono ("massacratore di Bulgari")
107) Gavril Radomir
(1014-1015), figlio di Samuele, venne assassinato dal cugino Ivan Vladislav
108) Ivan I Vladislav
(1015-1018), figlio di Aronne, uno dei Cometopuli, fu ucciso durante l'assedio
di Durazzo
109) Presian II (1018-1061),
figlio di Ivan Vladislav, guidò la resistenza contro i Bizantini che avevano
occupato la Bulgaria. Alla morte di Basilio II il 15 dicembre 1025, sconfisse le
armate bizantine e le cacciò dalla Bulgaria
110) Alusian (1041-1061),
fratello di Preslan II, generale bulgaro, fu associato al trono dallo Zar
111) Samuele II (1061-1082),
figlio di Alusian, fece pace con i bizantini. Sua
sorella Anna sposò l'imperatore bizantino Romano IV Diogene. Sua figlia Irina (o
Irene) sposò l'imperatore bizantino Alessio Comneno, che si proclamò Basileus
dei Romani e dei Bulgari, e realizzò così pacificamente l'unione tra i due
imperi che era sfuggita con le armi al Bulgaroctono
112) Costantino I Bodin (1071),
pronipote di Samuele I, fu acclamato Zar da una parte della nobiltà e tentò di
usurpare il trono di Samuele II con l'aiuto dei Serbi, ma fu sconfitto; in
seguito diventò Re di Doclea, tra Montenegro ed Albania
Basileis dei Romani e dei
Bulgari della dinastia dei Comneni
113) Alessio I
(1082-1118), generale bizantino, sconfisse Niceforo III e assunse il titolo di
Basileus. Realizzò l'unione tra Bizantini e Bulgari e sfruttò la Prima Crociata
per iniziare la riconquista di buona parte dell'Asia Minore, persa a vantaggio
dei Turchi Selgiuchidi
114) Giovanni II (Ivan
II come sovrano dei Bulgari, 1118-1143), figlio di Alessio I e di Irina.
Morì durante un misterioso incidente di caccia, a causa di una freccia
avvelenata
115) Manuele (1143-1180),
figlio di Giovanni II, continuò le conquiste in Asia Minore e conquistò
la Serbia
116) Alessio II (1180-1183),
figlio di Manuele, fu fatto strangolare da Andronico I con una corda d'arco
117) Andronico (1183-1185),
cugino di Manuele I e vicerè di Bulgaria, fece uccidere Alessio II. Ordinò
il Massacro dei Latini del 1181, fugge sotto la minaccia Normanna e fu linciato
dalla popolazione di Costantinopoli. Con lui si estinse la dinastia Comnena, ed
ebbero fine la politica di riconquista dell'Anatolia e l'unione con la Bulgaria
118) Isacco Angelo (1185-1187),
generale bizantino, fu nominato imperatore a furor di popolo. Quando i fratelli
Todor e Ivan Asen si presentarono al suo cospetto a Kypsela per richiedere una
pronoia, cioè un feudo, la loro richiesta venne rifiutata sprezzantemente e Ivan
fu schiaffeggiato durante l'alterco. I due fratelli fecero ritorno in Bulgaria
e, approfittando del forte malcontento causato dalla pesante tassazione imposta
dall'imperatore bizantino per finanziare la sua campagna contro Guglielmo II di
Sicilia e per celebrare il suo matrimonio con Margherita d'Ungheria, promossero
una sommossa popolare contro il governo bizantino, che alla fine si rivelò
vincente
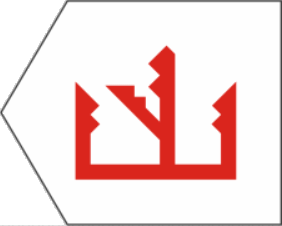
Bandiera della dinastia Asen
Zar
dei Romani e dei Bulgari della
dinastia Asen
119) Samuele III (1185-1197),
nome assunto da Todor (Teodoro) dopo la sconfitta di Isacco Angelo e l'ascesa al tronoo, regnò con i fratelli
Ivan III Asen e Kalojan
120) Ivan III (1189 1196),
regnò con i fratelli Samuele III e Kalojan
121) Kalojan il Conquistatore (1196-1207),
inizialmente regnò con i fratelli Samuele III e Ivan III, ed alla loro morte
restò unico sovrano. Quando nel 1204 i Crociati misero a ferro e fuoco
Costantinopoli, Kalojan sconfisse Baldovino di Fiandra, imperatore latino di
Costantinopoli, nella battaglia di Adrianopoli del 14 aprile 1205. Baldovino fu
catturato e in seguito morì in prigionia in Bulgaria. Kalojan occupò
Costantinopoli, accolto dai bizantini come un liberatore, scacciò i Crociati
dalla Macedonia e si proclamò Basileus dei Romani e dei Greci (lo stesso titolo
di Alessio I Comneno). Morì in circostanze misteriose durante un assedio
122) Boril (1207-1218), nipote
di Kalojan, continuò le guerre contro i Crociati
123) Ivan IV (1218-1241),
figlio di Ivan III, dopo la battaglia di Klokotnitsa (9 marzo 1230) contro il
Despota Te odoro d'Epiro, divenne il sovrano più potente della penisola
balcanica
124) Kaliman I (1241-1246),
figlio di Ivan IV e di Anna Maria d'Ungheria, aveva solo sette anni quando
succedette al padre. Durante il suo regno i Mongoli invasero la Bulgaria e le
imposero il pagamento di un tributo annuale. Colomanno fu probabilmente
avvelenato
125) Michele I (1246-1256),
figlio di Ivan IV e di Irene Comnena Ducas, governò sotto la reggenza della
madre. Fu eliminato in una congiura
126) Kaliman II (1256, figlio
di Alessandro, fratello minore di Ivan IV, uccise Michele durante una battuta di
caccia e ne usurpò il trono, ma fu a sua volta assassinato
127) Mico (1256-1257), cognato
di Michele I, ne usurpò il trono ma fu scacciato da Costantino I e morì in
esilio
128) Costantino II (1257-1277,
figlio di Tikh, usurpò il trono di Mico Asen. Sconfisse ripetutamente gli
Ungheresi
129) Michele II (1277-1279),
figlio di Constantino II da lui associato al potere, fu sconfitto e morì in
esilio
130) Ivailo (1278-1279),
soldato di umili origini, prese il potere mettendosi a capo di una massiccia
rivolta contadina e sposò Maria Paleologa Cantacuzena, vedova di Costantino I.
Fu ucciso dal condottiero mongolo Nogai Khan
131) Ivan V (1279-1280), figlio
di Mico Asen, morì in esilio
132) Giorgio I Terter
(1280-1292), di origine cumana, mandò in esilio Ivan V, ma il suo regno
rappresentò l'apice di un periodo di disintegrazione feudale dell'impero bulgaro
133) Šišman Terter (1280-1298),
fratellastro e inizialmente coreggente di Giorgio I, despota di Vidin, in
pratica regnò come un vassallo dei Mongoli dell'Orda d'Oro
134) Ivan VI Smilec (1298-1299),
si proclamò Zar in opposizione a Šišman Terter, ma fu sconfitto e rinchiuso in
un monastero, dove morì
135) Čaka (1299-1300),
figlio del sovrano mongolo Nogai Khan, sposò Elena, figlia di Giorgio I Terter.
Sostenne il padre Nogai nella sua guerra contro Tokta, il legittimo Khan
dell'Orda d'Oro, ma Nogai venne sconfitto e ucciso, mentre il figlio fuggì in
Bulgaria, approfittò di un momentaneo vuoto di potere e si fece incoronare Zar,
sperando di usare la Bulgaria come base per riconquistare l'Orda d'Oro. Tokta
tuttavia invase la Bulgaria,
Čaka fu ucciso dai suoi stessi sostenitori e la sua testa inviata in dono
al Khan
136) Teodoro Svetoslav (1300-1321),
figlio di Gorgio I Terter, fu determinante nella presa del potere da parte di
Čaka, fu da lui associato al potere, ma egli lo fece uccidere e fu
insediato da Tokta come proprio vassallo sul trono di Bulgaria
137) Giorgio II Terter (1321-1323),
figlio di Teodoro Svetoslav, cercò di porre dine al caos feudale, ma morì
giovane in battaglia senza eredi
138) Michele III Šišman (1323-1330),
cugino di Giorgio II Terter, fu un sovrano energico e ambizioso, che agendo
senza scrupoli sconfisse uno dopo l'altro i signori feudali bulgari e greci,
cercando di restaurare l'unità dell'impero bulgaro-bizantino. Osò troppo
scontrandosi con i Serbi nella battaglia di Velbažd del 28 luglio 1330, in cui
fu sbbaragliato e trovò la morte
139) Ivan VII Stefan Šišman (1330-1331),
figlio maggiore di Michele III Šišman e Anna Neda di Serbia, figlia di re
Stefano Uroš II Milutin di Serbia, fu associato al trono dal padre e gli
succedette, ma fu esiliato dalla nobiltà bulgara e morì in esilio in Dalmazia

Bandiera della dinastia Šišman
Zar dei Romani, dei Serbi e dei
Bulgari delle dinastie Dušan e Šišman
140)
Stefano I Uroš Dušan il Grande (1331-1355), re di Serbia con il nome di
Stefano IV, occupò Costantinopoli e si proclamò Zar dei Romani, dei Serbi e dei
Bulgari. Creò un grande impero, ma morì a soli 47 anni per un attacco epilettico
141) Stefano II Uroš Dušan il Debole
(1355-1361), re di Serbia con il nome di Stefano V, figlio di Stefano I e di
Elena, sorella di Ivan Aleksandăr di Bulgaria, fu succube della madre e dei
signori feudali
142) Ivan VIII Aleksandăr
(1361-1371), figlio del despota Sratsimir di Kran e di Petrica, sorella di
Michele III Šišman, rovesciò Stefano II e si proclamò a sua volta Zar dei
Romani, dei Bulgari e dei Serbi. Il sultano ottomano Murad I conquistò tutti i
possedimenti bizantini in Asia e si affacciòò in Europa occupando Gallipoli.
Ivan VIII si preparava a muovergli contro quando morì improvvisamente
143) Ivan IX Sracimir il Trionfatore
(1371-1397), figlio di
Ivan VIII Aleksandăr e di Teodora, alla guida di una grande coalizione affrontò
gli Ottomani nella Battaglia di Nicopoli (15 settemnre 1376), in cui li
sconfisse pesantemente e li espulse dall'Europa. I Turchi conservarono l'intera
Anatolia, ma non sarebbero riusciti mai più a rimettere piede oltre il Bosforo
144) Ivan X Šišman (1371-1395),
fratellastro di
Ivan IX Sracimir, fu da lui associato al trono e fu eroe della resistenza contro
i Turchi
145) Costantino III Šišman il Pervicace
(1397-1422), figlio di Ivan IX Sracimir di Bulgaria e di Anna di Valacchia,
figlia del principe valacco Nicolae Alexandru, continuò l'opera paterna
impedendo ai Turchi di rimettere piede in Europa. Si alleò con Tamerlano e
inflisse agli Ottomani una storica sconfitta nella Battaglia di Ankara (28
luglio 1402). Dalla moglie Elena Dragaš non ebbe figli maschi, cosicchè gli succedette il genero
Mamia I Gurieli, signore di Guria, nel sudovest della Georgia, anch'egli
difensore del suo paese contro i Turchi

Bandiera della dinastia Gurieli
Zar
dei Bulgari della
dinastia Gurieli
146) Giorgio III (1422–1430),
figlio di Kakhaber, a sua volta figlio di Giorgio Dadiani, signore di Guria e
Svaneti, sposò Keratsa, figlia di Costantino III Šišman,
e
divenne Zar dei Romani, dei Bulgari e dei Serbi in un
momento in cui gli Ottomani intensificavano i loro sforzi per prendere
Costantinopoli, tanto che egli fu cosretto a riportare la capitale a Tarnovo,
meglio difendibile
147) Mamia I (1430–1450), figlio di Giorgio III
148) Mamia II (1450–1469), figlio di Liparit I Dadiani,
sconfisse il Sultano Ottomano Maometto II che cercava di conquistare
Costantinopoli e lo uccise in battaglia
149) Kakhaber (1469–1483),
figlio di Mamia II
150) Giorgio IV (1483–1512),
figlio di Kakhaber II
151) Mamia III (1512–1534), figlio di Giorgio IV
152) Rostom (1534–1564), figlio di Mamia I
153) Giorgio V (1564–1583, 1°
regno), figlio di Rostom, fu deposto
154) Vakhtang I (1583–1587), figlio di Giorgio IV
153) Giorgio V (1587–1600, 2°
regno), restaurato
155) Mamia IV (1600–1625), figlio di Giorgio IV
156) Simeone II (1625), figlio
di Mamia II; deposto, morì dopo il 1672. Con lui iniziò per la Bulgaria un
secolo di progressiva anarchia feudale, con Zar intronati e deposti in
continuazione dalla grande nobiltà
157) Kaikhosro I (1625–1658), figlio di Vakhtang I
158) Dimitri (1659–1668), figlio di Svimon I; deposto, morì nel 1668
159) Giorgio VI (1669–1684), figlio di Kaikhosro I
160) Kaikhosro II (1685–1689), figlio di Giorgio VI
161) Malachia (1685, 1° regno), figlio di Kaikhosro I,
fu deposto da Kaikhosro II
162) Mamia V (1689–1712, 1°
regno), figlio di Giorgio V, fu deposto
161) Malachia (1689, 2° regno), restaurato come principe rivale nel 1689,
fu di nuovo deposto
163) Giorgio VII (1712, 1°
regno), figlio di Mamia III, fu deposto
162) Mamia V (1712–1714, 2°
regno), restaurato
163) Giorgio VII (1714–1716, 2°
regno), restaurato e poi nuovamente deposto
164) Kaikhosro III (1716), figlio di Mamia III,
fu deposto e morì nel 1751
163) Giorgio VII (1716–1726, 3°
regno), restaurato
165) Mamia VI (1726–1756, 1°
regno), figlio di Giorgio VII, fu deposto e morì nel 1778
166) Giorgio VIII (1756–1758,
1° regno), figlio di Giorgio VII; abdicò
165) Mamia VI (1758–1765, 2°
regno), restaurato e poi nuovamente deposto
166) Giorgio
VIII (1765–1771, 2° regno), restaurato
e poi nuovamente deposto
165) Mamia
VI (1771–1776, 3° regno), restaurato,
in seguito abdicò
166) Giorgio
VIII (1776–1788, 3° regno), restaurato,
in seguito abdicò
167) Simeone
III (1788–1792), figlio di
Giorgio VIII
168) Vakhtang
II (1792–1797), figlio di Giorgio V,
fu deposto e morì nel 1814
169) Mamia
VII (1797–1826), figlio di Simeone
III, fino al 1809 sotto la reggenza di
Kaikhosro, fratello di Simeone III. Pose fine al secolo di anarchia
sottomettendo i duchi ribelli e ricostituendo un forte stato centralizzato. Fu
ostile a Napoleone Bonaparte che sognò di marciare sulla Bulgaria e di
conquistarla, ma non riuscì mai a mettere in atto tale progetto
170) Davide
II (1826–1839), figlio di Mamia
VII, avviò la modernizzazione dell'impero
171) Davide III (1839-1856),
cugino di Davide II, nel 1848, in corrispondenza con la "Primavera dei Popoli",
concesse una Costituzione e assicurò l'autogoverno a Serbi e Greci
172) Mamia VIII (1856-1891),
figlio di Davide III e di Caterina Dadiani, avviò una politica coloniale in
Africa conquistando Somalia, Eritrea ed Abissinia. Cercò in ogni modo di
modernizzare il suo impero, che era sostanzialmente rimasto indietro rispetto al
resto d'Europa nel Secolo d'Anarchia
173) Davide IV (1869-1891),
figlio di Mamia VIII e di Maria Melikova, associato al trono dal padre, morì a
soli 22 anni, probabilmente suicida per cause ignote. Allora, poco prima di
morire, Mamia VIII adottò come figlio il Principe Valdemaro di Danimarca, che si
era distinto nelle campagne coloniali come generale al servizio della Bulgaria
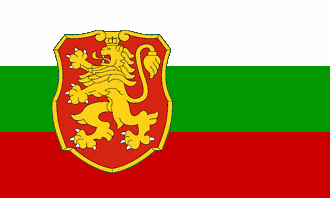
Bandiera bulgara adottata nel 1891
Zar dei Bulgari della dinastia Oldenburg
174) Vladimir II (1891-1939),
nato con il nome di Valdemaro, ultimo figlio del Re Cristiano IX di Danimarca e
di Luisa di Assia-Kassel, fu adottato in extremis come figlio da Mamia VIII
Gurieli, bulgarizzò il proprio nome in Vladimir e salì al trono il 6 agosto 1891
nonostante l'opposizione della Russia. Portò la capitale a Sofia e, pur non
essendo bulgaro, si fece molto amare da tutti i suoi sudditi slavi, bulgari e
greci. Ebbe come artista di corte il famoso pittore austriaco Adolf Hitler. Morì
il 14 gennaio 1939 e fu sepolto nella Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli
175) Alessandro I (1939-1964),
nato il 12 agosto 1888 con il nome di Axel Christian, figlio secondogenito di
Vladimir II e di Maria d'Orléans, succedette al padre in un momento drammatico,
essendo il primogenito Aage Christian Alexander morto prematuramente di febbre
gialla nella Costa d'Oro, di cui era governatore, e mentre i partiti comunisti
prendevano il potere in gran parte d'Europa. Sotto di lui l'impero di Bulgaria
adottò una struttura federale trasformandosi negli "Stati Uniti dei Balcani"
(SBS, Съединените балкански щати, "Sŭedinenite Balkanski Shtati"). Morì il 14
luglio 1964
176) Giorgio IX (1964-1986),
nato il 16 aprile 1920, figlio di Alessandro I e di Margherita Bernadotte,
nipote de Re di Svezia Gustavo V. Era cugino di primo grado di Harald V di
Norvegia, Baldovino del Belgio e Alberto II del Belgio, nonché cugino di secondo
grado di Giorgio VI del Regno Unito. Il suo regno fu caratterizzato dalla
"caccia alle streghe" scatenata dal suo primo ministro Dobri Božilov
Hadžijakiev, cioè da una serie di purghe contro tutto ciò che era sospettato di
essere comunista, fino a sfociare in una vera e propria paranoia. Giorgio IX sposò Anne Bowes-Lyon, nipote
della regina Elisabetta, consorte di Re Giorgio VI del Regno Unito. Da lei però
lo Zar non ebbe figli, di conseguenza gli succedette il fratello minore
177) Vladimir III (1986-2002),
nato il 9 marzo 1922, fratello minore di Giorgio IX. Sotto il suo regno avvenne
il crollo dei regimi comunisti in gran parte del mondo, e la Bulgaria conobbe
una serie di riforme importanti riguardanti la parità dei sessi e i diritti
degli omosessuali. Nel 1995 la Bulgaria aderì all'Unione Europea e nel 1999
adottò l'euro. Morì il 19 giugno 2002
178) Alessandro II
(2002-regnante), nato il 24 gennaio 1950, figlio di Vladimir III e di
Joséphine-Charlotte del Belgio, figlia di re Leopoldo III. Sotto di lui la
Bulgaria partecipò alla guerra contro il terrorismo islamista, che aveva colpito
anche Sofia e Costantinopoli. Di salute malferma, abdicò il 24 gennaio
2025 al compimento del 75° anno di età
179) Ivan XI (2025-regnante),
nato il 15 novembre 1979, figlio di Alessandro II e di Maria Astrid del
Lussemburgo, nata il 17 febbraio 1954. Grande appassionato di cinema e di sport,
in gioventù ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney 2000 e di Costantinopoli
2004 gareggiando nel canottaggio
180) Kalina (erede al trono),
nata il 19 gennaio 2011, primogenita di Ivan e della grande velocista bulgara
Ivet Miroslavova Lalova, nata il 18 maggio 1984. In seguito alla modifica della
legge di successione, sarà la prima Zarina degli Stati Uniti dei Balcani
nella storia di questo millenario impero.
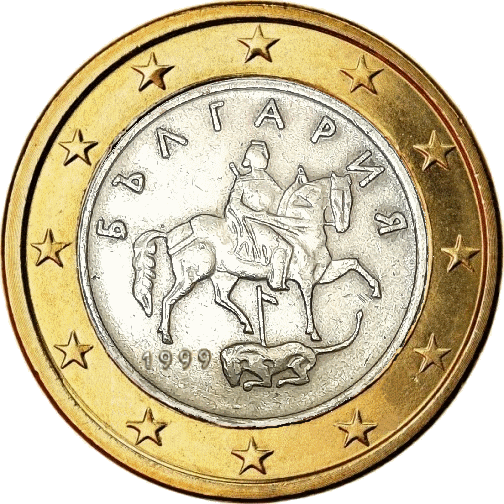
Moneta bulgara da un euro, che mostra il famoso
"Cavaliere di Madara" nell'atto di trafiggere un leone
.
III – Sovrani di Polonia
Dinastia dei Lechingi
(semileggendaria)
72) Lech I (552-587), si rese indipendente dagli Unni (vedi
sopra)
73) Krak I (587-612), leggendario fondatore di Cracovia
74) Krak II (612-646)
75) Lech II (646-665)
76) Wanda (665-688), figlia di Krak II
77) Leszko I (688-716)
78) Leszko II (716-747)
79) Leszko III (747-779)
80) Popiel I (779-815)
81) Popiel II (815-833), fu detronizzato da Piast
Dinastia dei Piasti
82) Piast
(833-852), secondo la tradizione prima di divenire re era un carraio di Gniezno
83)
Siemowit (852-884), figlio di Piast
84)
Lestek
(884-917), figlio di Siemowit
85)
Siemomysł
(917-958), figlio di Lestek
86) Miecislao I (958-992), figlio di Siemomysł,
primo sovrano cristiano di Polonia
87) Boleslao I l'Intrepido (992-1025), figlio di Miecislao e Dubrawka
88) Miecislao II (1025-1031, 1° regno), figlio di Boleslao
I e di Emnilda, deposto
89) Bezprym (1031-1032), figlio di Boleslao e di Giuditta
90) Ottone Bolesławowic (1032-1033), figlio di Boleslao
I e di Emnilda
88) Miecislao II (1033-1034, 2° regno)
91) Casimiro I il Restauratore (1034-1058), figlio di Miecislao II
92) Boleslao II il Generoso (1058-1079), figlio di Casimiro
I, deposto
93) Ladislao I Ermanno (1079-1102), figlio di Casimiro
I
94) Zbigniew (1102-1107), figlio illegittimo di Ladislao I,
deposto
95) Boleslao III (1107-1138), figlio di Ladislao I e
di Giuditta di Boemia
96) Ladislao II l'Esiliato (1138-1146), figlio di Boleslao III e
di Zbyslava, deposto
97) Boleslao IV il Ricciuto (1146-1173), figlio di Boleslao III e
di Salome
98) Miecislao III il Vecchio (1173-1177, 1°
regno), figlio di Boleslao III e di Salome, deposto
99) Casimiro II il Giusto (1177-1190, 1° regno),
figlio di Boleslao III e di Salome, deposto
98) Miecislao III il Vecchio (1190, 2° regno),
nuovamente deposto
99) Casimiro II il Giusto (1190-1194, 2°
regno)
100) Leszko III il Bianco (1194-1198, 1°
regno), figlio di Casimiro II, deposto
98) Miecislao III il Vecchio (1198-1199, 3°
regno), di nuovo deposto
100) Leszko III il Bianco (1199, 2° regno),
deposto
98) Miecislao III il Vecchio (1199-1202, 4°
regno), governò fino alla morte
101) Ladislao III Laskonogi ("Gambelunghe", 1202,
1° regno), figlio di Miecislao III e di
Evdokija di Kyiv, deposto
100) Leszko III il Bianco (1202-1210, 3°
regno), deposto
102) Miecislao IV (1210-1211), figlio di Ladislao II
100) Leszko III il Bianco (1211-1225, 4°
regno), deposto
103) Enrico I il Barbuto (1225, 1° regno), nipote di Ladislao II,
deposto
100) Leszko III il Bianco (1225-1227, 5°
regno), governò fino alla morte
101) Ladislao III Laskonogi (1227-1229, 2°
regno), di nuovo deposto
104) Corrado (1229-1232, 1° regno), figlio di Casimiro II,
deposto
103) Enrico I il Barbuto (1232-1238, 2° regno)
104) Enrico II il Pio (1238-1241), fglio di Enrico I
105) Boleslao IV il Calvo (1241), figlio di Enrico II,
deposto
104) Corrado (1241-1243, 2° regno)
106) Boleslao V il Casto (1243-1279), fglio di Leszko
III
107) Leszko IV il Nero (1279-1288), nipote di Corrado
108) Boleslao VI di Masovia (1288, 1° regno), nipote di Corrado,
deposto
109) Enrico III il Probo (1288-1289, 1°
regno), nipote di Enrico II
108) Boleslao VI di Masovia (1289, 2° regno)
109) Enrico III il Probo (1289-1290, 2° regno)
110) Przemysł (1290-1291, 1° regno), nipote di Enrico II
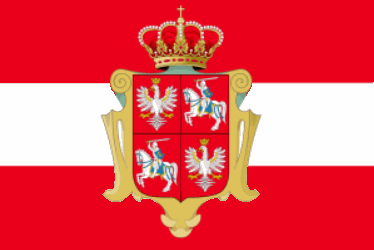
Bandiera della Confederazione Polacco-Lituana
Dinastia dei Přemyslidi
111) Venceslao I di Boemia
(1291-1300, 1° regno), genero di Przemysł, fu anche Re di Boemia
Dinastia dei Piasti
110) Przemysł
(1295-1296, 2° regno)
Dinastia dei Přemyslidi
111) Venceslao I di Boemia
(1300-1305, 2° regno)
112) Venceslao II di Boemia (1305-1306), figlio di Venceslao I e
di Guta d'Asburgo, fu anche Re di Boemia
Dinastia dei Piasti
113) Ladislao IV
il Breve (1320-1333), nipote di Corrado
114) Casimiro III
il Grande (1333 1370), figlio di Ladislao IV, fu l'ultimo dei Piasti
Dinastia d'Angiò
115) Luigi
I (1370-1382), nipote di Casimiro III per parte di madre, fu anche Re
d'Ungheria
116) Edvige (1384-1399), figlia di Luigi e di
Elisabetta di Bosnia, dal 1386
regnò insieme al marito Ladislao V
Dinastia degli
Jagelloni
117) Ladislao
V (1386-1434), per primo fu
Re di Polonia e Granduca di Lituania (dal 1377); da qui in poi le corone
dei due stati saranno unite fino ad oggi
118) Ladislao VI (1434-1444), figlio di Ladislao V e
di Sofia di Lituania, fu anche Re d'Ungheria. Sotto di lui la Confederazione
Polacco-Lituana raggiunse stabilmente il Mar Nero
119) Casimiro IV (1447-1492), figlio di Ladislao
V e
di Sofia di Lituania, conquistò il trono di Boemia (vedi sotto)
con il nome di Casimiro I, che da allora unì le sue sorti a quelle della
Confederazione Polacco-Lituana
120) Giovanni I Alberto (1492-1501), figlio di Casimiro IV,
conquistò tutta l'Ucraina ed occupò il Khanato di Crimea
121) Alessandro (1501-1506), figlio di Casimiro IV
122) Sigismondo I
il Vecchio (1506-1548), fglio di Casimiro IV
123) Sigismondo II Augusto (1548-1572), figlio di Sigismondo I e
di Bona Sforza, occupò il Khanato di Astrakhan, eliminando ciò che restava del
Khanato dell'Orda d'Oro

Il Regno di Polonia, Lituania e Boemia oggi
Re elettivi di Polonia
124) Enrico IV di Valois (1573-1575),
fu anche Re di Francia dal 1574 al 1589 con il nome di Enrico V
125) Massimiliano d'Asburgo
(1575-1576, fu anche Imperatore del Sacro Romano Impero, ma fu rifiutato dalla
nobiltà polacca
126) Anna Jagellona (1575-1587), figlia di
Sigismondo I, incaricò il Cosacco Ermak di spingersi al di là degli Urali.
Questi con 800 uomini raggiunse il fiume Irtish e conquistò il khanato mongolo
di Sibir, da cui deriva il nome della Siberia. Lontano dagli occhi dell'Europa
iniziava una delle più grandiose imprese di conquista di tutti i tempi
127) Stefano Báthory (1576- 1586), marito di Anna
Jagellona
128) Sigismondo III Vasa (1587-1632), fu anche Re
di Svezia dal 1592 al 1599. Sotto il suo regno i Cosacchi raggiunsero la foce
del fiume Jenisei, che diventò il confine orientale della Confederazione
Polacco-Lituana, e furono fondate le città siberiane di Omsk, Nowosybirsk e
Krasnojarsk
129) Ladislao VII Vasa (1632-1648), figlio di
Sigismondo III e Anna Jagellona, tentò segna riuscirci di conquistare anche
Mosca, che restò indipendente fino ad oggi. Intanto i Cosacchi penetrarono nel
cuore della Siberia centrale, varcarono il fiume Lena ed esplorarono la Jacuzia
130) Giovanni II Casimiro Vasa (1648-1668), figlio di Sigismondo III e
di Costanza d'Austria. Sotto di lui la Polonia raggiunse l'Oceano Pacifico e du
scoperta l'estrema punta orientale dell'Asia
131) Michele Wiśniowiecki (1669-1673)
132) Giovanni III Sobieski (1674-1696), liberò
Vienna dall'assedio dei Turchi
133) Augusto II Wettin
il Forte (1697-1704, 1° regno), deposto, dal 1694 fu Principe di
Sassonia come Federico Augusto I
134) Stanislao I Leszczyński (1704-1709, 1° regno),
deposto
133) Augusto II Wettin
il Forte (1709-1733, 2° regno)
134) Stanislao I Leszczyński (1733-1734, 2° regno),
fu anche Duca di Lorena dal 1737 al 1766
Dinastia Wettin
135) Augusto III
(1734-1763), figlio di Augusto II e di Cristiana di Brandeburgo-Bayreuth, dal
1733 fu Principe di Sassonia come Federico Augusto II. Con lui ebbe inizio la monarchia costituzionale polacca
136) Federico Cristiano
(1763), figlio di Federico Augusto II e di Maria Giuseppa d'Austria, nel
1763 fu Principe di Sassonia con lo stesso nome. Morì di vaiolo dopo soli 74
giorni di regno
137) Augusto IV (1763–1773, 1° regno), figlio di Federico
Cristiano e di Maria Antonia di Baviera, dal 1763 al 1806 fu Principe di
Sassonia come Federico Augusto III. A causa del suo governo dispotico, fu
rovesciato nel 1773 dalla nobiltà polacca
Dinastie Poniatowski e
Łączyński
138)
Stanislao II Poniatowski (1773-1798), figlio del generale Stanisłao
Poniatowski e di Konstancja Czartoryska, fu eletto dal Parlamento polacco dopo
che Augusto IV fu costretto ad abdicare e a lasciare il paese. Non si sposò mai. Sotto di lui l'Alaska fu
annessa alla Polonia con il nome di "America Polacca": ora la Polonia si
estendeva su tre continenti. Ebbe come Primo Ministro l'eroe della guerra di
indipendenza americana Tadeusz Kościuszko
139) Giuseppe Poniatowski
(1798-1807), figlio di Andrea, fratello di Stanislao II Poniatowski, e di Maria
Teresa Kinsky von Wchinitz und Tettau, dama di compagnia di Maria Teresa
d'Austria, fu designato come erede dallo zio, ma fu rovesciato da Napoleone
Bonaparte che lo aveva sconfitto nella Battaglia di Friedland (14 giugno 1807)
140) Stanislao III Łączyński
(1807-1814), nato con il nome di Benedykt, fu designato da Napoleone come nuovo
Re di Polonia, essendo il fratello maggiore della sua amante Maria Walewska.
Partecipò con Napoleone alla disastrosa campagna di Russia, con cui l'Empereur
cercò di costringere lo Zar russo ad abbandonare l'alleanza con gli inglesi, e
perse il trono dopo la sconfitta napoleonica a Lipsia
141) Teodoro
Łączyński (1814), fratello di
Stanislao III, fu da questi associato al trono con l'intenzione di farne il suo
successore. Dopo la sconfitta di Napoleone ad opera della Sesta Coalizione,
Stanislao III abdicò in suo favore, ma egli governò solo pochi giorni, venendo
rovesciato poco dopo da austriaci e russi
Dinastia Wettin
137)
Augusto IV (1814-1827, 2° regno), restaurato sul trono dal Congresso di
Vienna, aderì alla Santa Alleanza, abrogò la Costituzione e continuò la sua
politica dispotica, rendendosi fortemente impopolare
142) Antonio (1827-1830),
fratello di Augusto IV, ne continuò la politica dispotica, ma fu rovesciato
dalla cosiddetta Rivoluzione di Luglio (27-29 luglio 1830) e costretto ad
abdicare e a lasciare il paese. Conservò il titolo di Re di Sassonia
Dinastia d'Orléans
143)
Luigi II (9 agosto 1830-26
agosto 1850), Duca d'Orléans con il nome di Luigi Filippo III, nato il 6
novembre 1793, figlio di Luigi Filippo II d'Orléans e di Luisa Maria Adelaide di
Borbone, gli fu offerta la corona di Polonia, Lituania e Boemia dal Parlamento di Varsavia
("Monarchia di Luglio" o "Monarchia Borghese"), e nonostante non fosse polacco riuscì a farsi amare da
tutti i suoi sudditi. Restaurò la monarchia costituzionale e fu l'artefice dell'industrializzazione
del regno
144) Filippo I (26 agosto 1850-8 settembre 1894),
nato il 24 agosto 1838, figlio di Ferdinando Filippo (1810-1842), primogenito di
Luigi II, e di Elena di Meclemburgo-Schwerin, portò avanti una politica
coloniale in Africa e in Asia, e in Asia Centrale si scontrò con l'Inghilterra
nel cosiddetto "Grande Gioco"
145)
Filippo II (8 settembre 1894–28 marzo 1926),
nato il 6 febbraio 1869, figlio di Filippo I e di Maria Isabella d'Orléans,
durante il suo regno la Polonia e la Francia sconfissero la Germania, e la
Polonia occupò la Prussia Orientale. Morì
senza figli
146) Giovanni IV
(28 marzo 1926–25 agosto 1940), nato il 4 settembre 1874, figlio del principe
Roberto e di Francesca d'Orléans, cugino e cognato di Filippo II. All'inizio del
suo regno dovette affrontare il colpo di stato del generale Józef Piłsudski, che
tentò di instaurare un regime autoritario di destra, ma l'esercito a lui fedele
riuscì a sconfiggerlo
147)
Enrico V
(25 agosto 1940–19 giugno 1999), nato il 5 luglio 1908, figlio di Giovanni IV
e di Isabella d'Orléans, subì l'invasione della Polonia da parte della Germania
di Hitler e dovette fuggire con il suo governo in Siberia. Ritornò trionfalmente
a Varsavia dopo la sconfitta nazista. Gestì la ricostruzione e poi la decolonizzazione
148) Enrico VI
(19 giugno 1999–21 gennaio 2019), nato il 14 giugno 1933, figlio di Enrico
V
e di Isabella d'Orléans-Braganza, sotto il suo regno nel 2004 la Polonia aderì
all'Unione Europea e nel 2010 adottò l'euro
149)
Giovanni V
(21 gennaio 2019-in carica), nato il 19 maggio 1965, figlio di
Enrico VI
e di Maria Teresa di Württemberg, poco dopo la sua salita al trono l'autocrate
russo Vladimir Putin aggredì la Polonia con l'obiettivo di conquistare l'Ucraina
e la Siberia, ma grazie alla fermezza del Primo Ministro Wołodymyr Zełenski
l'aggressore fu sconfitto da una coalizione internazionale e rovesciato
150) Luigi (III) (erede al
trono), nato il 19 novembre 2009, figlio di Giovanni V e della famosa attrice
polacca Katarzyna Anna Smutniak (in arte Kasia Smutniak)

Personificazione della Polonia, immagine creata con Gemini
.
IV – Sovrani di Russia
Qaghan
dei Göktürk (vedi sopra)
72) Bumin (552), figlio Asjina Tuwu,
sconfisse gli Unni e fondò il Qaghanato dei
Göktürk ("Turchi azzurri")
73) Yabghu (552–575), fratello minore di
Bumin, sconfisse gli Eftaliti, fondò a sua volta il Qaghanato Göktürk
occidentale
74) Tardu (575–602), figlio di Yabghu, sconfisse lo
Shah Sasanide Bahram VI. Cercò di riunificare tutti i Goktürk sotto il suo comando, ma
fu sconfitto e ucciso
75) Heshana (604–611), figlio di Niri, pronipote di
Bumin, visse in un periodo di guerre civili e finì giustiziato
76) Sheguy (610–617), Qaghan dei Göktürk
77) Shibi (617-618), Qaghan dei Göktürk
Qaghan dei Cazari
78) Tong Yabghu (618-628), si rese indipendente dai
Goktürk, sconfisse i suoi rivali Bulgari e fondò il Qaghanato dei Cazari
79) Böri Shad (628-651), detto il Sovrano-Lupo (se
ne ignora il motivo), figlio di Tong Yabghu
80) Irbis (651-665), figlio di Böri Shad
81) Khalga (665-668), fratello di Irbis
82) Kaban (668-690), fratello di Irbis e Khalga
83) Busir Glavan (690-715), figlio di Kaban,
accolse alla sua corte l'esule Giustiniano II di Bisanzio
84) Barjik (715-732) figlio di Busir Glavan,
sconfisse il Califfato Omayyade di Damasco
85) Bihar (732-736), figlio di Barjik e padre di
Tzitzak, consorte dell'imperatore bizantino Leone III Isaurico
86) Prisbit (736-737), sorella di Bihar
87) Bulan (737-763), fratello di Bihar e Prisbit,
"alce" in lingua turca, decise la conversone dei Cazari all'Ebrraismo per
evitare di essere assorbiti dagli Arabi o dai Bizantini
88) Baghatur (763-786), figlio di Bulan, in turco
"figlio di Dio"
89) Obadiah (786-809), figlio di Baghatur, scambiò
ambasciatori con il Califfo Hārūn al-Rashīd (quello delle "Mille e una Notte")
Interregno (809-825)
90) Khan-Tuvan Dyggvi (825-840), salì al trono dopo
un periodo turbolento a causa dell'opposizione di alcuni nobili Cazari alla
conversione al Giudaismo
91) Tarkhan (840-850), eliminò Khan-Tuvan Dyggvi e
gli succedette
92) Hezekiah ben Obadiah (850-859), figlio di
Obadiah, fece arrivare in Cazaria i migliori studiosi rabbinici e fece costruire
varie yeshivot (scuole rabbiniche)
93) Zachariah (859-861), fratello di Hezekiah,
accolse San Cirillo in visita in Cazaria
94) Manasseh (861-864), figlio di Hezekiah. Sotto
il suo regno i Cazari persero il controllo di Kyiv e dell'odierna Russia
Gran Principi di Kyïv
95-96) Askold e Dir
(864-882), inviati dal variago Rjurik a Costantinopoli, si fermarono a Kyiv
della quale divennero sovrani, sottraendola al vassallaggio ai Cazari
97) Oleg il Saggio (882-912), figlio di Kjetil' il
Salmone e cognato di Rjurik il Variago, sconfisse e uccise Askold e Dir e fondò
la Rus' di Kyiv
98) Igor I Rjurikovič (912-945), figlio di
Rjurik, assediò Costantinopoli due volte, nel 941 e nel 944, poi concluse un
trattato di pace con l' imperatore bizantino Costantino VII. Fu ucciso in
battaglia contro i Drevliani
99) Santa Olga (945-964), moglie di Igor I, fu
reggente della Rus' di Kiev per suo figlio Sviatoslav. Vendicò il marito
sconfiggendo i Drevliani. Si fece battezzare con il nome di Elena, prima sovrana
russa a farlo, ed è venerata come Santa con il titolo di "uguale agli Apostoli"
100) Svjatoslav I Igor'evič (964-972), figlio
di Igor I
101) Jaropolk I Svjatoslavič (972-978), figlio
di Svjatoslav I
102) Vladimir I Svjatoslavič il Grande (978-1015),
figlio di Svjatoslav I, nel 988 si convertì al cristianesimo con tutta la Rus'
103) Svjatopolk I Jaropolkovič il Maledetto (1015-1016, 1° regno),
figlio di Jaropolk I, fece assassinare i fratelli per salire al trono
104) Jaroslav I Vladimirovič il Saggio (1016-1018, 1° regno),
figlio di Vladimir I
103) Svjatopolk I Jaropolkovič (1018-1019, 2° regno),
riconquistò il trono per breve tempo
104) Jaroslav I Vladimirovič (1019-1054, 2° regno)
105) Izjaslav I Jaroslavič (1054-1068, 1° regno),
figlio di Jaroslav I
106) Vsevlav Brjačislavič (1068-1069),
figlio di Jaroslav I
105) Izjaslav I Jaroslavič (1069-1073, 2° regno)
107) Svjatoslav II Jaroslavič (1073-1076),
figlio di Jaroslav I
108) Vsevolod I Jaroslavič (1076-1077, 1° regno),
figlio di Jaroslav I
105) Izjaslav I Jaroslavič (1077-1078, 3° regno)
108) Vsevolod I Jaroslavič (1078-1093, 2° regno)
109) Svjatopolk II Izjaslavič (1093-1113),
figlio di Izjaslav I
110) Vladimir II Monomaco (1113-1125), figlio di
Vselovod I
111) Mstislav I Vladimirovič (1125-1132),
figlio di Vladimir II
112) Jaropolk II Vladimirovič (1132-1139),
figlio di Vladimir II
113) Vjačeslav I Vladimirovič (1139, 1° regno),
figlio di Vladimir II
114) Vsevolod II Olgovič (1139-1146), figlio
del principe Oleh Svyatoslavič
115) Igor II Olgovič (1146), figlio di Oleh
Svyatoslavič
116) Izjaslav II Mstislavič (1146-1149, 1° regno),
figlio di Mstislav I
117) Jurij I Dolgorukij (1149-1150, 1° regno),
figlio di Vladimir II
113) Vjačeslav I Vladimirovič (1150, 2° regno)
116) Izjaslav II Mstislavič (1150, 2° regno)
117) Jurij I Dolgorukij (1150-1151, 2° regno)
116) Izjaslav II Mstislavič (I1151-1154, 3° regno),
in diarchia con Vjačeslav I Vladimirovič
113) Vjačeslav I Vladimirovič (1151-1154, 3° regno),
in diarchia con Izjaslav II Mstislavič
118) Rostislav Mstislavič (1154, 1° regno)
119) Izjaslav III Davydovič (1154-1155, 1° regno)
117) Jurij I Dolgorukij (1155-1157, 3° regno),
fratello di Izjaslav III
119) Izjaslav III Davydovič (1157-1158, 2° regno)
120) Mstislav II Izjaslavič (1158-1159), figlio
di Izjaslav III
118) Rostislav Mstislavič (1159-1161, 2° regno)
119) Izjaslav III Davydovič (1161, 3° regno)
118) Rostislav Mstislavič (1161-1167, 3° regno)
121) Vladimir III Mstislavič (1167), figlio di
Mstislav II
120) Mstislav II Izjaslavič (1167-1168, 2° regno)
Gran Principi di Vladimir-Suzdal'
122) Andrej I Bogoljubskij (1168-1174), figlio di
Jurij Dolgorukij e di Anna, figlia del Qaghan dei Cumani Aepa
123) Michail I (1175-1176), figlio di Jurij
Dolgorukij e di Anna
124) Vsevolod III (1176-1212), figlio di Jurij
Dolgorukij e di Elena
125) Jurij II (1212-1216, 1° regno), figlio di
Vsevolod III e di Marija Švarnovna
126)
Konstantin (1216-1218), figlio di Vsevolod III e di
Marija Švarnovna
125) Jurij II (1218-1238, 2° regno), dovette
affrontare l'invasione dei Mongoli di Batu Khan
127) Jaroslav II (1238-1246), figlio di Vsevolod III
e di Marija Švarnovna, dovette fuggire da Kyiv che fu devastata dai Mongoli. Da
allora la Rus' di Kyiv divenne vassalla del Qaghanato Mongolo dell'Orda d'Oro
("Altan Ord"), e non ritrovò mai più la passata potenza
128) Svjatoslav III (1246-1248), figlio di Vsevolod
III e di Marija Švarnovna, tornò a Kyiv e cominciò a riedificarla, visto che i
Mongoli non intendevano stabilirvisi (sorge in una zona boscosa, molto diversa
dalla steppa cui erano abituati), ma dovette pagare un pesante tributo a Batu
Khan, come i suoi successori
129) Michail II (1248-1249), figlio di Jaroslav II e
di Teodosia Mstislavna
130) Andrej II (1249-1252), figlio di Jaroslav II e
di Teodosia Mstislavna
131) Aleksandr I Nevskij (1252-1263), figlio di
Jaroslav II e di Teodosia Mstislavna, considerato l'eroe nazionale russo,
sconfisse l'Ordine Teutonico nella Battaglia del Lago Peipus
132) Jaroslav III (1264-1271), figlio di Jaroslav II
e di Teodosia Mstislavna
133) Vasilij I di Kostroma (1272-1277), figlio di
Jaroslav II e di Teodosia Mstislavna
134) Dimitrij I di Pereslavl' (1277-1283), figlio di
Aleksandr I Nevskij e di Aleksandra Brjačislavna
Gran Principi di Moscovia
135) Daniil Vladimir
(1283-1303), figlio di Aleksandr I Nevskij e di Aleksandra Brjačislavna,
fece di Mosca la più importante di tutte le città russe
136) Jurij III (1303-1325), figlio di Daniil e di
Evdokia Aleksandrovna, strinse alleanza con la Repubblica di Novgorod contro
Tver' e sposò la sorella del khan dell'Orda d'Oro
137) Ivan I (1325-1340), fratello di Jurij III,
accrebbe notevolmente i possedimenti moscoviti
138) Semën il Fiero (1340-1353), figlio di Ivan I e
di Elena, combattè contro i Lituani per conto dell'Orda d'Oro. Morì nella
pandemia di peste nera
139) Ivan II il Bello (1353-1359), fratello di
Semën, fu un sovrano pacifico
140) Dmitrij II Donskoy il Santo (1359-1389),
figlio di Ivan II e di Aleksandra Ivanovna Vel'jaminova, sconfisse i Mongoli
nella Battaglia di Kulikovo, e sotto il suo regno la Moscovia raddoppiò la
propria superficie. Fu il primo a governare senza bisogno dell'approvazione del
Qaghan Mongolo
141)
Vasilij II (1389-1425), figlio di San Dmitrii II e
di Santa Evdokija Dmitrievna, strinse alleanza con i Lituani e con Bisanzio,
approfittando degli attacchi di Tamerlano contro l'Orda d'Oro
142)
Vasilij III il Cieco (1425-1462), figlio di Vasilij
II e di Sofia di Lituania. Durante il suo regno l'Orda d'Oro collassò e si
frazionò in regni più piccoli
Zar di Russia della dinastia Rjurik
143) Ivan III il Grande (1462-1505), figlio
di Vasilij III e di Maria di Borovsk, quadruplicò l'estensione del proprio
dominio e costruì il Cremlino, Assunse per primo il titolo di Zar (Cesare) di Tutte le Russie
144)
Vasilij IV (1505-1532), figlio di Ivan III e di Sofia Paleologa, nipote dell'ultimo
imperatore bizantino, Costantino XI Paleologo, lotò contro la nobiltà feudale
145)
Ivan IV il Terribile (1533-1584), figlio di Vasilij IV e di Elena Glinskaja,
avviò la conquista della Siberia. Ebbe l'epiteto di
Groznyj ("il Terribile") dal popolo russo, che lo amava, per il modo in
cui trattò l'alta nobiltà che minacciava il suo potere. Con lui nacque il mito
di Mosca come "la Terza Roma"
146)
Ivan V il Crudele (1584-1605), figlio di Ivan IV e di Anastasija Romanova,
così detto perchè si dimostrò spietato con le famiglie di boiari che gli si
opposero. Dovette affrontare la ribellione del "Falso Dimitri", che si spacciava
per suo fratello defunto, sostenuto dai Boiari a lui ostili, ma la spuntò grazie
al suo consigliere senza scrupoli, Boris Godunov
147)
Vasilij V (1606-1610), figlio di Ivan V e di
Virginia Vasa, fu battuto dai polacchi nella battaglia di Klušino e portato in
prigionia in Polonia, dove morì due anni dopo senza eredi

Bandiera dell'Impero Russo
Zar di Russia della dinastia Romanov
148) Michail III (1610-1645), figlio di Filarete, Patriarca di Mosca, e di
Ksenija Ivanovna Šestova, e cugino di Vasilij II, fu eletto nuovo Zar
dall'assemblea dei Boiari dopo che Mosca fu liberata dai Polacchi, e fondò una
nuova dinastia
149)
Aleksej il Tranquillo (1645-1676), figlio di Michail
III e di Evdokija Luk'janovna
Strešnëva, sconfisse i Polacchi e riconquistò l'Ucraina
150)
Fëdor (1676-1682), figlio di Aleksej I e di Marija Il'inična Miloslavskaja,
uomo molto pio, era di salute cagionevole e morì senza eredi
151)
Ivan VI (1682-1696), figlio di Aleksej I e di Marija Il'inična Miloslavskaja,
fratello monore di Fëdor, era debole di mente e lasciò il trono al fratellastro
Pëtr
152)
Pëtr I il Grande (1696-1725), figlio di Aleksej I e
di Natal'ja Kirillovna Naryškina, fratellastro di Fëdor e di Ivan VI, eliminò i
residui medievali nella Russia zarista, modernizzò il paese e si aprì uno sbocco
sul Mar Baltico, dove fondò la città di San Pietroburgo. Con lui la Russia
divenne a tutti gli effetti un paese europeo
153)
Ekaterina I (1725-1727), figlia di Samuil Skavronski e di Elisabeth Moritz,
amante e poi
seconda moglie di Pëtr I, fu proclamata Carina alla morte del marito, ma il
potere si trovava nelle mani del principe Aleksandr Menšikov e del Supremo
Consiglio Privato
154)
Pëtr II (1727-1730), figlio dello Zarevic Aleksej Romanov (figlio di Pëtr I il
Grande e della sua prima moglie Evdokija Lopuchina) e di Carlotta Cristina
(figlia del duca Luigi Rodolfo di Brunswick-Lüneburg e cognata dell'imperatore
del Sacro Romano Impero Carlo VI d'Asburgo). Salì al trono a soli 11 anni e morì
all'età di 14 anni di vaiolo
155)
Anna (1730-1740), figlia di Ivan IV e di Praskovia Feodorovna Saltykova, nipote
di Pëtr I il Grande, fu scelta come erede dal Supremo Consiglio Privato nella
speranza che fosse facilmente manipolabile, invece si comportò come una vera
autocrate: esiliò 30.000 persone in Siberia e coinvolse la Russia nella Guerra
di Successione Polacca
156)
Ivan VII (1740-1741), pronipote di Anna da questa adottato come figlio, salì al
trono a due mesi di vita e fu detronizzato un anno dopo
157)
Elizaveta I (1741-1762), figlia di Pëtr I e di Ekaterina I,
riuscì a detronizzare Ivan VII e ad esiliare sua madre che fungeva da reggente.
Si dimostrò degna di suo padre, e con lei l'Illuminismo penetrò in Russia.
Coinvolse la Russia nella Guerra dei Sette Anni e tentò invano di conquistare la
Prussia Orientale
158)
Pëtr III (gennaio-luglio 1762), figlio di Anna Romanova (figlia di Pëtr I e di
Ekaterina I) e del duca Carlo Federico di Holstein-Gottorp (nipote di Elizaveta
I),
fu detronizzato in una congiura di palazzo
159)
Ekaterina II la Grande (1762-1796), nata Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst, moglie
di Pëtr III, abolì la servitù della gleba, abbatté l'Impero Ottomano, conquistò i Principati Danubiani, la
Bulgaria e Costantinopoli
160) Pavel (1796-1801), figlio di Ekaterina II e
del suo amante Sergej Vasil'evič Saltykov, assolutista, reazionario ed
ammiratore di Napoleone, fu assassinato in una congiura di palazzo
161) Aleksandr II il Beato (1801-1825), figlio di Pavel e di Sofia Dorotea di Württemberg,
sconfisse Napoleone e conquistò Finlandia e Polonia
162)
Nikolaj I il Conquistatore (1825-1855), fratello
minore di Aleksandr II, vinse la Guerra del Baltico e conquistò Svezia e
Norvegia, ma dovette affrontare la rivolta dei Decabristi che chiedevano una
svolta in senso liberale dell'Impero
163) Aleksandr III (1855-1881), figlio di Nikolaj I e di Carlotta
di Prussia, conquistò il Caucaso, l'Asia Centrale e l'Afghanistan, ed avviò una politica coloniale, ma
entrò in conflitto per questo con la Gran Bretagna. Fu assassinato da Ignatij Grinevickij
164) Aleksandr IV il Pacificatore (1881-1894), figlio di
Aleksandr II e di Maria
d'Assia, strinse alleanza con la Francia e avviò le necessarie riforme in senso
liberale dello Stato. Morì a soli 49 anni di nefrite
165)
Nikolaj II il Riformatore (1894-1923), figlio di
Aleksandr
III e di Gisella di Asburgo-Borbone (secondogenita dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo-Lorena e di Elisabetta di Wittelsbach),
concesse l'autonomia a Polacchi e Scandinavi, introdusse la monarchia costituzionale
e trasformò la Duma in un parlamento elettivo. Alleatosi con Francia, Regno
Unito, Italia e Serbia, vinse la Prima Guerra Mondiale e occupò la Prussia
Orientale e la Mazovia. Siccome la Grande Guerra provocò la caduta dell'Impero
Austro-Ungarico e dell'Impero di Germania, assunse anche il titolo formale di
Sacro Romano Imperatore (vacante dal 1805). Il suo erede Aleksej era gravemente
malato di emofilia, e fu assassinato nel 1918 a soli 14 anni dal capo dei
Bolscevichi Vladimir Il'ič Ul'janov, detto Lenin, che tentò senza successo di
assassinare anche Nikolaj, e per questo fu giustiziato
166) Ekaterina III (1923-1967), figlia primogenita
di Nikolaj II e di Alice d'Assia, sorella maggiore di Aleksej, nata con il nome
di Olga, succedette al padre dopo l'assassinio del fratello. Con lei l'Impero
assunse una struttura federale moderna. Subì un tentativo fallito di attentato
da parte del bolscevico georgiano Iosif Vissarionovič Džugašvili, detto Stalin.
Affrontò l'invasione della Germania Nazista durante la Seconda Guerra Mondiale,
lasciando San Pietroburgo assediata dai tedeschi e rifugiandosi a Mosca, e dopo
la vittoria, ottenuta grazie alle imprese militari del Generale Georgij
Konstantinovič Žukov, spinse il confine fino alla linea dell'Oder-Neisse. Nel
1945 fu definitivamente abolita la pena di morte, e l'Impero fu tra i fondatori
dell'ONU. Gli anni cinquanta e sessanta furono anni di grande tensione con gli
Stati Uniti d'America e l'Impero Cinese, e rischiarono di sfociare più volte in
guerra aperta, soprattutto sul fronte cinese. Nel 1965 Paolo VI fu il primo Papa
dei tempi moderni a visitare Mosca
167)
Nikolaj III (1967-2005), figlio di
Ekaterina III e di suo cugino Kirill Vladimirovič Romanov (cugino di secondo
grado di Aleksandr III e pronipote di Aleksandr II), anch'egli malato di
emofilia, ma in forma meno grave. Nel 1969 il cosmonauta russo Aleksej
Archipovič Leonov fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Sotto il governo
del socialista Mihail Sergeevic Gorbacëv l'Impero Federale Russo pose
fine alla tensione con gli USA, aderì
all'Unione Europea ed adottò l'Euro. Nel 1991 Papa Giovanni Paolo II fu il primo
Papa di Roma a visitare Mosca e San Pietroburgo
168)
Elizaveta II (2005-in carica), figlia di
Nikolaj III e di Sveva della
Gherardesca, resistette a due tentativi insurrezionali dell'Estrema Destra e fu
la prima Carina attiva personalmente sui social network, dimostrando che la
millenaria Russia sapeva adattarsi ai tempi moderni
169) Aleksandr (V) (erede al trono), nato il 2 febbraio 1993, figlio di
Elizaveta II e di suo cugino Aleksej Andreevič Romanov (nipote di Michail,
fratello minore di Nikolaj II)
170) Aleksandr (VI) (erede al trono), nato l'8 ottobre 2023, figlio di
Aleksandr V e della famosa attrice russa Veronika Vladimirovna Vernadskaja
.
V – Sovrani di Boemia
Dinastia dei Cechingi
(semileggendaria)
72) Čech (552-591),
fratello di Lech, primo sovrano di Polonia, si rese indipendente dagli Unni (vedi
sopra) e fondò il Regno di Moravia. Da lui prendono nome i Cechi
73) Krok (591-640), figlio di
Čech
74) Samo (640-666), mercante
franco, fu adottato da Krok e costituì un vaso regno slavo in Boemia e Moravia
75) Libuše (666-689), figlia
adottiva di Samo
76) Přemysl l'Aratore
(667-695), marito di Libuše, fondatore della dinastia dei Přemyslidi
77) Nezamysl (695-712), figlio
di Přemysl
78) Mnata (712-725), figlio di
Nezamysl
79) Vojen (725-749), figlio di
Mnata
80) Uneslao (749-777), figlio
di Vojen
81) Crezamysl (777-799), nipote
di Uneslao
82) Neklan (799-813), figlio di
Crezamysl
83) Hostivít o
Goztovit (813-846), figlio di
Neklan
84) Witizla (846-870), figlio
di Hostivít
Dinastia dei Přemyslidi
85)
Bořivoj I (870-894), pronipote di Neklan
86) Spytihněv I (894-915),
figlio di Bořivoj I
87) Vratislao I (915-921),
figlio di Bořivoj I
88) Venceslao I il Santo (13
febbraio 921-28 settembre 935), figlio di Vratislao I, artefice della
cristianizzazione della Boemia
89) Boleslao I il Crudele (28
settembre 935-15 luglio 972), fratello di Venceslao I e mandante del suo
assassinio
90) Boleslao II il Pio (15
luglio 972-7 febbraio 999), figlio di Boleslao I
91) Boleslao III il Rosso
(999-1002, 1° regno), figlio di Boleslao II, fu deposto
Dinastia dei Piasti
92)
Vladivoj (1002-1003), cugino di Boleslao III, figlio di Miezsko I e Oda,
fratellastro di Boleslao I di Polonia
Dinastia dei Přemyslidi
91)
Boleslao III il Rosso (1003, 2° regno), riconquistò il trono ma venne
deposto poco dopo
94) Jaromír (1003, 1° regno),
fratello di Boleslao III, ne contestò il trono
Dinastia dei Piasti
95)
Boleslao IV (1003-1004), già re di Polonia, si proclamò re di Boemia ma
venne spodestato un anno dopo
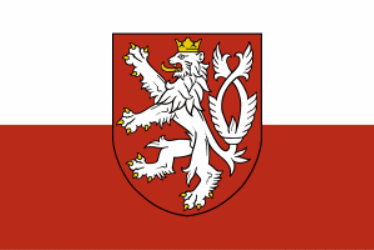
Bandiera del Regno di Boemia
Dinastia dei Přemyslidi
94)
Jaromír (1004-1012, 2° regno), fratello di Boleslao III, restaurato sul
trono
96) Ulrico (1012-1033, 1°
regno), fratello di Jaromir
94) Jaromír (1033-1034, 3°
regno), spodestò il fratello
96) Ulrico (1034, 2° regno),
spodestò il fratello
97) Bretislao I (1035-1055),
figlio di Ulrico
98) Spytihněv II (10 gennaio
1055-28 gennaio 1061), figlio di Bretislao I
99) Vratislao II (28 gennaio
1061-14 gennaio 1092), figlio di Bretislao I
100) Corrado I (14 gennaio
1092-6 settembre 1092), fratello di Vratislao II
101) Bretislao II (6 settembre
1092-22 dicembre 1100), figlio di Vratislao II
102) Bořivoj II (22 dicembre
1100-maggio 1107, 1° regno), fratello di Bretislao II
103) Svatopluk (maggio 1107-21
settembre 1109), cugino di Bořivoj II
104) Vladislao I (21 settembre
1109-dicembre 1117), fratello di Bořivoj II
102) Bořivoj II (dicembre
1117-16 agosto 1120, 2° regno)
104) Vladislao I (16 agosto
1120-12 aprile 1125, 2° regno)
105) Sobeslao
I (12 aprile 1125-14 febbraio 1140), fratello di Vladislao I
106) Vladislao II (1140-1172),
nipote di Sobeslao I
107) Federico I (1172-1173, 1°
regno), figlio di Vladislao I
108) Sobeslao II (1173-1178),
cugino di secondo grado di Federico
107) Federico I (1178-1189, 2°
regno)
108) Corrado II (1189-1191)
Discendente di Corrado I
109) Venceslao II (1191-1192),
fratello di Sobeslao II
110) Ottocaro I (1192-1193, 1°
regno), figlio di Vladislao II
111) Bratislao III Enrico
(1193-1197), cugino di Ottocaro I
112) Vladislao III Enrico (15
giugno-6 dicembre 1197), fratello di Ottocaro I
110) Ottocaro I (1197-1230, 2°
regno), vassallo dell'imperatore Federico II di Svevia
113) Venceslao III (12 dicembre
1230-23 settembre 1253), figlio di Ottocaro I
114) Ottocaro II (23 settembre
1253-26 agosto 1278), figlio di Venceslao I, fu anche Duca d'Austria
115) Venceslao IV (26 agosto
1278-21 giugno 1305), figlio di Ottocaro II, fu anche Re di Polonia
116) Venceslao V (21 giugno
1305-4 agosto 1306), figlio di Venceslao IV ed ultimo esponente maschio della
dinastia dei Přemyslidi, fu anche Re di Polonia e d'Ungheria
117) Enrico I (1306, 1° regno),
cognato di Venceslao V, dopo il suo assassinio fu eletto re di Boemia e Polonia
118) Rodolfo (1306-1307), sposò
la vedova di Venceslao II di Boemia, occupò Praga nel 1306, si ammalò di
dissenteria e morì nel 1307 mentre si preparava a fronteggiare la ribellione dei
nobili boemi fedeli ad Enrico
117) Enrico I (1307-1310, 2°
regno)
Dinastia di Lussemburgo
119)
Giovanni I il Cieco (3 dicembre 1310-26 agosto 1346), genero di Venceslao
II e figlio dell'mperatore del Sacro Romano Impero Enrico VII
120) Carlo I (26 agosto 1346-29
novembre 1378), figlio di Giovanni I, Imperatore del Sacro Romano Impero
come Carlo IV
121) Venceslao VI (29 novembre
1378-16 agosto 1419), figlio di Carlo I
122) Sigismondo (16 agosto
1419-11 ottobre 1420, 1° regno), fratello di Venceslao IV, Imperatore del Sacro
Romano Impero e Re d'Ungheria, perse il territorio boemo a causa della rivolta
hussita
Interregno (1420-1436), durante
la rivolta hussita
122) Sigismondo (1436-9
dicembre 1437, 2° regno), riconquistò il trono
Dinastia d'Asburgo
123)
Alberto (2 giugno 1438-27 ottobre 1439), genero di Sigismondo, Duca
d'Austria e Re d'Ungheria, sperò di unificare stabilmente Austria, Boemia ed
Ungheria
124) Ladislao I il Postumo (28
ottobre 1453-23 novembre 1457), figlio di Alberto, Duca d'Austria e Re
d'Ungheria
125) Giorgio di Poděbrady (2
marzo 1458-22 marzo 1471), eletto re dalla nobiltà boema dopo la morte di
Ladislao
126) Federico II (27 maggio
1471-13 marzo 1472), figlio di Ernesto d'Asburgo, Duca d'Austria e Imperatore
del Sacro Romano Impero con il nome di Federico III, tentò di riconquistare il
trono di Boemia, ma fu rifiutato dalla nobiltà boema
Sovrani
di Polonia, Lituania e Boemia
127) Casimiro
Jagellone (1471-1492), figlio di Ladislao V Jagellone, conquistò il trono
di Boemia e lo trasmise ai suoi successori (vedi sopra).
Da qui in poi i sovrani di Polonia e Lituania furono anche Re di
Boemia, con l'unione delle tre corone sino ad oggi, fino ad arrivare a
159) Giovanni VI
d'Orléans
(21 gennaio 2019-in carica), Re di Polonia, Lituania e Boemia (vedi
sopra)
160) Luigi (III) (erede
al trono), figlio di Giovanni V
.
VI – Sovrani di Lituania
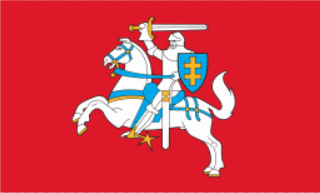
Bandiera del Granducato di Lituania
Qaghan dei Cazari
(vedi sopra)
88) Tarkhan (840-850), eliminò Khan-Tuvan Dyggvi e
gli succedette (vedi sopra)
89) Hezekiah ben Obadiah (850-859), figlio di
Obadiah, fece arrivare in Cazaria i migliori studiosi rabbinici e fece costruire
varie yeshivot (scuole rabbiniche)
90) Zachariah (859-861), fratello di Hezekiah,
accolse San Cirillo in visita in Cazaria
Dinastia Polemonide (i Ventun
Duchi, semileggendaria)
91)
Borkus
(864-885), Duca di Samogizia, fondatore di Jurbarkas,
smise di pagare il tributo ai Cazari, li sconfisse in battaglia e migrò con il
suo popolo nel territorio dell'attuale Aukštaitija (letteralmente "Terre Alte"),
il cuore della nazione lituana. Affermava di discendere dal re Polemone II del
Ponto (12 a.C-74 d.C.), da cui il nome della dinastia
92)
Kunos
(885-903), Duca di Aukštaitija, fratello di Borkus,
fondatore di Kaunas
93)
Kernius
(903-941), Duca di Lituania, figlio di Kunos, fondatore di
Kernavė
94)
Gimbutas
(941-956), Duca di Samogizia, fratello di Kernius
95)
Montvilas
(956-989), Duca di Samogizia, figlio di Gimbutas
96)
Vykintas
(989-993), Duca di Samogizia, figlio di Montvilas
97)
Erdvilas
(993-1046), Duca di Navahradak, fratello di Vykintas
98)
Živinbudas
(1046-1058), Duca di Samogizia, figlio di Vykintas
99)
Mingaila
(1058-1067), Duca di Navahradak e Polack, figlio di
Erdvilas
100)
Daujotas
(1067-1079), Duca di Lituania, discendente di Kunos
101)
Vilikaila
(1079-1090), Duca di Lituania, fratello di Daujotas
102)
Skirmantas
(1090-1121), Duca di Navahradak, figlio di Mingaila
103)
Ginvilas
(1121-1146), Duca di Polack, fratello di Skirmantas
104) Kukovaitis
(1146-1149), Duca della Samogizia, figlio di Živinbudas
105)
Liubartas
(1149-1162), Granduca di Karačev, figlio di Skirmantas
106)
Traidenis I
(1162-1175), Granduca di Navahradak, fratello di Liubartas
107)
Pisimantas
(1175-1190), Duca di Turaŭ, fratello di Liubartas e di
Traidenis
108)
Rogvolodas
(1190-1194), Duca di Polack, figlio di Ginvilas
109)
Gleb
(1194-1198), Duca di Polack, figlio di Rogvolodas
110)
Algimantas
(1198-1217), Duca di Navahradak, figlio di Liubartas
111)
Ringaudas
(1217-1236), Duca di Navahradak, figlio di Algimantas
Dinastia di Mindaugas
112)
Mindaugas (1236-1263), figlio
di Ringaudas, assassinato da Treniota e Daumantas
113)
Treniota (1263-1264), figlio
di Vykintas, Duca di Samogizia, e di una sorella di Mindaugas, assassinato dai
sicari di Vaišvilkas
114)
Vaišvilkas (1264-1267), figlio
di Mindaugas e di Morta, non sposato e senza figli, fu assassinato da Leone I di
Galizia
115)
Shvarn (1267-1269), figlio
di Daniele di Galizia, morì a soli 39 anni
116)
Traidenis II (1270-1282),
usurpatore
117)
Daumantas (1282-1285),
usurpatore, morì in battaglia presso Tver
Dinastia di Gediminas
118)
Butigeidis (1285-1291), figlio
di Skalmantas
119)
Butvydas (1291-1295), figlio di
Skalmantas
120)
Vytenis (1295-1316), figlio
di Butvydas
121)
Gediminas (1316-1341), figlio
di Butvydas, ebbe ben 13 figli e diede il nome alla sua dinastia
122)
Jaunutis (1341-1345), figlio
di Gediminas e di Jaunė
123)
Algirdas (1345-1377), figlio
di Gediminas e di Jaunė, morì alla bella età di 81 anni
124)
Jogaila Algirdaitis (maggio
1377-agosto 1381, 1° regno), figlio di Algirdas e di Uliana di Tver, si convertì
al cattoliesimo e fu battezzato con il nome di Ladislao. Fu anche Re di Polonia
dal 1386 al 1434 con il nome di Ladislao V (vedi sopra),
prima con la moglie Edvige e poi da solo. Fu deposto dal co-reggente pagano
Kęstutis
125)
Kęstutis (1345-1382), già
co-reggente con Algirdas e con Jogaila Algirdaitis, depose quest'ultimo,
contrario alla conversione della Lituania al cattolicesimo, ma fu imprigionato e
fatto uccidere da Jogaila
124)
Jogaila Algirdaitis (3 agosto
1382-1° giugno 1434, 2° regno), riconquistò il trono di Lituania e fu artefice
della conversione del suo popolo al cattolicesimo. Con l'Atto di Kreva (1385),
Polonia e Lituania furono de jure governate da un unico monarca, ma restarono
stati separati
126)
Skirgaila (1386-1392), fratello
di Jogaila Algirdaitis, fu reggente di Lituania per conto del fratello. Nel
1392, l'Accordo di Astrava pose fine alla guerra civile lituana, e Skirgaila
viene sostituito da Vytautas. Skirgaila morì a Kyiv nel gennaio 1397,
probabilmente avvelenato
127)
Vytautas il Grande (4 agosto
1392-27 ottobre 1430), figlio di Kęstutis e di Birutė. Vytautas e i suoi
successori regnarono de jure come reggenti del re di Polonia fino al 1440.
128)
Švitrigaila (27 ottobre 1430-1°
agosto 1432), figlio di Algirdas e di Uliana di Tver, reggente di Lituania, si
ribellò e fu deposto
129)
Žygimantas I Kęstutaitis
(Sigismondo, 1° agosto 1432-20 marzo 1440), figlio di Kęstutis e di Birutė,
reggente di Lituania, fu assassinato dai sostenitori di Švitrigaila
Dinastia
degli Jagelloni
130)
Kazimieras I Jogailaitis
(Casimiro, 29 giugno 1440-7 giugno 1492), figlio di Jogaila Algirdaitis e
di Sofia di Halshany, fu Re di Polonia e di Boemia come Casimiro IV
131)
Aleksandras Jogailaitis
(Alessandro, 30 luglio 1492-19 agosto 1506), figlio di Kazimieras I
Jogailaitis e di Elisabetta d'Austria, fu Re di Polonia e di Boemia
132)
Žygimantas II Senasis
(Sigismondo II il Vecchio, 8 dicembre 1506-1 aprile 1548), figlio di Kazimieras
Jogailaitis e di Elisabetta d'Austria, fu Re di Polonia e di Boemia come
Sigismondo I
133)
Žygimantas III Augustas
(Sigismondo II Augusto, 18 ottobre 1529-7 luglio 1572), figlio di Žygimantas il
Vecchio e di Bona Sforza, fu Re di Polonia e di Boemia come Sigismondo II
Augusto, Con l'Unione di Lublino, firmata nel 1569, Polonia e Lituania vennero
unite in un unico stato, la Confederazione Polacco-Lituana. Da qui in poi i sovrani di Polonia e
Boemia furono anche Granduchi e poi Re di
Lituania, con l'unione delle tre corone sino ad oggi, fino ad arrivare a
159) Giovanni IV
d'Orléans
(21 gennaio 2019-in carica), Re di Polonia, Lituania e Boemia (vedi
sopra)
160) Luigi (II) (erede
al trono), figlio di Giovanni IV
.
VIIa – Sovrani di Valacchia

Bandiera del Principato di Valacchia
Principi di Valacchia
118) Radu Negru (1280-1310 Basarabidi, approfittò
dell'estinzione della dinastia Arpad per rendersi indipendente dagli Ungheresi (vedi
sopra)
119)
Basarab I (1310-1352, Casa dei Basarabidi)
120)
Nicolae I Alexandru (1352-1364, Basarabidi)
121)
Vladislav I (1364-1377, Basarabidi)
122)
Radu I (1377-1383, Basarabidi)
123)
Dan I (1383-1386, Casa dei Basarabidi-Dăneștii)
124)
Mircea I cel Bătrân (Mircea il Vecchio, 23 settembre 1386-Ottobre-1394, Casa
dei Basarabidi-Drăculeștii)
125)
Vlad I Uzurpatorul (Vlad I l'Usurpatore, ottobre 1394-gennaio 1397)
126)
Mircea II cel Bătrân (Mircea il Vecchio) Gennaio (1397-31 gennaio 1418,
Basarabidi-Drăculeștii
127)
Mihail I (1418 Agosto 1420, Drăculeștii)
128)
Dan II (1420-1421, Dăneștii, 1° regno)
129)
Radu II Chelul (Radu II il Calvo, 1421, Drăculeștii, 1° regno)
128)
Dan II (1421-1423, Dăneștii, 2° regno)
129)
Radu II Chelul (Radu il Calvo, 1423, Drăculeștii, 2° regno)
128)
Dan II (1423-1424, Dăneștii, 3° regno)
129)
Radu II
Chelul (Radu il Calvo, 1424-1426, Drăculeștii, 3° regno)
128)
Dan II (1426-1427, Dăneștii, 4° regno)
129)
Radu II Chelul (Radu il Calvo, 1427, Drăculeștii, 4° regno)
128)
Dan II (1427-1431, Dăneștii, 5° regno)
130)
Alexandru I Aldea (1431-1436, Drăculești)
131)
Vlad II Dracul (1436-1442, Drăculești, 1° regno)
132)
Mircea III (1442-1447, Drăculești)
133)
Basarab II (1442-1443, Dăneștii)
131)
Vlad II Dracul (1443 2 dicembre 1447, Drăculești, 2° regno)
134)
Vladislav II (1447-1448, Dăneștii, 1° regno)
135)
Vlad III Țepeș (Vlad l'Impalatore, 1448, Drăculești, 1°
regno), la sua proverbiale crudeltà diede vita alla leggenda del vampiro Dracula
134)
Vladislav II (1448-1456 c. 20 agosto 1456 Dăneștii, 2° regno)
135)
Vlad III Țepeș (Vlad l'Impalatore, 1456-1462, Drăculești, 2° regno)
136) Radu III cel Frumos (Radu il Bello, 1462-1473, Drăculești, 1° regno),
figlio di Vlad II Dracul
137) Basarab III Laiotă cel Bătrân (Basarab Laiotă il Vecchio, 1473,
Dănești, 1° regno), figlio di Dan II, appoggiato da Ștefan III cel Mare di
Moldavia
136) Radu III cel Frumos (1473-1474, Drăculești, 2° regno)
137) Basarab III Laiotă cel Bătrân (1474, Dănești, 2° regno)
136) Radu III cel Frumos (1474, Drăculești, 3° regno)
137) Basarab III Laiotă cel Bătrân (1474, Dănești, 3° regno)
136) Radu III cel Frumos (1474-1475, Drăculești, 4° regno)
137) Basarab III Laiotă cel Bătrân (1475-1476, Dănești, 4° regno)
135) Vlad III Țepeș (1476, Drăculești, 3° regno)
137) Basarab III Laiotă cel Bătrân (1476-1477, Dănești, 5° regno)
138) Basarab IV Țepeluș cel Tânăr
(Basarab Țepeluș il Giovane, 1477-1481, Dănești, 1° regno), figlio di
Bassarab II
139) Mircea IV (1481, Drăculești, figlio di Vlad III Țepeș)
140) Vlad IV Călugărul
(Vlad IV il Monaco, 1481 Drăculești,
1° regno), figlio di Vlad II Dracul, appoggiato da Ștefan III cel Mare di
Moldavia
138) Basarab IV Țepeluș cel Tânăr (1481-1482, Dănești, 2° regno)
140) Vlad IV Călugărul (Vlad IV il Monaco, 1482-1495, Drăculești, 2° regno)
141) Radu IV cel Mare (Radu IV il Grande, 1495-1508, Drăculești), figlio di Vlad
Călugărul
142) Mihnea cel Rău (Mihnea I il Cattivo, 1508-1509, Drăculești), figlio di Vlad III
Țepeș
143) Mircea V (1509-1510, Drăculești) figlio di Mihnea cel Rău
144) Vlad V cel Tânăr (Vlad V il Giovane, 1510-1512, Drăculești),
discendente di Radu cel Mare
145) Basarab V Neagoe (1512-1521, Craiovești)
146) Teodosio (1521, Craiovești, 1° regno)
140) Vlad IV Călugărul (Vlad IV il Monaco, 1521, Drăculești, 3° regno)
146) Teodosio (1521-1522, Craiovești, 2° regno)
147) Radu V de la Afumați (1522-1523, Drăculești, 1° regno),
figlio illegittimo di Radu cel Mare, alleato dei Craiovești
148) Vladislav III (1523, Dănești, 1° regno), figlio di Vladislav II
149) Radu VI Bădica (1523-1524, Drăculești)
147) Radu V de la Afumati (1524, Drăculești, 2° regno)
148) Vladislav III (1524, Dănești, 2° regno)
147) Radu V de la Afumati (1524-1525, Drăculești, 3° regno)
148) Vladislav III (1525, Dănești, 3° regno)
147) Radu V de la Afumati (1525-1529, Drăculești, 4° regno)
150) Basarab VI (1529, Craiovești), presunto figlio di Basarab V Neagoe
151) Mosè (1529-1530, Dănești)
152) Vlad VI Înecatul (Vlad VII l'Annegato, 1530-1532, Drăculești), figlio di Vlad
V cel
Tânăr
153) Vlad VII Vintilă de la Slatina (1532-1535,
Drăculești), figlio di Radu IV cel Mare
154) Radu VII Paisie (1535-1545, Drăculești), figlio di Vlad VIII Vintilă de
la Slatina
155) Mircea VI Ciobanul (Mircea V il Pastore, 1545-1552, Drăculești, 1°
regno), figlio di Radu cel Mare
156) Radu VIII Ilias Haidăul (Radu VIII Ilias il Ribelle, 1552-1553, Drăculești), figlio
di Radu V de la Afumați
155) Mircea VI Ciobanul (1553-1554, Drăculești, 2° regno)
157) Pătrașcu cel Bun (Pătrașcu il Buono, 1554-1558,
Drăculești, 1° regno), figlio di Radu VII Paisie)
155) Mircea VI Ciobanul (1558-1559, Drăculești, 3° regno)
158) Petru I cel Tânăr (Petru il Giovane, 1559-1568 Drăculești figlio di Mircea
Ciobanul
159) Alexandru II Mircea (1568-1574, Drăculești, 1° regno), figlio di
Mircea III
160) Vintilă (1574, Drăculești), figlio di Petru Pătrașcu cel Bun
159) Alexandru II Mircea (1574-1577, Drăculești, 2° regno)
161) Mihnea II Turcitul (Mihnea il Tornato-Turco, 1577-1583, Drăculești,
1° regno), figlio di Alexandru II Mircea
162) Petru II Cercel (Petru l'Orecchino, 1583-1585, Drăculești), figlio di Petru
Pătrașcu cel Bun
161) Mihnea II Turcitul (1585-1591, Drăculești, 2° regno)
163) Ștefan I Surdul (Ștefan il Sordo, 1591-1592)
164) Alexandru III cel Rău (Alexandru III il Cattivo, 1592-1593), fu anche
principe di Moldavia
165) Mihai Viteazul (Michele il Coraggioso, 1593-1600, Drăculești), figlio
illegittimo di Petru Pătrașcu cel Bun, fu anche principe di Transilvania e principe di Moldavia,
e così fu il primo unificatore dei Principati danubiani
166) Simion Movilă (1600-1601, Movilești, 1° regno)
167) Radu IX Mihnea (1601-1602, Drăculești, 1° regno), figlio di
Minhea II Turcitul
166) Simion Movilă (1602, Movilești, 2° regno)
168) Radu X Șerban (1602-1610, Craiovești, 1° regno)
169) Gabriel I Báthory (1611, Báthory)
167) Radu IX Mihnea (1611, Drăculești, 2° regno)
168) Radu X Șerban (1611 Craiovești 2° regno
167) Radu IX Mihnea (1611-1616, Drăculești, 3° regno)
169) Gabriel II Movilă (1616, Movilești, 1° regno), figlio di Simion
Movilă
170) Alexandru IV Iliaș (1616-1618, 1° regno)
169) Gabriel II Movilă (1618-1620, Movilești, 2° regno)
167) Radu IX Mihnea (1620-1623, Drăculești, 4° regno)
171) Alexandru V Coconul
(Alexander il Principe-Bambino, 1623-1627, Drăculești), figlio di Radu IX Mihnea
170) Alexandru IV Iliaș (1627-1629, 2° regno)
172) Leon Tomșa (1629-1632)
173) Radu X Iliaș (1632)
174 Matei Basarab (1632-1654, Craiovești-Brâncovenești)
175) Constantin I Șerban (1654-1658, Craiovești), figlio illegittimo di Radu
X Șerban
176) Mihnea III (1658-1659, Drăculești), figlio di Radu IX Mihnea
177) Gheorghe I Ghica (1659-1660)
178) Grigore I Ghica (1660-1664, 1° regno)
179) Radu XI Leon (1664-1669)
180) Antonie Vodă din Popești (1669-1672)
178) Grigore I Ghica (1672-1673, 2° regno)
181) Gheorghe II Duca (1673-1678)
182) Șerban Cantacuzino (1678-1688) nipote di
Radu X Șerban
183) Constantin II Brâncoveanu (1688-1714)
184) Ștefan Cantacuzino (1714-1715, Cantacuzini)
185) Nicolae II Mavrocordat (1715-1716, Mavrocordat, 1° regno)
186) Giovanni Mavrocordat (1716-1719, Mavrocordat
185) Nicolae II Mavrocordat (1719-1730, 2° regno)
187) Constantin III Mavrocordat (1730, 1° regno)
188) Mihail Racoviță (1730-1731, 1° regno)
187) Constantin III Mavrocordat (1731-1733, 2° regno)
189) Grigore II Ghica (1733-1735, 1° regno)
187) Constantin III Mavrocordat (1735-1741, 3° regno)
188) Mihail Racoviță (1741-1744, Racoviță, 2° regno)
187) Constantin III Mavrocordat (1744-1748, 4° regno)
189) Grigore II Ghica (1748-1752, 2° regno)
190) Matei Ghica (1752-1753)
191) Constantin IV Racoviță (1753-1756, 1° regno)
187) Constantin III Mavrocordat (1756-1758, 5° regno
192) Scarlat I Ghica (1758-1761, 1° regno)
187) Constantin III Mavrocordat (1761-1763, 6° regno
191) Constantin IV Racoviță (1763-1764, 2° regno)
193) Ștefan Racoviță (1764-1765)
192) Scarlat I Ghica (1765-1766, 2° regno)
194) Alexandru VI Ghica (1766-1768)
195) Grigore III Ghica (1768-1769)
196) Emanuel Giani Ruset (1770-1771)
197) Alexandru VII Ypsilanti (1774-1782, 1° regno)
198) Nicolae III Caragea (1782-1783)
199) Mihail Suțu (1783-1786, 1° regno)
200) Nicolae IV Mavrogheni (1786-1789)
199) Mihail Suțu (1791-1793, 2° regno)
201) Alexandru VIII Moruzi (1793-1796, 1° regno)
197) Alexander VII Ypsilanti (1796-1797, 2° regno)
202) Constantin V Hangherli (1797-1799)
201) Alexandru VIII Moruzi (1799-1801, 2° regno)
199) Mihail Suțu (1801-1802, 3° regno)
202) Alexandru IX Suțu (1802)
203) Constantin IX Ypsilanti (1802-1806)
Occupazione russa (1806-1812)
204) Ioan Gheorghe Caragea (1812 -1818)
205)
Grigore IV Brâncoveanu (1818)
206) Alexandru Suțu (1818-1821)
207)
Grigore V Brâncoveanu (1821)
208) Tudor Vladimirescu (1821, capo della Rivolta valacca)
209) Scarlat II
Callimachi (1821)
210) Grigore IV
Ghica (1822-1828)
Occupazione russa (1828-1834)
211) Alexandru X (1834-1842, Ghica)
212) Gheorghe V (1842-1848, Bibescu)
Re
di Valacchia
213) Barbu I Știrbei (1848-1853, 1° regno)
Occupazione russa (1853-1854)
213) Barbu I Știrbei (1854-1856, 2° regno)
214) Alexandru XI Ghica (1856-1858)
215) Alexandru XII Ioan Cuza (1859-1862), fu anche Re di Moldavia in unione personale
216)
Barbu II Dimitrie Știrbei (1862–1869), figlio di Barbu I Știrbei, fu
anche Re di Moldavia in unione personale
Re
di Romania
217)
Alexandru XIII Barbu Știrbei (1869–1895), figlio di Barbu II Dimitrie Știrbei e di
Elisabeta Cantacuzino, primo Re di Romania, nata dalla fusione di Valacchia e
Moldavia
218)
Barbu III Alexandru Știrbey (1895–1914, 1° regno), nato il 4 novembre 1872, figlio di Alexandru
XIII Barbu Știrbei e di
Maria Ghica-Comănești
Occupazione austriaca (1914-1918)
218)
Barbu III Alexandru Știrbey (1918–1941, 2° regno), rimesso sul trono dopo la
sconfitta dell'Austria-Ungheria nella Prima Guerra Mondiale
Occupazione nazista (1941-1945)
218) Barbu III Alexandru Știrbey (1945–1946, 2° regno), rimesso sul trono dopo la
sconfitta nazista nella Seconda Guerra Mondiale
219)
Marina Știrbei (1946–2001), figlia di George Știrbei, fratello di Barbu
Alexandru, nata il 19 marzo 1912, aviatrice ed eroina di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale
220)
Constantin X Emanuel Brâncoveanu (2001-in carica), figlio di Marina Știrbei e di
Constantin Basarab Brâncoveanu, nato il 28 gennaio 1943
.
VIIb – Sovrani di Moldavia

Bandiera del Principato di Moldavia
Principi
di Moldavia
123) Dragoș (1352-1353), ottenne l'autonomia da Luigi I
d'Ungheria, pur restando nominalmente suo vassallo (vedi
sopra)
124)
Sas (1354-1358), figlio di Dragoș
125)
Bâlc (1359), figlio di Sas
126)
Bogdan I (1359-1365), depose Bâlc; con lui la Moldavia ottenne la piena
indipendenza dall'Ungheria
127)
Lațcu (1365-1373), figlio di Bogdan I
128) Costea Mușat (1373-1374,
Casa di Mușatini), fratellastro di Lațcu, da lui prese il nome la
dinastia dei Mușatini
129)
Iuga Koriatovici (1374-1377, 1°
regno)
130)
Petru I (1375-1391, Mușatini), figlio di Costea Mușat, dal 1387 vassallo del Regno
di Polonia
131)
Roman I (1391-1394, Mușatini), figlio di Costea Mușat
132)
Ștefan I (1394-1399, Mușatini), figlio di Costea Mușat
129)
Iuga Koriatovici (1399-1400, 2° regno), deposto per intervento di Mircea
cel Bătrân di
Valacchia
133)
Alexandru I cel Bun
(Alessandro il Buono, 1400-1432, Mușatini), figlio di Roman I, , messo sul trono da
Mircea cel Bătrân di Valacchia
134) Iliaș I (1432-1433,
Mușatini, 1° regno), figlio di Alexandru cel Bun
135) Ștefan II (1434-1435,
Mușatini, 1° regno), figlio di Alexandru cel Bun
134)
Iliaș I (1435-1443, Mușatini, 2° regno), congiuntamente a Ștefan II
135)
Ștefan II (1436-1447, Mușatini, 2° regno), fino
al 1443 congiuntamente a Iliaș, nel
1444-1445 congiuntamente con Petru II
136) Petru II (1444-1445,
Mușatini, 1° regno), figlio di Alexandru cel Bun
137)
Roman II (1447-1448, Mușatini), figlio di Iliaș
136)
Petru II (1448-1449, Mușatini, 2° regno)
138) Ciubăr Vodă (1449)
139)
Alexăndrel (1449-1423, 1° regno)
140)
Bogdan II (1449-1451, Mușatini), nipote di Alexandru cel Bun
141)
Petru III Aron (1451-1452, Mușatini,
1° regno), figlio illegittimo di Alexandru cel Bun
139)
Alexăndrel (1452-1454, 2° regno)
141)
Petru III Aron (1454-1455, Mușatini, 2° regno)
139)
Alexăndrel (1455, 3° regno)
141)
Petru III Aron (1455-1457, Mușatini 3° regno),
vassallo dell'Impero Ottomano
142)
Ștefan III cel Mare (Stefano il Grande, 1457-1504, Mușatini), figlio di Bogdan II
143) Bogdan III cel Orb (Bogdan
III il Cieco, 1504-1517, Mușatini), figlio di Ștefan cel Mare
144)
Ștefan IV cel Tinar (1517-1527, Mușatini, figlio di Bogdan III),
fino al 1523 sotto la reggenza di Luca Arbore
145)
Petru IV Rareș (1527-1538, Mușatini,
1° regno), figlio illegittimo di Ștefan cel Mare
146)
Ștefan V Lăcustă (1538-1540, Mușatini, nipote di Ștefan cel Mare)
147)
Alexandru II Cornea (1540-1541, Mușatini), nipote di Petru Aron
145)
Petru IV Rareș (1541-1546, Mușatini, 2° regno)
146)
Iliaș II Rareș (1546-1551, Mușatini), figlio di Petru Rareș
147)
Ștefan VI Rareș (1551-1552, Mușatini), figlio di Petru Rareș
148)
Ioan I Joldea (1552)
149)
Alexandru III Lăpușneanu (1552-1561, 1° regno)
150)
Ioan II Iacob Heraclid (1561-1563), chiamato
anche Despot Vodă
151)
Ștefan VII Tomșa (1563-1564)
149)
Alexandru III Lăpușneanu (1564-1568, 2° regno)
152)
Bogdan IV (1568-1572)
153)
Ioan III cel Cumplit (Giovanni
III il Terribile, 1572-1574)
154)
Petru V Șchiopul (Pietro il Paralitico, 1574-1577, 1° regno)
155)
Ioan IV Potcoavă (1577, Hetman)
154)
Petru V Șchiopul (1578-1579, 2° regno)
156)
Iancu Sasul (Giovanni il Sassone, 1579-1582, Mușatini), figlio illegittimo di
Petru Rareș
154)
Petru V Șchiopul (1582-1591, 3° regno)
155)
Aron Tiranul (Aron il Tiranno, 1591-1592, 1° regno)
156)
Alexandru IV cel Rău (Alessandro l'Immorale, 1592), governò anche la Valacchia
dal 1592 al 1593
157)
Petru VI Cazacul (Pietro il Cosacco, 1592, Mușatini), figlio illegittimo di Bogdan III
155)
Aron Tiranul (Aron il Tiranno, 1592-1595, 2° regno)
158)
Ștefan VI Răzvan (1595)
159)
Ieremia Movilă (1595-1600, Movilești, 1° regno), nipote di Petru Rareș
160)
Mihail I Viteazul (Michele il Coraggioso,
1600, Drăculești), figlio illegittimo di Petru Pătrașcu cel Bun, fu anche
principe di Transilvania e principe di Valacchia, e così fu il primo unificatore
dei Principati danubiani
159)
Ieremia Movilă (1600-1606, Movilești, 2° regno)
160)
Simion Movilă (1606-1607, Movilești), fratello di Iremia Movilă
161) Mihail II Movilă (1607,
Movilești, 1° regno), figlio di Ieremia Movilă
162) Constantin I Movilă (1607,
Movilești, 1° regno), figlio di Ieremia Movilă, sotto la reggenza di sua madre
Elzbieta Csomortany de Losoncz
161)
Mihail II Movilă (1607, Movilești, 2° regno)
162)
Constantin I Movilă (1607-1611, Movilești, 2° regno),
sempre sotto la reggenza della
madre
151)
Ștefan VII Tomșa (1611-1615, 2° regno)
162)
Constantin I Movilă (1615-1616, Movilești, 3° regno)
163)
Radu Mihnea (1616-1619, 1°
regno), Drăculești
164)
Gașpar Graziani (1619-1620)
165)
Alexandru V Iliaș (1620-1621, 1° regno)
151)
Ștefan VII Tomșa (1621-1623,
3° regno)
163)
Radu Mihnea (1623-1626, Drăculești, 2° regno)
166)
Miron Barnovschi-Movilă (1626-1629, Movilești, 1° regno)
167)
Alexandru VI Coconul (Alessandro il Principe
Fanciullo, 1626-1629, Drăculești, 1°
regno)
168)
Mosè Movilă (1630-1631 Movilești, 1° regno)
165)
Alexandru V Iliaș (1631-1633, 2° regno)
164)
Miron Barnovschi-Movilă (1633, Movilești, 2° regno)
168)
Mosè Movilă (1633-1634, Movilești, 2° regno)
169)
Vasile Lupu (1634-1653, 1° regno)
170)
Gheorghe I Ștefan (1653, 1° regno)
169)
Vasile Lupu (1653, 2° regno)
170)
Gheorghe I Ștefan (1653-1658, 2° regno)
171)
Gheorghe II Ghica (1658-1659)
172)
Constantin II Șerban (1659, 1° regno)
173)
Ștefăniță Lupu (1659-1661, 1° regno)
172)
Constantin II Șerban (1661, 2° regno)
173)
Ștefăniță Lupu (1659-1661, 2° regno)
174)
Eustratie Dabija (1661-1665)
175)
Gheorghe III Duca (1665-1666, 1° regno)
176)
Iliaș III Alexandru (1666-1668)
175)
Gheorghe III Duca (1668-1672, 2° regno)
177)
Ștefan VIII Petriceicu (1672-1673, 1° regno)
178)
Dumitrașcu Cantacuzino (1673, 1° regno
177)
Ștefan VIII Petriceicu (1673-1674, 2° regno)
178)
Dumitrașcu Cantacuzino (1674-1675, 2° regno)
179) Antonie Ruset (1675-1678)
175)
Gheorghe III Duca (1678-1683, 3° regno)
177)
Ștefan VIII Petriceicu (1683-1684, 3° regno)
178)
Dumitrașcu Cantacuzino (1684-1685, 3° regno)
180)
Constantin III Cantemir
(1685-1693)
181)
Dimitrie Cantemir (1693, 1° regno), deposto dagli
Ottomani
182)
Constantin IV Duca (1693-1695, 1° regno)
183)
Antioh Cantemir (1695-1700, 1° regno)
182)
Constantin IV Duca (1700-1703, 2° regno)
184)
Ioan V Buhuș (1703, 1° regno)
185)
Mihail III Racoviță (1703-1705, 1° regno)
183)
Antioh Cantemir (1705-1707, 2° regno)
185)
Mihail III Racoviță (1707-1709, 2° regno)
184)
Ioan V Buhuș (1709-1710, 2°
regno)
186)
Nicolae I Mavrocordat (1709-1710, 1° regno)
181)
Dimitrie Cantemir (1710-1711, 2° regno)
187)
Lupu Costachi (1711)
188) Ioan
VI Mavrocordat (1711)
186)
Nicolae I Mavrocordat (1711-1715, 2° regno)
185)
Mihail III Racoviță (1715-1726, 3° regno)
189)
Grigore I Ghica (1726-1733, 1° regno)
190)
Constantin V Mavrocordat (1733-1735, 1° regno)
189)
Grigore I Ghica (1735-1741, 2° regno)
190)
Constantin V Mavrocordat (1741-1743, 2° regno)
188) Giovanni Mavrocordat (1743-1747, 2° regno)
189)
Grigore I Ghica (1747-1748, 4° regno)
190)
Constantin V Mavrocordat (1748-1749, 3° regno)
191)
Iordache Stavrachi (1749)
192)
Constantin VI Racoviță (1749-1753, 1° regno)
193) Matei Ghica (1753-1756)
192)
Constantin VI Racoviță (1756-1757, 2° regno)
194) Scarlat I Ghica (1757-1758)
195) Giovanni Teodoro Callimachi (1758-1761)
196)
Grigore II Callimachi (1761-1764, 1° regno
197)
Grigore III Ghica (1764-1767, 1° regno)
196)
Grigore II Callimachi (1767-1769, 2° regno)
198)
Constantin VII Mavrocordat (1769, 4° regno
Occupazione russa (1769-1774)
197)
Grigore III Ghica (1774-1777, 2° regno)
199)
Constantin VIII Moruzi
(1777-1782)
200) Alexandru VI Mavrocordat Delibey (1782-1785)
201) Alexandru VII Mavrocordat Firaris (1785-1786)
202)
Alexandru VIII Ypsilanti
(1786-1788)
203) Emanuel Giani Ruset
(1788-1789)
204)
Alexandru IX Moruzi (1792, 1° regno)
205) Mihail IV Suțu (1793-1795)
206) Alexandru X Callimachi (1795-1799)
207) Alexandru XI Suțu (1801-1802)
208)
Iordache I Conta (1802)
204)
Alexandru IX Moruzi (1802, 2° regno)
209)
Scarlat II Callimachi (1806, 1° regno)
204)
Alexandru IX Moruzi (1806-1807, 3° regno)
210)
Alexandru XII Hangerli (1807)
209)
Scarlat II Callimachi (1807, 2°
regno), deposto dai russi
210) Iordache II Ruset-Roznovanu
(1807)
211) Veniamin Costache
(1807-1812, 1° regno)
209) Scarlat II Callimachi (1812-1819,
3° regno
212) Mihail V Suțu (1819-1821)
213)
Manu e Rizos-Nerulos (1819)
211)
Veniamin
Costache (1821, 2° regno)
214)
Ștefan IX Vogoride
(1821-1822)
215)
Ioan VII Sturdza (1822-1828
Occupazione russa (1828-1834)
216)
Mihail VI Sturdza (1834-1849
Re
di Moldavia
217)
Grigore IV Alexandru Ghica (1849-1853, 1° regno)
Occupazione russa (1853-1854)
217)
Grigore Alexandru Ghica (1854-1856, 2° regno)
218)
Teodor Balș (1856-1857)
219)
Nicolae II Vogoride (1857-1858)
220-223) Ștefan X Catargiu,
Vasile Sturdza e
Anastasie Panu (1858-1859);
Catargiu si dimise nel 1858 e fu sostituito da
Ioan VIII Cantacuzino
224)
Alexandru XIII Ioan Cuza (1859-1862, sovrano di Valacchia in unione personale
Re
di Romania
225)
Alexandru XIV Barbu Știrbei (1869–1895), figlio di Barbu II Dimitrie Știrbei e di
Elisabeta Cantacuzino, primo Re di Romania, nata dalla fusione di Valacchia e
Moldavia
226)
Barbu I Alexandru Știrbey (1895–1914, 1° regno), nato il 4 novembre 1872, figlio di Alexandru
XIV Barbu Știrbei e di
Maria Ghica-Comănești
Occupazione austriaca (1914-1918)
227)
Barbu II Alexandru Știrbey (1918–1941, 2° regno), rimesso sul trono dopo la
sconfitta dell'Austria-Ungheria nella Prima Guerra Mondiale
Occupazione nazista (1941-1945)
228) Barbu II Alexandru Știrbey (1945–1946, 2° regno), rimesso sul trono dopo la
sconfitta nazista nella Seconda Guerra Mondiale
229)
Marina Știrbei (1946–2001), figlia di George Știrbei, fratello di Barbu
II Alexandru, nata il 19 marzo 1912, aviatrice ed eroina di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale
230)
Constantin X Emanuel Brâncoveanu (2001-in carica), figlio di Marina Știrbei e di
Constantin Basarab Brâncoveanu, nato il 28 gennaio 1943
.
VIII – Sovrani di Serbia

Bandiera attuale del Regno di Serbia
Dinastia
dei Dervan (semileggendaria)
72) Dobręta o
Davritas (552-583), capo degli
Sclaveni, primo capo degli Slavi meridionali di cui si abbia notizia, secondo lo
storico bizantino Menandro Protettore, si ribellò al morente impero unno (vedi
sopra) e guidò il suo popolo al di là del Danubio, nel'attuale Serbia
73) Dervan I (583-610), Župan
(Principe) dei Serbi Bianchi o Sorabi, lontano parente di Dobręta, guidò la sua gente dalla pianura
sarmatica fino alla Lusazia, l'area compresa fra i bacini dell'Elba e della
Saale, dove ancora oggi si trovano alcuni dei loro discendenti
74) Dervan II (610-641), figlio
di Dervan I, secondo il "De administrando imperio" scritto dall'imperatore
bizantino Constantino VII, migrò con la maggior parte dei Sorabi verso sud, e
gli fu concesso di insediarsi nei territori bizantini dopo aver aiutato
l'imperatore Eraclio I a respingere l'invasione degli Avari nel 629
75) Dervan III (641-688),
figlio di Dervan III, sul suo regno non si hanno informazioni
76) Dervan IV (688-737), nipote
di Dervan III, combattè a lungo contro gli Avari
77) Dervan V (737-776), sul suo
regno non si hanno informazioni
Primi Župan dei Serbi
78) Viseslao (776-807), Župan
di Neretva e delle regioni di Tara, Piva e Lim, unificò le tribù serbe formando
il primo stato serbo unitario
79) Radoslao (803-822), figlio
di Viseslao
80) Prosigoj (822-840), figlio
di Radoslao, regnò durante la rivolta di Ljudevit Posavski contro i Franchi
descritta negli "Annales Regni Francorum"
81) Vlastimiro (840-859),
figlio di Prosigoj. Eponimo della dinastia Vlastimirović, riuscì a respingere
gli attacchi bulgari. Ebbe tre figli (Mutimir, Strojimir e Gojnik) e una figlia
data in sposa a Krajina Belojević, a cui diede la Travunia
82) Mutimiro (859-891),
primogenito di Vlastimiro, respinse gli attacchi del Khan Boris I di Bulgaria ed
esiliò i suoi sue fratelli minori che si ribellarono contro di lui. Favorì la
cristianizzazione dei serbi e nel 871 fondò la Eparchia di Ras
83) Pribislavo (891-892),
primogenito di Mutimiro, governò brevemente perchè suo cugino Pietro Gojniković
tornò dall'esilio e lo sconfisse. Pribislavo fuggì con i fratelli Bran e Stefano
e il figlio Zaharije nel principato di Croazia
84) Pietro I Gojniković
(892-917), figlio di Gojnik, tornò dall'esilio e depose Pribislavo; conquistò la
Bosnia e gran parte della Zaclumia e annettè la Pagania. Nel 917 cadde in una
imboscata di Simeone I, fu catturato e portato in Bulgaria, dove morì l'anno
successivo
85) Paolo Branović (917-921),
figlio di Bran Mutimirović, fu sconfitto dopo aver attaccato Pietro I, ma quando
quest'ultimo fu deposto, salì al trono. Sconfisse Zaccaria, figlio di
Pribislavo, speditogli contro dai Bizantini. Inizialmente fu un vassallo di
Simeone I di Bulgaria, per passare poi dalla parte dei Bizantini. Nel 921
sconfisse di nuovo Zaccaria, stavolta speditogli contro dai Bulgari
86) Zaccaria Pribislavljević
(921-924), figlio di Pribislavo, una volta sconfitto Pavle, tradì Simeone I di
Bulgaria alleandosi coi Bizantini. Sconfisse una prima armata bulgara nel 923
spedendo due teste di generali a Costantinopoli come trofeo, ma nel 924 fu
sconfitto da una seconda armata, più numerosa e guidata da Časlav Klonimirović,
secondo cugino di Zaccaria, e fuggì in Croazia. Simeone, anziché consegnare i
territori serbi a Časlav, lo fece arrestare e li annettè direttamente alla
Bulgaria
87) Simeone (924-927), Khan del
Primo Impero bulgaro, fu anche Župan di Serbia per breve tempo
88) Časlav Klonimirović
(927-960), figlio di Klonimir, tornò e riuscì a organizzare una rivolta contro
il dominio bulgaro, unendo gli stati di Raška, Bosnia, Doclea, Zaclumia,
Travunia e Pagania in un'unica entità statale. Sconfisse gli Ungari, ma poi morì
in un attentato da loro organizzato e la Serbia fu occupata dai Bizantini

Bandiera di Časlav Klonimirović
Occupazione bizantina
89) Niceforo
(963-969), imperatore bizantino con il nome di Niceforo II Foca, si proclamò Re
di Serbia
90) Giovanni I (969-976),
imperatore bizantino con il nome di Giovanni I Zymiskes, fu anche Re di Serbia
91) Basilio I (976-1025),
imperatore bizantino con il nome di Basilio II il Bulgaroctono, fu anche Re di
Serbia
92) Costantino (1025-1028),
imperatore bizantino con il nome di Costantino VIII, fratello di Basilio, fu
anche Re di Serbia
Principi di Doclea
93) Stefano I Vojislav
(1028-1052), Principe di Doclea nell'attuale Montenegro, si rivoltò contro i
Bizantini e si proclamò Re di Serbia
94) Michele I Vojisavljević
(1052-1081), figlio di Stefano Vojislav
Dinastia dei
Nemanjić
95) Vukan
(1081-1114), Principe di Raška, sconfisse il Principato di Doclea e si proclamò Re di Serbia
96) Uroš I (1114-1140), figlio
di Vukan
97) Uroš II (1140-1161), figlio
di Uroš I
98) Desa (1161-1165), figlio di
Uroš II, fu detronizzato da Tihomir Zavidović
99) Tihomir Zavidović
(1161-1165), figlio di Zavida Vukanović
100) Stefano II Nemanja
(1165-1199), fratello di Tihomir Zavidović
101) Stefano III Prvovenčani
(1199–1228), secondogenito di Stefano Nemanja
102) Stefano IV Radoslav
(1228–1234), figlio di Stefano Prvovenčani
103) Stefano V Vladislav
(1234–1243), figlio di Stefano Prvovenčani
104) Stefano Uroš I
(1243–1276), figlio di Stefano Prvovenčani
105) Stefano VI Dragutin
(1276–1282), figlio di Stefano Uroš I
106) Stefano Uroš II Milutin
(1282–1321), figlio di Stefano Uroš I
107) Stefano Uroš III Dečanski
(1321–1331), figlio di Stefano Uroš II Milutin
108) Stefano Uroš IV Dušan il Grande
(1331–1355), figlio di Stefano Uroš III Dečanski, conquistò la Bulgaria e
l'Impero Bizantino e si proclamò Zar dei Serbi, dei Romani e dei Bulgari. Fu il
più grande dei sovrani serbi
109) Stefano Uroš V
(1355–1371), figlio di Stefano Uroš IV Dušan, perse il controllo della Bulgaria,
ma conservò Costantinopoli
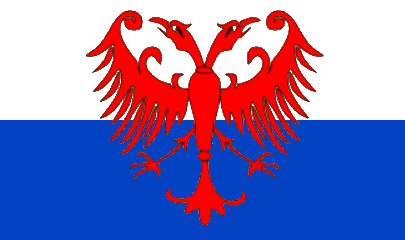
Bandiera di Stefano Uroš IV Dušan il Grande
Dinastia dei Lazarević
110) Lazzaro I
Hrebljanović il Santo (1371–1389), succedette a Stefano Uroš V che morì
senza figli. Quando gli Ottomani invasero i Balcani, formò una coalizione con il
Re di Bosnia Tvrtko I, con lo Zar bulgaro Ivan IX Sracimir e con la Republlica
di Venezia, e inflisse ai Turchi una storica sconfitta nella Battaglia di Kosovo
Polje ("la Piana dei Merli", 15 giugno 1389), ma cadde nello scontro. Fu
canonizzato dalla Chiesa Ortodossa
111) Stefano VII Lazarević il
Vittorioso (1389–1427), figlio di Lazzaro I Hrebeljanović, continuò la
guerra contro i Turchi e li espulse dall'Europa, riconquistando Costantinopoli,
ma morì senza figli maschi
Dinastia dei Branković
112) Giorgio I Branković
(1427–1456), figlio di Vuk Branković e di Mara, figlia di Lazzaro I
Hrebeljanović
113) Lazzaro II Branković
(1456–1458), figlio di Giorgio I Branković
114) Stefano VIII Branković il Cieco
(1458–1476), fratello di Lazzaro II Branković
115) Giorgio II Branković
(1476-1502), figlio di Stefano VIII Branković, abdicò e si fece monaco ortodosso
con il nome di Maxim; morì nel 1516
116) Giovanni II Branković
(1493-1502), fratello di Giorgio II Branković, da lui associato al trono e suo
successore
117) Giovanni III Berislavić
(1502-1514), di origini croate, secondo marito di Jelena Jakšić, vedova di Giovanni II Branković
118) Stefano IX Berislavić
(1514-1535), figlio di Giovanni III Berislavić e di Jelena Jakšić, fu ucciso in
battaglia dagli Ungheresi. La Bosnia, la Serbia e la Grecia furono annesse
all'Ungheria, mentre Macedonia e Costantinopoli vennero occupate dall'Impero
Bulgaro, cui appartengono ancor oggi
Imperatori d'Ungheria, di
Serbia e dei Romani della dinastia
Zápolya
131) Giovanni IV
Zápolya (1535-1540), Re d'Ungheria (vedi
sopra), alleato con i Bulgari sconfisse
e uccise Stefano IX Berislavić e si proclamò anche Zar dei Serbi
132) Giovanni
V Zápolya (1540-1560), figlio di Giovanni IV e di Isabella Jagellona, fu
fortemente impopolare tra i Serbi e i Greci perchè cattolico, e allira decise di
annettere la sola Bosnia e di fare della Serbia e della Grecia uno stato
vassallo, affidandolo a Makarije, Principe-Vescovo del Montenegro, che fu
investito anche dell'autorità politica
Era dei Principi-Vescovi di
Serbia e Montenegro (vassalli degli Ungheresi)
133) Macario
(1560-1561). Dal momento che la tradizione ortodossa prevedeva che i vescovi
mantenessero il celibato, il titolo di Principe si tramandò sempre di zio in
nipote
134) Ruvim I (1561-1569)
135) Pacomio Komanin
(1569-1579)
136) Gerasim (1575-1582)
137) Beniamino (1582-1591)
138) Nicanore (1591-1593)
139) Ruvim II Boljević-Njegos
(1593-1636)
140) Mardarije Kornečanin (1636
1649, 1° governo)
141) Visarion I (1649-1659)
140) Mardarije Kornečanin
(1659-1673, 2° governo)
142) Ruvim III Boljević
(1673-1685)
143) Basilio II Velikrasić
(1685)
144) Visarion II Bajica
(1685-1692)
145) Sava I Kaluđerović
(1692-1696)

Bandiera dei rincipi-Vescovi della dinastia dei Petrović-Njegoš
Principi-Vescovi della dinastia
dei Petrović-Njegoš (de facto indipendenti)
146) Danilo I Šćepčev
(luglio 1696-22 gennaio 1735), con lui Serbia e Montenegro erano teoricamente
ancora vassalli dell'Ungheia, ma nei fatti portavano avanti una politica del
tutto indipendente da Budapest
147) Sava II (22 gennaio 1735-9
marzo 1781)
148) Basilio III (1750-21 marzo
1766), coprincipe con Sava II
149) Arsenio Plamenac (9 marzo
1781-12 marzo 1782)
150) Pietro II (12 marzo 1782-23 aprile 1815)
Zar dei Serbi e dei Greci della
dinastia degli Obrenović
151) Miloš Obrenović il
Grande (23 aprile 1815-25 giugno 1839), sulla scia dei principi liberali
giunti nei Balcani dopo le imprese di Napoleone, depose l'ultimo
Principe-Vescovo, restaurò il governo civile e si proclamò Zar dei Serbi e dei
Greci. Concesse una Costituzione ed abdicò in favore dei suoi figli. Morì il 26
settembre 1860
152) Milan I Obrenović (25
giugno 1839-8 luglio 1839), figlio maggiore di Miloš; regnò solo per 13 giorni,
poiché morì a soli 19 anni di tubercolosi
153) Michele I Obrenović (8
luglio 1839-10 giugno 1868), fratello di Milan Obrenović, portò avanti una
decisa modernizzazione del paese
154) Milan II Obrenović (10
giugno 1868-11 febbraio 1901), pronipote di Miloš Obrenović, avviò una
politica coloniale nel Corno d'Africa
155) Alessandro Obrenović (11
febbraio 1901-11 giugno 1903), figlio di Milan II, fu assassinato con la moglie
Draga durante un colpo di stato di nobili serbi, i quali volevano scongiurare
che lo Zar nominasse suo erede Nikodije, l'impopolare fratello della moglie. Il
trono fu offerto a Nicola Petrović-Njegoš, discendente della dinastia
montenegrina dei Principi-Vescovi, ed egli accettò
Zar dei Serbi e dei Greci della
dinastia dei Petrović-Njegoš
156) Nicola I
Petrović-Njegoš (28 agosto 1910-1° marzo 1921), figlio di Mirko
Petrović-Njegoš e di Anastasija Martinović. Rimase neutrale nel
conflitto tra Prussia e Russia che provocò il collasso di quest'ultima. Ebbe dodici figli, tra cui il
successore Danilo ed Elena, moglie di Vittorio Emanuele III e Regina d'Italia
157) Danilo II Alessandro
Petrović-Njegoš (1° marzo 1921-24 settembre 1939), figlio di Nicola I e
di Milena Vukotić, rmase neutrale anche nel successivo conflitto tra
Francia e Prussia, e dovette affrontare gli opposti estremismi di destra e di
sinistra all'interno del suo regno
158) Michele II Petrović-Njegoš
(24 settembre 1939-24 marzo 1986), terzogenito del principe Mirko, a sua volta
nono figlio di Nicola I, e di Natalija Konstantinović, visse in un'epoca di
consolidamento della democrazia e di grande crescita economica. Nel 1957 la
Serbia fu uno dei paesi fondatori della CEE
159) Nicola II Petrović-Njegoš
(24 marzo 1986-7 luglio 2024), figlio di Michele II e di Maria Teresa di
Braganza, nato il 7 luglio 1944, abdicò al compimento dell'80° compleanno in
favoe del figlio. Nel 1999 la Serbia adottò l'euro
160) Michele III Petrović-Njegoš
(7 luglio 2024-in carica), figlio di Nicola II e di Anna, secondogenita della
regina Elisabetta II del Regno Unito, nato il 21 gennaio 1980. Il 12
maggio 2007 ha sposato la principessa Maddalena Bernadotte, terza figlia del Re
di Svezia Carlo Gustavo XVI. Da lei il 15 giugno 2015 ha avuto l'erede al trono
Nicola (III)

Personificazione della Serbia, immagine creata con Gemini
.
IX – Sovrani di Mongolia
Qaghan
dei Göktürk
72) Bumin (552), figlio Asjina Tuwu,
sconfisse gli Unni e fondò il Qaghanato dei
Göktürk o Turchi azzurri (vedi sopra)
73) Yabghu (552–575), fratello minore di
Bumin, sconfisse gli Eftaliti, fondò a sua volta il Qaghanato Göktürk
occidentale
74) Tardu (575–602), figlio di Yabghu
75) Heshana (604–611), figlio di Niri,
pronipote di Bumin
76) Sheguy (610–617), figlio di Tulu, figlio di
Tardu
77) Tong Yabghu (617–630,
figlio di Tughluq Yabghu, pronipote di Tardu
78) Baghatur (630), figlio di
Tughluq Yabghu, nipote di Tardu
79) Si Yabghu (630–632), figlio
di Tuluq Yabghu
80) Tughluq (632–634), figlio
di Baghatur
81) Ishbara Tolis (634–639),
figlio di Baghatur
82) Illig Beg Tughluq
(638–642), nipote di Tughluq Yabghu
83) Illig Qutlugh Illig Beg
(639–640), figlio di Ishbara Tolis Qaghan, in opposizione a Illig Beg Tughluq
84) Illig Beg Ishbara Yabghu
(639–641), figlio di Shad, in opposizione a Illig Beg Tughluq
85) Illig Beg Shekuei
(642–653), figlio di Illig Kul Bilge, nipote di Apa
86) Ishbara (650–658), figlio
di Böri Shad, nipote di Tughluq Yabghu
Qaghan Xingxiwang
87) Ashina Mishe (658–662),
governò sui Turchi come vassallo della Cina dei Tang ed ebbe, come i suoi
successori, il titolo di Xingxiwang, "Colui che fa risorgere i caduti"
88) Ashina Duzhī (Onoq, 662-679),
alleatosi con l'Impero Tibetano rovesciò Ashina Mishe
89) Ashina Yuanqing (679–692),
figlio di Ashina Mishe
90) Ashina Tuizi (692–694),
figlio di Ashina Yuanqing
Qaghan Türgesh
91) Üç Elig Qaghan (694–706),
si rese indipendente dai Cinesi e fondò il Qaghanato Türgesh nel Turkestan
orientale
92) Sakal Qaghan (706–711),
figlio di Üç Elig Qaghan
93) Suluk Qaghan (716–738),
generale di Üç Elig Qaghan
94) Kut Chor (738–739), figlio
di Suluk Qaghan
95) Kül Chor (739–744),
generale di Suluk Qaghan, fu sconfitto dai cinesi, catturato e giustiziato. Alla
sua morte il Qaghanato Türgesh piombò nella guerra civile e fu infine
conquistato dagli Uighuri

Bandiera del Qaghanato Göktürk
Qaghan del Secondo Qaghanato
Göktürk (orientale)
96) Ilterish Qaghan (682-694),
discendente di Illig Beg Shekuei, restaurò in parte il Qaghanato dei Turchi Azzurri
in opposizione agli Xingxiwang dei Tang e al Qaghanato Türgesh
97) Qapaghan Qaghan (694–716),
fratello minore di Ilterish Qaghan
98) Inel Qaghan (716), figlio di
Qapaghan Qaghan
99) Bilge Qaghan (716–734), figlio di
Ilterish Qaghan
100) Yiran Qaghan (734), figlio di
Bilge Qaghan
101) Tengri Qaghan (734–741), figlio di
Bilge Qaghan
102) Kutluk
Yabgu Qaghan (741–742), figlio di
Ilterish Qaghan
103) Ilterish Qaghan (742–744), capo
della tribù Basmyl
104) Ozmysh Qaghan (742–744), iglio di
Pan Kul Tigin
105) Báiméi Qaghan (744–745), figlio
di Pan Kul Tigin
Qaghan degli Uighuri
106) Kutlug Bilge I Köl
Qaghan
(745–747), figlio di Hushu, capo del clan Yaglakar, si rese indipendente dal
Qaghanato Göktürk in dissoluzione e conquistò il Qaghanato Türgesh
107) Bayan Çor Qaghan (747–759),
figlio di Kutlug Bilge I Köl Qaghan
108) Bögü Qaghan (759–779),
figlio di Bayan Çor
109) Tun Baga Tarkan (779–789),
generale di Bögü
110) Külüg Bilge Qaghan (789–790),
figlio minorenne di Tun Baga Tarkan
111) Kutluk Bilge II Qaghan
(790–795), figlio di Kutlug Bilge I Köl Qaghan
112) Alp Kutlug II (795–808),
Gran Visir di Kutluk Bilge II
113)
Baoyi Qaghan
(808–821), figlio di Kutluk Bilge II
114)
Chongde Qaghan (821–824), usurpatore
115) Zhaoli Qaghan
(824–832), figlio di Baoyi Qaghan
116) Zhangxin Qaghan (832–839), nipote di
Zhaoli Qaghan
117) Qasar Qaghan
(839-841), usurpatore
118) Öge Qaghan (841–846),
figlio di Zhaoli Qaghan
119) Enian Qaghan (846-848),
fratello minore di Öge Qaghan, cadde vittima di un'invasione dei
suoi ex vassalli, i
Kirghisi, che posero fine al Qaganato degli Uighuri
Qaghan dei Karakhānidi (Kirghisi)
120) Bilge Kul Qadir Khan
(848–893), discendente dello yabghu Karluk, fondò il Qaghanato Kirghiso
121) Bazir Arslan Khan
(893–920), luogotenente di Bilge Kul Qadir Khan
122) Oghulcak Khan (893–940),
fratello minore di Bazir Arslan Khan
123) Satuk Bughra Khan
(920–955), figlio di Bazir Arslan Khan, nel 932 si convertì all'Islam
124) Musa Bughra Khan (955–958),
figlio di Satuk Bughra Khan
125) Suleyman Arslan Khan
(958–970), fratello di Musa Bughra Khan
126) Ali Arslan Khan (970–998),
figlio di Musa Bughra Khan
127) Ahmad Arslan Qara Khan
(998–1017), figlio di Ali Arslan
128) Mansur Arslan Khan
(1017–1024), figlio di Ali Arslan
129) Muhammad Toghan Khan
(1024–1026), figlio di Hasan b. Sulayman
130) Yusuf Qadir Khan
(1026–1032), figlio di Hasan b. Sulayman
131) Ali Tigin Bughra Khan
(1020–1034), Grande Qaghan a Samarcanda, figlio di Hasan b. Sulayman
132) Abu Shuja' Sulayman
(1034–1042), usurpatore, fu sconfitto da Chongxi, sovrano del Kara Khitay
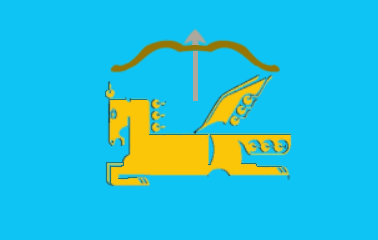
Bandiera del Kara Khitay
Sovrani del Kara Khitay (Liao)
133) Chongxi (1042-1055), rese
grande l'impero del Kara Khitay ("i Khitay Neri"), dal cui nome deriva il
termine europeo medioevale di "Catai"
134) Daozong (1055–1101),
figlio di Chongxi
135) Xianyong (1065-1074)
136) Taikang (1075-1084)
137) Da'an (1085-1094)
138) Shouchang (1095-1101)
139) Tianzuodi (1101-1110)
140) Tianqing (1111-1120)
141) Baoda (1121-1125)
142) Yelü Dashi (1124-1144)
143) Tabuyan (1144-1150)
144) Yelü Yilie (1150-1164),
successivamente idenrificato con il mitologico "Prete Gianni" delle leggende
europee medioevali
145) Yelü Pasuwan (1164-1178)
146) Yelü Zhilugu (1178-1211)
147) Kuchlug (1211-1218)
Gran Khan dell'Impero Mongolo
eurasiatico
148) Gengis Khan (Temujin, 1206-1227),
figlio di Yesugei e di Ho'elun, fu uno dei più grandi conquistatori della storia
dell'uomo
149) Tolui Khan (1227-1229),
figlio di Gengis Khan e di Börte, fu reggente dell'Impero mongolo fino a quando
suo fratello Ögedei non divenne Khan
150) Ögodei Khan (13 settembre
1229-11 dicembre 1241), fratello di Tolui
151) Töregene Khatun
(1242-1246), sposa di Ögodei, reggente dell'Impero mongolo fino all'elezione del
figlio, Güyük Khan
152) Güyük Khan (24 agosto
1246-20 aprile 1248), figlio di Ögodei e di Töregene
153) Oghul Qaimish (1248-1251),
reggente dell'Impero mongolo fino alla sua morte nel 1251
154) Möngke Khan (1° luglio
1251-11 agosto 1259), figlio di Tolui e di Sorgaqtani Beki
155) Ariq Böke (11 agosto
1259-12 agosto 1264), fratello di Möngke, rivendicò il titolo di Gran Khan e
combatté contro Kublai nella guerra civile toluide
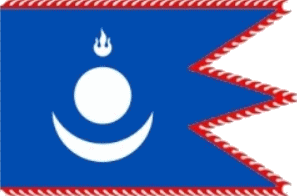
Bandiera della Dinastia Yuan
Imperatori della dinastia Yuan
(Cina e Mongolia)
156) Kublai Khan (18 dicembre
1271-18 febbraio 1294), fratello di Möngke e di Ariq Böke, accolse alla sua
corte Marco Polo
157) Temür Khan (10 maggio
1294-10 febbraio 1307), nipote di Kublai
158) Külüg Khan (21 giugno
1307-27 gennaio 1311), pronipote di Kublai
159) Ayurbarwada Buyantu Khan
(7 aprile 1311-1° marzo 1320), fratello di Qayshan Gülük
160) Gegeen Khan (19 aprile
1320-4 settembre 1323), figlio di Ayurbarwada Buyantu Khan e di Radnashiri
161) Yesün Temür (4 ottobre
1323-15 agosto 1328), pronipote di Kublai
162) Ragibagh Khan (1° ottobre
1328-14 novembre 1328), figlio di Yesün Temür e di Babukhan
163) Jayaatu Khan Tugh Temür
(16 ottobre 1328-2 settembre 1332), figlio di Külüg Khan
164) Khutughtu Khan Kusala (27
febbraio 1329-30 agosto 1329), fratello e già coreggente di Jayaatu Khan Tugh
Temür
165) Rinchinbal Khan (23
ottobre 1332-14 dicembre 1332), figlio di Khutughtu Khan Kusala e di Babusha
166) Toghon Temür (19 luglio
1333-23 maggio 1370), figlio di Khutughtu Khan Kusala e di Mailaiti, fu
sconfitto da Zhu Yuanzhang che divenne imperatore di Cina con il nome di Hongwu
e fondò la Dinastia Ming
Imperatori della dinastia Yuan
Settentrionale (sola Mongolia)
167) Biligtü Khan Ayushiridara
(1370–1378), figlio di Toghon Temür, si ritirò sull'altopiano mongolo
168) Uskhal Khan Tögüs Temür
(1378–1388), fratello minore di Biligtü Khan Ayushiridara
169) Jorightu Khan Yesüder
(1388–1391), discendente di Ariq Böke
170) Engke Khan (1391–1394),
figlio di Jorightu Khan Yesüder
171) Elbeg Nigülesügchi Khan
(1394–1399), fratello minore di Elbeg Nigülesügchi Khan
172) Gün Temür Khan
(1399–1402), figlio di Elbeg Nigülesügchi Khan
173) Örüg Temür Khan (Guilichi,
1402–1408), discendente di Ögedei
174) Öljei Temür Khan (Bunyashiri,
1408–1412), figlio di Elbeg Nigülesügchi Khan
175) Delbeg Khan (Dalbag,
1412–1415), discendente di Ariq Böke, insediato dalla tribù degli Oirati
176) Oyiradai (1415–1425),
discendente di Ariq Böke, insediato dagli Oirati dopo l'assassinio di Delbeg Khan
177) Adai Khan (1425–1438),
figlio di Örüg Temür Khan
178) Tayisung Khan Toghtoa Bukha
(1433–1452), figlio di Ajai, figlio di Elbeg Nigülesügchi Khan
179) Agbarjin (1452-1453),
fratello minore di Tayisung Khan Toghtoa Bukha
180) Esen Taishi (1453–1454),
figlio di Toghan, capo degli Oirati, catturò l'imperatore Yingzong dei Ming
nella battaglia della fortezza di Tumu (1449)
181) Markörgis Khan (Ükegtü,
1454–1465), figlio di Tayisung Khan Toghtoa Bukha
182) Molon Khan (1465–1466),
fratello minore di Markörgis Khan
183) Manduul Khan (1475–1478),
fratello di Tayisung Khan Toghtoa Bukha e di Agbarjin
184) Dayan Khan (Batu
Möngke, 1478-1516), figlio di Bayanmongke, capo del clan dei Borjigin
185) Bars Bolud Jinong
(1517-1519), terzo figlio di Dayan Khan
186) Bodi Alagh Khan
(1519-1547), nipote abiatico di Dayan Khan
187) Daraisung Guden Khan
(1547–1557), figlio maggiore di Bodi Alagh Khan
188) Tümen Jasagtu Khan
(1557–1592), figlio di Daraisung Guden Khan
189) Buyan Sechen Khan
(1592-1604), figlio di Tümen Jasagtu Khan
190) Ligdan Khan (1604–1634),
nipote di Buyan Sechen Khan
191) Ejei Khan (1634–1635),
figlio di Ligdan Khan, fu sconfitto da Hong Taiji, che assunse il nome di
Taizong e fondò la Dinastia Qing, di origine Manciù

Bandiera della Mongolia moderna
Sechen Khan di Mongolia
192) Sholoi (1635–1655), figlio
di Morbuim, signore della Mongolia orientale, conquistò l'intero paese dopo la
fine degli Yuan settentrionali
193) Babu (1655–1683), quinto
figlio di Sholoi
194) Norov (1683–1688), terzo
figlio di Babu
195) Ilden Ravdan (1688–1690),
usurpatore
196) Ömkhei (1691–1709), nipote
di Norov
197) Günchin (1709–1728), primo
figlio di Ömkhei
198) Tsevdenbanjuur
(1728–1733), primo figlio di Günchin
199) Choizav (1733–1735),
nipote di Norov
200) Damiran (1735–1751),
secondo figlio di Günchin
201) Manybadar (1751–1767),
primo figlio di Damiran
202) Tsevdenjav (1767–1788),
secondo figlio di Damiran
203) Tseveendorj (1788–1795),
primo figlio di Tsevdenjav
204) Puntsagdorj (1795),
secondo figlio di Tsevdenjav
205) Sanzaidorj (1796–1800),
primo figlio di Tseveendorj.
206) Mahashiri (1800–1807),
usurpatore
207) Enkhtör (1807–1817), primo
figlio di Mahashiri.
208) Artased (1817–1875),
figlio di Enkhtör
209) Tserendorj (1875–1893),
figlio di Artased
210) Demchigdorj (1893–1909),
figlio di Tserendorj
211) Navaanneren (1910-1911),
figlio maggiore di Tserendondov, figlio di Orjinjav, figlio di Artased
Bogd Khan di Mongolia
212) Agvaan Luvsan Choijinnyam Danzan
Vanchüg (1911-1924), ottavo Jebtsundamba Khutuktu (guida spirituale del
buddismo tibetano in Mongolia), assunse il titolo di Bogd Khan ("Signore
Sacro"). Alla sua morte l'assemblea dei monaci, per evitare un lungo interregno
in attesa di individuare la reincarnazione di Agvaan, designò che il Bogd Khan
sarebbe stato il Khambo Lama, cioè l'abate dell'importantissimo monastero di
Gandantegchinlen, ad Ulaan Bator. Fu così che la Mongolia divenne una teocrazia,
come il Tibet
213) Luvsanheimchig (1924-1937)
214) Naidangiin Erdenepel
(1937-1960)
215) Samaagiin Gombozav
(1960-1980)
216) Harhuugiin Gaadan
(1980-1990)
217) Sugaryn Dagvadorz
(1990-1991)
218) Tumuriin Damdinsuren
(1991-1993)
219) Gabju
Dembereliin Choyjamts (1993–2023)
220) Dulmaragchaagiin Zhavzandorj
(2023-in carica), governa la Mongolia dal 1° novembre 2023, data della sua
elezione

Personificazione della Mongolia, immagine creata con BING
.
X – Sovrani di Turchia
Yagbu degli Oghuz
87) Inal Yavi (657-680), alla
morte di Ishbara, Qaghan dei Göktürk (vedi sopra), fondò
la Confederazione Oghuz nella Transoxiana
88) Duyli Kai (680-693), figlio
di Inal Yavi
89) Irqi (693-722), figlio di
Duyli Kai
90) Tuman (722-725), figlio di
Irqi
91) Qanli Yavi
(725-748), figlio di Tuman
92) Mur Yavi (748-766), figlio
di Qanli Yavi
93) Qara Khan (766-802), figlio
di Mur Yavi
94) Bughra Khan (802-825),
figlio di Qara Khan
95) Quzitekin (825-847), figlio
di Bughra Khan
96) Arslan (847-853), figlio di
Quzitekin
97) Usman (853-874), figlio di
Arslan
98) Isli (874-911), figlio di
Usman
99) Shaiban (911-946), figlio
di Isli
100) Buran (946-979), figlio di
Shaiban
101) Ali Khan (979-998), figlio
di Buran
102) Malik
Shah I (998-1037), fu sconfitto
e deposto da Toghrul Beg, che invase il Medio Oriente e fondò il Sultanato
Selgiuchide

Bandiera dell'Impero Selgiuchide
Sultani Selgiuchidi
103) Toghrul Beg
(1037-1063), nipote di Seljuq, capo di una delle tribù degli Oghuz, conquistò la
Persia e la Mesopotamia
104) Alp Arslan (1063-1072), nipote di Toghrul Beg
105) Malik Shah II (1072-1092), figlio di Alp Arslan,
conquistò l'Anatolia togliendola ai Bizantini
106) Mahmud I (1092-1094), figlio di Malik Shah I e di Terken Khatun
107) Barkiyaruq (1094-1105), figlio di Malik Shah I e di Zubayda Khatun
108) Malik Shah III (1105), figlio di Barkiyaruq
109) Muhammad I Tapar (1105-1118), figlio di Malik-Shah I e di Taj al-Din Khatun
Safariya
110) Ahmed I Sanjar (1118-1153), figlio di Malik-Shah I e di Taj Safariyya Khatun
Sultani di Rum
111)
Mas'ud I (1153-1156), figlio
di Qilij Arslan, prese il controllo
dell'Anatolia al momento della disgregazione del Sultanato Selgiuchide
112)
ʿIzz al-Dīn Qilij Arslan I
(1156-1192), secondogenito di Mas'ud
113)
Giyāth al-Dīn Kaykhusraw I (1192-1196, 1° regno), figlio
di ʿIzz al-Dīn Qilij Arslan I
114)
Rukn al-Dīn Suleymānshāh
(1196-1204), fratello di Giyāth al-Dīn Kaykhusraw I
115)
Qilij Arslan II (1204-1205),
figlio di Rukn al-Dīn Suleymānshāh
113)
Giyāth al-Dīn Kaykhusraw I
(1205-1211, 2° regno)
116)
ʿIzz al-Dīn Kaykaus I
(1211-1220), figlio di Giyāth al-Dīn Kaykhusraw I
117)
ʿAlāʾ al-Dīn Kayqubad I
(1220-1237), fratello di ʿIzz al-Dīn Kaykaus I
118)
Kaykhusraw (1237-1246), figlio
di ʿAlāʾ al-Dīn Kayqubad I
119)
ʿIzz al-Din Kaykaus II
(1246-1260), figlio di Kaykhusraw
120)
Rukn al-Dīn Qilij Arslan III
(1246-1265), fratello di ʿIzz al-Din Kaykaus II e inizialmente suo coreggente
121)
ʿAlāʾ al-Dīn Kayqubad II
(1249-1257), fratello dei suoi due predecessori
122)
Giyāth al-Dīn Kaykhusraw II
(1265-1284), figlio di Rukn al-Dīn Qilij Arslan III
123)
Giyth al-Dīn Masʿūd
II (1284-1296, 1° regno), figlio di ʿIzz
al-Din Kaykaus II, governò come vassallo dei Mongoli
124)
ʿAlāʾ al-Dīn Kayqubad III
(1298-1302), nipote di Giyth al-Dīn Masʿūd
123)
Giyāth al-Dīn Masʿūd
II
(1303-1308, 2° regno), restaurato sul trono
Sultani
Ottomani, primo periodo
125) Osman I il Guerriero (1308-1326),
figlio di Ertuğrul e di Halime Hatun, sconfisse l'ultimo Sultano di Rum e fondò
il Sultanato Ottomano
126) Orhan I (1326-1362), figlio di Osman I e di
Malhun Hatun
127) Murad I il Devoto (1362-1389), figlio di Orhan
e di Nilüfer Hatun, morì nella battaglia di Kosovo Polje (15 giugno 1389)
128) Bayezid I la Folgore (1389-1402), figlio di
Murad I e di Gülçiçek Hatun, catturato da Tamerlano durante la Battaglia di
Ankara, morì in prigionia nel 1403
Sultani Timuridi
129) Timur Leng (Tamerlano,
1402-1405), tentò senza successo di ricostruire l'Impero Mongolo eurasiatico
130) Pir Muhammad (1405-1407), nipote di Timur Leng
131) Khalil Sultan (1407-1409), nipote di Timur
Leng e cugino di Pir Muhammad
132) Shah Rukh (1409-1413), figlio di Timur Leng e
padre di Khalil Sultan

Bandiera della Turchia Ottomana
Sultani
Ottomani, secondo periodo
133) Mehmet II l'Affabile (1413-1421), figlio di
Bayezid I e di Devlet Hatun, sconfisse i Timuridi e restaurò la dinastia
Ottomana
134) Murad II il Grande (1421-1444, 1° regno),
figlio di Mehmet II e di Emine Hatun, abdicò in favore di suo figlio Mehmed II
135) Mehmet III il Conquistatore (1444-1446, 1°
regno), figlio di Murad II e di Hüma Hatu, restituì il trono a suo padre dopo
che questi gli ebbe chiesto di tornare al potere
134) Murad II il Grande (1446-1451, 2° regno), fu
costretto a tornare sul trono in seguito alla rivolta dei Giannizzeri, e regnò
fino alla morte
135) Mehmet III il Conquistatore (1451-1481, 2°
regno), figlio di Murad II e di Hüma Hatun, conquistò Costantinopoli e si
proclamò Imperatore dei Romani
136) Bayezid II il Santo (1481-1512), figlio di Mehmet III e
di Gülbahar Hatun
137) Selim I il Forte (1512-1520), figlio di Bayezid
II e di Gülbahar Hatun, alla sua corte lavorò e morì Leonardo da Vinci
138)
Suleyman I il Magnifico (1520-1566), figlio di Selim I e Hafsa Sultan
139)
Selim II il Biondo (1566-1574), figlio di Suleyman III e di Aleksandra Anastasija Lisowska,
detta Roxelllana
140) Murad III (1574-1595), figlio di Selim II e di Cecilia Venier Baffo
141) Mehmet IV il Giusto (1595-1603), figlio di Murad I e di Sofia Sultan
142) Ahmed II il Fortunato (1590-1617), figlio di Mehmet IV e di Handan Sultan
143) Mustafa I (1° regno, 1617-1618), figlio di Mehmet IV e di Halime Sultan, malato
di mente, fu deposto e sostituito dal nipote
144) Osman II (1618-1622), figlio di Ahmed II e di Mahfiruz Hatun, fu deposto a sua
volta e assassinato
143) Mustafà I (2° regno, 1622-1623), rimesso sul trono, fu poi deposto una seconda
volta
145) Murad IV il Guerriero (1623-1640), figlio di Ahmed
II e di Kösem Sultan, protesse Galileo Galilei, fuggito dall'Italia perchè
perseguitato dal Sant'Uffizio
146) Ibrahim (1640-1648), fratello di Murad II, fu deposto da un colpo di stato
147) Mehmet V il Cacciatore (1648-1687), figlio di Ibrahim II e di Turhan Sultan
148) Suleyman II (1687-1691), figlio di Ibrahim II e di Saliha Dilaşub Sultan
149) Ahmed III (1691-1695), figlio di Ibrahim II e di Muazzez Sultan
150) Mustafa II (1695-1703), figlio di Mehmet V e di Gülnuş Sultan, fu deposto dai
suoi giannizzeri
151) Ahmed IV (1703-1730), fratello di Mustafa II
152) Mahmud II (1730-1754), figlio di Mustafa II e di Saliha Sultan
153) Osman III il Devoto (1754-1757), figlio di Mustafa II e di Şehsuvar Sultan
154) Mustafa III (1757-1774), figlio di Ahmed IV e di Mihrişah Kadın
155) Abdül Hamid I (1774-1789), figlio di Ahmed IV e di Rabia Şermi Kadın
156) Selim III (1789-1807), fIglio di Mustafa III e di Mihrişah Sultan
157) Mustafa IV (1807-1808), figlio di Abdülhamid I e di Sineperver Sultan
158) Mahmud III (1808-1839), figlio di Abdül Hamid I e di Nakşidil Sultan
159) Abdül Mejid I (1839-1861), figlio di Mahmud III e di Bezmiâlem Sultan, concesse
per primo una Costituzione
160) Abdülaziz (1861-1876), figlio di Mahmud III e di Pertevniyal Sultan, fu deposto
dai suoi ministri ed assassinato
161) Murad V (1876), figlio di Abdülmecid I e di Şevkefza Sultan, fu deposto dopo
tre mesi di regno perchè ritenuto troppo progressista
162) Abdül Hamid II (1876-1909), figlio di Abdül Mejid e di Tirimüjgan Kadin
163) Mehmet VI (1909-1918), figlio di Abdül Mejid I
e di Gülcemal Kadin, fu il primo Sultano a regnre ma non a governare, dopo
l'introduzione della monarchia costituzionale
164) Mehmet VII (1918-1926), figlio di Abdül Mejid
I e di Gülüstü Hanım, ebbe Mustafa Kemal come Primo
Ministro
165) Abdül Mejid
II (1926-1944), figlio di Abdülaziz e di Hayranidil Kadın, con lui
l'Impero Ottomano assunse una struttura federale e concesse l'indipendenza allo
Stato d'Israele
166) Ahmed V (1944-1954), figlio di Mehmet, a sua
volta figlio di Murad V, e di Naziknaz Hanım
167) Osman IV (1954-1973), figlio di Mehmet, a sua
volta figlio di Murad V, e di Jalefer Hanım
168) Mehmet VIII (1973-1977), figlio di Mehmed
Seyfeddin, a sua volta figlio di Abdülaziz, e di Neşefelek Hanım
169) Ali Vâsib (1977-1983), figlio di Ahmed V e di
Safiru Hanım
170) Mehmet IX (1983-1994), figlio di Mehmed
Abdülkadir, a sua volta figlio di Abdül Hamid II, e di Mihriban Hanım
171) Osman V (1994-2009), figlio di Mehmed
Burhaneddin, a sua volta figlio di Abdül Hamid II, e di Aliye Melek Nazlıyar
Hanım
172) Bayezid III (2009-2017), figlio di Ibrahim
Tevfik, nipote di Abdül Mejid I, e di Hatice Şadiye Hanım
173) Orhan II (2017-in carica), nato il 25 agosto
1963, figlio di Harun Osman, pronipote di Abdül Hamid II, e di Farizet Hanım
174) Selim (IV) (erede al trono), nato il 22
febbraio 1989, figlio di Orhan II e di Nuran Yıldız Hanım
175) Mehmet (X) (secondo in linea di successione),
nato il 17 luglio 2024, figlio di Selim (IV) e di Damla Işık
.
XI – Sovrani di Crimea
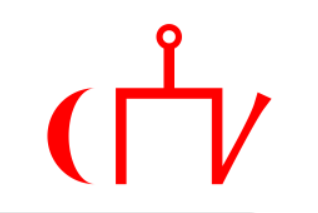
Bandiera del Kkamato dell'Orda d'Oro
Khan dell'Orda d'Oro (Qipchaq)
148) Gengis Khan (Temujin,
1206-1227), vedi sopra
149) Batu Khan (1227-1255),
figlio di Jöchi, pimogenito di Gengis Khan
150) Sartak (1255-1256), figlio
di Batu Khn
151) Ulakci (1256-1257),
fratello di Sartak
152) Berke (1264-1266),
fratello di Batu Khan
153) Mengu Temur (1266-1282),
figlio di Toqoqan Khan, figlio di Batu Khan
154) Tuda Mengu (1282-1287),
fratello di Mengu Temur
155 Tala Buga (1287-1291),
nipote di Mengu Temur
156) Tokta (1291-1312), figlio
di Mengu Temur
157) Üz Bek (1313-1341), nipote
di Mengu Temur, da lui prese nome il popolo degli Uzbeki
158) Tini Bek (1341-1342),
figlio di Üz Bek
159) Ganī Bek (1341-1357),
fratello di Tini Bek, assediando Caffa in Crimea provocò la pandemia di Peste
Nera in Europa
160) Birde Bek (1357-1359),
figlio di Gani Bek
161) Qulpa (1359-1360),
fratello di Birde Bek
162) Nauruz
Bek (1360), fratello di Birde
Bek e Qulpa
163) Mamaj (1361-1380), preteso
discendente di Gengis Khan
164) Toktamish (1380-1394),
discendente di Togha Temur, Khan dell'Orda Blu, ultimo grande Khan dell'Orda
d'Oro, subì i devastanti attacchi di Tamerlano
165) Temur Kutlug (1394-1400),
figlio del khan dell'Orda Bianca Timur Malik, rivale di Toktamish
166) Shadi Bek (1400-1407),
fratello di Temur Kutlug
167) Pulad Khan (1407-1412),
fratello di Temur Kutlug e di Shadi Bek
168) Jalal Al Din (1412-1413),
figlio di Toktamish
169) Karim Birdi (1413-1414),
fratello di Jalal al Din
170) Kebek Khan (1414-1417),
fratello di Jalal al Din e di Karim Birdi
171) Jabbar Birdi (1417-1419),
fratello di Jalal al Din, di Karim Birdi e di Kebek Khan
172) Uluğ Muhammad (1419-1420,
1° regno), cugino di Toktamish
173) Devlat Birdi (1420-1421),
figlio di Jabbar Birdi
174) Barak Khan (1421-1428),
nipote di Toktamish
172) Uluğ Muhammad (1428-1434,
2° regno), restaurato sul trono
175) Sayyd Ahmad I (1434-1436),
nipote di Toktamish
176) Kuchuk Muhammad (1436-1441),
nipote di Pulad Khan
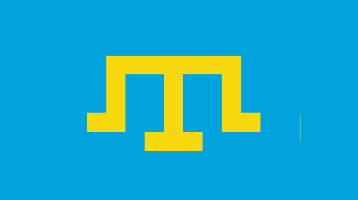
Bandiera del Kkamato di Crimea
Khan di Crimea (Grande Khanato)
177) Hacı I Giray (1441-1466),
fondò il Khanato di Crimea dopo la frammentazione definitiva dell'Orda d'Oro
178) Nur Devlet (1466-1467, 1° regno)
179) Meñli I Giray (1467, 1° regno)
178)
Nur Devlet (1467-1469, 2° regno)
179) Meñli I Giray (1469-1475, 2° regno)
180) Hayder Giray (1475)
178) Nur Devlet (1475-1476, 3° regno)
vacante (1476-1478)
179)
Meñli I Giray (1478-1515, 3° regno)
181)
Mehmed I Giray (1515-1523)
182) Ğazı I Giray (1523-1524)
183) Saadet I Giray (1524-1532)
184) İslâm I Giray (1532)
185) Sahib I Giray (1532-1551)
186) Devlet I Giray (1551-1577)
187) Mehmed II Giray (1577-1584)
188) Saadet II Giray (1584)
189) İslâm II Giray (1584-1588)
190) Ğazı II Giray (1588-1596, 1° regno)
191) Fetih I Giray (1596)
190) Ğazı II Giray (1596-1607, 2° regno)
192) Toqtamış Giray (1607-1608)
193) Selâmet I Giray (1608-1610)
194) Canibek Giray (1610-1623, 1° regno)
195) Mehmed III Giray (1623-1628)
194) Canibek Giray (1628-1635, 2° regno)
196) İnayet Giray (1635-1637)
197) Bahadır I Giray (1637-1641)
198) Mehmed IV Giray (1641-1644, 1° regno)
199) İslâm III Giray (1644-1654)
198) Mehmed IV Giray (1654-1666, 2° regno)
200) Adil Giray (1666-1671)
201) Selim I Giray (1671-1678, 1° regno)
202) Murad Giray (1678-1683)
203) Hacı II Giray (1683-1684)
201) Selim I Giray (1684-1691, 2° regno)
204) Saadet III Giray (1691)
205) Safa Giray (1691-1692)
201) Selim I Giray (1692-1699, 3° regno)
206) Devlet II Giray (1699-1702, 1° regno)
201) Selim I Giray (1702-1704, 4° regno)
207) Ğazı III Giray (1704-1707)
208) Qaplan I Giray (1707-1708, 1° regno)
206) Devlet II Giray (1709-1713, 2° regno)
208) Qaplan I Giray (1713-1715, 2° regno)
209) Devlet III Giray (1716-1717)
210) Saadet IV Giray (1717-1724)
211) Meñli II Giray (1724-1730, 1° regno)
208) Qaplan I Giray (1730-1736, 3° regno)
212) Fetih II Giray (1736-1737)
211) Meñli II Giray (1737-1740, 2° regno)
213) Selamet II Giray (1740-1743)
214) Selim II Giray (1743-1748)
215) Arslan Giray (1748-1756, 1° regno)
216) Halim Giray (1756-1758)
217) Qırım Giray (1758-1764, 1° regno)
218) Selim III Giray (1765-1767, 1° regno)
215) Arslan Giray (1767, 2° regno)
219) Maqsud Giray (1767-1768)
217) Qırım Giray (1768-1769, 2° regno)
220)
Devlet IV Giray (1769-1770, 1° regno)
221) Qaplan II Giray (1770)
218) Selim III Giray (1770-1771, 2° regno)
222) Sahib II Giray (1771-1775)
220) Devlet IV Giray (1775-1777, 2° regno)
223) Şahin Giray (1777-1782, 1° regno)
224) Bahadır II Giray (1782)
223) Şahin Giray (1782-1783, 2° regno)
Khan di Crimea (Piccolo
Khanato)
225) Bakht Giray (1783-1800),
nato nel 1745, figlio di Şahin Giray, dopo le conquiste di Caterina II di Russia
potè regnare sulla sola penisola di Crimea
226) Katy I Giray (1800-1846),
nato nel 1788, figlio di Bakht Giray
227) Katy II Giray (1846-1920),
nato nel 1836, figlio di Katy I Giray, dovette affrontare una seconda invasione
russa, ma Regno Unito, Francia e Regno di Sardegna intervennero nella Guerra di
Crimea e sconfissero le truppe dello Zar Nicola I. Dietro impulso del Primo
Ministro Ismail Gaspirali, Katy II introdusse una Costituzione Liberale e
modernizzò il Khanato, ma morì senza figli maschi
228) Noman Çelebicihan
(1920-1924), nato nel 1885, fu eletto Khan in un momento in cui i Bolscevichi
stavano attaccando la Crimea cercando di annetterla. Fu catturato in battaglia
dai Bolscevichi e giustiziato il 23 febbraio 1924
229) Cafer Seydamet (1924-1925,
1° regno), braccio destro di Noman Çelebicihan, gli succedette ma fu sconfitto e
rovesciato da Kılıç Giray
230) Kılıç Giray (1925-1942),
nato nel 1880, figlio di Shahana Giray (1815–1898), discendente di un figlio
cadetto di Şahin Giray, sconfisse definitivamente i Bolscevichi. Fu arrestato
dai nazisti e giustiziato il 16 gennaio 1942
229) Cafer Seydamet (1942-1945,
1° regno), fu rimesso sul trono dai nazisti, ma rovesciato nel 1945 e costretto
ad andare in esilio. Morì nel 1960
231) Kadir Giray (1945–1953),
nato nel 1891, discendente di un altro figlio cadetto di Şahin Giray, eroe di
guerra contro i Boscevichi prima e contro i Nazisti poi
232) Chingiz I Giray
(1953-1999), nato nel 1921, figlio di Kadir Giray, abdicò il 31 dicembre 1999
per motivi di salute
233) Azamat Giray (1999-2001),
nato il 14 agosto 1924, fratello minore di Chingiz I Giray, morì l'8 agosto 2001
234) Jezzar Raji Pamir Giray
(2001-in carica), nato il 12 agosto 1959, figlio di Azamat Giray, ebbe come
primo Ministro Mustafa Abdülcemil Qırımoğlu
235) Chingiz (II) Karim Sultan Giray
(erede al trono), figlio di Jezzar Raji Pamir Giray, nato il 21 ottobre 1992
.
XII – Sovrani del Turkestan
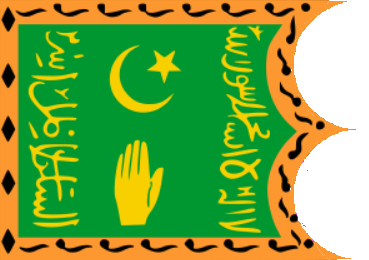
Bandiera del Kkamato del Turkestan
Khan di Bukhara, dinastia
Shaybanide
173) Abu al-Khayr (1420-1468),
discendente patrilineare di Shiban, quinto figlio di Jochi (primogenito di
Gengis Khan). Sconfisse Uluğ Muhammad (vedi sopra), uno
degli ultimi Khan dell'Orda d'Oro (vedi sopra) e
approfittò della dissoluzione di quello stato per fondare il Khanato di Bukhara.
Il suo popolo prese il nome di Uzbeki in omaggio a Üz Bek, Khan dell'Orda d'Oro
e loro protettore
174) Yadgar Khan (1468-1469),
usurpatore
175) Muhammad Shaybânî
(1500-1510), nipote di Abû-l-Khayr
176) Köchkunju (1512-1531),
figlio di Abû-l-Khayr
177) Abû Sa`îd (1531-1534),
figlio di Köchkunju
178) Ubaydallâh (1534-1539),
nipote di Abû-l-Khayr
179) Abdallâh I (1539-1540),
figlio di Köchkunju
180) Abd al-Latîf (1540-1552),
figlio di Köchkunju
181) Nawruz Ahmad (1552-1556),
nipote di Abu al-Khayr
182) Pîr Muhammad I
(1556-1561), figlio di Jânî Beg, pronipote di Abû-l-Khayr
183) Iskandar (1561-1583),
figlio di Jânî Beg
184) Abdallâh II (1583-1598),
figlio di Iskandar
185) Abd al-Mu'min (1598),
figlio di Abdallah II
186) Pîr Muhammad II
(1598-1599), nipote di Jânî Beg
Khan di Bukhara, dinastia
Janide
187) Baqi Muhammad Khan
(1599–1605), figlio di Jânî Beg
188) Vali Muhammad Khan
(1605–1611), fratello di Baqi Muhammad Khan
189) Imam Quli Khan
(1611–1642), figlio di Din Muhammad Khan
190) Nadir Muhammad Khan
(1642–1645), fratello di Vali Muhammad Khan
191) Abd al-Aziz Khan
(1645–1680), figlio di Nadir Muhammad Khan
192) Subhan Quli Khan
(1680–1702), fratello di Abd al-Aziz Khan
193) Ubaidullah Khan
(1702–1711), figlio di Subhan Quli Khan
194) Abu al-Fayz Khan
(1711–1747), fratello di Ubaidullah Khan
195) Muhammad Abd al-Mumin
(1747–1748), figlio di Abu al-Fayz Khan, posto sul trono a soli nove anni da
Muhammad Rahim, antenato della dinastia Manghit
196) Muhammad Ubaidullah II
(1748–1753), figlio di Abu al-Fayz Khan
197) Abu'l Ghazi (1758–1785),
figlio di Abu al-Fayz Khan, ultimo della dinastia Janide
Khan del Turkestan, dinastia
Manghit
198) Shahmurad
(1785-1800), figlio di Danial Khan, discendente di Muhammad Rahim, conquistò
tutto il Turkestan dal Mar Caspio alla Cina e fondò la dinastia Manghit
199) Haydar bin Shahmurad
(1800-1826), figlio di Shahmurad
200) Mir Hussein bin Haydar
(1826-1827), figlio di Haydar bin Shahmurad
201) Umar bin Haydar (1827),
figlio di Haydar bin Shahmurad
202) Nasrullah Khan (24 aprile
1827-20 ottobre 1860), figlio di Haydar bin Shahmurad
203) Muzaffar bin Nasrullah (20
ottobre 1860-4 novembre 1885), figlio di Nasrullah Khan
204) Abd al-Ahad Khan (4
novembre 1885-23 dicembre 1910), figlio di Muzaffar bin Nasrullah, nato il 26
marzo 1859
205) Mohammed Alim Khan (3
gennaio 1911-28 aprile 1944), figlio di Abd al-Ahad Khan, nato il 3 gennaio
1880, nel 1919 sconfisse i Bolscevichi russi che tentavano di occupare il
Turkestan. Nel 1933 introdusse la Monarchia Costituzionale
206) Sa`îd
Mir Ibrahim Khan (28 aprile
1944-15 gennaio 1945), figlio di Abd al-Ahad Khan, morì combattendo contro i
Nazisti
207) Sultan Murad Khan (15
gennaio 1945-1° aprile 1950), figlio di Abd al-Ahad Khan, fu assassinato da un
suo suddito simpatizzante dei Bolscevichi
208) Qasem
Khan (1° aprile 1950-15 novembre 1993), figlio di Mohammed Alim Khan
209) Husein Bukharaei (15 novembre 1993-in carica),
figlio di Qasem I Khan
210) Hasan Bukharaei (erede al trono), figlio di
Husein Bukharaei e di Bibimeymanat Mohsenolhoseini
E così, l'eredità degli Unni è costituita da ben dodici nazioni odierne: Ungheria, Bulgaria, Polonia, Russia, Boemia, Lituania, Romania (unione di Valacchia e Moldavia), Serbia, Turchia, Crimea, Turkestan e Mongolia. Non male, per un popolo che si riteneva completamente sparito dalla storia!
Lord Wilmore
.
William Riker commenta entusiasta:
Caspita, che lavoro! Le successioni dei sovrani ungheresi, bulgari, polacchi, russi, serbi e turchi sono manifestamente tra loro incompatibili, invece quella dei sovrani mongoli e quella dei sovrani di Crimea sono compatibili con tutte e tre le altre singolarmente (i sovrani di Crimea e quelli del Turkestan sono incompatibili solo con quelli di Polonia). Le successioni dei Re di Polonia, di Boemia e di Lituania invece costituiscono manifestamente un'unica ucronia, dato che tutte confluiscono in una sola, con lo stesso numero di sovrani, così come quelle di Valacchia e di Moldavia, che confluiscono alla fine nella Romania. I miei complimenti!
.
Aggiungiamo ora questa avvincente proposta di Paolo:
Uno dei miei chiodi fissi è la rilatinizzazione della valle del Danubio, alla stregua dei Valacchi in Dacia. Una multietnicità essenzialmente quadruplice (slavi, tedeschi, latini, magiari) incapace di creare un regno unitario. Principati feudali in lotta tra loro e lo sviluppo di un'area urbana da caratteristiche fiamminghe, molto fiorente, anello di congiunzione tra la pianura padana, l'Europa settentrionale e il Mar Nero e Costantinopoli. Lo so, lo so, è molto poco fattibile, però immaginare gli elementi per la creazione di qualcosa del genere mi affascina...
.
Gli risponde il solito Franz Joseph von Habsburg-Lothringen:
Non mi sembra affatto "poco fattibile": basta dosare gli elementi che hanno causato lo stesso fenomeno sul Basso Danubio, il che per l'attuale Bulgaria è semplicissimo, ossia consiste nella nomina del Vescovo Legato Formoso (poi Papa Formoso, 891-896) o del Diacono Marino (poi Papa Marino I, 882-884) ad Arcivescovo di Bulgaria da parte di Papa Adriano II (867-872) entro il Quarto Concilio di Costantinopoli (870). Più complicato sarebbe per l'attuale Ungheria, dove in teoria sarebbe più facile postulare una mancata conversione dei Magiari (né con Santo stefano né poi), altrimenti una loro confluenza in una Compagine Politica locale già non solo cristianizzata da Clero Romano, ma in particolare dalla Missione di Aquileia (o, se da quella di Salisburgo, con prevalenza in quest'ultima dell'elemento ladino su quello marcomannico in Baviera).
.
Interviene Lord Wilmore:
Secondo voi, amici, cosa sarebbe necessario per ottenere la completa latinizzazione della pianura pannonica dopo la ritirata degli Unni, evitando quindi le irruzioni di Avari, Ungari, Cumani e Peceneghi?
.
Franz Joseph von Habsburg-Lothringen gli spiega:
Se dev’essere dopo la ritirata degli Unni,
viene meno una possibilità (quella che ha neolatinizzato la Romania con i
Protobulgari); Peceneghi e Cumani non hanno potuto lasciare effetti linguistici
duraturi, quindi il tutto si concentra sugli Avari (responsabili della
‘definitiva’ – per così dire – Slavizzazione) e gli Ungari (della
Magiarizzazione, se la clan egemone rimane quella degli Árpádok).
A questo punto le uniche possibilità rimangono i Longobardi e i Gepidi (a
seconda della Riva del Danubio): i Longobardi come sé stessi a Sud delle Alpi (e
non come i loro ‘gemelli’ Bavari a Nord), i Gepidi come i loro fratelli Goti.
Sarebbe però indispensabile che rimanesse un Vescovato latino in Pannonia
(dipendente da Aquileia).
Il pannonico sarebbe più o meno come l’istroromanzo o istrioto.
.
Anche Paolo dice la sua:
È possibile che la migrazione romana post
invasione unna sia stata più lenta di quanto si immaginava anche solo due
decenni fa. Diversi siti sul lago Balaton (come Keszthely-Fenekpuszta) mostrano
che, per quanto uno spopolamento ci sia stato nel quinto secolo, ancora nel
sesto e addirittura settimo e ottavo secolo vi sono tumulazioni e un accenno di
vita urbana, con produzione artigiana. Ora, ciò non vuol dire necessariamente
che chi abitava i centri urbani fosse (ancora) romano, ma sicuramente il
mantenimento di vita urbana e funzioni religiose cristiane possono contribuire a
supporre che il passato romano ci mise un bel po' a scomparire del tutto. Ci si
può azzardare a ipotizzare l'esistenza di piccoli ed effimeri centri di potere
romano-germanici o romano-slavo/avari per un certo periodo? Non lo so, ma non
sarebbe molto diverso da quanto accaduto in Britannia, in fondo.
A mio avviso occorre che avvenga una invasione che abbia 'interesse' ad
appoggiarsi ai residui di romanità per controllare la zona (e residui di
romanità sufficientemente vitali per aderire al progetto).
Dunque, la mia ovvia, banale e prevedibile risposta, è che le campagne
mauriziane contro gli Avari si concludano con la loro sconfitta definitiva
(quindi il pod è che Maurizio non perda il controllo del suo esercito nel 602,
in effetti). La valle del Tibisco è oggettivamente troppo lontana da
Costantinopoli e le scorrerie slave nei Balcani restano un problema. Per cui
credo che Sirmio possa rappresentare l'avamposto fortificato più avanzato sotto
il diretto controllo bizantino.
Chiaro che dal punto di vista della successione imperiale, da qui, si va al
buio... Ma amministrativamente parlando, con o senza Eraclio, le guerre persiane
si sarebbero svolte lo stesso e la parte più caotica del limes danubiano
pannonico avrebbe visto un esarcato autonomo centrato su Sirmio e una serie di
ducati 'bizantini' 'fluviali' lungo il corso di quattro assi portanti: Sava,
Drava, Danubio fino ad Aquincum e basso Tibisco.
Le vicende successive andrebbero analizzate, ma la ricristianizzazione della
regione sarebbe ancora incentrata sul latino - a meno di avere dei Cirillo e
Metodio in anticipo - così come dubito che ammimistrativamente parlando si possa
imporre qualcosa di diverso dal latino. Qualsiasi sia il popolo invasore
successivo, se intende convertirsi al cristianesimo che trova, presto o tardi
assimila la lingua in cui viene predicato e pregato. Quindi, in ultima analisi,
dipende da come di risolverà in quei decisivi anni la lotta a morte tra latino
delle città lungo i fiumi e il Pelso/Balaton e slavo in tutto il resto del
territorio (che potrebbe anche benissimo essere risolta da decisori individuali
con molto potere).
.
Tommaso Mazzoni domanda:
Scusa, Franz Joseph, perchè i Protobulgari hanno neolatinizzato la Romania?
.
E Franz Joseph von Habsburg-Lothringen spiega pazientemente:
È stata una specie di ‘polarizzazione’
rispetto agli Avari, che hanno molto valorizzato l’elemento (balto)slavo che
hanno trovato e di conseguenza hanno catalizzato la formazione e diffusione
della comunione linguistica slava; i Protobulgari hanno invece formato un Regno
come quelli Romano-Germanici, appoggiandosi sulle comunità urbane latinofone del
Basso Danubio (tanto da adottarne, per esempio, l’onomastica personale nei nomi
dei proprî Sovrani: Romano, Campagnano, Sabino &c.).
Il processo ha toccato l’apice dopo la distruzione del Khānato degli Avari,
allorché quello dei Protobulgari ha raggiunto la massima estensione, soprattutto
a Nord del Danubio, dove appunto i suoi effetti sono stati duraturi; a Sud,
invece (dove nel frattempo si era ristretto il Regno, a causa dell’arrivo dei
Peceneghi su sollecitazione di Bisanzio), la successiva Conversione al
Cristianesimo secondo le modalità della Missione Cirillo-Metodiana (con
Bo[go]ris I.) ha determinato – una volta che la rivalità con gli Avari era ormai
lontana – una riformulazione identitaria che ha rotto sia la continuità
ancestrale con l’elemento altaico sia ogni (pericolosa) inclinazione verso la
Romanità o la Grecità, per appoggiarsi invece sull’elemento rustico degli Slavi.
È per questo che la Bulgaria è slava (mentre ci si aspetterebbe che fosse
latina) e la Romania è neolatina (mentre tutto portava a farla diventare il
centro della Slavità, quale in effetti la Dacia deve essere stata nella
Protostoria)...
.
William Riker suggerisce:
Mi è venuta in mente un’altra cosa: e i Gepidi? Secondo voi c’era qualche chance per questa popolazione germanica per sopravvivere fino ad oggi nella Pianura Pannonica, così da avere in essa una nazione germanofona?
.
Franz Joseph von Habsburg-Lothringen ribatte:
Germanofona o latinofona a seconda della
loro Confessione Cristiana definitiva.
La proposta che facevo era appunto che, stanti i bassi numeri demografici sia
dei Gepidi sia dei Longobardi rispetto ai Locali, diventassero entrambi Regni
Romano-Germanici neolatini (come i Longobardi storici e i Goti); ai Gepidi però
sarebbe indispensabile l’annessione della Mesia.
.
La parola ad Alberto Maria di Lorenzo:
Tra il 894 e il 896 ci una guerra fra Bisanzio e la Bulgaria. Leone VI il Saggio, che a quel tempo era basileus, si alleò con i Magiari, vale a dire i proto-ungheresi, contro i Bulgari. Lo zar Simeone li sconfisse, e questo li costrinse a migrare ad ovest verso la Pannonia. Ma se i Bizantini vincessero la guerra e i futuri ungheresi non fossero costretti a migrare?
.
Gli risponde Franz Joseph von Habsburg-Lothringen:
Decisivi per la Migrazione sono stati i
Peceneghi, che è possibile che attaccassero ugualmente i Magiari; se però questi
ultimi si trovassero di fronte la Bulgaria completamente indifesa, vi si
potrebbero insediare in alternativa alla Pannonia (a vantaggio dapprima della
Grande Moravia, poi della Carinzia e in generale della Baviera, i cui confini
orientali rimarrebbero sul Tibisco e sui Carpazi Orientali di Rutenia).
Il massimo di divergenza che si può mettere in conto è che la Pannonia rimanesse
romanza (± istroromanza?) fino alla Colonizzazione Tedesca dell’Est, che i
Valacchi del Danubio espulsi dai Magiari fossero quelli di Transilvania,
Moldavia e (appunto...) Valacchia, che l’Ungheria si formasse fra il Tibisco e i
Balcani, a Sud dei quali gli Slavi sarebbero stati alla fine (benché magari
soltanto nel Novecento) (ri)ellenizzati. È una grande divergenza, in pratica il
confine fra Austria e Ungheria sarebbe il Tibisco, i Balcani quello fra Ungheria
e Bisanzio (che sarebbe l’unica Romanìa, mentre quella che noi conosciamo con
questo nome non esisterebbe affatto, come neppure la Bulgaria; gli Slavi
Meridionali sarebbero ‘solo’ gli Sloveni, i Croati, i Serbi, eventualmente i
Bosniaci, Montenegrini e Macedoni, che forse potrebbero conservare il nome di
Bulgari).
.
Iacopo Maffi aggiunge di suo:
Il collasso della compagine Khazara e l'invasione magiara del bassopiano pannonico sono uno dei punti più complessi della storia politica delle Steppe. Non dei più oscuri, per fortuna. Ma l'intreccio di interessi e progetti è davvero articolato.
.
Interviene Paolo Maltagliati:
Sarò sincero, a me più che il destino di Bisanzio a me interesserebbe approfondire il destino dei Peceneghi, dei Cumani e dei Cazari in una timeline del genere (da cui peraltro dipende effettivamente in parte anche Bisanzio)... Proviamo un po'.
I Cumani, dopo la grande invasione mongola, dovettero sloggiare dalle loro terre a nord del Mar Nero. Molti di loro, valenti guerrieri e cavallerizzi, fuggirono a chiedere ospitalità presso il popolo che secoli prima avevano scacciato e che nel frattempo si era "civilizzato", diventando un grande regno, ossia l'Ungheria. I sovrani magiari accettarono volentieri, poiché avere uomini forti e valenti che controllavano i passi dei Carpazi settentrionali, poco abitati, se non da genti slave, di cui non si fidavano molto, faceva sempre comodo. La terra in cui si stanziarono, oltre il Tibisco, venne ribattezzata dai magiari Kunsag. Ora, nella nostra timeline i Cumani, pur mantenendo a lungo le proprie tradizioni (i re ungheresi concedettero che rimanessero della loro fede animista con una patina sincretico-musulmana), nel corso dei secoli finirono per magiarizzarsi completamente, pur lasciando qualche impronta linguistica sull'ungherese. Inoltre San Domenico di Guzman, pervaso da zelo missionario, voleva andare a convertire proprio i Cumani, ma Innocenzo III convinse lui e Diego Acevedo a prendere la via della Linguadoca per contrastare la diffusione del catarismo. Poniamo che Domenico non si lasci distrarre. Molto probabilmente il papa troverà qualcun altro da mandare in Occitania, in quel fiorire di movimenti religiosi che fu il periodo tra gli ultimi anni del XII e la prima metà del XIII secolo. Magari riciclerà i Valdesi, riabilitandoli. Comunque Domenico andrà dai Cumani e, essendo una persona intelligente, farà quello che hanno sempre fatto i santi intelligenti quando vogliono mettersi a convertire un popolo: imparare la lingua e tradurre la bibbia, chiedendo dispense particolari al pontefice sull'uso del latino. Grazie al fatto di avere un testo scritto nella propria lingua e magari, almeno per un po', un rito liturgico particolare, la lingua e la cultura cumana non scompariranno. Certo, regrediranno, assimilandosi progressivamente sul lato ungherese, ma quello che perderanno a sudovest guadagneranno a nord-est, assimilando le popolazioni delle attuali Transcarpazia e Maramures. Il loro destino seguirà quello degli ungheresi fino al 1526, quando si sottometteranno volontariamente agli Asburgo. Nel 1918 cosa accadrà? l'ipotesi più probabile è che diventino uno stato indipendente, anche se magari "punito" a nord a vantaggio dei polacchi e a est a vantaggio dei romeni (anche se dipende da quanto presto si distaccano dal carro ungherese). Solita dittatura di stampo fascista tra le due guerre e solita occupazione da parte dell'armata rossa con annesso ingresso nell'orbita sovietica. Sarà comunque una tra le "baracche allegre del gulag", come le altre due repubbliche "asburgiche" in mano russa (non escluso un intervento cumano a favore degli ungheresi nel '56, poi represso). Nell'unione europea dal 2004 ma non nell'euro. La bandiera è a due strisce, azzurra sopra e verde sotto, con il simbolo antico del leone che ha sostituito la falce ed il martello dal 1989... (genialissima idea di Paolo Maltagliati)
E se invece i Peceneghi prima e i Cumani dopo non riescono ad eliminare totalmente i "magiari dell'est", quelli che non attraversarono i Carpazi? Mettiamo che rimangono almeno in parte nella regione che gli storici di Budapest chiamano Etelkoz, in una zona compresa tra il Siret ed il Dnepr, a sud-est della Volinia. Loro, a differenza dei cugini occidentali, diventano ortodossi, sottomessi alla Rus' di Kiev, poi, per resistere alle invasioni mongole e tatare, si alleano alla Galizia-Volinia. Si alleano o ne finiscono sottomessi? certo è che, dalla seconda metà del XIV secolo, finiscono nell'orbita Lituana prima e polacca poi. I Polacchi li usano come carne da macello per contrastare i tatari di Crimea, mostrando loro non troppa gratitudine, cosa per cui alla fine fanno come i cosacchi e passano alla sponda moscovita. Rimanendo doppiamente fregati, perché vessati sia dai russi, sia dai ruteni. Il loro sogno di indipendenza nasce nel 1918. Ce la faranno a ottenere uno stato loro, oppure rimarranno fregati come gli ucraini? (personalmente propendo per la seconda ipotesi) In ogni caso, idem come sopra: orbita/dominio sovietica/o. Nella speranza che non aiutino troppo i nazisti avanzanti per finire spazzati via come i tatari di Crimea, anche se temo che potrebbe andare proprio a finire così: immaginatevi i nazisti che si portano dietro una divisione dei "cugini" ungheresi d'occidente come liberatori. Oltretutto, non essendo slavi, non sarebbero neanche trattati così male come gli ucraini, anche se non saprei dirvi le perverse logiche delle SS come potrebbero considerare la questione. Forse riusciranno ad ottenere l'agognata indipendenza nel 1991, come "Repubblica di Etelchia". Quali e quante differenze linguistiche sussisteranno tra il magiaro orientale e quello occidentale? e tra questi due e il Siculo (ungherese di Transilvania) e lo Csango (ungherese di Moldavia)? Saranno mutuamente intelligibili oppure no?
Ecco queste cartine approssimative. In rosso /violetto (popolazione maggioritaria/presenza) Etelchia ( a ripensarci però forse ho un po' esagerato...); in Blu/azzurro (idem come sopra) Cumania.
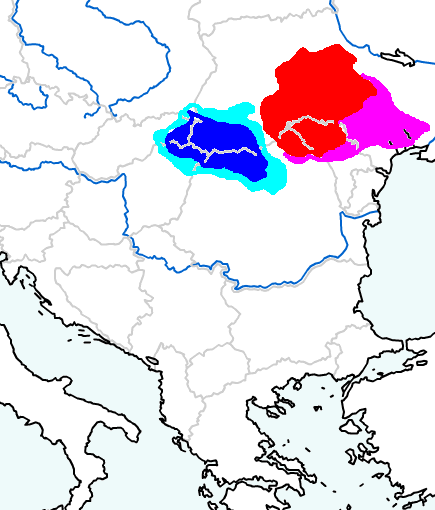
.
Rivoluzionario Liberale ci scherza su:
I Cumani non si assimilano e continuano a vivere in comunità loro, di allevamento e artigianato, e sono minoranza in Ungheria, Valacchia, Moldavia, Balcani. Poi arriva il XIX secolo e molti Cumani iniziano a migrare verso occidente: con la rivoluzione industriale il loro artigianato era già fuori mercato da tempo, e allora iniziano a vivere di furti. Il nazismo li perseguita in quanto popoli non ariani. Alcuni comuni adibiscono campi profughi per loro, al pari dei ROM, e spesso vengono confusi con essi, anche se parlano una lingua turca.
Poi arriva la Lega: « Bhhhhhhhhggggggrrrrr (la voce di Bossi), noi popoli padani non vogliamo questi invasori turchi, li rimandiamo a casa! » Alla stazione i bambini Cumani vanno a rubare il portafoglio alle vecchiette. Alcuni Cumani ubriachi con un SUV mettono sotto un vigile. Eccetera...
.
Gli risponde Paolo:
Amaramente divertente (e quasi realistica, purtroppo...) Guarda, in effetti avevo pensato anch'io ad un'eventuale assimilazione con i Rom da parte degli occidentali...
.
Franz Joseph von Habsburg-Lothringen dal canto suo aggiunge:
Splendide ucronie! Sulle bellissime cartine solo un appunto: il Kunság storico si trovava proprio nel centro della pianura, nelle attuali province (megyék) di Bács-Kiskun (la Cumania Minore) e Jász-Nagykun-Szolnok (la Cumania Maggiore). In pratica la mia domanda è: perché ucronizzare la Cumania in Rutenia Subcarpatica?
.
E Paolo Maltagliati chiarisce:
È dettato da una mia valutazione sulla posizione della Cumania Minore, derivata dal fatto che comunque davo per scontata una magiarizzazione della Cumania Maggiore. Poi anche perché non volevo togliere troppo spazio agli ungheresi... Evidentemente mi sono lasciato prendere la mano: ho spostato i Cumani "troppo" a nord, in un'area relativamente periferica per tutti, in cui questo popolo non interferisse "troppo" con la grande storia...
.
Franz Joseph von Habsburg-Lothringen annuisce:
Ah, ho capito. Per parte mia, pensavo soprattutto alla Cumania Minore come zona ideale di sopravvivenza, perché le modalità di insediamento (estensivo e rado) sul territorio comportano meno resistenza da parte di componenti locali preesistenti, mentre la Rutenia Subcarpatica è paragonabile al Caucaso come persistenza delle Comunità etniche storiche (è una delle regioni europee - con l'Irlanda, il Galles, la Scandinavia, la Germania Settentrionale, i Paesi Baltici, il Paese Basco, Roma [in parte], l'Albania interna e l'Attica - in cui si ha continuità ininterrotta, senza sostituzioni di lingua, dalla Preistoria a oggi).
.
Paolo allora ci lavora intorno di fantasia:
Si potrebbe immaginare una situazione carpatica paragonabile ai Balcani, o peggio, al Caucaso, con una tale parcellizzazione etnica da indurre quasi necessariamente a far diventare tutta la zona tra la pianura pannonica ed i carpazi un punto caldo, anzi, caldissimo. Basta trovare un pod (questa è la parte più difficile) che permetta la sopravvivenza di stanziamenti di molti popoli che sono transitati da quelle parti in epoca medievale.
1) "Pannoni". Non mi riferisco ai Pannoni antichi, ma ad una popolazione neolatina che riesca a sopravvivere (prove archeologiche di un volgare latino nella zona di Aquincum nel V secolo ci sono). Stanziamento maggiore nella selva Baconia?
2) Popolazioni Germaniche. Propenderei per i Gepidi, assieme a resti di Eruli e Rugi che si Gepidizzano. Se sopravvivessero in qualche modo sarebbero oltretutto una manna per i linguisti, avrebbero una lingua germanica "orientale". Dunantul meridionale, sforando anche oltre la Drava, alle pendici dei colli Bilogora e Papuk?
3) Avari. Crearono un grande impero, ma rimasero arretrati per la loro tendenza isolazionistica, anti-cristiana e tradizionalista. Fossero stati più malleabili... Tra Danubio e Tibisco, spinti progressivamente a sud quando arrivano i Magiari?
4) Ungheresi. Quelli che storicamente sono risultati vincenti nella nostra TL, a conti fatti. Occuperanno la piana ungherese tra il Danubio e i monti Apuseni?
5) appunto, i Cumani. A Nord degli Ungheresi (la piana comincia ad essere piuttosto affollata...)?
Se poi contiamo a nord gli Slavi occidentali, a sud i Serbi ed i Croati, a est i Valacchi ed a ovest i prototedeschi, la situazione comincia a farsi confusa. Vogliamo fare uno sforzo masochistico e complicarla ancor di più? Ripescare, andando indietro, i celti, magari arroccati in qualche sparuta comunità montana stile allobrogico sui Tatra. Se avete altre idee... Nel frattempo proverò a pensare a quale pazza timeline potrebbe dare questo esito e quali le conseguenze dal punto di vista politico...
.
Riprende la parola Rivoluzionario Liberale:
Sarebbe bella la sopravvivenza di un po' tutti questi, ad esempio mandati dagli ungheresi nella Transilvania che non si romanizza. Quindi ad esempio:
a)
sopravvivono i Daci, in alcuna zone
b) presenza romanza minoritaria, al pari degli Arumeni nel sud dei Balcani
c) sopravvivono i Gepidi, con la loro lingua germanica
d) colonizzazione Szekeli, magiara (come nella HL)
e) Cumani
f) Yazigi iranici
g) i rom si stabilizzano in alcune aree
h) colonizzazione sassone
Alla fine il territorio della Transilvania e del Banato non ha un ceppo prevalente. Con l'autonomia dell'Ungheria il governo di Budapest tenta di imporre l'ungherese a tutti. Si arriva a Trianon e l'Ungheria che ne ha posseduto l'area viene smembrata, ma la Romania la rivendica.
1) Trianon decide che la T. rimane ungherese e impone al governo di B. larga autonomia
2) La T. passa alla Romania che deve gestire un'area multietnica
3) La T. nasce come stato indipendente e multietnica, la lingua ufficiale torna il
tedesco
4) Nasce tutta una serie di stati.
Continuate voi...
.
Franz Joseph von Habsburg-Lothringen mette in ordine tutte queste idee:
Dunque, sinora abbiamo enumerato: tra le popolazioni prelatine, i Daci e i Celti; tra i Neolatini, i 'Pannonoromanzi' e i Valacchi; tra i Germani, Gepidi (+ Eruli e Rugi) e poi i Bavari; tra gli Slavi, i Serbi e i Croati; tra i Popoli delle Steppe, gli Avari, i Magiari, i Székelyek, i Cumani; infine gli Jazigi.
Faccio notare che abbiamo saltato tre etnie centralissime in Pannonia: i Pannoni appunto, gli Unni e i Longobardi (mi permetto di caldeggiarne la sopravvivenza; fra l'altro i Longobardi possono benissimo rimanere, così come i Goti di Crimea sono sopravvissuti almeno un Millennio più degli Ostrogoti, Visigoti e Gepidi).
.
Non può mancare il nuovo contributo di Paolo:
Mi sono messo d'impegno e ho provato a raffigurare una situazione del genere su una cartina. Premetto che è piuttosto arbitraria, però è un tentativo che mi ha divertito molto.
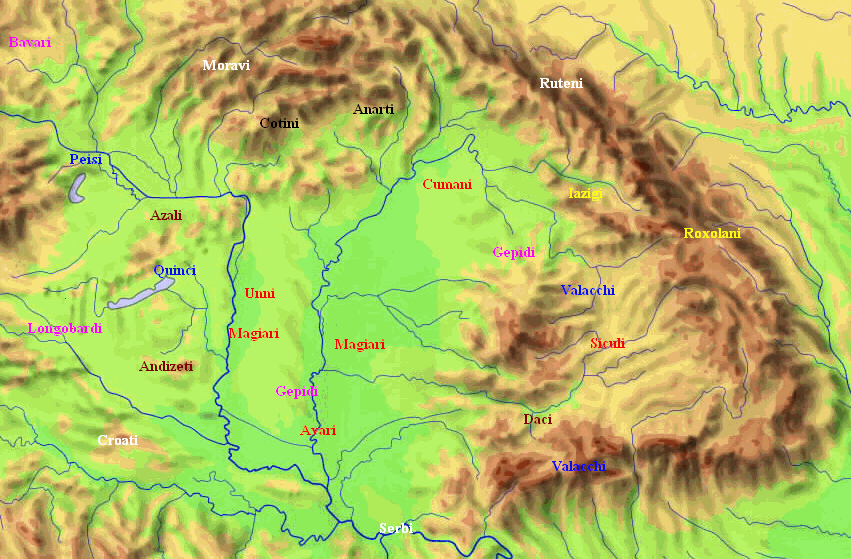
Dopo le reazioni prodotte dalla discussione sull'"aumento del tasso di varietà locale" nell'ambito pannonico, proviamo a fare lo stesso discorso per quanto riguarda un'altra area interessante, il Baltico. Immaginiamo di raddoppiare il numero delle repubbliche baltiche sopravvissute al giorno d'oggi. Per la precisione, tre baltiche e tre baltofinniche (invece di due e una).
Baltiche: vado sul sicuro, Prussia, Lituania e Lettonia
Finniche: e qui mi sbizzarrisco, Livonia, Estonia, Ingria
Quali i punti di divergenza per arrivarci?
A livello generale, penso ad una prolungata fluidità ed instabilità politica della regione. Se invece di "egemonie" (Tedesca, Polacco/Lituana, Svedese, Russa) successive, una dopo l'altra, rimanesse area contesa a lungo.
In secondo luogo, implica una netta revisione del cammino della potenza moscovita: o un suo ridimensionamento anche molto forte, oppure una cornice completamente diversa delle sue direttrici espansionistiche. Se per esempio l'arrivo sul mar Nero fosse arrivato prima dell'espansione verso nord-ovest, idealmente l'omologo di Pietro avrebbe potuto costruire la sua capitale nell'attuale luogo in cui si trova Kerc. Comunque sarebbe una timeline che coinvolgerebbe in maniera diversa tutto il resto del mondo (Sopravvivenza dell'impero bizantino prolungata? Eliminazione anticipata di Kazan? e tantissimo altro).
.
Ecco la risposta di Massimiliano Paleari:
Spunto ucronico molto interessante, anche se di difficile sviluppo:
Per ipotizzare l'esistenza odierna di queste tre Repubbliche Baltiche in più mi pare che i pod più verosimili vadano collocati molto indietro nel tempo e collegati precisamente alle modalità di introduzione del Cristianesimo in queste terre. Per questi popoli infatti l'abbandono del paganesimo coincise con l'inizio di un processo di snazionalizzazione, dal momento che il Cristianesimo fu imposto sostanzialmente manu militari: il Cattolicesimo ai Pruzzi e ai Livoni dagli Ordini Cavallereschi (Portaspada e Teutonici) Germanici; il Luteranesino agli Ingri (già in parte Ortodossi) dai Finno/Svedesi. Se invece ipotizziamo una introduzione "più dolce" del Cristianesimo e legata in qualche modo alla creazione di "Chiese Nazionali" e di un Clero locale, allora questi popoli (forse gli Ingri no in ogni caso) avrebbero mantenuto maggiormente la propria identità etnica e linguistica. Lo sbocco più razionale sarebbe stato la nascita di una Federazione Baltica (entità statale che anche nella nostra timeline è realmente esistita anche se in maniera effimera durante il 1918 e sotto tutela tedesca) o al limite di due federazioni: una baltica propriamente detta (Pruzzia, Lituania, Samogizia, Curlandia, Semgallia, Latgallia) e una balto/finnica: Estonia, Ingria, Finlandia.
.
A questo punto si intromette Iacopo:
Per quel che ho capito, non sarebbe stato ancora del tutto chiarito in che misura le affinità tra queste lingue, appartenenti a differenti rami di lingue indoeuropee, siano dipendenti da una "parentela" e quanto invece dalla vicinanza geografica dei popoli che le parlavano. Tu su questo tema che cosa pensi? E' possibile trovare in questa "lega linguistica" una lingua che potremmo considerare "centrale"? Ci sono tra queste lingue alcune che sono mutualmente intelligibili (per esempio, un serbo e un bulgaro, parlando ciascuno nella propria lingua, potrebbero capirsi)
.
Subito Franz Joseph von Habsburg-Lothringen gli replica:
La formula della Lega Linguistica Balcanica è, in sintesi, così riassumibile:
1) stratificazione dell’indoeuropeo preistorico (come nel resto dell’Indoeuropa), con espansione demica dall’Anatolia di Agricoltori Neolitici indoeuropei (7000-3500 a.C.) fra Cacciatori-Raccoglitori Mesolitici indoeuropei, poi con invasioni o comunque massicce infiltrazioni di Pastori Allevatori Calcolitici indoeuropei dalle Steppe Ponto-Caspiche (4200-2100 a.C.); questa è la lunga fase di selezione (rispetto al più ampio inventario dell’indoeuropeo comune) della maggior parte della grammatica e del lessico greco, illirico, baltoslavo-dacomisio-tracio (anche frigio), naturalmente anche veneto-istro-liburnico e celtico, nonché del fondo più antico del lessico ‘balcanico’ comune (quello diffuso in tutte o quasi le lingue balcaniche e anteriore al latino);
2) differenziazione – anche fonologica – dell’indoeuropeo balcanico (e delle regioni contermini) fra le classi greca, frigia, illirica, baltoslavo-dacomisio-tracia, veneto-istro-liburnica e celtica (II. millennio a.C.);
3) possibili migrazioni (‘pelasgica’, dorica, tirrenica &c.: ultimi secoli del II. millennio a.C.) e contatti con l’Anatolia e l’Egitto; ipotetica Lega Linguistica Paleobalcanica fra macedonico, illirico, tracio e dacomisio (e frigio?);
4) espansione coloniale e culturale del greco (I. millennio a.C., forse con inizio già prima), dal II. sec. a.C. – ma soprattutto nella prima metà del I. millennio d.C. – anche del latino; formazione della Latinità Balcanica (soprattutto il rumeno, ma non solo), Cristianizzazione e Fase Bizantina più antica (greco, protoalbanese, protorumeno, tracio [finché è rimasto], dacomisio [che partecipa alla trasformazione del baltoslavo meridionale in protoslavo]);
5) effimeri superstrati germanici orientali (anche con gli Unni); Slavizzazione del dacomisio (sotto l’egida politica degli Avari, di lingua altaica) e del tracio; espansione del rumeno (sotto l’egida politica dei Bulgari, discendenti degli Unni e linguisticamente multifarî fra turco-tataro, ’īrānico, slavo e balcanolatino). Sono i secoli (VI.-IX.) di formazione della Lega Linguistica Balcanica fra albanese, rumeno, bulgaro-macedone e serbo (con effetti visibili a livello sia lessicale sia grammaticale);
6) Missioni Bizantine fra gli Slavi, Fasi Paleoslava e (seconda) Bizantina (entrambe IX.-XIV. secolo) della Lega Linguistica Balcanica (greco, albanese, bulgaro-macedone e serbo, rumeno);
7) Turcocrazia (XIV.-XIX. secolo), Fase Ottomana della Lega Linguistica Balcanica (turco, greco, albanese, bulgaro-macedone e serbo, rumeno).
Così si può rispondere alle domande:
- le somiglianze fra albanese, greco, rumeno, bulgaro-macedone e serbo sono sia per parentela (indoeuropea; per bulgaro-macedone e serbo anche e soprattutto slava) sia per vicinanza, mentre le somiglianze del e col turco sono solo per vicinanza (contatto linguistico);
- le somiglianze che coinvolgono il turco sono una parte (minoritaria) di quelle dovute a vicinanza che coinvolgono soltanto albanese, greco, rumeno, bulgaro-macedone e serbo;
- le somiglianze dovute a vicinanza sono nel complesso minori di quelle dovute alla parentela indoeuropea e ovviamente molto minori di quelle fra bulgaro-macedone e serbo dovute alla parentela slava;
- a parte le lingue slave fra loro, le lingue che partecipano alla Lega Linguistica Balcanica (albanese, bulgaro-macedone e rumeno; greco, serbo e turco sono più marginali) non sono mutuamente comprensibili (si può capire qualche parola, ma meno che l’inglese per un italofono che non lo abbia studiato); fra bulgaro-macedone e serbo c’è più o meno la somiglianza che si ha fra italiano e spagnolo, mentre fra bulgaro e macedone è come fra toscano e còrso (anche se bisogna rilevare che macedone e bulgaro hanno l’accento di parola completamente diverso – che disturba notevolmente la comprensione immediata – e così pure la formazione dei cognomi);
- tuttavia (in parte proprio per queste ragioni), per molti secoli il plurilinguismo è stato la regola (tutti o quasi conoscevano il greco e/o il turco) e le appartenenze nazionali erano soltanto due, Musulmani (perlopiù Sunniti) e Cristiani (Ortodossi), percepite rispettivamente come Turchi e Greci (per cui un Albanese musulmano e un Albanese ortodosso si potevano benissimo parlare in albanese – ghego o tosco – ma si consideravano di Nazioni diverse), con l’aggiunta dei Serbi, che sono in gran parte sfuggiti all’identificazione coi Greci (mentre, per contro, moltissimi Rumeni erano annoverati fra i Serbi);
- questo significa che albanese, bulgaro-macedone e rumeno erano solo basiletti parlati a livello locale, da persone comunque bilingui col serbo o il greco e/o il turco (non c’era bisogno dell’intercomprensibilità, perché la comunicazione era garantita dal bilinguismo);
- hanno avuto un ruolo di lingua ‘centrale’, in ordine di tempo, il latino, il greco bizantino, il paleoslavo (non per i Greci) e il turco.
.
Iacopo insiste:
Secondo te quali erano confini settentrionali del daco-misio-tracio? In particolare, esistono tracce di un tale sostrato anche oltre i Carpazi? In Galizia, in Polonia? Dovevano essere aree pochissimo popolare, ma si può ricostruire il percorso del confine tra area celtica, area balto-slava-daco-misia e area proto-germanica?
.
Franz Joseph von Habsburg-Lothringen non si fa certo pregare:
Le due principali teorie sulla Protopatria degli Slavi sono quella Occidentalista (prediletta in Polonia, perché sostiene che la Polonia sia la Protoslavia) e quella Orientalista (preferita in Germania, perché spostando la Protoslavia in Ucraina lascia disponibile la Polonia come parte della Protogermania). Queste sono le due scuole in cui ho studiato e da giovane ritenevo che la soluzione alla diatriba fosse semplicemente di unirle, dal momento che entrambe risultano incontrovertibili per la propria parte positiva né sono reciprocamente incompatibili (come invece vengono presentate). D’altra parte, il mio interesse era per il Bacino Danubiano e dunque per i Daci e i Traci (su cui la bibliografia è prevalentemente in bulgaro e rumeno) e così per molto tempo mi sono accontentato di perseguire, per quanto riguarda la Questione della Protoslavia, soltanto l’unificazione della Teoria Occidentalista e Orientalista.
All’inizio il problema più importante mi sembrava quello di distinguere con precisione il tracio dal dacio e dal getico e ho seguito l’insegnamento di Duridánov (quindi di Georgíev) soprattutto per questo aspetto; dopo di ciò, ho seguìto l’itinerario di Georgíev in relazione all’etrusco e infine sono passato, secondo il suo modello, all’Anatolistica. Poi però, verificando con più attenzione le varie teorie sui Daci e i Mesî, mi sono reso conto che le trasformazioni dall’indoeuropeo al dacomisio sono identiche a quelle dall’indoeuropeo allo slavo, ho recuperato gli studî di Duridánov sulla toponimia della Mesia e quelli di Mario Enrietti sulle solidarietà fra protoslavo e rumeno e infine ho appreso che il lignaggio genetico autosomico patrilineare degli Slavi Meridionali è in grandissima maggioranza diverso da quello comune agli Slavi Occidentali (Cechi, Slovacchi, Sorabi, Polacchi) e Orientali (Russi, Bielorussi, Ucraini). La conclusione che mi sono trovato obbligato a trarre è questa: l’unificazione delle Teorie Occidentalista e Orientalista sulla Protoslavia (ossia che la Protopatria degli Slavi andasse dalla Volga all’Elba) vale per gli Slavi Settentrionali (= Occidentali e Orientali), ma la Protoslavia si estendeva anche nel Bacino Danubiano-Carpatico e quindi era in parte ricompresa nell’Impero Romano. Non che i Russi o i Polacchi siano mai provenuti da Sud; è chiaro che rappresentano la continuità della popolazione (baltoslava) dell’Istmo Ponto-Baltico. Ma gli Slavi invasori di cui parlano le fonti bizantine sono semplicemente i Daci e i Geti e a Sud del Danubio si sono stanziati fra popolazioni (discendenti dei Mesî) che, come già sapevamo, parlavano la loro stessa lingua: in altri termini, nell’Impero Romano c’erano già gli Slavi ed erano nient’altro che i Mesî, i Daci e i Geti.
Certo, all’epoca dell’Impero Romano non parlavano ancora il protoslavo; parlavano appunto il dacomisio, che, come ci mostra la toponomastica, era identico al baltoslavo a Nord dei Carpazi. Tuttavia, è dai territorî già romani che sono partite le innovazioni che hanno più differenziato (insieme a quelle di origine ’īrānica: scitica, sarmatica e alanica) il futuro protoslavo dal resto del baltoslavo (ossia dal baltico). Ecco perché le principali innovazioni protoslave sono così simili alle trasformazioni dal latino classico al latino volgare (in particolare al latino balcanico): si sono diffuse dal latino volgare al dacomisio (tardo) e da qui al resto del protoslavo...
Quindi, per riassumere: la Protopatria degli Slavi si estendeva sì dall’Elba
alla Volga (unificazione delle Tesi Occientalista e Orientalista), ma anche a
Sud dei Carpazi (compresa la Bassa Pannonia), fino ai Balcani e alle Alpi
Dinariche. Così si capisce perché Strabone scrivesse che i Traci sono la nazione
più grande del Mondo: intendeva anche i Dacomisî e i Baltoslavi, che in effetti,
tutti insieme, occupavano mezza Europa (l’altra metà essendo invece perlopiù
celtica).
Dunque, visto da Sud e con la terminologia etnica greco-latina, i Traci erano
compresi fra l’Egeo e i Balcani, a Nord dei quali abitavano i Mesì fino al
Danubio, oltre il quale i Geti e, in Transilvania, i Daci (nei Carpazi i
Coestoboci, che erano dimostrabilmente Slavi nel senso più stretto del termine);
a Nord dei Carpazi la stessa comunione linguistica continuava con gli Slavi veri
e proprî e, più a Nord (fra il Baltico e la Moscova), i Balti. Non c’era quindi
un “sostrato”: come gli Indoeuropei danubiano-carpatici sono diventati i
Daco-Misî (e Geti), così gli Indoeuropei ponto-baltici sono diventati i
Baltoslavi e le trasformazioni linguistiche degli uni e degli altri sono state
le stesse, dopodiché quelle dei Daco-Misî e Geti a contatto con la Latinità
Balcanica hanno innescato le traformazioni dal baltoslavo al protoslavo (ciò
spiega perché i nomi delle città della Dalmazia risultano essere passati dal
latino volgare a una fase ancora baltoslava, a partire da cui hanno poi preso
parte a tutte le trasformazioni dal baltoslavo al protoslavo: non è che i
Baltoslavi si siano spostati fino all’Adriatico, sono semplicemente i Dalmati
dell’Entroterra che parlavano baltoslavo e poi si sono trasformati in Protoslavi).
Per fare un paragone con l’Occidente: come non c’era differenza fra il gallico e
il britannico, così non ce n’era fra il dacomisio e il baltoslavo. Non è che i
Daci si estendessero a Nord dei Carpazi: erano gli Indoeuropei a Nord dei
Carpazi che si sono trasformati linguisticamente allo stesso modo degli
Indoeuropei da cui sono discesi i Daci, i Geti &c.
Dopo la fase indoeuropea preistorica si sono diffuse, da centri diversi, trasformazioni linguistiche reciprocamente alternative: certi dialetti ne accoglievano alcune, altri altre. I confini fra i dialetti indoeuropei che hanno accolto le innovazioni germaniche e quelli che hanno accolto quelle celtiche oppure quelle baltoslavo-dacomisie sono diventati i confini fra le classi linguistiche germanica, celtica e baltoslava(-dacomisia). Il confine celto-germanico andava più o meno dal Basso Reno ai Mittelgebirge, tendendo sempre più verso Sud-Est (al punto che la Baviera settentrionale era germanica); il confine germano-baltoslavo doveva andare, approssimativamente, dal Baltico lungo il bacino del fiume Oder fino all’alto corso dell’Elba. Celti e Baltoslavo-Dacomisî confinavano sul Medio Danubio (indicativamente fra Vienna e Bratislava), in Pannonia (la Pannonia Superiore era celtica, la Pannonia Inferiore baltoslavo-dacomisia, anche se i Celti Scordisci si sono poi spinti fino alla zona di Belgrado) e, più a Sud, fra Pannonia Superiore (appunto celtica) e Dalmazia (se non era, almeno in parte, illirica), fino ai Liburni (veneto-istro-liburnici) in prossimità dell’Adriatico. La costa adriatica veneto-istro-liburnica si è massicciamente latinizzata (data anche l’affinità linguistica), i Dalmati sono diventati Slavi e poi anche i Celti alpini sudorientali si sono a loro volta slavizzati, diventando gli Sloveni (da notare che hanno assunto il nome generale degli Slavi Meridionali, appunto Sloveni).
La presenza di Colonie Greche in Occidente in fase micenea (II. millennio a.C.) è accertata per Roma, fortemente indiziata per Napoli e la Sicilia nonché, nell’Adriatico, almeno per Traù e comunque ipotizzabile in generale per tutte le località in cui la Tradizione antica riporta la memoria di peregrinazioni di Eroi di ritorno dalla Guerra di Troia. In area specificamente baltolsavo-dacomisia, il ricordo di frequentazioni pre- e protostoriche è incorporato nei Miti relativi agli Iperborei (nome generico che, nella maggior parte dei casi, si riferisce a Dacomisî e Baltoslavi); in questo caso però si tratta solo di contatti, non di Colonie.
Un aspetto delicato che vedo (spesso trascurato) nei livelli di appartenenza ‘intermedî’ è la loro sovrapponibilità. Per esempio, un Valacco del 1500 poteva con ottime ragioni considerarsi ed essere qualificato come gallesco (‘valacco’), tedesco (in particolare... boemo), serbo o greco: la somma delle appartenenze coincide con le quattro Nazioni dell’Europa in epoca ottoniana (Greci, Latini, Germani, Schiavoni). riconoscere la coesistenza di identità (apparentemente) ‘alternative’ costringe a cercare una cornice comune sovraordinata, all’epoca ‘cristiana’ (somma di romano-germanica e greco-slava), oggi appunto ‘indoeuropea’.
Sulla formazione del rumeno a Sud del
Danubio non sussistono dubbi, data la toponimia locale e le attestazioni
storiche (v. cartina № 4.); si può discutere sulla continuità anche a Nord del
Danubio, del tutto verosimile nelle città: il punto cruciale è che il nome del
fiume Olt, anticamente (come registrato in latino) Ălŭtă, presuppone la
trasformazione slava (del IX. secolo) *Olŭtŭ (donde *Olŭt nel X. secolo) da *Ălŭtŭ
< *Ălŭtăs, mentre se il latino Ălŭtă si fosse conservato in rumeno suonerebbe,
nel migliore dei casi, †Altă (nel peggiore †Arătu). In altri termini, il nome
rumeno del principale fiume che attraversa e divide in due la Valacchia è stato
preso dallo slavo in rumeno dopo il IX. secolo.
D’altra parte, va osservato che proprio nel IX. secolo si è avuta la massima
espansione del Khānato Protobulgaro (anche in tutta l’attuale Romania), il quale
per parte sua era centrato sulle aree più latinizzate (quindi protorumene) a Sud
del Danubio (anche i nomi di alcuni suoi sovrani sono schiettamente latini, come
Sabino, Campagnano &c.). Non dimentichiamo, poi, che la formazione dello slavo
(necessariamente centrata sulla Dacia, altrimenti non avrebbe raggiunto il
baltoslavo meridionale a Nord dei Carpazi) implica la presenza rumena a stretto
contatto, dunque anche a Nord del Danubio. È quindi possibile che l’unificazione
del protorumeno, fra Nord e Sud del Danubio, si sia compiuta nel IX. secolo e
che allora sia avvenuta l’espansione anche nelle zone (a Nord del Danubio)
all’epoca compattamente slave.
È questa ampiezza di orizzonti che riconcilia le opposizioni e offre (come l’unificazione delle teorie sulla Protoslavia...) una soluzione ai conflitti di lealtà identitaria; la sua mancanza contribuisce, credo, ad alimentare i tentativi ipernazionalistici di riscatto dalla frustrazione di essere ‘prigionieri’ di una Nazione percepita come mediocre.
.
Non possiamo non pubblicare qui questa cartina di Lord Wilmore:
Se i Visigoti si fossero stanziati nei Balcani Occidentali, ecco come essi potrebbero apparire oggi...
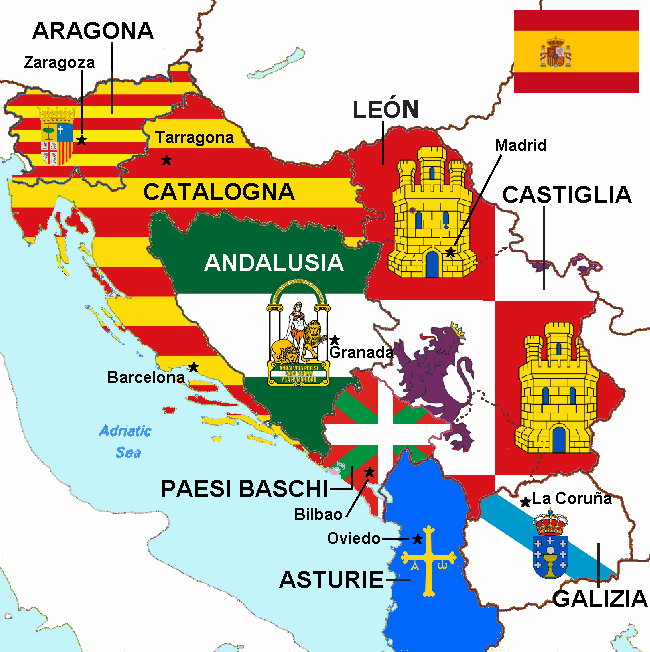
.
Gli risponde Alessio Mammarella:
Potremmo pensare ad un un insediamento dei Visigoti in Italia dopo il sacco di Roma e lo spostamento proprio in Gallia (per esempio con Arelate come capitale) del baricentro dell'Impero d'Occidente. Nei secoli successivi l'Impero d'Occidente (o il Regno dei Franchi in sua sostituzione) che progressivamente riconquistano la penisola italiana. Presa tra le guerre contro i franchi e le prime scorrerie dei saraceni, gran parte della nobiltà gotica si sposta oltre le Alpi Giulie, in quella regione occidentale dei Balcani che è sempre meno controllata dall'Impero d'Oriente.
Chiaramente questi visigoti romanizzati avranno battuto avari e ungari così come altri popoli (slavi) intenzionati a migrare verso sud. Forse solo la Galizia subirà un influsso slavo e non a caso si chiamerà così, come una regione della non lontana Polonia. Con il tempo, le varie regioni del paese si differenziano, in particolare la Catalogna e la Navarra hanno rapporti commerciali e culturali con gli stati "franchi" a ovest dell'Adriatico, mentre invece nelle aree impervie dell'interno si arroccano i superstiti delle popolazioni illiriche preromane che ancora orgogliosamente persistono nelle loro tradizioni.
L'avanzata dei turchi rappresenta un problema per questa ricostruzione perché se i turchi avanzassero come in HL l'unità del paese sarebbe rotta per secoli e ripristinata non prima del XIX secolo. Potremmo al limite ipotizzare che il regno gotico sia forte e possa dover sacrificare la sola Andalusia. Per quanto riguarda le questioni dinastiche e le avventure militari, l'ingerenza degli aragonesi in Italia e in Grecia sarà favorita da uno scenario del genere, mentre invece non possiamo pensare ad esplorazioni oceaniche. Viaggi come quelli di Colombo partiranno comunque dalla Penisola Iberica, la cui organizzazione politica esula dal nostro discorso (anche se sarebbe interessante ipotizzarla).
Il passaggio del regno agli Asburgo sarebbe ancora più logico che in HL, vista la continuità del paese con territori come l'Austria e l'Ungheria. In assenza della Penisola Iberica e delle sue colonie oltreoceano, non so se Carlo V avrebbe diviso la sua eredità in due diversi rami, ma comunque la cosa rileva poco visto in un secondo momento si sarebbero riuniti. L'unica cosa che possiamo ipotizzare è che il mondo asburgico sarebbe stato meno potente militarmente, e quindi alcune guerre dei secoli XVI-XVII-XVIII sarebbero andate diversamente. In ogni caso, vicende politiche da definire avrebbero portato il regno balcanico a separarsi dal resto dei domini asburgici (forse l'unico rimasto monarchico, dopo che altri paesi vicini sono diventati repubbliche?)
Possiamo forse solo ipotizzare, per arrivare ai giorni nostri, che il dittatore Tito abbia svolto un ruolo paragonabile a quello di Franco in HL, predisponendo il ritorno alla monarchia dopo un periodo repubblicano seguito a una guerra civile.
.
Generalissimus propone:
Modu Chanyu, il fondatore dell'impero
degli Xiongnu, nel 192 a.C. ebbe l'ardire di chiedere in sposa l'Imperatrice Lü
della Dinastia Han.
Costei rimase estremamente scandalizzata dalla proposta, al punto che sondò la
possibilità di dichiarare guerra a quello che non vedeva altro che come un
barbaro inferiore, ma poi uno dei suoi consiglieri la portò a più miti consigli
quando le fece notare che l'esercito del capo degli Xiongnu era decisamente più
potente di quello cinese.
Ma cosa accadrebbe se invece l'Imperatrice Lü accettasse e i due imperi si
unissero?
.
Ed è ancora Federico a rispondergli:
Particolare interessante: dopo la morte di Modu gli Xiognu svilupparono un sistema di governo dualistico tra il Chanyu (il Khan, in pratica), che regnava direttamente dalla capitale Longcheng (attuale Mongolia centrale) e sulla metà orientale della confederazione, e il Tuqi Wang (“Saggio Principe”), che governava l’altra metà della confederazione ed era usualmente l’erede al trono. Le regole di successione prevedevano anche che se l’erede diretto fosse troppo piccolo allora l’erede adulto, per esempio il fratello del re, assumesse il trono, cosa che alla fine portó alla nascita di numerosi rami cadetti che iniziarono a lottare per il potere.
Ora, immaginiamo che l’Imperatrice Lu accetti. Dovrebbe essere costretta, visto che in HL era tanto entusiasta da pretendere la guerra contro gli Xiognu. Forse gli stessi potrebbero infliggere ai cinesi una sconfitta ancora più umiliante a Baideng, otto anni prima, catturando o uccidendo lo stesso Imperatore Gaozu (in HL ci mancò poco). Dopo il matrimonio e l’unione dei due troni il sistema duale potrebbe svilupparsi con un Khan a Luangcheng e il Tuqi Wang a Chang’an, capitale della dinastia Han, o viceversa. Quando le lotte dinastiche inizieranno il principe che sarà meglio riuscito ad integrarsi coi costumi cinesi potrà guadagnare il loro supporto, sconfiggere i rivali e riprendere saldamente il trono, eventualmente introducendo lo successione alla cinese. L’Impero Sino-Xiognu si espanderebbe dall’Isola di Hainan al Lago d’Aral. Abbiamo tracce dei rami dinastici Xiognu almeno fino al 460 DC, per cui la nuova dinastia si guadagnerebbe un posto nella storia cinese con un regno di più di cinque secoli. Comunque sia, se diamo credito all’idea che gli Unni siano originatisi dagli Xiognu Settentrionali e sapendo che questi a loro volta si sono distaccati a seguito della guerra civile Xiognu, che qui non avverrebbe, al netto del fascino di vedere Attila al servizio di questo impero, è chiaro come anche la storia delle migrazioni “barbariche” ne risulterebbe sconvolta.
.
William Riker ha avuto un'altra idea geniale:
Ardagasto, re degli Anti (Sarmati slavizzati), non viene sconfitto dall'imperatore Maurizio nel 585 durante la sua incursione in Tracia, ma anzi travolge le truppe bizantine al comando di Prisco e si stanzia stabilmente in quella che è la nostra Bulgaria, sottraendola all'Impero Romano d'Oriente. Che accade all'arrivo dei Bulgari? Questi ultimi dove si stanzieranno?
.
E Franz Joseph von Habsburg-Lothringen gli replica puntualmente:
Si sono fatte tantissime ucronie sulla persistenza dell'Impero Romano (che poi è realmente persistito, a Bisanzio), ma poche sulla persistenza degli Anti, certo meno celebri, ma altrettanto se non più importanti; non a caso, Paolo Maltagliati se ne è occupato nella sua grande Ucronia Gotica. Io proporrei questo schema di risposta: Austria (bavarese) fino a Belgrado; Boemia fino ai Carpazi; Bulgaria slava (col nome di Slovenia) estesa a tutta la Romania.
Ora però voglio sottoporvi una variante: non una vittoria degli Anti su Bisanzio, ma la mancata sovrapposizione degli Avari sugli Anti. Circa la loro affiliazione etnico-linguistica, una delle prospettive più diffuse (alle quale aderisco) è che fossero Slavi (magari mi atterrei a un più generico e prudente «Baltoslavi»). Da Boz, Booz, Box (ca. 376-380, citato da Giordane) = */Bōz(ĭ)s/ (cfr. lituano buožis, lettone buõzis ‘verga, zucca (nel senso di “testa”; termine infantile)’, in lotta con gli Ostrogoti, a Dabragezas (attivo nel 555–56) = "buon bastone" (cfr. paleoslavo žezlъ ‘bastone, asta’), che ha guidato la flotta bizantina in Crimea contro i Persiani, se non fossero giunti gli Avari era già formato un Impero protobaltoslavo che avrebbe dominato dal Danubio al Don, perfettamente in equilibrio fra Bisanzio e gli Alani (poi i Chazari).
Per me dunque la Slavia Orientale Meridionale è questa e vi associo l’ucronia seguente: verso l’830 d.C. il primo Voivoda dei Magiari («Tourkoi» nella narrazione di Costantino VII. Porfirogenito [905-959], Dē Ădmĭnĭstrăndō Ĭmpĕrĭō, capitolo XXXVIII), Lebedíās, invece di controproporre Almoútzēs o il figlio di quest'ultimo, Arpadḗs (in ungherese Árpád), accetta l’offerta del chagan dei Chazari di diventare Principe dei Magiari («Sábartoi ásphaloi»), nella regione di Atelkoúzou (ungherese Etelkőz), presso il Dnepr, dopodiché tutta la storia degli Ungari si svolge pressoché identica fino al 1867, ma in lingua rusina anziché magiara (questa sarebbe una Slavia Orientale... Sud-Occidentale). L’ucronia arrivava al trionfo del duplice Progetto Großösterreichisch e Austroslavista, all’orientamento dell’Impero Russo verso le due Direttrici Geopolitiche alternative al Panslavismo (Protezione degli Ortodossi ed Eurasismo) e con la Prussia nel «ruolo di Mediatrice fra la Germanità di Russia e la Componente Evangelico-Riformata in Germania (come alternativa al ruolo asburgico di Mediazione fra Slavia Romana e Componente Cattolica in Germania, oltre ovviamente all'Italia)» (con possibile disinnesco della Grande Guerra fra una Cordiale Intesa a due e la Santa Alleanza dei Tre Imperatori).
In questo caso viene invece a mancare la sovrapponibilità alla Storia reale (perlomeno quella fino al 1867): la persistenza dell’Impero degli Anti nelle proprie sedi (a fronte di Avari, Bulgari, Chazari, Peceneghi, Cumani, Tatari, se non nelle stesse forme dei Principati Russi) impedisce – come nell’ucronia di Ardagasto – la formazione della Romanìa neolatina (perché si slavizza) e della Croazia e Slovenia slave (perché vengono germanizzate), unita all’ucronia di Lebedìa (visto che stiamo ragionando per obiettivi e non per singoli Punti di Divergenza) vede la slavizzazione (rusina) della Pannonia (anziché in lingua ceca come nell’ucronia di Ardagasto), per cui alla fine avremo una Slavia Occidentale (Boemia e Polonia), una Slavia Nordorientale (Rutenia e Moscovia) e una Slavia Sudorientale (Antia e Sabartia/Rusinia), quest’ultima dall’Ungheria all’Ucraina (e alla Bulgaria).
.
Chiudiamo con quanto ci ha spedito Lord Wilmore:
Ogni ranto mi diverto a generare dei meme... :D :D
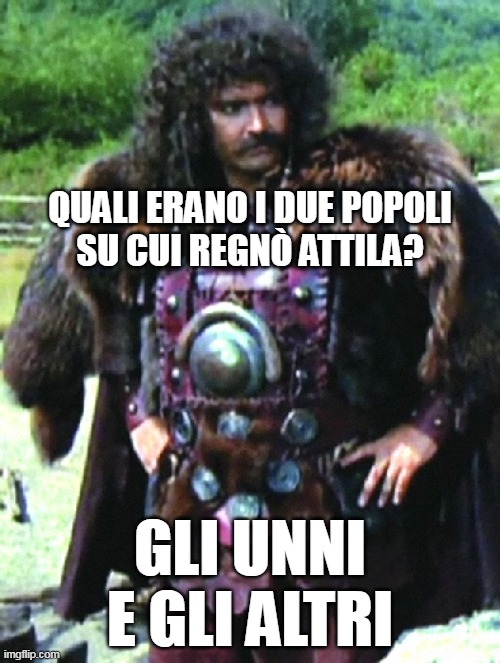
.
Generalissimus ha replicato con questa barzelletta rumena:
Molti secoli fa il capostipite degli
Ungheresi, Attila l'Unno, arrivò in Transilvania.
Vide un bellissimo lago, si tolse la sua armatura dorata, posò la sua spada in
acciaio damasco, legò il suo stallone bianco vicino alla sponda e andò a farsi
una nuotata.
Quando uscì dal lago l'armatura era scomparsa, la spada non c'era più e lo
stallone non si trovava più da nessuna parte.
Adesso ditemi, chi sono stati i primi ad arrivare in Transilvania, gli Ungheresi
o i Romeni? :D
.
Se volete farci conoscere la vostra opinione in proposito, basta che scriviate al Webmaster...
.
|
Successioni ininterrotte di sovrani ucronici Imperatori di tutta l'umanità – Re di Roma – Imperatori Romani 1 – Imperatori Romani 2 – Imperatori Romani di Britannia – Re Celtici di Britannia – Iperborei – Sciti – Ostrogoti – Visigoti – Geti – Longobardi – Franchi – Anglosassoni – Burgundi – Baschi – Svevi – Israele – Sparta – Italia – Scozia – Irlanda – Frislandia – Germania – Baviera – Valacchia Baltica – Boemia – Danimarca – Svezia – Norvegia – Finlandia – Ungheria – Bulgaria – Polonia – Lituania – Valacchia – Moldavia – Serbia – Russia – Turchia – Crimea – Arabia – Babilonia – Persia – Battriana – Turkestan – Yavana – India – Mongolia – Cambogia – Siam – Laos – Vietnam – Birmania – Malesia – Sambas – Brunei – Giava – Aceh – Corea – Marocco – Nubia – Kanem-Bornu – Mali – Senegal – Ashanti – Dahomey – Congo – Buganda – Zimbabwe – Zulu – Inca |
